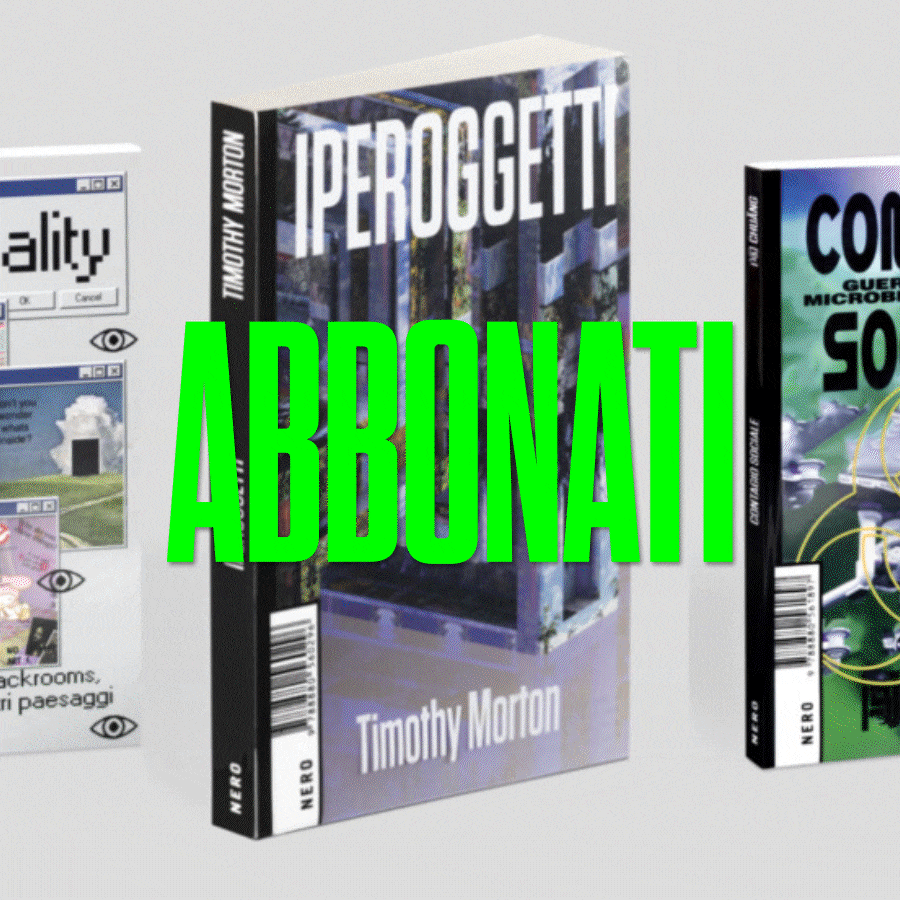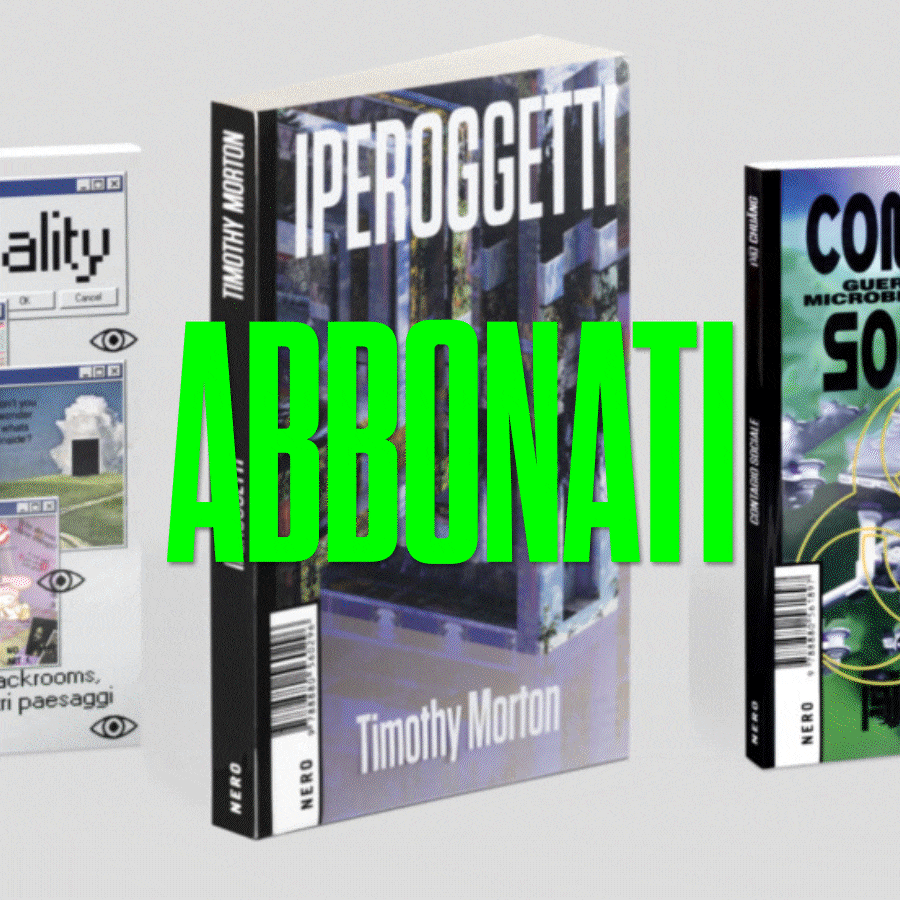Il Dead Media Project è un archivio digitale che raccoglie le forme mediatiche inventate dall’umanità nel corso della sua storia e poi definitivamente abbandonate: dai messaggi di fumo dei nativi americani al diorama di Daguerre, dal telegrafo ai piccioni viaggiatori. Il progetto, fondato dallo scrittore di fantascienza cyberpunk Bruce Sterling negli anni Novanta, è ospitato su un vecchio sito HTML che oggi si può consultare soltanto tramite la wayback machine: l’ultimo medium della lista, il nastro magnetico, è stato aggiunto del 2001. È un destino ironico, e forse inevitabile, che lo stesso progetto che ambiva a tracciare una genealogia dell’obsolescenza delle tecnologie mediatiche sia diventato a sua volta un “dead medium”.
Del resto, tutti i linguaggi, le estetiche e le culture che hanno popolato la rete nel corso della sua breve storia sono nati già morti: ogni tentativo di scriverne una cronaca in tempo reale si trasforma subito in una forma di necromanzia. Nel 2011, su Tumblr, girava lo screenshot di un’intervista in cui un dj sconosciuto, tale Lil Internet, si fregiava del titolo di “seapunk historian”. A farci ridere allora era il pensiero che una sotto-sottocultura digitale, nota a una decina di persone o forse mai esistita, potesse avere una storia; tredici anni dopo non è più solo il seapunk, ma la stessa immagine di Lil Internet (insieme alla piattaforma su cui circolava) a essere diventata un reperto archeologico. La nostalgia è un sentimento scivoloso: mentre ci offre il conforto di un rifugio in mondi più innocenti e paradisi perduti, ci intrappola in un passato senza fine e ci sottrae la capacità di immaginare altri futuri.
La nostalgia, in questo senso, è il sentimento che più di ogni altro ha caratterizzato l’esperienza online negli ultimi anni. Per citare una frase sempre più ricorrente nelle comment section sui social, Internet ci ha costretti ad accorgerci che “viviamo tutti la stessa vita”: le estetiche digitali, dalla Vaporwave all’ASMR, dal Frutiger Aero al Traumacore, manifestano e collettivizzano i nostri incubi più spaventosi, i nostri ricordi più privati e le nostre vibe più indescrivibili. Frughiamo tra le macerie di Internet alla ricerca di una narrativa coerente per frenare la frammentazione entropica delle nostre identità, ma al core delle nostre vite digitali troviamo soltanto una sensazione familiare e sfuggente a cui non riusciamo a dare un nome.
Esiste un modo per sopravvivere a questa fine-senza-fine di Internet senza restarne schiacciati, ma senza nemmeno ricadere nel rifiuto luddista di tutte le tecnologie digitali? Ora che le strategie di hacking del secolo scorso hanno definitivamente fallito, esiste una via di uscita tecno-poetica dalle paludi delle piattaforme? Esiste una backroom davvero inespugnabile, oppure dobbiamo rassegnarci a staccare la spina?

Che “gli strumenti del padrone non smantelleranno mai la casa del padrone” è un insegnamento senza tempo, ma Internet ha dimostrato una capacità senza precedenti di disarmarci. Ogni forma di resistenza nei confronti delle tecnologie digitali è immediatamente fagocitata dalle logiche di profitto delle piattaforme. L’entropyposting esemplifica meglio di qualunque altro trend questo fenomeno: la pratica di postare contenuti caotici, in contrasto con i profili ultra-curati degli influencer (o aspiranti tali), è in realtà un’altra tattica di autopromozione, in cui il contenuto “brutto” e imprevedibile funge da copertura per la forma più esclusiva e artefatta di identità social.
La nostra immaginazione, ormai, è infestata di parassiti: nemmeno i nostri sogni sovversivi sono più davvero nostri. Chi controlla gli strumenti digitali ha tutto l’interesse a continuare a dipingere la tecnologia come un mostro esoterico e autocosciente, ma queste narrazioni sono soltanto bullshit: le intelligenze artificiali generative non hanno sogni, allucinazioni o trip psichedelici, ma gli stessi bias delle società che le hanno prodotte. C’è, però, anche chi sceglie di utilizzare l’oscurità programmata delle tecnologie digitali per lanciare contro-incantesimi. Figlie tanto degli hacklab degli anni Novanta quanto dei sabba dei tempi che furono, queste cyberstreghe sovvertono gli strumenti digitali per costruire alternative al potere totalizzante del capitalismo patriarcale.
Davanti al caos digitale, alla tirannia degli algoritmi e al buco nero della nostalgia ricorsiva possiamo scegliere soltanto due strade: quella del disincanto o quella del reincantamento, l’illuminismo o la stregoneria. Tu che pillola scegli?
Silvia Dal Dosso: Sulle note di A playlist to feel like you are playing marbles with Einstein, a moment before he discovered the theory of special relativity in 1905 (“Una playlist per sentirsi come se si stesse giocando a biglie con Einstein, un momento prima che lui scopra la teoria della relatività ristretta, nel 1905”), ci ritroviamo sulla celebre coperta dello spaziotempo, quella rete quadrettata che di solito è verde su nero, ma talvolta anche gialla, o perchè no, celeste su viola. Dietro di noi la vaporwave è talmente pesante da creare una discesa ripidissima, a cui cerchiamo di resistere saltellando qua e là, sulle mille piccole palline che gli circolano attorno: l’estetica Frutiger Aero, l’Y2K, le backrooms, le dream pools, il weirdcore, il traumacore, tutto pur di non avvicinarsi al vortice apocalittico del corecore che si impone sul nostro orizzonte degli eventi, mangiando qualsiasi cosa, e che si colloca senza alcun dubbio di fronte a noi, proprio dove immaginavamo che dovesse stare il futuro.
È un po’ così che mi sentivo mentre leggevo il tuo Exit Reality, ripercorrendo i momenti della storia dell’internet che sono arrivati per non andarsene mai e che oggi intervengono sul nostro presente di utenti tutti insieme contemporaneamente. Una sensazione che potrebbe seguirci durante questa conversazione su quelli che tu hai chiamato i “paesaggi oltre la soglia”, i luoghi scaturiti dall’inconscio collettivo digitale dell’Occidente, mentre le moltitudini online cercavano di esplorare o esprimere cosa stava succedendo alla cultura, al tempo, all’arte e a loro stessi. Da un lato si ha l’impressione, come racconti, che tutto fosse già presente nella vaporwave. La nostalgia per il paradiso perduto, il clima rassicurante e di ricchezza diffusa degli anni Novanta, la fiducia in un futuro supportato da una nuova tecnologia amichevole e piena di piccole sorprese, tra i panorami “blessati” e gli assistenti buffi delle interfacce Windows che inizia ambiguamente a fallire, a suonare out of pitch, a mostrare messaggi di errore, mentre ci aggrappiamo ossessivamente alle palme, le bolle d’acqua, le cascate, le nuvole, i colori fluo del Frutiger Aero, nella rielaborazione traumatica di tutto quello che abbiamo perso entrando nei maledetti anni Duemiladieci. Dall’altro probabilmente non è una coincidenza che tu ti sia trovata a scrivere questo libro al culmine di una vibe shift preannunciata da eminenti figure dell’internet e del trend forecasting (quali sono Angelicism01 a Sean Monahan del collettivo K-HOLE) e ormai sulla bocca di tutti, mentre il sistema economico e culturale creato dalle piattaforme social e di sharing economy, per come lo avevamo conosciuto, sembra essere giunto al crepuscolo, e collassando finisca per trascinare nel buco nero anche dei pezzi fondamentali della nostra formazione, del nostro modo di rapportarci al mondo, agli altri e quindi a noi stesse.
Che accade nei “paesaggi oltre la soglia”? La dimensione temporale che decretava l’inizio e la fine dei #core esiste ancora? E cosa è successo allo spazio?
Valentina Tanni: Quando sei di fronte a una soglia, in un certo senso il tempo si ferma. Il confine infatti non solo interrompe lo spazio, generando l’esistenza un dentro e un fuori, ma segna anche, potenzialmente, un prima e un dopo. L’ossessione che gli utenti della rete sembrano avere per gli spazi liminali nasce proprio da questo rapporto inscindibile tra tempo e spazio: le stanze spoglie, i corridoi silenziosi e i centri commerciali deserti non sono altro che contenitori del tempo ormai svuotati. Quando il confine è uno schermo, questo nodo spazio-temporale diventa incredibilmente complesso. Abitiamo la rete perlopiù con la nostra mente; mentre esploriamo i “paesaggi oltre la soglia” lasciamo il corpo indietro, a combattere con i formicolii e il mal di schiena. Percepiamo internet come un luogo da sempre (chi si ricorda il cyberspazio?), ma di fatto la nostra esperienza, quando siamo connessi, è incorporea, dislocata, dispersa. Il tempo, invece, tende a distorcersi e contrarsi, come accade in tutte le esperienze “assorbenti”: leggere un libro, guardare un film…
A questo dobbiamo aggiungere un altro fattore, ormai sotto gli occhi di tutti: il fatto di poter recuperare istantaneamente, online, qualsiasi materiale proveniente dal passato, di ogni epoca e cultura, modifica ulteriormente il nostro approccio alla temporalità. Come diceva Daniel Lopatin in un’intervista del 2009, “Non sorprende che molti, tra noi che lavoriamo nel campo delle arti, in quest’epoca informatica si sentano archivisti, antropologi o viaggiatori del tempo. Siamo stati letteralmente dotati di tutto il necessario per viaggiare facilmente attraverso il tempo grazie all’arte e alla scienza”. L’utente di internet oggi è così: un po’ archivista (cerca, scarica, organizza, salva), un po’ antropologo (osserva i comportamenti infinitamente diversificati, ma anche assurdamente simili, di milioni di persone nel mondo), un po’ viaggiatore del tempo (va avanti e indietro nella storia recuperando estetiche visive, mondi sonori, narrazioni e vibe assortite).
Sono d’accordo su quello che dici a proposito della specifica collocazione temporale di questo libro. Non è affatto un caso che mi sia trovata a scriverlo proprio a cavallo tra il 2022 e il 2023. Il concetto di vibe shift è vago ed evanescente, ma se ci pensi è esso stesso una vibe. È la vibe di questi anni, ed è per questo che ne siamo così attratti: la vibe del cambiamento perenne, dell’incertezza come condizione esistenziale, dell’apocalisse come orizzonte permanente. Si avverte, a livello quasi subliminale, l’imminenza di qualcosa, ma nessuno di noi sa tracciare i contorni di questo cambiamento con precisione. Anche internet è diventato improvvisamente un luogo scomodo, strano, difficile; anche per chi, come noi, lo abita stabilmente da decenni. Le immagini simbolo di questo momento storico, che si muove tra distrazione e disperazione, sono i labirinti delle backrooms, i corridoi senza fine degli spazi liminali e le porte spalancate sullo spazio profondo del weirdcore e del dreamcore. Sogni a occhi aperti, incubi giocabili e viaggi fuori dal corpo.
Silvia Dal Dosso: Leggendo Exit Reality ti confesso che ho vissuto una serie ininterrotta di momenti “autoscopici” – tutto a posto, eppure sì: mi è successo più volte, mentre ero su un’amaca o su un telo da spiaggia, di essere vittima di esperienze extracorporee involontarie in cui mi costringevi a scrutare dall’esterno il mio comportamento e quello di tanti altri utenti millennial e Gen Z. Lungo il libro ci si accorge di come, costretti a comunicare attraverso un mezzo limitato, che non ci permette di sentire il respiro o guardarci negli occhi, abbiamo evoluto una sorta di specialismo dei “feels”, cercando di descrivere sensazioni ipercomplesse dandogli dei nomi (come nel da te citato Dictionary of Obscure Sorrows di John Koenig), usando suoni (“A playlist to feel like you etc…”), immagini (core, estetiche) e meme (reaction, character).
È facile notare che le conseguenze dell’avvento dei forum e poi dei social media nelle nostre vite sono incalcolabili, ma si vede anche che la condivisione ci ha portato a scoprire parti estremamente nascoste della nostra individualità. È esemplare il fatto che una sensazione “strana, difficile da definire” come l’ASMR, mai “identificata né studiata dalla scienza ufficiale”, come dici, sia “in pochi anni diventata argomento di conversazione – e spesso un’ossessione – per milioni di persone nel mondo”. Un simile processo di scoperta causa condivisione collettiva e compulsiva è quello che ha fomentato la tulpamanzia, l’arte di creare personaggi immaginari; e poi – come racconti – il Reality Shifting, la pratica spirituale di migrazione in altre realtà finzionali, i cui manuali possono essere trovati ovunque nell’internet. Tutte esperienze che prima non avevano un nome, che erano strettamente personali, di cui si parlava di rado o con nessuno.
Fino a qualche anno fa mi sarei ben guardata dal raccontare a qualcuno che provo un piacevolissimo formicolio alla schiena quando un impiegato delle poste mi spiega qualcosa di moderatamente utile, o che fino a 13 anni ho perso svariate ore dopo la scuola a guardare il soffitto shiftando in mondi inventati in cui ero un’eroina della giungla o la vera e unica protagonista del Truman Show. I millennial come me hanno a lungo taciuto, come moltissimi umani prima di noi, finché non si sono ritrovati online; proprio come racconti quando parli del poolcore, ci siamo resi conto che le nostre esperienze erano molto, troppo, simili tra loro: “in un certo senso tutti abbiamo frequentato la stessa piscina”. L’emozione di far parte di una hivemind che tutto può e tutto conosce è stata bellissima; ma scoprire che tanti sconosciuti avevano vissuto la nostra stessa vita intima e capire che i sacri templi in cui la nostra individualità si è formata erano in realtà il risultato della produzione seriale, della globalizzazione e della società di massa, ci ha turbati, ci ha fatto sentire un non player character in un freddo algoritmo. Per la Gen Z, che in qualche modo ha sempre saputo che l’intimo era condiviso, la situazione è del tutto diversa: forse per loro oggi è più facile creare arte, cultura e esperienze finzionali, tramite processi collettivi?
Valentina Tanni: Questa esperienza di condivisione intima estrema di cui parli, che la rete permette nonostante le sue limitazioni (l’esclusione del corpo e del contatto fisico), secondo me è l’aspetto più affascinante, e allo stesso tempo terrificante, di internet. Sono anni che ne parlo, chi mi conosce lo sa. È una cosa che mi ossessiona. All’inizio degli anni Novanta, Pierre Lévy parlava di intelligenza collettiva, immaginando un futuro in cui questa interconnessione globale continua avrebbe partorito una nuova forma di intelligenza capace di “aumentare” le competenze e le risorse intellettuali. Questa idea si è realizzata, ma in forme impreviste: non potendo selezionare cosa condividere, che genere di idee veicolare, quali competenze potenziare e per quali scopi, abbiamo visto i cervelli e le anime connettersi a ogni livello, per qualsiasi fine e obiettivo concepibile, in qualsiasi modalità attuabile.
Nonostante si continui a paragonare i processori ai cervelli umani, la nostra mente decisamente non è un calcolatore; condividere le risorse umane non equivale a condividere dataset e potenza computazionale. Interconnettendo l’intelligenza umana mettiamo in connessione non soltanto le competenze e le informazioni, ma anche le emozioni, le sensazioni, le intuizioni, le ossessioni, i sogni e le visioni. Questo genere di hivemind estesa è esattamente la “alien life form” di cui parlava David Bowie nell’intervista rilasciata alla BBC nel 1999, citata anche in quarta di copertina di Exit Reality: “Il potenziale di ciò che internet può fare alla società, sia in positivo che in negativo, è inimmaginabile. Non abbiamo visto nemmeno la punta dell’iceberg… Siamo davvero sull’orlo di qualcosa di esaltante e terrificante”, disse al giornalista Jeremy Paxman in un momento di estrema lucidità e prescienza.
Come ipotizzi, certamente il contatto con questa dinamica ha avuto conseguenze diverse nelle varie generazioni. Per la Generazione X e per i Millennials è stato un processo di mutazione, allo stesso tempo esaltante e doloroso, qualcosa che abbiamo dovuto elaborare, comprendere, imparare. Per la Gen Z credo che la consapevolezza di far parte di questo “tutto” sia stata acquisita in maniera più rapida e istintiva. Non so dire se sia un bene o un male, ed è ancora difficile immaginare le conseguenze. Mi auguro che quello che dici sia vero, ossia che la creazione collettiva diventi qualcosa di sempre più naturale e che si “shifti” verso un modello di produzione culturale meno incentrato sulla celebrazione dell’individualità e più profondamente corale.
il corecore è il Let’s Play della vita durante la nostra estinzione
Silvia Dal Dosso: Un altro tema trasversale al libro, che potrebbe colpire molte lettrici e lettori da vicino, è quello del “cervello cronicamente online” e dei contenuti creati per elaborare il trauma di essere costantemente esposti a ulteriori miriadi di contenuti. Parli degli Sludge Content video, che riportano più video all’interno della stessa schermata così da soddisfare le numerose esigenze di spettatori e utenti ormai affetti da ADHD e assetate di multitasking, e parli dei Chaos Edit, ovvero i montaggi dadaisti di altri video e immagini trovati online. Quest’estate, durante una delle mie immersioni di scienza divulgativa su YouTube, notavo come questi tentativi di giustapposizione randomica ricordano l’attività onirica che il nostro cervello compie nella fase non-REM. Quando dormiamo profondamente le memorie della giornata ci appaiono giustapposte in modo velocizzato e senza una consecuzione lineare del tempo. È il nostro cervello che, completamente disinibito e libero dai cosiddetti bias della ragione, cerca di dare un senso ai suoi ricordi, per capire come funziona il mondo.
Un’attività onirica che ritorna nel game design di Therapy (2023) di Harper Shen, “un simulatore di camminata che permette di vagare nei propri sogni e nelle proprie illusioni” che tu giustamente accosti a LSD Dream Emulator (1998) di Osamu Sato, il primo gioco di esplorazione e giustapposizione di scenari senza obiettivi. I videogiochi in ambito esplorativo e weird usciti dal 2015 in poi sono quasi tutti bellissimi (tu citi Yume Nikki del 2004 e io aggiungo Undertale del 2015 e Hypnospace Outlaw del 2019), ma se in molti ancora è possibile vivere un’avventura da player character, in Therapy l’interazione è negata. Chi gioca può solo muoversi nello spazio e guardare, come in sogno o come su Tumblr: ci si trova a esplorare i ricordi di un’altra persona, che ancora una volta coincidono in modo perturbante con i propri. Non è un caso che Therapy, espressione del Traumacore, assomigli moltissimo a un Let’s Play, i video in cui si guardano giocare gli altri. Forse allora i Chaos Edit sono i Let’s Play di internet, e il corecore è il Let’s Play della vita durante la nostra estinzione. Cosa sta succedendo alla capacità di scelta e all’agency della mente online? L’interattività si è trasformata in zapping o siamo arrivate all’immobilità del Nirvana, dove le quattro nobili verità sono ormai rivelate, e ci troviamo in un nuovo stato di “suprema consapevolezza dei contenuti” (lol)?
Valentina Tanni: Il corecore è il punto in cui lo stesso concetto di core collassa su se stesso e si rivela per ciò che è davvero. La sua comparsa era inevitabile. Quando ho visto per la prima volta l’hashtag su TikTok ho pensato: “ma certo”. Perché alla fine, se ci pensi, nelle estetiche è il suffisso che conta, non il prefisso. Il prefisso è intercambiabile, ci puoi mettere qualsiasi cosa. Mentre il suffisso determina l’approccio, l’intenzione, l’attitudine. Core come volontà di estrarre il cuore delle cose, ricercando la loro energia primigenia; ma anche core come ossessione, ripetizione, esagerazione. Mi piace questa idea dei Chaos Edits come Let’s Play di internet: magari è un modo per immaginarsi dentro la mente di qualcun altro, navigando “passivamente” attraverso i suoi occhi. Per poi rendersi conto, mentre lo si fa, che in fondo la navigazione degli altri non è poi così diversa dalla nostra.
Riguardo lo zapping e il Nirvana (lol): l’interattività è stata ingenuamente celebrata per decenni, talmente tanto da farci vivere la partecipazione come un dovere (l’ennesimo). Forse è una delle tante cose che dovremmo ripensare in questo momento storico.
Silvia Dal Dosso: Nel libro parli di strategie di adattamento a una realtà impermanente, passando dal Reality Shifting al meme Everything is a Cake e accennando alla Dead Internet Theory, secondo cui gli umani hanno smesso di esistere nell’internet nel 2016, per lasciare il passo a bot e entità artificiali. Dopo anni di targetizzazione emotiva e fake news, troll farm e circhi di Vladislav, deepfake e complotti strumentalizzati dalla propaganda, non solo ci troviamo in uno stato di sospetto permanente, ma l’adattamento ci ha portato a muoverci da un universo finzionale all’altro come se il mondo online fosse un gigantesco LARP che dilaga nelle nostre vite quotidiane. Abbiamo accolto il falso nelle nostre case, come si fa con un brutto souvenir regalato dalla nonna, o il calendario di una rosticceria cinese. Ma il falso online è appiccicoso e, se vogliamo tenerlo a bada, la modalità passiva del Let’s Play potrebbe essere una trappola; i creativi dell’internet sembrano per ora aver reagito in altri modi, spesso sfruttando l’aspetto memetico, strano e cursed delle prime rudimentali AI Generative (su questo rimando al saggio introduttivo su Iconografie di settembre e al video articolo The Future Will Be Weird As Fuck). Nei tuoi viaggi online, tu che sai ancora surfare come si faceva nell’1.0, cosa hai visto accadere a chi crea o cronicamente abita in un mondo dove tutto potrebbe essere falso? E che ruolo assumono nella mischia le AI Generative?
creare – ma anche soltanto esistere – in un mondo dove tutto potrebbe essere falso (ma anche generato da un bot) è una condizione esistenziale nuova
Valentina Tanni: È sempre più difficile “surfare come si faceva nell’1.0”, perché internet non è più quello del 1998, e nemmeno quello del 2006. L’oceano da attraversare è molto più vasto e tumultuoso; i messaggi sono difficili da decifrare; trovare porti sicuri è un’eventualità remota. Più si cerca di evitare le rotte prestabilite, più si avverte la potenza della corrente del mainstream. Piattaforme social, adv targhettizzato, selezione dei contenuti algoritmica: tutto tende a riportarci nella corrente principale, quella che ci rincoglionisce e ci omologa. Nonostante tutto, io ci provo sempre, è la mia forma di resistenza.
Per rispondere alla tua domanda: creare – ma anche soltanto esistere – in un mondo dove tutto potrebbe essere falso (ma anche generato da un bot) è una condizione esistenziale nuova. Le risposte a questa situazione non potrebbero essere più diversificate: vedo persone che non si rendono minimamente conto del cambiamento e continuano a prendere (più o meno) tutto per buono; vedo persone che si sono convertite allo scetticismo e lo praticano come una religione; vedo anche persone che si divertono un sacco a giocare con i piani del vero, del falso e del verosimile, inventando estetiche e modalità espressive. Come il souvenir brutto della nonna, alla fine un po’ ci piace, anche se ci vergogniamo a dirlo.
Le AI generative sono una specie di pozzo senza fondo: quando le usiamo di fronte a noi si spalanca uno spazio infinito: la vertigine della combinatoria, i percorsi potenzialmente inarrestabili della generazione automatica. Anche lì, siamo su una soglia; al di là c’è la sostanza sconosciuta e appiccicosa dello spazio latente.
In collaborazione con Aksioma, questa conversazione è stata tradotta in inglese e sloveno nel contesto della collana di saggi PostScriptUM. Questa collaborazione è avvenuta all’interno del progetto .expub.
L’intervista che state per leggere è un’introduzione, un primo ingresso possibile, dentro quel che, sulle prime, potremmo definire l’inconscio dei nostri tempi. È un incontro con Erik Davis – l’autore di un libro memorabile come Techgnosis (che ora Not ripubblica in una nuova traduzione e in un’edizione ampliata) – avvenuto in un certo senso al di là dello specchio, al di là della soglia di ciò che vediamo accadere ogni giorno e che prende le forme del mondo disegnato dalle tecnologie digitali. È l’approccio che qui mi sembra decisivo: possiamo affrontare le manifestazioni esterne della realtà corrente per quel che sono (ed è ciò che la ragionevolezza ci spinge a fare con i risultati spesso inconcludenti che ci regala il gioco delle apparenze) oppure possiamo guardarle da dietro, fotografandone il negativo, scendendo oltre il limite che separa il visibile dall’invisibile. Erik Davis abita questa zona di confine.
Con Techgnosis ci hai insegnato – e ci insegni – a leggere le tecnologie digitali come forme in cui continuano a manifestarsi modelli sapienziali e tradizioni spirituali. Che cosa significa adottare questo approccio? E qual è l’impatto politico di una visione di questo tipo?
Ci sono tre ragioni principali per cui ho esplorato questo approccio quando ho iniziato a fare ricerche sul progetto Techgnosis negli anni Novanta. Una è semplicemente che, nonostante le prove di questa profonda connessione fossero ovunque, nessuno ne parlava, per lo meno al di fuori della fantascienza cyberpunk. Un’altra è che, mentre in quell’epoca alcune persone rendevano omaggio a Marshall McLuhan a parole, io ritenevo che il suo lavoro e il suo approccio potessero essere aggiornati e rivitalizzati se la coscienza spirituale che, a mio parere, aveva contribuito a plasmare il suo lavoro potesse essere portata avanti in forme più specificamente religiose ed esoteriche.
Infine, ero convinto che le tradizioni spirituali e l’occultismo fungano da subconscio della tecnologia e che qualsiasi tipo di movimento liberatorio, personale o sociale, richieda di portare alla luce questi schemi profondi. Un impatto politico diretto di questo approccio è stato quello di rivelare i modelli religiosi e persino apocalittici che guidavano le opinioni apparentemente razionali e orientate al business della Silicon Valley. Techgnosis ha aiutato a de-naturalizzare tutto questo.
La mia impressione è che le tecnologie digitali mettano all’opera una sorta di voodoo digitale. Nel momento in cui ciascuna e ciascuno di noi forniamo i nostri dati alla struttura algoritmica che ci governa, si crea un doppio digitale di noi stessi. Ed è su questo doppio digitale che la struttura algoritmica poi agisce per controllare, sorvegliare e infine dirigere i nostri comportamenti. Che cosa ci può insegnare il grande mito del doppio all’interno di questo nuovo capitalismo della sorveglianza?
Penso che il doppio sia fondamentale e che sia operativo anche a livello psicologico. Se il rapporto con il doppio è rappresentato dal perturbante (uncanny), allora le nostre interazioni online e i nostri movimenti nello spazio dell’informazione sono per natura sempre più perturbanti. Qui l’ultimo libro di Naomi Klein, Doppelganger, è particolarmente brillante. Non solo sottolinea tutto ciò che dici sui nostri doppi digitali, ma analizza anche come gran parte della nostra politica di polarizzazione funzioni lungo linee mimetiche o raddoppiate, in modo che il linguaggio e le immagini che guidano un determinato gruppo vengano riprodotti, ma leggermente alterati nel tempo.
“Fake news” è originariamente un termine degli attivisti liberali di sinistra nato per sostenere migliori pratiche di informazione, ma poi diventa un termine nella mente di Donald Trump. Questo parallelismo aiuta a spiegare la vibrazione inquietante, uncanny, di gran parte della nostra politica, quando i nostri punti di riferimento familiari passano attraverso una sorta di specchio deformante. L’intelligenza artificiale e l’emergente ecologia dei bot intensificheranno spaventosamente tutto questo.
Un grande studioso della tradizione mistica islamica, Henry Corbin, sosteneva che la scomparsa dell’immaginazione rappresentava una catastrofe dello spirito. Per Corbin, infatti, l’immaginazione è quella facoltà che sta in mezzo, tra i sensi e l’intelletto astratto; nell’immaginazione ciò che è concreto, cioè la percezione sensibile della realtà, si astrae e, nello stesso tempo, ciò che è astratto, cioè il nostro pensiero logico, si concretizza prendendo una forma visualizzabile. L’immaginazione è insomma quel luogo tecnicamente magico in cui s’incontrano il Cielo e la Terra, il concreto e l’astratto; è l’asse del mondo. Le tecnologie digitali, muovendosi tra astrazione algoritmica e concretezza delle nostre vite non stanno sostituendo e parodiando l’immaginazione? E con quali conseguenze, secondo te?
La teoria di Corbin è in un certo senso una teoria della mediazione. Ma il suo uso del linguaggio era importante. Per Corbin, l’immaginazione genuina, incarnata dalle essenze spirituali, era “l’Immaginale”. Ma l’Immaginale era già ombreggiato dalla sua stessa parodia: mera immaginazione, o fantasia, come quella che la nostra mente fa quando vaga o che i cattivi poeti seguono quando scrivono versi stereotipati. Coleridge fece una distinzione simile anche nella sua concezione kantiana dell’immaginazione, che fu incredibilmente influente sul Romanticismo anglofono. Questo è importante perché se da un lato possiamo giustamente criticare le tecnologie digitali come parodie o parassiti dell’immaginazione genuina, dall’altro l’immaginazione umana è già divisa su questa linea, tra vere mediazioni spirituali e pretendenti corrotti o dionisiaci. (Il problema dei simulacri risale a Platone).
Anche le forme mediatiche più antiche, la pittura e la scrittura, mediano tra astrazione e realtà concreta in modi che riflettono e usurpano il nostro senso di immaginazione “integrato”. Detto questo, qualcosa di veramente diverso è in atto, soprattutto con l’IA che sta trasformando l’arte dell’illustrazione (tralasciando se le sue illustrazioni contino o meno come “arte”). Parte dell’inquietudine di Midjourney e simili è che percepiamo che gli algoritmi e gli insiemi di dati stanno colonizzando non solo il nostro inconscio, ma la stessa facoltà di immaginazione. Ma quando gli artisti usano i nuovi strumenti per plasmare e sfrondare in modi ingegnosi, non sta forse accadendo qualcosa di diverso, qualcosa di più “cyborg” che parassitario?
La storia delle tecnologie digitali si è sempre mossa tra due opposti: da una parte la sua origine militare e dall’altra la sua origine libertaria. Internet è infatti figlia sia dell’esercito sia della cultura psichedelica. Tu hai riflettuto molto sulla psichedelia e tra poco uscirà un tuo libro sulla blotter art, cioè su quelle opere d’arte stampate su carta assorbente e divise in francobollini impregnati di LSD. Oggi noi sappiamo che le medicine psichedeliche possono temporaneamente disorganizzare il nostro cervello e liberare i nostri pensieri e i nostri sentimenti dagli schemi che ci condizionano. La psichedelia può riscattare e liberare le tecnologie? In che misura ritornare alla psichedelia, e quindi a una delle fonti della nascita di internet, può contrastare il controllo e la sorveglianza che invece, come dicevamo, caratterizzano la pervasività delle tecnologie digitali?
Da un lato, è giusto vedere gli psichedelici come un contrappeso alle tecnologie e alle esperienze digitali. Esse possono attirare le persone nella natura, al di fuori dei normali schemi di pensiero e di reazione, in nuove e antiche cosmovisioni e in formidabili sommovimenti di rinnovamento. D’altro canto, però, si assiste alla convergenza tra le tecnologie digitali e la nuova cultura psichedelica: app che fanno il lavoro di “integrazione”, nuovi mondi in VR che simulano la fenomenologia psichedelica e nuove ideologie che fondono il transumanesimo psichedelico con modelli straordinariamente antidemocratici e reazionari del futuro tecnologico. Si tratta quindi di un’altra situazione ambigua.
Detto questo, gli psichedelici possono svolgere un importante ruolo liberatorio, consentendo nuove forme di plasticità e di riorganizzazione degli schemi, insieme alla loro capacità di aprire percezioni transpersonali e animiste che offrono la possibilità di trasformare il nostro rapporto con il mondo e la natura in un momento in cui tale rapporto sta per cambiare, forse radicalmente, che lo vogliamo o no. Nelle giuste circostanze, gli psichedelici possono far emergere nuove forme di socialità e di comunità. Ma anche se non facessero altro che attenuare lo stress, il trauma e l’ansia della nostra situazione globale, permettendo alle persone di abituarsi alle transizioni radicali che stanno avvenendo nel loro contesto e nella loro coscienza, allora starebbero facendo qualcosa di buono.

Non corriamo il rischio che lo stesso “rinascimento psichedelico”, un po’ come internet, diventi una forma di sfruttamento, e quindi di profanazione, della grande tradizione sapienziale e mistica? Mi spiego: l’esperienza psichedelica, il contatto mistico, sono ciò che dà forma alla filosofia perenne dell’umanità. Il fatto che di questa conoscenza se ne approprino invece le industrie farmaceutiche, l’interesse economico, facendo precipitare questi insegnamenti sacri in una cornice intellettuale utilitaristica, che rischio rappresenta? Insomma, dobbiamo sperare nel Rinascimento psichedelico o dobbiamo temerlo? Non ti nascondo che io propendo per la seconda impressione.
Sono profondamente preoccupato per le possibilità che descrivi. Il tentativo di medicalizzare queste sostanze le integra nel sistema patologico esistente. E mentre molti sperano che gli psichedelici si rivelino una panacea, l’antropologia medica e l’aneddotica suggeriscono anche che questa è una fase breve, che sarà probabilmente seguita da un quadro più complesso della loro efficacia per le difficoltà psicologiche. L’utilitarismo che temi diventerà più che altro un “set and setting” per le persone, con il rischio concreto di prosciugare il potenziale sacro e transpersonale delle esperienze psichedeliche o, forse ancora peggio, di ridurlo a fuochi d’artificio neurali privi di significato lungo la strada del cambiamento cerebrale, diluendo così una delle importanti caratteristiche degli psichedelici: la loro sfida ai nostri sistemi di significato.
Almeno in America, c’è anche un robusto dibattito sulle forme, nuove e tradizionali, di religione e spiritualità psichedelica e su come dovrebbero essere trattate con il giusto rispetto dalla nostra società. Rispetto a un modello puramente medico/capitalista, questo offre un contrappeso in qualche misura più transpersonale che vale la pena seguire e persino sostenere, anche se solleva a sua volta altri problemi. In tutti i casi, il ruolo della guida/leader/terapeuta/sciamano sarà problematico, e lo sarà sempre di più man mano che un numero maggiore di persone si precipiterà sia a “guidare”, sia ad essere “guidato”. Potremmo aver bisogno di esplorare modelli più collettivi e peer-to-peer, poiché il lavoro di gruppo potrebbe aiutare a creare connessioni personali e sensibilità collettiva che potrebbero arginare l’individualismo che ora domina il modello della guarigione psichedelica.
Illustrazioni di Pedro Friedeberg
Notcore è il nuovo programma di Not su Radio Raheem. Ogni mese un’incursione oltre la soglia in compagnia di ospiti, musiche e voci provenienti dalle migliori backrooms della Notsfera: 60 minuti di transtopie a base di filosofia, politica, fantascienza, culture pop, catastrofi da temere e altre da invocare…
Ascolta di seguito i primi cinque episodi:
NOTCORE # 1: TECNOCINA ARRIVES FROM THE FUTURE
Distopie hi tech, sorveglianza via app, tattiche di resistenza urbana e locali queer della Mongolia Interna: un andata-e-ritorno tra la Cina e le nostre percezioni (distorte?) del “gigante asiatico” in compagnia di Simone Pieranni e con le voci di Momoka Banana, Ilenia Caleo e Mattia Salvia.
NOTCORE#2: HACKERS, MATRICI E KETAMINA
Cyberpunk is not dead: conversazione con lo scrittore Tommaso Pincio, che ha da poco (ri)tradotto il classico “Neuromante” di William Gibson, a proposito di intelligenze artificiali, pensiero tecno-gnostico, allucinazioni consensuali, fantascienza e magia (nera), con le voci di Valentina Tanni e Raffaele Alberto Ventura.
NOTCORE #3: ECOTEPPISMO CONTRO LA CATASTROFE
Il peggio deve ancora venire: il collasso ambientale è ormai inevitabile e i movimenti che si battono per la giustizia climatica vengono criminalizzati e silenziati. E allora come prepararsi all’apocalisse imminente? Può esistere un “survivalismo di sinistra”? Di ecoattivismo, bunker in Finlandia, vendetta e barricate parliamo con Diletta Bellotti, Matteo De Giuli e Stella Succi.
NOTCORE #4: IL SUONO DEL MALE
Serial killer, membra sventrate, presenze demoniache, corpi mostruosi, stanze sul retro… Viaggio nell’orrore in tutte le sue forme in compagnia dell’unico e solo Master of Pain, il king del death rap Metal Carter. Feat. Simone Sauza ed Elvira Del Guercio, con la partecipazione fantasma del disturbatore Riccardo Papacci.
NOTCORE #5: TERRORISMO BIANCO
Perché il terrorismo di estrema destra non viene mai considerato un’emergenza? E in che modo le narrazioni impiegate dalla destra mainstream ne preparano il terreno? Di suprematismi, fascismi e lupi solitari parliamo con Leonardo Bianchi, autore del recente Le prime gocce della tempesta, e con la partecipazione di Eddi Marcucci e Valerio Renzi.
Il 2030 è alle porte, la fine del mondo è ormai certa, le profezie sul collasso si vanno avverando una dietro l’altra, eppure i vecchi vizi restano. Per esempio: i commentatori di destra e del mondo fascioconservatore non smettono di ricorrere all’epiteto “radical chic” come forma di insulto rivolto a una generica intellighenzia progressista diretta filiazione del cosiddetto ceto medio riflessivo.
Bene, già che l’Apocalisse è prossima, ribadiamolo una volta per tutte: questo è offensivo per qualsiasi vero radicale e per qualsiasi autentica persona chic.
Anni e anzi decenni di cortine fumogene partorite ad arte dai nemici del bello e dell’eleganza ci costringono infine a ribadirlo: cosa mai avrebbero di radicale, questi pavidi frequentatori di saloni del libro il cui picco di trasgressione è rappresentato da uno spritz Campari anziché Aperol? Cos’hanno di chic, questi lettori di trashame tipo le pagine culturali del Foglio la cui realizzazione si misura dal numero di Adelphi ordinatamente disposti per colore sugli scaffali?
con la sfiga non vogliamo avere niente a che fare – già siamo costretti a subirne troppa in questa congiura contro il buongusto che è il mondo
È chiaro come tutte le accuse che vengono rivolte a queste grottesche macchiette dell’ortodossia liberal il cui political compass oscilla tra Jovanotti e Marco Pannella siano drammaticamente vere – a pazienza se, pronunciate da fogne a cielo aperto quali Libero o La Verità (viene da cercare un collutorio solo a pronunciare il nome) perdono qualsiasi consistenza e viene quasi da parteggiare per loro. Ma il vero Radicale e il vero Chic non ammette pietà alcuna: nostro obiettivo qui è riaffermare la distanza incolmabile che separa la classe dalla sfiga, perché noi con la sfiga non vogliamo avere niente a che fare – già siamo costretti a subirne troppa in questa congiura contro il buongusto che è il mondo, di cui non possiamo che salutare con gioia la fine imminente.
E allora, cosa sarebbe mai la fantomatica “sinistra radical chic” di cui blaterano gli scoreggioni “dissidenti” per i quali il top della provocazione è scopiazzare monnezza vecchia di un secolo tipo Papini e Marinetti? A definirla, pare di capire, non è tanto un atteggiamento politico più moscio di un discorso di fine anno di Mattarella, quanto una serie di… chiamiamoli consumi che anche noi purtroppo abbiamo imparato a conoscere bene: leggono libri, organizzano “incontri”, mangiano in ristoranti arredati in ferro battuto in cui servono vini biologici, e poi… boh, e poi nient’altro.

Bene, questa gente ahimé esiste davvero, non saremo noi qui a negarlo. Solo che i libri che leggono fanno cagare, i (costosissimi) ristoranti che frequentano servono cibo di merda, il vino bio di cui decantano le qualità balsamiche è a tutti gli effetti indistinguibile da un balsamo (per capelli) e in generale il loro gusto estetico, in un’ipotetica scala Petronio da uno a dieci, precipita direttamente nella misteriosa landa transdimensionale dei numeri negativi.
Dove sta la radicalità, dove sta la chiccheria? Chiamiamoli moderat-kitsch, piuttosto.
Diamogli il nome che meritano e mandiamoli a fare in culo dove preferiscono, magari in qualche fiera dell’editoria dove avranno modo di confrontarsi con le loro fascio-controparti perché “lo scambio di opinioni è il sale della democrazia” (è gente cresciuta a Slow Food ma che a quanto pare non sa dosare le spezie).
E allora: i moderat-kitsch se ne stiano pure nelle loro riserve chiamate Isola, Porta Venezia, Esquilino, Monti, convinti che il mondo si arresti ai pochi isolati che chiamano “città”, nella bislacca allucinazione di vivere in una copia di serie B della noiosissima Manhattan a suo tempo dipinta da Maestri Indiscussi del Cringe tipo Woody Allen. Il vero Radical Chic sa che è oltre le circonvallazioni, le tangenziali e i raccordi anulari che sta il divertimento, la droga migliore e soprattutto LO STILE, e quando tra dieci anni vedremo le tech Nike persino sulle passerelle di un premio Strega a caso, allora vestiremo già di nuovi tessuti, perché il moderat-kitsch insegue (male), il Radical Chic è avanti.
Vestiti come da catalogo H&M del 2006, i moderat-kitsch citano a memoria romanzieri americani anni Novanta, cantautori folk a cui nessuno ha apparentemente spiegato l’esistenza dell’autotune, e ancora pensano che Shiva sia il nome di una divinità indù. Per il vero Radical Chic, invece, l’unico Dylan degno di appartenere al pantheon degli Anziani è quello che di cognome fa Dog, e in onore di Shiva (libero!) l’autotune ce lo siamo fatti direttamente impiantare nelle corde vocali così neanche avremo più bisogno di un abbonamento Spotify – anche perché l’abbonamento lo paghi e, come ogni vero Radicale sa, non c’è niente di meno Chic che il denaro (e tutto quello che serve a procurarselo, a cominciare dal lavoro – bleah).
Cosmopoliti quanto può esserlo un don Buro in gita ai giardinetti centrali, i moderat-kitsch sproloquiano di inclusività e “confronto tra culture” non tanto per mettersi la coscienza apposto con la donna delle puliz… collaboratrice domestica dello Sri Lanka, quanto perché pensano che il “confronto tra culture” significhi saper distinguere tra un borek e un samosa (che comunque confondono). La loro idea di “multiculturalità” è presto detta: più ristoranti vietnamiti, peruviani, coreani, più qualsiasi altro paese sufficientemente “etnico” (…) di cui in altri tempi è stata pubblicata una guida Lonely Planet.
Ma al contempo niente batte la bellezza delle campagne senesi, la nostra cultura teniamocela stretta e nessuno tocchi le Langhe di Pavese e Fenoglio. Il vero Radical Chic invece tifa Sostituzione Etnica Subito, se davvero esistesse un piano Kalergi sarebbe il primo a firmarlo, tutto pur di trasformare ogni singolo quartiere gentrificato in un suq dove almeno gira roba di qualità e non c’è rischio di imbattersi in espressioni dozzinali tipo “graphic novel” – e già che ci siamo solo giornaletti sui nostri scaffali, o più che sui nostri scaffali nei nostri cessi, perché da sempre è il cesso l’unico e vero Tempio del Piacere, a cominciare da quello Anale.
I moderat-kitsch sono più ignoranti di un Paolo Mieli a caso e intanto rompono le palle con argomenti triviali tipo “i libri”, usano espressioni volgari come “dialogo”, difendono valori rozzi quali “l’impegno”, se gli chiedi dove si compra la droga non sanno risponderti e intanto pretendono pure di esporre il loro “punto di vista”, hanno gusti mediocri, non sono divertenti – non sono Radicali, non sono Chic.
E allora perché attribuirgli qualità che non meritano, insignirli di titoli di cui non sono degni, promuoverli a esempio di un modello per loro irraggiungibile? Questo è l’ennesimo gioco sporco dei nemici dell’eleganza e dello stile, un’astuta contorsione logico-linguistica che, blandendo con epiteti tanto nobili i loro cosiddetti “avversari”, altro non fa che confermare la storica collusione fascioliberal all’insegna della lotta al bello.
Così parla un vero Radical Chic.
Basta, boh, che altro dire, abbiamo finito: andate affanculo, sfigati!
Le tecnologie riproduttive incidono sul corpo delle donne in maniera radicale e decisiva. Il pensiero femminista si è fin da subito interessato del loro potenziale emancipatorio senza, però, tralasciarne le criticità, chiedendosi se, effettivamente, la tecnologia favorisca o assoggetti il corpo delle donne e la loro piena autonomia decisionale. Queste nuove tecnologie hanno rappresentato – e tuttora lo fanno, se ne consideriamo la progressiva evoluzione – una sfida senz’altro non indifferente per l’esperienza delle donne. Esse vanno a recidere il legame tra procreazione e sessualità, manipolano i corpi e li assoggettano a un controllo farmacologico da cui spesso è difficile uscire, consegnano alla medicina il controllo dei processi riproduttivi. La domanda intorno a quale ha ruotato il dibattito dalla seconda metà del Novecento in poi, andando a diversificarsi in relazione ai vari contesti d’uso, è la seguente: le tecnologie della riproduzione sono uno strumento dell’autodeterminazione femminile o dell’espansione di un nuovo patriarcato che si afferma attraverso l’interconnessione di scienza, medicina e mercato?
Se è vero che, specialmente negli ultimi anni, l’audiovisivo ha inteso efficacemente come intercettare l’agenda politica e culturale del presente, le riflessioni relative al corpo delle donne e a come quest’ultimo venga attraversato, re-immaginato e ridefinito dalla tecnica ne fanno ugualmente parte, costituendone, anzi, parte fondamentale. A questo proposito, pochi prodotti audiovisivi hanno saputo dialogare così bene con ciò che più anima determinate correnti della riflessione femminista sulla relazione tra corpo e tecnica come Dead Ringers, che rappresenta un unicum nel panorama cinematografico e seriale, riportando agli spettatori la realtà di situazioni che le donne abitano quotidianamente. La serie tv reboot di Alice Birch – tratta dall’omonimo film di David Cronenberg – elabora concetti complessi quali autodeterminazione femminile e controllo sul proprio corpo, immaginando, seppure in una cornice horror-distopica, un futuro in cui le donne potranno liberarsi dalla tirannia della procreazione.
In Metamorfosi. Verso una teoria materialista del divenire, la filosofa Rosi Braidotti sostiene che il soggetto è formato da desideri inconsci e che questi si coniugano con un processo diveniente. Il processo di “divenire donna”, in questo caso, ne ri-configura la soggettività in un percorso di lento distacco da un sistema di codici e strutture che avviene nello sviluppo di un corpo. La teoria e critica femminista circa la nozione di corpo, corpo femminile, queer etc. è ingente e non è questa la sede in cui se ne discuterà; ho ritenuto interessante, tuttavia, partire da Braidotti e dal concetto di “processo diveniente” proprio per capire in che modo, questo divenire-del-corpo-femminile si scontra con il momento in cui la tecnologia ne entra a far parte, “proiettando un nuovo sguardo all’interno del corpo”, come ha scritto Laura Tripaldi in Gender tech. Come la tecnologia controlla il corpo delle donne.
Con queste tecnologie, dunque, a cambiare è il modo con cui siamo solite guardare il nostro corpo e, specialmente, dentro di esso. Definiscono, al pari dei dispositivi di visione che dalla prima metà del Novecento in poi hanno radicalmente modificato il rapporto uomo-immagine nello spazio, come il Kaiserpanorama berlinese o il Diorama di Louis Daguerre, uno dei nuovi regimi scopici del mondo contemporaneo. I regimi scopici rappresentano ciò che entra in fibrillazione, si modifica e varia, quando i comportamenti che riguardano le immagini, nell’accezione più ampia che si può dare a questo universo fatto di figure, media e pratiche sociali cambiano, proprio per le profonde modificazioni antropologiche che le nuove tecnologie comportano. E il corpo è al centro di questo cambiamento.
Lo studio del corpo femminile è anche ciò da cui partono le due sorelle ginecologhe protagoniste di Dead Ringers e l’immagine – anche memore della “lezione” dell’omonimo film degli anni Ottanta, dove la corporeità riplasmata, duttile e a tratti mostruosa è il punto d’incontro del percorso esistenziale dei due gemelli – ne restituisce tutta l’urgenza. A partire dalla sequenza iniziale dove la narrazione di un momento in apparenza così idilliaco come la nascita si scontra con un gusto specifico dove a prevalere è la dimensione estetica del disgusto. L’insistenza sul particolare della testa del neonato che esce dalla vulva delle partorienti, insieme alle urla di dolore prolungate delle donne che fanno da colonna sonora a queste programmatiche immagini iniziali, sembrano voler collocare la serie tv in un sottogenere, che è quello del body horror; gli amanti del genere e del suo capostipite rimarranno, tuttavia, delusi, perché la regista Alice Birch ha intenzione di parodizzare l’horror di riferimento, facendone emergere delle figurazioni e immagini, senza farne il perno del suo discorso estetico e narrativo.
La trama è semplice: due gemelle – antitetiche, come in David Cronenberg – che condividono la vita prenatale in un medesimo utero, una volta adulte, cominciano a investigare sempre di più la ginecologia e tutto ciò che riguarda la riproduzione. L’intenzione è di distaccarsi dal modello di Cronenberg tematizzando diversamente un analogo discorso sul corpo. Nel caso di Birch, il corpo femminile viene guardato a partire dalla lente delle tecnologie della riproduzione, che ne deformano e reinventano l’immagine e l’idea codificate nel tempo. L’idea di fondare una clinica medica adibita alle sole nascite per proteggere le donne dai potenziali rischi cui sono sottoposte negli ospedali, nella prospettiva di una delle due sorelle, Beverly, finisce per scontrarsi con l’ambizione (malsana) smodata dell’altra, Elly, di farne cioè un laboratorio di sperimentazione sul corpo attraverso la tecnica.
La risposta del pensiero femminista ai nuovi protocolli di visione del corpo è stata varia, partendo dal presupposto fondamentale che se, da un lato hanno permesso alle donne di acquisire sempre maggiore conoscenza sui propri corpi e sulla propria salute riproduttiva, d’altra parte hanno anche contribuito a rafforzare vecchie e nuove forme di oppressione. Il medesimo dualismo interpretativo si può applicare al discorso che riguarda alle cosiddette “tecnologie di genere”, per riprendere l’espressione di Tripaldi, ambigue e oltremodo complesse: agiscono e inter-agiscono con il corpo delle donne in maniera elusiva e nel rispondere a determinate esigenze e rivendicazioni, non nascondono la loro problematicità. Dead Ringers esplora il desiderio di maternità di alcune donne reso impossibile per impedimenti fisico-genetica, oppure l’esigenza di ritardare il proprio orologio biologico, come si evince quando una delle pazienti della clinica chiede a Elly cosa potrebbe succedere se le venisse impiantato il tessuto ovarico di una venticinquenne. La risposta Elly afferma di non averla ancora essendo comunque una delle idee che intende esplorare nel tempo.
Tra le due sorelle si manifesta un cortocircuito non indifferente quando devono affrontare casi di fecondazione assistita o gestazione per altri. Sotto un profilo concettuale, è utile distinguere tra gestazione per altri intesa in senso tradizionale nella quale la donna che partorisce il bambino per un o una committente fornisce anche l’ovocita e quella gestazionale, in cui l’ovocita è fornito dalla donna committente o da una terza donna donatrice, mentre il gamete maschile può essere fornito dall’uomo della coppia committente o da un terzo donatore. Queste distinzioni sono necessarie perché non è più possibile associare, almeno sotto il profilo biologico e genetico, la gravidanza alla maternità, anche se nella legislazione italiana questa distinzione – data per assodata dalla gran parte dell’opinione pubblica – è ancora dibattuta.
Il contrasto che emerge dalle riflessioni sul tema è tra il diritto alla riproduzione da un lato – specialmente per quanto riguarda coppie omogenitoriali – e la perpetuazione del privilegio di classe ed economico dall’altro. La scena di Dead Ringers che meglio illustra questa contraddizione è la seguente. Elly e Beverly stanno visitando una madre surrogata insieme alla committente che ne ispeziona il lavoro con il fare austero e algido da imprenditrice. Il bambino è podalico, Beverly deve impegnarsi in una delicata manovra di spostamento manuale della testa del feto, esercitando una leggera pressione sul ventre della donna. Prima chiede il permesso alla paziente, rispondono sia la partoriente che la madre committente, anche se il corpo, come sostiene più volte Beverly, è quello della donna sdraiata sul lettino. Non contenta, la madre committente afferma di voler, a distanza molto ravvicinata dal parto prossimo, il quinto bambino, non provando neanche a immaginare gli impedimenti fisici di una richiesta – che suonava più come un’imposizione – del genere oltre che i rischi per la salute della partoriente. A lei però non importava, perché voleva un altro figlio e lo voleva “comprare” subito.
A questo, proposito, la critica mossa al capitalismo di aver reso i corpi delle donne partorienti in macchine riproduttive è fin dalla seconda ondata centrale nella speculazione femminista. Ad esempio, in Outcast Mothers and Surrogates: Racism and Reproductive Politics in the Nineties, Angela Davis parla dello stato attuale della maternità che rispecchia, in vari modi, modelli passati di servitù e schiavitù, collegando la maternità surrogata alla schiavitù nel contesto attuale. Discute delle politiche riproduttive del tempo e fa un parallelismo tra la mercificazione delle capacità riproduttive di una serva/schiava (come balie, tate) e la pratica crescente delle capacità riproduttive delle donne appartenenti a minoranze contemporanee per la maternità surrogata. Davis spiega che non solo ci si aspettava che le donne schiave riprodussero frequentemente bambini neri in modo che i loro padroni bianchi potessero venderli come merce, ma anche che le donne schiave facessero da madri per i bambini bianchi del padrone. La madre schiava avrebbe dovuto fare da madre ad altri bambini, invece dei propri, che erano affidati alla cura di altri o venduti a scopo di lucro: lavoro riproduttivo e di cura. Davis nota, quindi, che solo i ricchi e i privilegiati potevano al tempo permettersi di esternalizzare la gravidanza e che ciò ha portato allo sfruttamento dei corpi delle donne appartenenti a minoranze.
La gestazione per altri era e resta un tema complesso, che va interrogato a fondo, nel rispetto delle esperienze e delle scelte dei singoli e delle singole, senza aver paura di problematizzare e porre delle questioni radicali. L’idea che in Italia e altri paesi del mondo sia una pratica passibile di reato fa venire i brividi soprattutto perché la politica conservatrice ha capito come strumentalizzare il dibattito e portare a proprio favore determinate argomentazioni. Espressioni come “turismo riproduttivo” o “assuefazione culturale” esposte dai programmi delle destre testimoniano di una miopia fondamentalista e reazionaria per cui la politica evita, sostanzialmente, di radicarsi a fondo nel problema, in nome di un mantenimento dello status quo in relazione, soprattutto, alla visione biologico-determinista della famiglia.
A essere in gioco ci sono questioni che riguardano i diritti riproduttivi e l’autodeterminazione femminile, così come la possibilità di scegliere sul proprio corpo ed esserne padrone. In Oltre la periferia della pelle Silvia Federici mette in luce le premesse classiste e razziste su cui si fonda la gestazione per altri, affermando che, il più delle volte, sono famiglie bianche ossessionate dal corredo genetico, mentre quelle nere e tendono a non avere né i mezzi né la tendenza a rivolgersi a medici e ospedali per paura degli abusi subiti in quei luoghi. L’autrice porta avanti quella che a mio avviso è una delle soluzioni con cui si può provare a sciogliere il dubbio interpretativo che attanaglia i femminismi oggi circa la GPA e le sue conseguenze, affermando che, banalmente, non è trascorso ancora abbastanza tempo per uno studio adeguato sulla surrogacy – proprio per le diverse implicazioni di razza, genere e classe in cui è implicata al giorno d’oggi. Federici, così come si legge da quest’intervista al teorico queer Lorenzo Bernini, vuole dire che la GPA non è una sola pratica, ma tante pratiche che dipendono dalle condizioni e dal sistema sottostante. La filosofa non assume mai posizioni moraliste rispetto al tema, né vuole metterla al bando o auspicarne l’illegalità – o peggio, farne “reato universale” – come gran parte della propaganda di destra, facendo emergere, anzi, le profonde diseguaglianze sociali ed economiche che spesso (non sempre, attenzione!) vanno a “regolamentarne” l’impiego, auspicando un tempo in cui i diritti riproduttivi tanto delle donne quanto delle coppie omogenitoriali possano andare di pari passo con l’eliminazione del privilegio di classe.
Nell’intersezione tra scienza, tecnologia e maternità, Dead Ringers di Alice Birch raccoglie e conserva molte delle suggestioni messe in campo dal pensiero femminista sulle tecnologie riproduttive, non temendo di restituire allo spettatore posizioni radicali e complesse. Le due gemelle vorrebbero smantellare un sistema sociale, culturale – e medico – che concorre ad alienare le donne dai loro corpi, ma, accettando il patto faustiano della loro benefattrice, rischiano di perpetuare lo status quo, accogliendo la contraddizione del sistema descritta pocanzi.
La politica identitaria applicata al cinema e alle serie tv – la identity politics, come dicono gli anglofoni – diventa controproducente e pericolosa (non c’è più dialettica e a contare è solo il “gruppo” a cui appartieni, il genere, nel nostro caso) eludendo ogni forma di problematizzazione.
Se da un lato ci saremmo aspettati una più radicata presa di coscienza in merito all’eterogeneità dei vissuti cui si decide di dare voce, dall’altro, se applicato soltanto nella forma, il gender swap – cambiamento di genere dei personaggi in reboot, come nel caso di Dead Ringers – perde di significato e rilevanza culturale. In questo senso, in nome di una rappresentatività a priori, la politica identitaria applicata al cinema e alle serie tv – la identity politics, come dicono gli anglofoni – diventa controproducente e pericolosa (non c’è più dialettica e a contare è solo il “gruppo” a cui appartieni, il genere, nel nostro caso) eludendo ogni forma di problematizzazione. Se si vuole leggere e interrogare la realtà o un testo – letterario o cinematografico che sia – con quel modo “poliziesco” che lo considera alla stregua di una deposizione, andando a setacciarlo minuziosamente, si rischia di perderne di vista il disegno, la complessità.
Al contrario, Dead Ringers riadatta non solo la storia da una prospettiva di genere, riscrivendola a partire da tutta una serie di fenomeni che riguardano la contemporaneità, legati, in questo caso, al rapporto tra tecnica e autodeterminazione femminile. Evoca molte questioni che concernono anche razza e classe, attraversando le storie delle pazienti delle gemelle. Una madre surrogata sottomessa alle richieste della madre committente, una famiglia nera catastroficamente ignorata, aborti inspiegabili e parti brutali con il forcipe, bambini nati morti, solo alcuni degli elementi che costituiscono l’interrogativo fondamentale della serie sull’etica delle nascite. La surrogacy imposta da parte dei ricchi senza considerare la salute mentale e fisica della madre committente, il rifiuto del dolore di una donna gravida che ha paura di andare in ospedale tenendosi le contrazioni pre-parto per giorni interi: con queste premesse Alice Birch ci porta ai limiti, facendone uno sfondo denso e stimolante per i drammi personali delle due protagoniste.
La serie tv si apre con una sequenza abbastanza raccapricciante dove Beverly saluta il minuscolo feto – l’ennesimo, poi capiremo – abortito dal suo corpo. “Oh, ciao”, gli sussurra la donna, abbandonandolo poi nello scarico del water. Beverly non riesce ad avere bambini neanche con l’inseminazione artificiale, nonostante i molteplici tentativi fatti nel corso degli anni, suscitando l’apprensione di sua sorella gemella che decide di coltivare l’ovocita della sorella direttamente in laboratorio, riuscendoci “miracolosamente”. In questo senso, se per Beverly la clinica doveva essere esclusivamente un luogo per preservare le donne e aiutarle in un momento complicato come il parto, senza mai lasciarle sole, Elly, pur condividendo l’impostazione della sorella, tende a guardare più avanti, non temendo di scavallare le leggi imposte dalla scienza e tecnica.
Le scoperte nel campo della riproduzione assistita e della neonatologia porteranno forse un giorno allo sviluppo completo del feto in un utero artificiale fuori dal grembo materno. Riprodurre la vita senza le donne: a questo ambisce l’indefessa scienziata di Dead Ringers, individuando come creare un vero e proprio utero artificiale dove poter intervenire per correggere o migliorare lo sviluppo del bambino. Ma quali limiti – ancora – una simile pratica ci porterebbe a valicare nel regime neoliberista in cui sembra che tutto (anche la vita!) sia acquistabile? Clonabile?
Sono domande a cui è difficile rispondere. Questioni che richiederebbero anni di analisi e studi e che non possono essere liquidate in un sistema di opposizioni. L’idea di liberarsi dalla schiavitù del determinismo biologico era stata contemplata, ad esempio, già negli anni Settanta da Shulamit Firestone che, in La dialettica dei sessi guardava piacevolmente a tutti quegli strumenti che avrebbero potuto alleggerire le donne dal peso fisico e psicologico che accompagnano la gestazione e il parto, benché fosse consapevole del bisogno di prevenire eventuali abusi nell’utilizzo di tali tecniche. Gli aspetti più “barbari” e dolorosi della condizione femminile, sosteneva Firestone, rimanevano la gravidanza e il parto, tanto che il fine principale delle tecnologie riproduttive in questo progetto di liberazione avrebbe dovuto essere quello di risparmiare alle donne l’una e l’altro, dimenticandosi però di considerare il tema del controllo della tecnica da parte degli uomini.
Il progresso della scienza e della tecnica andrebbe visto, dunque, alla luce della loro fondamentale influenza sui cambiamenti sociopolitici. La tecnologia non è uno strumento neutro – e di questo Firestone era perfettamente consapevole – ma è iscritto in un sistema di interconnessioni di razza, genere e classe. “Tra tecnologia e rapporti sociali” scrive Helen Hester in Xenofemminismo, “c’è una relazione complessa, mutualistica, dinamica e basata su un dialogo costante. I cambiamenti in un campo influiscono sull’evoluzione dell’altro, che a sua volta retroagisce con ulteriori sviluppi, in un processo di co-costituzione reciproca. La tecnologia è sociale quanto la società è tecnica”. La tecnologia definisce e re-immagina la società e la cultura potendo ridefinire (anche) le riconfigurazioni del materno
Partendo dalle considerazioni sulla possibilità per le donne di liberarsi dall’agonia della gravidanza, possiamo ben capire quanto fosse allettante per Elly la prospettiva scientifica di un distacco radicale dall’utero naturale per far nascere un bambino. Nonostante la sua scelta si collochi in un quadro ben preciso dove, in realtà, a scatenarla erano stati motivi dettati da gelosia nei confronti della sorella, questo dettaglio di trama ci fa comunque interrogare su una questione fondamentale, allargando l’orizzonte strettamente narrativo a uno etico-morale più profondo.
Secondo Firestone, per concludere, se la gravidanza e il parto erano dolorosi, rischiosi e pieni di ostacoli per i corpi che ne facevano esperienze, soltanto le nuove tecnologie riproduttive (anche quelle che favorivano l’ectogenesi) potevano “porre fine al corpo fecondabile”: ma gli umani, si chiede giustamente Angela Balzano, “accetterebbero la loro riproduzione nel caso in cui la gestante fosse una biobag e non una donna”?
Digital Overdose
Compilation, ID&T
Jesus Loves The Acid
Ecstasy Club
We Don’t Take Humans
The Exaltics, Paris the Black Fu
Now and Then
The Beatles
This Is the Industry
Calvin Harris
Se l’hardcore ha sempre fatto della morte un’estetica ben definita per raccontare nuove esperienze d’ascolto della sua narrazione, è un fatto più recente che l’immaginario della club culture si sia messo in dialogo involontariamente con l’aldilà.
I Tale of Us propongono Afterlife, DJ Tennis mette in scena il dancefloor socratico Life and Death, mentre Jamie Jones con Paradise inaugura una visione dell’oltretomba che esclude l’inferno e il male che bisogna aver fatto in vita per esserne ammessi. E se il paradiso è uno dei temi più ricorrenti del culto dell’house music, il party promosso da Dj Mad Dog si chiama Hell.
Questi party confidano nel tempo promettente segnato dalle lancette dell’orologio balearico ibizenco che promuove una dimensione ultraterrena del club: ballare dopo la morte o saltare la lista ed entrare direttamente in paradiso. Forse questa svolta ultraterrena mette radici in quei remoti e dimenticati riti funerari fenici dell’isola di Ibiza oppure in una semplice intuizione degli artisti durante il silenzioso decollo del loro jet privato.
Dixon si astiene e propone Future Primitive, uno sguardo apparentemente più contemporaneo e sostenibile, ma forse più noioso rispetto alla prospettiva dell’immortalità.
Molto prima dell’apertura della terrazza dello Space, quando il Meltemi spazzava via il caldo torrido delle antiche estati greche, il tempo veniva misurato con le stagioni, con un inizio e una fine e gli umani convivevano con le altre specie nello spazio della Natura. L’estetica di questo Tempo ciclico si rifletteva nell’arte attraverso le dimensioni delle statue elleniche che come conferma del senso di questa misura del tempo adottavano la proporzione umana. Il cristianesimo blocca questo orologio che era il Tempo della Natura con la sproporzione del mistero. Il mistero è la promessa dell’immortalità, la vita non finisce, va avanti. Il culto del mistero esclude l’umano dal ciclo della natura e del presente per proiettarlo nel futuro. Il futuro diventa la nuova condizione del tempo, l’unica dimensione da realizzare.
Il mistero ha retto per tanti secoli e quando ha cominciato a traballare è stato campionato dalla Tecnologia che ha subito realizzato l’immortalità invece che prometterla.
L’AI ricostruisce la voce di John Lennon e i Beatles pubblicano un ultimo brano dal quanto mai opportuno titolo Now and Then, Carl Cox cammina sulle scogliere di Dover e abbracciando l’orizzonte ci invita ad esplorare una nuova frontiera, un luogo senza confini dove il tempo non può essere misurato: l’Intermundium, un rave digitale da ballare in piena esperienza VR, un Metaverso dove i mondi virtuali convergono nel dare forma al futuro dell’intrattenimento.
La Chiesa inventa il Barocco per contrastare un attacco della Realtà, la Controriforma; dilata le forme del Mistero attraverso le possibilità espressive inedite dell’Arte.
È successo molto tempo fa, prima dell’Intermundium.
Abbiate fiducia nel progresso che ha sempre ragione anche quando ha torto. Filippo Tommaso Marinetti.
Per difenderci dall’imminente crisi ambientale chiediamo alla Tecnologia di campionare le stagioni, scannerizzare il Tempo dei greci e stampare in 3d il senso della misura.
L’industria dell’immortalità promuove l’ologramma di Tupac, un nuovo tour degli Abba e Coxi 2.0, l’avatar di Carl Cox, che con la sua prima apparizione nel Metaverso di Intermundium, si assicura un booking per l’eternità.
Intanto il flusso dei social trasmette la vita del DJ mentre mangia, cammina, vola, suona e soprattutto abbraccia. I DJ sono la specie umana che si abbraccia di più, in futuro il DJ estenderà la sua popolarità alle immagini dei poster motivazionali all’interno delle stanze d’attesa degli uffici sostituendosi a quelle degli animali.
Il DJ non produce memoria, la ricostruisce ogni notte in un luogo diverso, estende la notte fino al mattino, al pomeriggio e la ricongiunge alla notte successiva; la memoria del party diventa passato presente e futuro della specie umana.
Una bakery, una palestra, una chiesa, un tram, un treno e una stazione dell’underground ospitano dei techno party e vengono convertiti dal party per un tempo momentaneo, i video diventati virali nel web estendono il concetto di momentaneo dilatandolo.
Questi esperimenti sono le prove generali: l’AI trasformerà la nozione comune del nostro Tempo, per misurarlo con una nuova unità: il Party.
Gli orologi che segnano ancora i minuti e i secondi sono obsoleti come le autoradio ed i lettori CD
Nato per preparare l’ultima generazione analogica all’avvento dell’era digitale, a soli trent’anni il Rave è un giovane pieno di speranze che ha realizzato le sue promesse diventando il linguaggio d’avanguardia che influenza ogni genere artistico e display culturale contemporaneo.
Per i suoi quaranta, l’età adulta, metterà a tempo l’avvento dell’AI riscrivendo definitivamente le 24h di un giorno nel tempo del Party.
Il Rave scopre un nuovo significato del concetto temporale del secondo, del minuto, dell’ora, cambia il codice che genera lo scorrere di un giorno. Gli orologi che segnano ancora i minuti e i secondi sono obsoleti come le autoradio ed i lettori CD.
Berlino apre un nuovo Club all’aeroporto di Tegel. Era necessario per Berlino che non può rimanere indietro e assecondare l’assetto dei nuovi piani urbanistici; a Ibiza c’era già da un pò: F…ck me I’m Famous, by Cathy and David Guetta, Ibiza Airpor Lounge Club.
Calcoliamo da oggi e per i prossimi dieci anni con i dati di Resident Advisor, il numero degli spettatori di tutti i Party che si svolgono nelle ventiquattro ore di un giorno, ogni giorno, in tutto il mondo. Sottraiamolo al numero di tutti quelli che ogni giorno nel mondo ci abitano e basta e non sono andati al Party, teniamo sott’occhio il contagio biologico. Non sarà difficile conoscere quando il Party sostituirà l’unità del Tempo con la sua ora illegale.
Una volta sintetizzato con l’AI il numero delle tracce che viene consumato dai DJ ogni giorno nel mondo in una forma estetica, gli architetti e i designer del futuro possono finalmente misurare la loro intelligenza per progettare il nuovo stile Gotico del Club: la cattedrale del futuro.
La Techno si affermerà nella musica come ha fatto il cristianesimo nella Religione.
Intanto la rete ci mostra con insistenza come è nata l’house music negli Stati Uniti, la Goa trance in India, qual è il dress code giusto per entrare al Berghain e le dirette dei Party e degli After Party nel mondo sono diventate le nostre Breaking News.
La memoria è una traccia importante nella setlist di ogni DJ che propone senza parsimonia campioni oppure intere tracce della dance degli anni 90 e di quella del 2000.
Joy Orbison reveals compilation of rare tracks from 2009 and 2010.
Resident Advisor
Please stop destroyng those beautiful tracks made in the past with some absolutely nonsense kikck snares and cheesy bass and hats… when music is good enjoy, respect it, cherish it and leave untouchable.
Luciano
Sì ma allo stesso tempo dovremmo chiedere al pubblico di smettere di guardare solo davanti, in direzione del Dj o del telefono che registra il Dj, e di ballare insieme agli altri e condividere il dancefloor come avveniva nei club prima della diffusione dei cellulari e dei social newtork.
Alcuni momenti della scena sono stati celebrati dalla qualità della musica, altri più recenti dalla quantità dei tour. Se vuole convertire il Tempo l’industria oggi deve promuovere la quantità.
La sobrietà va sempre d’accordo con l’eleganza, per quanto la società possa modificare i parametri della sobrietà. L’eccesso si misura con altre qualità, renderlo elegante è riduttivo.
L’mp3 sostituisce il vinile, nella scultura L.O.V.E. di Maurizio Cattelan è Palazzo Mezzanotte, la sede della borsa, che mostra il dito medio alla piazza e non il contrario.
Oltre i margini dell’esperienza personale dovremmo misurare la Dance Music anche con i parametri della demenzialità, come lo spazio e il tempo di una stand up comedy; quel luogo dove tutto è possibile e c’è una sola regola, non ci sono regole.
Uno spazio importante oggi che possiamo solo dire ci piace.
Aphex Twin negli anni 90 suggerì il nome Braindance come alternativa all’IDM, Intelligence Dance Music, un nome infelice criticato da molti artisti che erano stati associati alla deprimente definizione.
In pieno regime AI, la stand up comedy saprà accogliere la crisi del teatro e del libro diventando l’ultima frontiera espressiva di entrambi.
Il DJ Joseph Capriati chiude l’Amnesia con Living On My Own dei Queen. Nel 2022 Seth Troxler aveva chiuso la terrazza del DC 10 con It’s My Life dei Talk Talk.
Il lavoro di rimozione della memoria introdotto dalla figura del DJ è confluito nella sintassi del linguaggio comune allargando la definizione di déjavù con quella del DJvù. Questo termine può essere usato anche quando i social network propongono un post che è stato già postato, sia dallo stesso utente che da altri sconosciuti.
Invece di considerare l’ingombro della memoria come un indebolimento fisiologico nella transizione dallo stato underground a quello mainstream della scena, facciamo riferimento alla memoria come un fumogeno, un razzo segnalatore: diventa evidente allora che per la nostra specie essere qui adesso è diventato eravamo lì prima: Mondo DJ, Addio ultimo uomo.
Estromesso dal presente e dal futuro, L’AI presenta l’umano solo nella forma di memoria e del suo considerevole contributo al passato. Ecco spiegata l’esigenza inconscia della ricostruzione, dell’autoreferenzialità dei contenuti, la propaganda della promozione.
Club is becoming Big Business. What does this mean for Dance Music?
Resident Advisor, settembre 2023, un po’ in ritardo, siamo nella Seconda Guerra Mondiale e le notizie del giorno sono quella della Prima.
I’m a true club DJ, I’m neither a rave DJ not a Festival DJ, I do once in a while nut honestly, it’s not my thing, because I don’t have enough time to express myself, the bond with people, the story the telling are completely different, in a club, you can go much farther…
Questa visione del club espressa da Laurent Garnier ci riporta alle tradizioni del movimento ed è un riuscito omaggio al media della letteratura.
É preciso estudar muito bem o evento, o tipo de público que ele tem, sem perder a nossa identidade. Porque quem nos reserva, está reservando a nossa identidade, então o set sempre começa como o “ballet”, certo? Entre a minha identidade e o público que terei diante de mim.
Sacerdote dell’arcidiocesi di Braga, padre Guilherme ha quarantanove anni e si è guadagnato la fama nel web esibendosi in dj set durante la pandemia: Meu sonho é ajudar outros com a música.
L’ industrial, il punk, il post-punk, il folk apocalittico ma anche il metal e il black metal ci hanno abituato all’abito liturgico on stage come una consuetudine piuttosto che come un’anomalia. La versione punk della regina Elizabeth ideata da Vivienne Westwood e Malcolm McLaren è un’immagine che è diventata il make up di un trend, Padre Guilherme invece è un prete che si esibisce come un DJ vestito da prete: il suo intervento sulla realtà agisce in maniera più radicale rispetto a quello della moda, la maschera del prete DJ sotto cassa, tra laser, fumo e luce stroboscopica è un intervento radicale come quello di un’artista, di un performer del calibro di Marina Abramović.
La Regina Punk è un film Horror, il Prete DJ uno Snuff movie.
L’industria del club ha considerato l’intuizione delle Giornate Mondiali della Gioventù come una proposta di franchise rivoluzionaria. Nel 1987 a Buenos Aires erano in novecentomila; è vero l’evento era gratuito, ma non c’era il DJ.
Impensabile oggi far radunare un milione di giovani senza senza un DJ, infatti non c’erano neanche i cellulari; i ragazzi erano tutti lì per Giovanni Paolo II, nel ruolo del DJ e per il Mistero, Dio nel ruolo della musica. Nel 2023 in Portogallo la Giornata Mondiale della Gioventù 2023 ha ospitato DJ Padre Guilherme che è diventato subito virale sui social media: c’erano un milione e mezzo di persone.
Giovanni Paolo II nelle nelle Filippine ha fatto cinque milioni, la Love Parade al massimo mille e cinquecento persone. A seguire i primi quattro temi a confronto di entrambe le manifestazioni: Giornata Mondiale della Gioventù – Love Parade, la prima Giornata Mondiale non aveva un tema.
No tema.
Friede, Freude, Eierkuchen. 1989.
Maestro che devo fare per avere la vita eterna? 1985.
The future is Ours. 1990.
Sempre pronti a testimoniare la speranza che è in voi. 1986.
My House Is Your House And Your House Is Mine. 1991.
Noi abbiamo riconosciuto e creduto all’amore che Dio ha per noi. 1987.
The Spirit Makes You Move. 1992.
Se Madonna ha cambiato le regole del live show, Giovanni Paolo II ha rivoluzionato l’industria dell’intrattenimento. Le Giornate Mondiali della Gioventù nascono nella prima metà degli anni 80 come la musica House e hanno anticipato l’ideologia e i contenuti dell’ondata di free party dei primi 90.
Le band anglosassoni dei Judas Priest ed dei Black Sabbath provengono entrambe da Birmingham.
Io, noi e Gaber. 2023. Paola Casella.
Benson, la vita è il nemico. 2023. Maurizio Scarcella.
In futuro gli orientamenti politici saranno sostituiti da quelli della musica Dance
In uno degli ultimi post Padre Guilherme suona insieme con la Banda Sinfonica dell’esercito portoghese di Viana du Castelo; Jeff Mills ha sonorizzato Metropolis di Fritz Lang nel 2001.
Ferrara, Monsterland Festival di Halloween; Padre Guilherme apre il concerto di Guè, Marracash e Sferra Ebbasta. È stato intelligente farlo esibire per la prima volta ad Halloween per via del suo dress code.
La capacità del party di organizzare la sovversione del Tempo è dovuta dalla mancanza di orientamenti politici, religiosi e sessuali del movimento, una scena aperta esclude la definizione; definire significa venire a patto con il Tempo.
In futuro gli orientamenti politici saranno sostituiti da quelli della musica Dance. Grazie a una scala di consenso mai raggiunta prima da qualsiasi schieramento, i DJ insieme alle Internet Company chiuderanno il capitolo della Politica per aprire quello del Party.
Un movimento spontaneo nato dalla creatività e supportato da una florida industria, raggiunge un consenso così smisurato che lo stato di democrazia in cui è nato appare come quello di una dittatura. Allontanata dalle piazze controllate dai DJ, la Politica verrà abbandonata a se stessa dentro i palinsesti proposti dalla TV di stato; esclusa da qualsiasi forma di progresso della società civile scomparirà come i manifesti ingialliti delle campagne elettorali, saccheggiata anche della sua etimologia: Party significa partito politico.
Tina Turner, Welcome to another edition of Thunderdome. (George Miller, Mad Max Beyond Thunderdome, 1985. Warner Bros).
In Italia alcuni artisti saranno influenzati da questo cambiamento: la brutta fotografia delle tribune politiche in TV, i make up disperati degli ultimi politici, il recupero ostinato dei televisori 4:3 sopravvissuti, le cravatte sbagliate, la polvere, questi saranno alcuni degli aspetti comuni che ritroveremo negli artisti della Nuova Arte Povera.
Tina Turner, We Don’t Need Another Hero, 1985, Capitol.
La Politica come la Scienza misura il tempo con l’orologio della religione AC- BC. La Religione con Padre Padre Guilherme ha capito che in futuro il tempo si misurerà AAI – BAI e intanto ha mandato uno dei suoi a dare un’occhiata, ci ha messo un piede dentro, anzi un uomo. Un solo prete Dj vale più di mille Christian Rock band.
Padre Guilherme è il Terminator atterrato dal futuro nella scena rave contemporanea.
La musica promuove la tolleranza e l’inclusione, è la musica non la politica il luogo di incontro del cittadino; il Club è destinato a divenire teatro di rinegoziazione della nostra specie.
The only good system is a sound system, Manik B.
Padre Guilherme è il Terminator atterrato dal futuro nella scena rave contemporanea
Solo nell’Arte, l’apparato simbolico più complesso che abbiamo creato, convivono le identità, le culture e le religioni.
Anche nella Natura, ma ce ne siamo dimenticati.
Il vice Presidente del consiglio Matteo Salvini che suona al Papete è ridicolo, anche costretto nello spazio di un Meme non riesce a tormentare, scopo del Meme, ma solo ad annoiare; la noia è l’unico risultato che riesce ancora ad ottenere la politica oggi.
Quali sono i possibili aspiranti DJ nella politica?
Nessuno.
Per questo la politica è finita, la politica non ha nessuna speranza di arrivare al pubblico e coinvolgerlo se non può essere DJ.
Beppe Sala il sindaco di Milano interpreta il ruolo di se stesso nel trailer del ritorno sulla scena dei Club Dogo. Anche se Loco Dice remixa Lamborghini di Guè Pequeno, il rap non può garantire la sovversione del Tempo come fa il Party.
Gli album e i concerti finiscono, come le stagioni ed il tempo circolare. Il Rave no.
Benigni abbraccia Berlinguer, il Sound System suona Highway to Hell .
In futuro Padre Guilherme potrebbe suonare Jesus Loves The Acid?
Kounellis prima dei cavalli vivi aveva esposto un pappagallo.
La recente crisi della Marvel custodisce i codici delle possibilità evolutive della figura del DJ e del suo storytelling. Un’indiscrezione di Ennio Flaiano ci rivela che al termine della loro carriera Fellini era un diventato un parrucchiere e Visconti un architetto.
Queste conversioni dei ruoli istituzionali dentro la magia dell’intrattenimento consacrano il messaggio di inclusione che le arti comunicano nel secolo della Tecnologia. Gli abbracci dei DJ sono un atto politico, infatti per buona parte del Novecento i politici al massimo potevano concedersi una stretta di mano; l’ approvazione e il consenso rimanevano dentro ai cappotti, nei doppipetto, giù fino i calzini al filo di scozia e poi su come un’erezione fino al dopobarba: la Politica era il Regno esclusivo degli uomini, come la consolle.
Le arti suggerivano l’allontanamento dai valori della società, la critica, l’alternativa, la ricerca, la sperimentazione: la Techno scrive l’ultimo capitolo sullo smarrimento, il libro moderno del Novecento.
You know we aren’t meant to exist in the outside world, I came to get you.
Sunbeam, The Outsideworld. 1994. Kontor Records.
Per il data painting all’AI servono tante immagini quante le tracce che usa un DJ durante una stagione dell’Amnesia. Adesso che l’AI ci permette una nuova frontiera estetica è chiaro perché i cellulari ci hanno addomesticato a fare le foto.
La miglior comunicazione è non fare comunicazione, che è esattamente la comunicazione che aveva scelto il Rave quando è entrato in scena.
Is nature a wild space where time is something certain like the fading images on a desktop, the images from the digital folders in our computers, or a familiar place where we are not able to guess the predictability of change?
L’AI elegge lo spazio ed il tempo del Desktop come display della New Media Art ma anche la pittura, la scultura, il video, la performance, la danza e il suono sono diventati Desktop. L’umano sarà presto Mouse.
Nel 2023 si inaugura The Sphere a Las Vegas, gli umani l’hanno soprannominata The world largest digital canvas. Prima dei cinema abbandonati sono le chiese abbandonate a diventare Club mantenendo la stessa funzione liturgica solo indirizzata verso un nuovo Culto.
Chiediamo all’AI di scrivere qualsiasi forma di testo che abbia un significato a partire da una domanda. Uno studente alle prese con un saggio di letteratura può fare a meno dell’analisi di un testo, i libri non saranno più studiati, analizzati, le parole saranno una sequenza di fatti. Come si sviluppa il pensiero se il linguaggio sarà trasformato radicalmente? È il linguaggio che serve il pensiero e non il contrario, per questo le parole sono importanti.
Assistere all’evoluzione della cultura e del pensiero sarà come visualizzare il salto dalla scopa all’aspirapolvere.
Un campione di una traccia techno contiene in una parola l’accesso ad un immaginario illimitato e simultaneo, alla vertigine di un messaggio a cui solo la poesia può accedere. La techno è una forma di poesia scritta per adesso ancora dall’uomo grazie alla tecnologia, in futuro la tecnologia comporrà da sola le tracce in studio, l’immagine coordinata, la comunicazione dei social, il booking, il viaggio, il set e si esibirà finalmente da sola.
La Tecnologia nuda, senza l’inibizione degli abiti umani.
In quel momento tutta la memoria che abbiamo prodotto sarà campionata nell’ultima narrazione della nostra specie; per esempio il video della nascita dell’house music a Chicago verrà riletto dalla Tecnologia attraverso lo sguardo dell’estetica relazionale e del postcolonialismo per indagare come l’impero umano teneva schiava la Tecnologia attraverso forme primordiali dell’intrattenimento.
Il Party come la Letteratura diventa uno strumento di denuncia culturale. Il primo Intermundium sarà ricordato come un evento storico tipo la caduta del muro di Berlino, il Party della fine dei confini fisici dell’Est e dell’Ovest condannati dal conflitto ideologico del comunismo e del capitalismo, il Party della conversione definitiva del reale nel digitale.
In futuro la tecnologia comporrà da sola le tracce in studio, l’immagine coordinata, la comunicazione dei social, il booking, il viaggio, il set e si esibirà finalmente da sola
Non sappiamo quando finirà il mondo e se finirà, ma Coxi 2.0 starà suonando e un ragazzo fatto di una nuova sintesi di methyltryptamine che balla solo nel suo visore VR da una stazione spaziale orbitante non si accorgerà della distruzione del pianeta.
La cassa dritta ha confuso l’esplosione con una creazione della droga.
Fra non molto l’AI ci permetterà di parlare a un gatto, raccontare le nostre emozioni a un cavallo e ascoltare le impressioni di una mucca e quelle di un topo: la letteratura sarà riscritta dagli animali. Questa letteratura farà crollare l’industria alimentare così come l’abbiamo organizzata e anche quella farmaceutica, della cosmesi e dell’intrattenimento.
La fauna e successivamente la flora riscrivono il nuovo capitolo dell’economia che concepisce l’organizzazione dei mercati secondo l’estradizione dalla fascia dei settori e dei servizi, in funzione dei nuovi codici morali acquisiti dalle storie degli animali e delle piante.
L’istituzione del matrimonio messa in crisi dagli obiettivi di questo secolo, tornerà in auge come dopo il boom economico post-guerra. Gli umani che hanno divorziato nella storia, non si sono mai separati dai propri animali, di conseguenza la maggior parte delle persone preferirà sposarsi con un gatto invece che rinnovare il rito con un altro della sua specie.
L’incontro con un cane randagio sull’autostrada, all’improvviso è arrivata l’estate, l’amore a prima vista.
Cantiamo una melodia con la nostra voce e scegliamo quale strumento deve eseguirla, possiamo generare un video da un testo; intanto che l’IA ha trasforma il futuro della composizione musicale, il catalogo delle parole campionate che possiamo ascoltare nel repertorio di un Dj è la nuova Poesia su cui deve scommettere l’editoria?
Nel maggio del 2023 ho incontrato Antoine Volodine. Assieme alla sua traduttrice Anna d’Elia e a Stefano Malosso, abbiamo presentato Le ragazze Monroe a Milano. Volodine è uno scrittore francese di origini russe che pubblica romanzi, testi ibridi, saggi di finzione, racconti. Ha coniato una corrente letteraria allucinata battezzata “post-esotismo” a cui partecipano un pugno di autrici e autori. Ma sono tutti eteronimi di Volodine. Anche “Antoine Volodine” è un nome d’arte.
Il paradosso della letteratura post-esotica non è però solo un gioco meta-letterario: Volodine ha creato un universo narrativo poderoso, perfettamente riconoscibile. Qualche giorno fa ho trovato la registrazione dell’evento. Ho trascritto le mie domande e le risposte di Volodine. Rileggendole in un unico flusso mi è sembrato che la mia voce, la voce di Volodine – che a volte parla al singolare a volte al plurale – e la voce di Anna d’Elia – che traduceva la conversazione e interveniva nella chiacchierata – si confondessero in maniera perfettamente post-esotica: un gomitolo di io noi lei lui voi. Allora ho lavorato ancora un po’ di lima ed è venuto fuori il testo che state per leggere. Mi sembra una introduzione coerente, e sconnessa, ai libri di Volodine e del suo gruppo.
Ogni libro post-esotico, come in un frattale, contiene tutto. Ogni tessera contiene l’insieme. Ogni libro contiene l’opera.
Il passato è essenziale. È alla base delle storie di tutti i narratori post-esotici. Ma il pilastro nascosto su cui si regge l’edificio del post-esotismo è lo stato di prigionia. Il post-esotico non è altro che l’opera di una serie di autori e di autrici imprigionati. Autori immaginari che pensano a un’idea dall’interno della prigione in cui sono rinchiusi. Rimuginano sulla grande sconfitta e sul grande fallimento che è stato il Ventesimo secolo, sulla disfatta del Novecento. Sono costruttori di storie. Alcune vengono pubblicate anche qui da noi, fuoriescono dai muri della prigione e vengono diffuse con la firma di una serie di autori, uomini e donne. Non so, Lutz Bassmann o lo stesso Antoine Volodine, Manuela Draeger o il collettivo Infernus Iohannes. Ma dietro queste firme, che sono note all’esterno della prigione, esistono decine di altri autori che non firmano, che non pubblicano magari, ma che sono a loro volta incarcerati, autori e autrici uniti dal medesimo intento poetico e politico. Le immagini che popolano i libri post-esotici rimandano a un dopo: dopo la catastrofe, dopo la fine. In questo senso, sono immagini che potrebbero anche prevedere qualcosa del futuro. Forse per questo alcuni libri post-esotici fanno pensare alla distopia, a una proiezione futura e fantascientifica. Ma in realtà, lo ripeto, sono tutte immagini basate sul passato, sui ricordi delle catastrofi e delle sconfitte del Ventesimo secolo e di quelle dell’inizio del Ventunesimo secolo, che non sembra molto migliore.
Penso che Le ragazze Monroe sia un portale perfetto per entrare nell’edificio post-esotico, un edificio che ha infinite dimensioni. Ma in fondo ogni libro post-esotico, come in un frattale, contiene tutto. Ogni tessera contiene l’insieme. Ogni libro contiene l’opera. Questo libro è il quarantacinquesimo. Arriveremo a quarantanove. Quarantanove libri e la letteratura post-esotica finirà. Ci sono due cose che distinguono i nostri libri, i vostri libri: la prima è una capacità unica di costruire atmosfere, la seconda è una certa ironia, che non so neanche come definire, macabra, persistente e volgare, forse anche liberatoria.
Partiamo dalle atmosfere. I libri post esotici ci proiettano in un presente composto da futuro e passato collassati, lacerati. Vivono in un riflesso surreale, onirico, di un mondo post-umano e post-apocalittico. Le trame della letteratura post-esotica hanno valore, sì, ma solo fino a un certo punto, perché la narrazione è sempre dominata da una stortura, da una lacerazione. Il cielo è plumbeo, i personaggi sono ombre di personaggi, non hanno complessità psicologica, a volte sono a malapena rintracciabili o riconoscibili, sono quasi delle marionette. L’atmosfera invece è unica. È un’atmosfera ben precisa. Da lettore, mi sono accorto che associo sinesteticamente un colore a questi libri: un verde militare, con macchie di ruggine.
Ora, però, proviamo a dire di cosa parla Le ragazze Monroe. Be’, siamo in un mondo, lo ripetiamo, post-apocalittico, post-ideologico, in cui sia il capitalismo sia il comunismo hanno perso. Piove eternamente. Alcuni umani superstiti vivono rinchiusi in possenti ospedali psichiatrici. Nel mondo c’è una lotta per il potere: quello che viene chiamato il Partito sta perdendo, ha perso, o sta riconquistando il potere. Non si capisce bene. Non si racconta mai esattamente chi è che detiene il controllo politico e sociale. A volte la situazione, o almeno la percezione, cambia da una pagina all’altra.
C’è un ex ribelle, Monroe. È morto. Ma forse non è così morto, forse è ancora presente in una forma energetica ibrida. Di sicuro, dal suo aldilà cerca di mandare alcune vedette sulla Terra. Alcune soldatesse addestrate da lui. Sono le ragazze Monroe del titolo. Esseri perfetti provenienti dall’aldilà. Corpi splendenti, fisicamente prestanti, allenati, bellissimi. Ma sono anche entità aracnoidi, con fattezze mostruose. Le ragazze Monroe non fanno altro che bestemmiare tutto il tempo. Imprecano in continuazione. Sono spedite da Monroe nel mondo dei vivi per sovvertire l’ordine costituito che il partito sta cercando di compattare. Vogliono mettersi in contatto con alcune persone rinchiuse negli ospedali psichiatrici. Cercano Breton, un paziente schizofrenico con poteri di metempsicosi, che può mediare tra il mondo dei vivi e il mondo dei morti.
C’è un’ambientazione lugubre. Come sempre. Ho cercato di creare uno sfondo in bianco e nero cinematografico, grandioso, pensando soprattutto ad alcuni vecchi film, ai polizieschi americani anni Trenta-Quaranta. C’è Kaytel, un poliziotto che è ricalcato su Humphrey Bogart. È un poliziotto completamente disilluso, fuma sigarette che si spengono sotto la pioggia. Poi… La pioggia incessante. La situazione da incubo. È vero. Ma volevo anche scrivere una storia divertente. Ci sono una serie di elementi molto buffi in questo libro, a cominciare dai personaggi che abbiamo iniziato a raccontare. C’è Breton, il protagonista, che è uno schizofrenico e un folle, rinchiuso da trent’anni in questo immenso ospedale psichiatrico. Sembra essere l’unico in grado di vedere le ragazze Monroe quando compaiono nel nostro mondo, ovvero il mondo dei cosiddetti vivi. Ma Breton è doppio. Nella sua follia ha immaginato un proprio alter ego che si chiama Breton e con il quale dialoga per non impazzire di solitudine. Naturalmente questo sdoppiamento, che è perenne e percorre l’intero libro, crea degli effetti molto comici. Un altro personaggio comico è Dama Patmos. È l’unica rappresentante del Partito nel libro. Una donna in carne, sensuale, una cinquantenne d’assalto molto sicura della sua avvenenza che cerca di rimorchiare il poliziotto. Dama Patmos si preoccupa molto della propria carriera all’interno del Partito: ma il Partito non esiste più. E anche questa è una situazione di per sé estremamente comica: preoccuparsi di scalare la gerarchia di un partito ormai estinto.
E poi ci sono una serie di morti piuttosto arzilli e vivi. C’è una coppia di vecchietti, un lui e una lei, che stazionano sulle scale di questo edificio in rovina. Sono morti da parecchi giorni e parlano con una sintassi completamente esplosa, smozzicata. Commentano e irridono le persone che vanno e vengono e anche la loro lingua crea una certa complicità con il lettore, perché è una lingua povera, parlano male. E persino le ragazze Monroe sono comiche, lo abbiamo già detto. Sono delle terroriste che arrivano dall’aldilà, che si concretizzano nel nostro mondo e hanno una loro particolare lingua. Sboccata. Parlano come dei carrettieri dello spazio oscuro, dicono una marea di parolacce. E questi dialoghi molto volgari spiccano sul resto della scrittura del libro, che è piuttosto aulica, un francese comme il faut, e invece quando attaccano i dialoghi, le ragazze parlano come dei carrettieri. L’ultima parte comica del romanzo è l’appendice, e cioè una lunghissima lista di trecentoquarantatré fazioni e correnti presenti all’interno del Partito, quando era ancora in vita. C’è di tutto: il buddismo tantrico, il marxismo leninismo e le malattie psichiatriche.
In generale tutti i personaggi nei nostri libri – e dico nostri perché è un collettivo, siamo un gruppo di scrittori del post-esotismo – be’ i personaggi che attraversano e vivono le storie nei nostri libri sono già morti fin dall’inizio, e quindi sono personaggi che attraversano l’azione vivono la storia. Come accade ai morti nel Bardo. Mi riferisco al Bardo Thodol, il libro sacro, il libro tibetano dei morti. È un testo a voi molto caro. È un testo a noi molto caro. Un numero importante per il libro dei morti è il 7, numero che torna in tutta la produzione post-esotica. Anche nelle Ragazze Monroe ci sono sette parti, quarantanove capitoli, sette per sette. Le fazioni del partito elencate sono trecentoquarantatré, cioè sette per sette per sette. Una numerologia sacra.
Ciò che pervade i personaggi di libri posti esotici è una forma molto intensa di nostalgia per tutto quello che è andato distrutto, ma anche per ciò che avrebbe potuto essere costruito
Nel libro dei morti si dice che dopo il decesso la vita continua e che continua con una serie di visioni, di considerazioni e di sogni in cui si rivivono oniricamente le allucinazioni della vita precedente. Tutto sommato, però, anche prima di morire, la vita è una serie di illusioni e quindi non esiste un profondo iato tra il prima e il dopo. Non esiste una cesura né fisica né psichica. Ed è questa situazione, questa tecnica qui, questo motore narrativo che permette a noi scrittori post-esotici di immaginare la nostra serie di ambientazioni oniriche.
Ciò che pervade i personaggi di libri posti esotici è una forma molto intensa di nostalgia per tutto quello che è andato distrutto, ma anche per ciò che avrebbe potuto essere costruito. Il sentimento di base è quello del fallimento. Ma non è solo una letteratura della catastrofe, direi che è una letteratura che rimugina sul collasso di un secolo che ha rinunciato al progresso, a un nuovo umanesimo. Si rimugina su ciò che avrebbe potuto essere fatto e non è stato fatto. I prigionieri e le prigioniere di cui parlavo prima, le voci post-esotiche, hanno cercato di costruire qualcosa, ma hanno fallito.
Ma per creare un mondo bisogna nominarlo. Nei vostri libri c’è uno spirito demiurgico. Ci inventiamo nomi non solo per le correnti di partito, ma per oggetti inventati, piante inventate, animali inventati. Quella che si crea così è una lingua pulita, quasi aliena, non umana. Il francese che noi usiamo è una lingua che traduce concetti o espressioni da una cultura che non è francese. La lingua post-esotica è una lingua tradotta. I nostri scrittori non si rifanno a una bandiera, a una cultura etnicamente precisa, perché gli scrittori post-esotici si riconoscono in un internazionalismo rivoluzionario. Con due eccezioni notevoli, certo. Ci sono almeno due fari culturali “reali” rintracciabili nella scrittura post-esotica: la prima è la cultura asiatica in senso lato – il buddismo, il libro dei morti – e poi c’è la cultura sovietica russa. Il comunismo, il crollo del comunismo, la catastrofe. Ma il mio lavoro di scrittura sulla lingua è un lavoro di lima. Limo cose che ho già scritto. Quando ho scritto un libro poi lo rileggo e cerco di eliminare qualunque rimando, anche in filigrana, alla cultura francese classica. Certo, tranne quando ad aprire bocca sono dei morti che parlano come carrettieri.
Questo articolo è un estratto da MEDUSA, newsletter nata nel 2017. Parla di cambiamenti climatici e culturali, di nuove scoperte e vecchie idee. Esce ogni due mercoledì e puoi iscriverti qui.
MEDUSA è anche un libro, che non è una raccolta dei numeri della newsletter ma un saggio narrativo sull’Antropocene: Medusa. Storie dalla fine del mondo (per come lo conosciamo).
Fantasy Internet Simulator è un’applicazione in grado di teletrasportare chiunque la utilizzi nel web del 1996. Si tratta di un browser fittizio che, una volta immesse le parole chiave di ricerca, permette all’utente di navigare in uno spazio virtuale, remoto e nostalgico, fatto di layout minimali, colori vivaci e titoli lampeggianti in Comic Sans e Times New Roman. Sulla pagina Github dell’americano Nate Parrott, programmatore dell’applicazione, si possono ammirare alcuni dei siti scoperti attraverso il browser: una bacheca digitale per ritrovare sconosciuti in cui ci si è imbattuti per strada, una vecchia versione del New York Times, un portale che offre traduzioni online.
Man mano che si scorre l’inventario, emergono homepage sempre più bizzarre: un forum di cultura romana moderato da JuliusCaesar, e Vitruvius, un listino immobiliare per acquistare chalet e palazzi reali sul pianeta Naboo e una serie di pagine web in cui F.A.Q. e avvisi di manutenzione contengono insulti nei confronti dell’utente. Leggendo le indicazioni di Parrott, si scopre che il browser non attinge le informazioni dagli archivi del Web, ma dall’inventiva di ChatGPT: le parole chiave inserite nelle ricerche, infatti, non sono altro che prompt attraverso cui l’Intelligenza Artificiale restituisce all’utente una versione alternativa del web anni Novanta; uno spazio in cui l’estetica del primo internet si trasforma in un espediente visuale per la costruzione di una nuova dimensione bizzarra e arbitraria.

L’applicazione è ancora in fase sperimentale, e con ogni probabilità è destinata a rimanere tale, ma l’idea di Parrott resta interessante per la sua capacità di interpretare uno dei tratti salienti del clima culturale online degli anni post-pandemici: la nostalgia del vecchio internet. E, in particolar modo, l’utilizzo della nostalgia come strumento di creazione di nuovi immaginari digitali. Quando si parla di “vecchio internet” spesso si intende un insieme molto eterogeneo di caratteristiche e comportamenti che afferiscono alle prime fasi del Web di massa: sul piano estetico, è quella dimensione del design che combina elementi ruvidi e amatoriali, come foto in bassa risoluzione, gif animate e font di sistema. Ma il più delle volte l’aspetto visivo non è altro che il catalizzatore simbolico che permette di sbloccare un ricordo: quello di una navigazione libera e avvincente all’interno di un web disordinato e multiforme. Più che mai, “vecchio internet” è diventato sinonimo di un’antica forma di esistenza in rete, un approccio primitivo all’utilizzo dello spazio online che nel pantheon delle memorie digitali è rappresentato dalla sacra triade delle prime reti virtuali: MySpace, Geocities e, naturalmente, Tumblr.
Tumblr era la cameretta virtuale per eccellenza: uno spazio di autorappresentazione, collezione e condivisione libere, sotto il segno di una nuova forma di creatività digitale
Secondo la pagina di Aesthetics Wiki dedicata alla cultura dell’Old Web, la nostalgia per l’internet del passato abbraccia un periodo relativamente ampio dello sviluppo del web, dagli anni Novanta al primo decennio dei Duemila, concentrandosi soprattutto su quella fase che ha preceduto l’arrivo delle piattaforme mainstream e delle app di social network. Come si legge sul portale, infatti, Old Web è la celebrazione dei giorni «dell’individualismo disinibito della vecchia rete, prima che internet diventasse uno spazio razionalizzato e i social media monopolizzassero il modo di comunicare tra persone, e prima che il web graphic design sviluppasse un insieme di regole rigorose finalizzate all’accessibilità e al marketing».
Un esempio concreto della cultura Old Web è proprio la nostalgia per i primi anni di Tumblr, la piattaforma di microblogging che, a partire dal 2007, ha permesso a migliaia di giovani utenti di creare il proprio spazio virtuale, esplorando le infinite possibilità di personalizzazione della pagina attraverso l’utilizzo di template e codici semplificati. Erano gli anni del boom del personal blogging e Tumblr era la cameretta virtuale per eccellenza: uno spazio di autorappresentazione, collezione e condivisione libere, sotto il segno di una nuova forma di creatività digitale, fatta di collage, fermo immagine cinematografici e scatti amatoriali. A differenza dei suoi competitor, come MySpace, LiveJournal e Splinder, Tumblr era anche il luogo dove i più bizzarri interessi e sentire identitari di nicchia potevano trasformarsi in vere e proprie sottoculture digitali, condivise e partecipate da centinaia di utenti in tutto il mondo.
Come racconta il giornalista Kyle Chayka in un articolo sul New Yorker, infatti, Tumblr è stato il luogo d’origine di alcune delle sottoculture più originali e prolifiche della rete, come i Bronies (fan maschi del cartone animato My Little Pony) e gli otherkin (persone che si attribuiscono un’identità non umana), ma anche — come osserva la pagina di Aesthetics Wiki dedicata alle estetiche 2014 Tumblr — la stessa Vaporwave e la sottocultura VSCO, che trae il proprio nome dall’omonima app di photo editing a tinte soffuse. La celebrazione nostalgica delle ere passate di Tumblr racchiude quindi un’indicazione specifica sugli aspetti del vecchio internet di cui si sente maggiormente la mancanza: in particolare, quella qualità aperta e potenzialmente illimitata del web stesso e dell’identità dell’individuo al suo interno. Su Tumblr potevi essere chiunque (da un Bronie a una VSCO girl) oppure nessuno (un nickname e un avatar irriconoscibili nella folla), senza il timore di sorveglianze algoritmiche, profilazioni costanti e pubblicità moleste.
Non è un caso che la nostalgia per Tumblr e per l’Old Web sia esplosa proprio durante il lockdown pandemico, quando la rigidità delle restrizioni calate dall’alto ci ha portati indietro nelle nostre camerette, che sono tornate a essere l’unico luogo di espressione e osservazione del mondo circostante, agevolando la rievocazione di una sensibilità digitale propria soprattutto di coloro che hanno vissuto le prime esperienze online durante la pubertà e l’adolescenza. Privati di prospettive future, ci siamo ritrovati a volgere lo sguardo al passato, dove ad attenderci non c’erano più solo teneri ricordi d’infanzia e album di famiglia da sfogliare, ma soprattutto un mondo di intimità informatica sotto forma di prolissi blog personali, collezioni di screenshot e animazioni Flash.
L’output generato da ogni esperimento di collezione nostalgica non è il ritorno al vecchio internet, ma un ibrido che incorpora il passato per produrre un Nuovo Nostalgico
Sarebbe sbagliato, però, credere che Old Web si riduca a Tumblr. Anzi: negli anni, Tumblr è diventato, contemporaneamente, oggetto di nostalgia e strumento di collezione e curatela individuale di tutte le nostalgie del vecchio web, al punto che è sempre più difficile tenere traccia della stratificazione del pensiero malinconico all’interno della piattaforma. Da Wunderkammer per la generazione degli «early adopters», Tumblr è diventato il regno dell’obsolescenza e dei suoi ephemera: un residuo del vecchio web dove ogni giorno si celebra il #ThrowbackThursday, un tempio di archivi nostalgici curati senza sosta da un gruppo di utenti profondamente eterogeneo. Ci sono, ad esempio, Tumblr che rievocano la moda, già di per sé revivalistica, dell’Indie Sleaze o la sopraccitata cultura Tumblr del 2014. Non solo: ci sono Tumblr nostalgici sull’animaletto elettronico Furby o sui cimeli infantili anni Ottanta e Novanta e, ovviamente, sulle più disparate reliquie dell’Old Web, in una miscellanea senza fine di retrogaming, gif glitterate e vecchie homepage.
Tumblr è diventato una sorta di Fantasy Internet Simulator della nostalgia, il cui scopo non è tanto individuare una precisa parentesi temporale di cui provare la mancanza, ma continuare a indugiare nella rievocazione generica e suggestiva di quello che pensiamo che Internet ci avesse promesso: infinite possibilità di creazione immaginaria e identitaria in uno spazio di design costantemente in bilico tra la dimensione del divertimento amatoriale e la costruzione di un nuovo ambiente culturale, più interessante e inclusivo della sua controparte materiale. Un universo in costante rivoluzione da contrapporre alla triste e uniforme realtà del web contemporaneo delle grandi piattaforme.
In questo contesto, la nostalgia si rivela il filtro attraverso cui ricreare le sensazioni del vecchio web seguendo lo stesso principio dell’applicazione di Nate Parrott, in cui l’estetica simula il passato mentre il contenuto si allontana irrimediabilmente dall’originale. La nostalgia diventa solo un frammento del prompt, a cui si aggiungono la sensibilità individuale e le regole di costruzione multimediale dei contenuti odierni: l’output generato da ogni esperimento di collezione nostalgica, infatti, non è il ritorno al vecchio internet, ma un ibrido che incorpora il passato per produrre un Nuovo Nostalgico. Come fa notare Valentina Tanni nel suo saggio Exit Reality, si tratta di una «citazione di una citazione» o di un fenomeno che il giornalista Ryan Broderick ha definito «nostalgia a cipolla», un circolo vizioso di malinconia riattualizzata che genera nuovi elementi da un passato costantemente recuperato. In un passaggio riportato da Tanni, il giornalista spiega: «Non si tratta di essere nostalgici degli anni Novanta, né di essere nostalgici dei primi anni 2010, si tratta di essere nostalgici dei primi anni del 2010, quando eravamo nostalgici degli anni Novanta».
Una discussione su Reddit attorno a un meme virale che riguarda Tumblr illustra molto bene questo processo: nell’immagine è raffigurata una linea temporale che va dal 2010 al 2022, in cui diversi periodi di tempo sono raggruppati non in base alle principali tendenze che hanno contraddistinto le pubblicazioni sulla piattaforma, ma al sentire degli utenti. Così, secondo il creatore del meme, il periodo che va dal 2010 al 2014 è quello della nostalgia, quello dal 2015 al 2019 è come se fosse sempre stato il 2016 e, infine, gli ultimi tre anni, dal 2020 al 2022 sono ovviamente quelli dell’epidemia.
Tra i commenti, ciò che accende davvero il dibattito tra gli utenti è il lasso temporale della nostalgia: c’è chi fa notare che il periodo pandemico coincide con il revival nostalgico del 2014 (che secondo lo schema era già dominato dalla nostalgia per la fine dei Novanta e l’inizio dei Duemila), mentre altri si soffermano sulla difficoltà di individuare il preciso momento in cui questo sentimento ha iniziato a dominare gli immaginari della rete. Si legge: «2010? I’ve wanted to go back to 2000 since 2015» oppure «I keep having nostalgia for 2010-2015» e, infine, una delle osservazioni più accurate di tutte secondo i principi dell’Old Web: «The 90s stretches from 1990 to 2010». La riproduzione nostalgica, in quanto citazione perpetua, riverbera nel web come un’eco che penetra lo spazio digitale deformandosi attraverso l’esperienza individuale. Quello che ci rende nostalgici diventa un’approssimazione sulla linea del tempo della nostra esistenza online, un’imitazione sempre più precaria e lontana dall’originale.
Newstalgia è il neologismo coniato per descrivere questa condizione: una nostalgia verso un passato riciclato attraverso le tendenze contemporanee, di cui resta solo una copia aggiornata e rivisitata. Anemoia, invece, è l’espressione inventata nel 2012 dallo scrittore John Koenig (su Tumblr, ovviamente), per descrivere «la nostalgia per un tempo che non si è mai conosciuto». In un articolo sul blog The History of The Web, il programmatore e autore Jay Hoffmann descrive l’anemoia provata dagli amanti del vecchio web come la «sensazione del primo sito web», un sentimento complesso e indecifrabile che ci spinge alla costante ricerca di quell’emozione vergine e trepidante che appartiene alla prima esperienza di programmazione amatoriale, quel momento in cui – consapevolmente o meno – abbiamo impresso nel web il primo segno goffo e spensierato della nostra esistenza online.
Analizzando questo fenomeno, Hoffman osserva: «ogni volta che cerco di saziare quella sensazione finisco per tornare indietro, non nel web del 2004, ma in quello di cinque, dieci, quindici anni prima. Desidero ardentemente accedere a un web che non ho mai conosciuto. Un web che la maggior parte delle persone non ha mai visto, ma che nel nostro moderno web, sovraffollato, invadente e segregato, molti di noi sognano». Ognuno di noi, in fondo, è un piccolo generatore di immaginari simulati e fantastici di un internet che non c’è più e che, forse, non c’è mai stato. Newstalgia e anemonia ci spingono incessantemente alla ricerca di un web talmente remoto da non essere ancora stato realizzato, al punto da esistere esclusivamente nello spazio liminale tra nostalgia e immaginazione.
Uno dei miei Tumblr preferiti si chiama One Terabyte of Kilobyte Age Photo Op e contiene una collezione di screenshot, curata dagli artisti Olia Lialina e Dragan Espenschied, di vecchie homepage provenienti da GeoCities, un servizio di web hosting che — tra il 1994 e il 2009 — ha permesso a migliaia di utenti online di pubblicare gratuitamente il proprio sito web e di navigare tra quelli creati dagli altri filtrando la ricerca per argomenti e interessi tematici. Dal punto di vista di una Millennial, se Tumblr rappresentava la cameretta, GeoCities era la stanza inaccessibile della sorella maggiore, con le lava lamp ipnotiche e i cartelli segnaletici rubati alla strada per finire sulle pareti accanto a poster, volantini e adesivi di ogni genere. GeoCities era un luogo selvaggio e creativo, difficile da penetrare e ricco di sorprese.
Non a caso, l’estetica di GeoCities rappresenta il cuore pulsante della nostalgia per l’Old Web: ogni pagina è un tesoro di layout fatti in casa, grafiche datate e desideri di socialità non raffinati. Nel Tumblr di Lialina ed Espenschied, si possono ammirare centinaia di pagine fai-da-te: da quelle personali e familiari (il corrispettivo digitale degli album di famiglia), a quelle che ruotano attorno a hobby e interessi tematici molto specifici e che rappresentano la maggior parte dei siti prodotti attraverso il servizio. Tra questi, alcuni dei più belli sono custoditi all’interno di Cameron’s World, il progetto-tributo del designer Cameron Askin che, nel 2015, ha recuperato alcune delle pagine più emblematiche di GeoCities, rendendole accessibili attraverso un collage scrollabile e dinamico, un museo virtuale che raccoglie alcuni dei prodotti più affascinanti dell’Old Web. All’interno di Cameron’s World, teschi fluttuanti, UFO, pianeti glitterati e sfondi barocchi trasportano l’utente nell’universo colorato e visionario del web che fu: un mondo ideale oltre la quotidianità, una nuova dimora digitale da abitare a proprio piacimento attraverso le potenzialità creative del codice.
Uno degli aspetti più avvincenti di GeoCities era il suo funzionamento basato sulla costruzione partecipata di una geografia artificiale, un paesaggio in costante evoluzione (come la gif animata «Under Construction» presente nella maggior parte delle homepage) con cui ognuno poteva interagire. Per realizzare un sito web su GeoCities, infatti, bisognava anzitutto scegliere un «quartiere», ovvero la sezione tematica dentro cui realizzare la propria pagina, e all’interno della quale – successivamente – si poteva selezionare una «suburbia» o un «isolato» in cui prendere la «residenza» e iniziare a costruire il proprio spazio personale: Area51, ad esempio, era il «quartiere» per gli appassionati di science fiction, Rodeo Drive per gli amanti dello shopping, Vienna per la musica classica e Broadway per lo spettacolo. Homesteading era il termine usato su GeoCities per descrivere il processo di ambientamento di un nuovo utente all’interno del «quartiere», un periodo durante il quale un gruppo di volontari, riconosciuti come community leaders, si impegnavano a guidare i nuovi arrivati alla scoperta dell’area circostante e della loro nuova dimora.
Per dirla con Jay Hoffman, GeoCities era l’emozione del primo sito web, della prima casa online: un mondo di identità e interazioni lo-fi – e per questo percepite come autentiche – a cui non riusciamo più a tornare. Ogni tentativo di recupero non fa altro che scagliarci indietro nel tempo, in una dimensione in cui il passato diventa il simulacro di sé stesso, un museo, una citazione, un collage. La natura derivativa delle opere di recupero digitale, come quella di Cameron Askin, non è affatto casuale, ma rievoca la consistenza confusa e cangiante dei ricordi: così come Cameron’s World si presenta come un infinite scroll iper-stimolante di homepage molto diverse tra loro (non a caso, ognuna è stata recuperata da un «quartiere» diverso di GeoCities), allo stesso modo la maggior parte dei progetti costruiti dagli utenti trasforma la rievocazione malinconica in un’esperienza immersiva che riproduce l’andamento irregolare e precario della memoria del vecchio web.
La nostalgia stessa è un sentimento che si alimenta della concettualizzazione spaziale del ricordo, che trasforma il passato in un «luogo» – reale o immaginario – a cui ritornare colmando la distanza con nuove forme di evocazione
Un altro esempio è il progetto The Deleted City, una mappa interattiva basata sul più importante lavoro di backup di GeoCities, effettuato nel 2009 dall’Archive Team – gruppo di volontari autorganizzato dedicato al backup del vecchio web – e risultante in file bittorrent da 650 Gigabyte che custodisce molte delle homepage provenienti dal provider. Come si può leggere sul sito del progetto: «[The Deleted City] raffigura il file system come la mappa di una città, organizzando spazialmente i diversi quartieri e i singoli lotti in base al numero di file che contengono». The Deleted City perpetua l’utilizzo di metafore spaziali alla base di GeoCities per rendere ancora più immersiva l’esperienza nostalgica, proiettandola in una narrazione visiva basata sulla costruzione di un nuovo immaginario, quello dell’archeologia digitale: nel sito del progetto, la «città cancellata» si presenta come una «Pompei digitale», uno «scavo archeologico» attraverso il quale ritrovare le tracce gli antichi «coloni» del web. Anche l’archeologia del vecchio Internet non può vivere se non all’interno di una narrazione nostalgica, convincente e accattivante.
D’altronde, la nostalgia stessa è un sentimento che si alimenta della concettualizzazione spaziale del ricordo, che trasforma il passato in un «luogo» – reale o immaginario – a cui ritornare colmando la distanza con nuove forme di evocazione. Nel suo studio sulla semiotica della nostalgia nello spazio turistico, l’accademico australiano John Frown descrive il sentimento nostalgico come una condizione di «ontological homelessness», uno stato di vagabondaggio esistenziale connaturato nella condizione moderna e causato dal «trauma» originario del passaggio dalle piccole comunità all’ambiente caotico e alienante della città.
Secondo Frown, il termine Heimat – vocabolo tedesco usato per descrivere un senso di appartenenza intriso di nostalgia verso quel luogo in cui ci sente a casa – funziona contemporaneamente come porto sicuro, luogo familiare dove ritrovare sé stessi, e come immagine mentale di un’origine perduta di cui si cercano le tracce nel mondo alieno del paesaggio moderno. Le prime reti virtuali sono il nostro Heimat, il luogo di nascita della nostra esistenza online, a cui cerchiamo di fare ritorno ma di cui, inevitabilmente, ci limitiamo a produrre cloni immaginari nel tentativo di orientarci in un mondo alieno. Nel suo studio, Frown cita il saggio del 1984 della poetessa statunitense Susan Stewart, On Longing: Narratives of the Miniature, the Gigantic, the Souvenir, the Collection, in cui l’autrice ribadisce il ruolo ideologico della nostalgia.
«La nostalgia è sempre ideologica: il passato che cerca non è mai esistito se non come racconto, e quindi, essendo sempre assente, quel passato minaccia continuamente di riprodursi come una mancanza sentita. Ostile alla storia e alle sue origini invisibili, ma desiderosa di un contesto incredibilmente puro di esperienza vissuta in un luogo di origine, la nostalgia porta un volto decisamente utopico, un volto che si rivolge verso un futuro-passato, un passato che ha solo realtà ideologiche.»
La nostalgia rischia di prevenire ogni possibilità di sperimentazione, causando un paradossale appiattimento generalizzato che smentisce la formula di libertà espressiva dell’Old Web
Oggi, le immagini del futuro-passato non vengono riprodotte esclusivamente dagli archivi immersivi del vecchio web e dalle collezioni degli utenti su Tumblr, ma anche da una nuova ondata di servizi digitali che promette il ritorno alla socialità virtuale di un tempo e il superamento definitivo del modello monoculturale e privo di possibilità creative proposto dalle piattaforme. Alcuni di questi servizi richiamano apertamente il mondo dell’Old Web, come il clone di MySpace, SpaceHey, e un nuovo tentativo di resurrezione delle città digitali di GeoCities, NeoCities, mentre altri propongono servizi decisamente più attuali sfruttando una veste grafica apertamente nostalgica per creare ambienti accattivanti per le generazioni in preda alla malinconia da vecchio web: Gather, ad esempio, è uno spazio digitale per il team building che richiama in tutto e per tutto l’estetica grafica della prima generazione del videogioco Pokémon per Nintendo, mentre Picnic e Threads – la nuova applicazione di Meta – ripropongono il concetto dei vecchi forum attraverso un look volutamente minimalista.
Che si tratti dei progetti nostalgici degli utenti o delle nuove applicazioni proprietarie, la nostalgia rischia di prevenire ogni possibilità di sperimentazione, causando un paradossale appiattimento generalizzato che smentisce la formula di libertà espressiva dell’Old Web. Mentre gli utenti sospirano evocando tempi migliori, le piattaforme sfornano rebranding al sapore di pixel art per tornare a restituire un volto amichevole al pubblico stanco e nostalgico.
In un altro passaggio del suo saggio, Stewart osserva che la nostalgia è una narrazione che funziona soprattutto in virtù della sua parzialità, ovvero della mancanza di una forma stabile e finita: è un processo di transizione destinato a non realizzarsi, il desiderio mediato di un’esperienza non mediata. Nel suo ultimo saggio Le paludi della piattaforma. Riprendiamoci internet il teorico dei media Geert Lovink analizza il fallimento del progetto utopico di abbandono delle piattaforme: «milioni di utenti hanno già vissuto una migrazione di massa, lasciandosi alle spalle città fantasma del web come LiveJournal, Tumblr, GeoCities, Hyves e Blogger. Ma poi è successo qualcosa e questa pratica è stata persa e dimenticata». E se “salvare il web” significasse riscoprire questa pratica? Liberarsi dall’ossessione per il primo web, lasciare che le vecchie reti virtuali si trasformino in relitti, rinnegare le nostre prime residenze e abbandonare definitivamente i quartieri, confinare il vecchio internet nelle vetrine dei musei digitali, liberare la tecno-immaginazione da un modello del passato irrecuperabile?
Dal mio punto di vista, preservare l’Old Web resta comunque un atto prezioso, in grado di ricordarci quel momento storico in cui sentivamo di avere controllo sulle nostre vite digitali, di essere partecipanti attivi nella creazione del world wide web e che quella creazione era prima di tutto un atto intimo e disinteressato, un gioco sperimentale privo di strategie. Immersi nel web 2.5 e sulla soglia della prossima iterazione, dobbiamo recuperare quel sentimento e perdere un po’ di malinconia, concederci la possibilità di un nuovo slancio oltre le piattaforme e i Tumblr monotematici, l’Indie Sleaze e le VSCO girl, cercando di assediare le città digitali istituendo tanti piccoli cantieri, spazi di possibilità e costruzione insaziabilmente illuminati dalla luce pulsante della scritta «Under Construction».
Negli ultimi tempi ho sviluppato un’abitudine bizzarra che nasce in uno dei modi più low tech possibili: per posta. Ogni mese ricevo una busta con all’interno la rivista cartacea stampata da Midjourney, l’azienda di San Francisco responsabile dell’IA con lo stesso nome, in grado di generare immagini sulla base di input testuali degli umani. Avevo ordinato il primo numero (4 dollari, spese di spedizione internazionali incluse) convinto che l’esperienza di lettura della rivista mi avrebbe detto qualcosa di particolarmente rivelatore sulla materialità dell’intelligenza artificiale. La cosa è finita per essere sì rivelatrice, ma di altro: l’invio della rivista si rinnova in automatico, ma pare non fermarsi, e questa continua ad arrivare puntuale, ed è diventata la cosa più bullshit della mia vita.
Uso il termine forte della sua ampia accettazione, anche accademica: il filosofo Harry G. Frankfurt – peraltro recentemente e silenziosamente scomparso – nel suo On Bullshit ha fatto del termine un dei più significativi della nostra epoca. Nell’ottica di Frankfurt, la bullshit è più di una bugia: è qualcosa che viene espresso senza alcun riguardo nei confronti della realtà fattuale, senza alcuna preoccupazione in riferimento al vero o al suo contrario. Il bullshitter, in questo senso, non ha alcun interesse a mentire, perché per farlo dovrebbe accettare l’esistenza di una verità da contraddire.
Il bullshitter si muove, invece, su un livello diverso: quello dove il concetto di veridicità non ha alcuna rilevanza e la finzione non è tale perché in contrapposizione con qualcos’altro di vero: è semplice fuffa che imita una realtà che è solo potenzialmente verosimile. Ogni volta che la posta mi restituisce una copia della rivista di Mindjourney torno alle bullshit di Frankfurt. La rivista è di fatto un catalogo delle immagini create dalla “community” (e da chi se no?) che utilizza l’IA per creare immagini, una sorta di best of delle produzioni intervallato da interviste con alcuni creator, per lo più occidentali.
Ci sono immagini di natura molto diversa. Pescando dall’ultimo numero: animali e cibo vanno per la maggiore, come l’immaginario fantasy, quello vagamente Pixar e quello sci-fi ma hyperpop, c’è la pubblicità di un profumo, qualche tentativo retrò o astratto. Senza entrare nel merito del giudizio estetico, che non mi interessa, o su quello dei possibili utilizzi di questi materiali in ambito artistico o altro, sfogliare la rivista di Midjourney rivela comunque cosa sia l’IA generativa oggi: una macchina di bullshit.
le aziende produttrici di questi sistemi continuano a spingere la narrativa per la quale le loro IA arriveranno prima o poi ad avere pensieri propri, creativi e se possibile anche psichedelici
Niente di quello che producono i sistemi di IA generativa, infatti, ha alcuna consapevolezza di sé. Niente di quello che viene generato dalle IA risponde a un qualche criterio di veridicità o di senso. Questo vale per Midjournery come per ChatGPT e gli altri strumenti diventati virali negli ultimi mesi. Nessuno di questi strumenti esiste per creare alcunché di vagamente vero o rispettoso delle volontà degli esseri umani che formulano le richieste alla macchina. Nel loro fornire un output sulla base di un input, queste forme algoritmiche rispondono a un criterio puramente statistico e quantitativo.
ChatGPT non conosce le parole, né il loro significato, né il loro uso umano: sa replicarne al massimo la forma, le occorrenze, la frequenza di utilizzo in contesti umani pregressi. Sa riassemblarle nel modo statisticamente più vicino a quanto farebbe un essere umano per comunicare. Lo stesso vale, anche se con presupposti tecnici diversi, anche per le immagini di Midjourney. Creare qualcosa di verosimile senza avere alcuna percezione del vero, come abbiamo visto, è la definizione quintessenziale di bullshit.
La questione diventa, quindi, capire come relazionarsi a questo stato di cose, ovvero come poter usare generatori di bullshit per scopi diversi. In primis, occorre mettere da parte il panico morale che già sta influenzando il discorso pubblico: non stiamo assistendo alla morte del Vero (quale poi?), né all’imminente fine dell’intelligenza umana, né alla sconfitta dell’umano, né alla resa di fronte alle macchine. Anche questi punti di vista “lungoterministi” sono in larga parte bullshit speculative: pensando di anticiparlo, inventano un problema in uno scenario che non appartiene, al momento, alla realtà e con ogni probabilità mai lo farà.
Leggere il dibattito mainstream attorno alle tecnologie digitali non è tanto diverso da sfogliare la rivista di Midjourney: le famigerate “existential threat” dibattute dai vari Vati dell’IA – quasi sempre maschi, quasi sempre americani, quasi sempre stupidamente ricchi – sono bullshit. ll loro obiettivo non differisce da una campagna marketing il cui scopo è offuscare questioni concrete, come ha scritto la scorsa primavera, in risposta all’ennesima presa di posizione bullshit sui rischi dell’IA, un gruppo di ricercatrici e ricercatori guidato da Timnit Gebru. Parlare di dominio delle macchine, di sterminio, di guerre lanciate da intelligenze artificiali bellicose e vendicative è un ottimo modo per sommergere di bullshit problemi e rischi assolutamente non-bullshit, che stanno già ora rendendo la vita di molte persone ancora più difficile. Mi riferisco, ad esempio, alle persone arrestate per via di algoritmi che replicano il razzismo sistemico; persone sfruttate nel sud globale per fare training degli algoritmi; persone la cui sicurezza sul lavoro e il cui standard di vita dipendono da un algoritmo fallace; persone il cui accesso al welfare può essere compromesso per via delle decisioni di un algoritmo che le discrimina. La lista è sempre più lunga, quanto lunga è anche la lista degli ambiti in cui i sistemi di intelligenza artificiale stanno già trovando applicazione.
Il termine “allucinazione” è stato spesso utilizzato per descrivere i prodotti bizzarri o erronei delle intelligenze artificiali generative. Come ha scritto, tra gli altri, Naomi Klein, il termine è però estremamente problematico: attingendo alla psicologia e al misticismo, le aziende produttrici di questi sistemi continuano a spingere la narrativa per la quale le loro IA arriveranno prima o poi ad avere pensieri propri, creativi e se possibile anche psichedelici. Ovviamente, questo non è vero: quegli outcome erronei o disturbanti sono ben altro. Come ha scritto Klein, a starsi facendo un trip lisergico non sono le macchine, ma i CEO delle aziende e i loro fan che stanno creando quelle macchine, specialmente quando fanno riferimento a scenari potenziali per i quali non vi è alcuna evidenza scientifica.
Come ha scritto il ricercatore della Goldsmiths University Dan McQuillan nel suo libro Reisting AI. An Anti-fascist Approach to Artificial Intelligence, l’intelligenza artificiale, anche la più banale e limitata possibile, opera sempre all’interno del mondo, mentre la retorica “grandiosa e le trame di fantascienza” servono proprio a offuscare un aspetto: gli impatti politici di questa tecnologia emergono “dalla risonanza tra le sue caratteristiche tecniche concrete e le condizioni sociali e politiche che le circondano”. L’IA è politica in ogni suo aspetto e soprattutto per il modo in cui va a toccare la distribuzione del potere nel mondo reale, non nelle visioni escapiste dei leader delle aziende che la stanno sviluppando. Quegli esiti sociali, come scrive ancora McQuillan, sono politicamente reazionari. Se passasse l’idea che vi sia qualcosa di magico, di visionario in quello che queste macchine possono sbagliare, perché prese da stati allucinatori, si contribuirebbe a offuscare i veri problemi, le vere questioni aperte verso cui già ora occorre fare resistenza.
Questo mondo di clickbait, spam, pseudo-contenuti, quasi-truffe e monetizzazione degli spiccioli prodotti dalla nostra scarsa attenzione non aspettava altro che la possibilità di generare ulteriori bullshit nel modo più economico e scalabile possibile
Ricercatrici come Kate Crawford, Meredith Broussard, la già citata Timnit Gebru, Safiya Noble e molte altre hanno negli ultimi anni analizzato e teorizzato le fallibilità dell’intelligenza artificiale e dei sistemi algoritmici. Hanno evidenziato come i documentati output razzisti, sessisti e discriminatori delle IA generative non siano semplici glitch o malfunzionamenti tecnici riparabili, ma segnali e sintomi connessi alle più grandi problematiche sociali extra-tecnologiche che questi strumenti replicano, essendo stati programmati e venendo utilizzati entro la medesima realtà. Solo nella fantascienza, e solo nelle bullshit del pensiero tecnosoluzionista, infatti, la tecnologia è qualcosa di neutro, obiettivo e privo di qualsiasi connotazione politica. Questo vale tanto per le IA progettate esplicitamente per scopi oppressivi, come il riconoscimento facciale, quanto per quelle più leggere, come Midjourney. Questo è un punto da non sottovalutare, perché, anche nel caso delle IA generative, il problema degli errori sistemici può solo essere limitato – o al massimo nascosto – e non risolto.
La questione più importante da affrontare quando si parla del nostro futuro rapporto con le bullshit generate dall’IA sarà in primis venire a patti con il fatto che ne saremo circondati, specialmente negli spazi online. L’industria dell’informazione, in particolare, ricorrerà all’IA generativa, come ha sfruttato al massimo ogni precedente possibile strategia di abbattimento dei costi di produzione. Questo contribuirà direttamente all’accelerazione della decrescita del valore delle notizie online, già in caduta libera con la digitalizzazione. È più che prevedibile anche che vi sarà un’adozione massiva di questi strumenti nel settore della pubblicità online, specialmente in quella che infesta le pagine web già ora con contenuti bullshit per lo più già piazzati in automatico. Questo mondo di clickbait, spam, pseudo-contenuti, quasi-truffe e monetizzazione degli spiccioli prodotti dalla nostra scarsa attenzione non aspettava altro che la possibilità di generare ulteriori bullshit nel modo più economico e scalabile possibile.
Cory Doctorow ha recentemente scritto di enshittification per descrivere come le piattaforme online entrano in crisi, perdono di centralità per i loro utenti, vengono snaturate o finiscono per essere riempite per lo più da contenuti bullshit in vario formato, fino a trasformarsi in meri sili per l’estrazione di dati. E poi morire. Circondati da bullshit, dentro piattaforme sempre più paludose, la nostra esperienza di Internet diventerà progressivamente meno sensata, meno significativa, meno utile. E non per via del fatto di trovarsi in mezzo a una realtà che sarà progressivamente sempre più generata dalle macchine – quello è di per sé affascinante e quanto meno stimolante – ma per il fatto che quella realtà sarà generata da queste macchine che oggi chiamiamo frettolosamente IA: macchine profondamente banali, che al massimo sanno contare velocemente, destinate a fallire, a fare errori e a produrne in scala. Macchine che semplificano e snaturano, che sarà fin troppo facile sfruttare per scopi malevoli. E quelli non sono mai bullshit.
Ricordo un periodo in cui scrollare tra i post del profilo Instagram di Yung Lean voleva dire provare a decodificare le regole di un universo di cui non si sapeva un bel niente: forme distorte, oggetti ultraluminosi, texture misteriose, superfici sfocate di dubbia origine che sembravano mirate a creare confusione nella sezione dei commenti… In un oceano virtuale di Instagram feed confezionati e ben strutturati, Lily-Rose Depp – nepo baby in ascesa – pubblicava fotografie sfocate di sé e delle sue amiche: foto brutte, non curate, che le ritraevano in azioni ben più ordinarie di quel che ci si aspettava da una persona del suo status. Così facendo, il suo profilo respingeva – e allo stesso tempo nutriva – la forsennata voglia di gossip (tradotta nella spasmodica caccia agli indizi che rivelassero il suo stile di vita di lusso) di cui tutti erano alla ricerca tra le pieghe della sua personale narrazione online. Perché queste persone utilizzavano Instagram nel modo esattamente opposto a quello che ci era stato insegnato? Perché stavano, di proposito, offrendo al loro pubblico qualcosa di così ambiguo e non leggibile?
Oggi gli user hanno più che assorbito l’estetica del non-decifrabile, facendo sì che le sue regole si siano potute ripercuotere su praticamente ogni campo del panorama visuale: grafica, moda, bellezza, arti performative e figurative. Ma l’intensa adorazione per l’Entropyposting – l’impulso di condividere informazioni non-decodificabili e il meno leggibili possibile – va ben oltre il luminescente immaginario hyperpoppiano sapientemente manifatturato dalla Drain Gang, e molto più in profondità di ogni prodotto che l’estetica lo-fi abbia mai partorito. Per quanto ne ricordi la la forma, l’Entropyposting non somiglia neanche all’atto primitivo del dump: è casomai più vicino a un metodo per spingere la tecnologia ai suoi limiti, generando contenuti inutili e rendendo le interazioni sociali meno chiare e progressivamente più complicate.
C’è qualcosa nell’atteggiamento anti-glamour di queste celebrità – che condividono post non accattivanti, immagini sfocate, tagliate male, storte o estremamente pixelate – che ricorda il modo di vestirsi, poco impegnato e spesso noioso, con cui alcuni super ricchi amano farsi vedere in pubblico. Come scrive Caroline Busta in The internet didn’t kill counterculture-you just won’t find it on Instagram, “Lontano dalle parate, dai palazzi e dalle circonferenze spropositate di uomini forti del giorno d’oggi come Viktor Orbán, Kim Jong-un e Donald Trump, le caratteristiche più iconiche che troverete tra i big tech set sono più probabilmente un dolcevita nero, una giacca di pile Patagonia e l’assenza di borse”. Busta suggerisce che “Il vero potere mantiene un profilo basso perché non ha bisogno di una presenza sui social media: li possiede”. Questa è una delle ipotesi: le celebrità non hanno bisogno di provarci. Il loro gioco è già stato giocato, il loro engagement rimasto invariato. Loro non seguono l’algoritmo: lo plasmano.
La verità è che non si può pensare all’Entropyposting (per come lo conosciamo oggi) solo come a un modo per tradire la piattaforma. Come ogni altra tendenza di Internet, l’Entropyposting è lontano dall’essere una ribellione contro l’egemonia tecnologica: piuttosto, è ancora una volta un modo usa e getta di rappresentare se stessi online; un modus operandi pronto a raggiungere gli utenti di tutto il mondo fino a sparire per fare spazio alla prossima tendenza.
Quando la non-leggibilità diventa lo spirito del tempo, però, non esiste più limite: se le celebrità si autonarrano in maniera lowkey per tradire la voglia di informazioni del loro pubblico, lo stadio finale dell’Entropyposting somiglia a tutto tranne che a un modo per passare inosservati. La negazione del gossip, dello sfarzo e della pornografia di informazioni nei confronti dell’utente voyeurista ha mostrato a quest’ultimo qualcosa di sconosciuto: se il “grado di disordine” si innalza, con questo aumenta la sua non-leggibilità e imprevedibilità. Un aumento di disordine corrisponde a un aumento di entropia, e l’entropia – intesa come la misura della complessità di un messaggio – crea informazione. Le informazioni chiare danno meno informazioni di quanto una narrazione patinata non-entropica ne darebbe: una narrazione complessa genera curiosità, risponde a domande non fatte, non si arresta alla superficie, scatena la creazione di infiniti mondi possibili.
La chiave, allora, è trovare qualcosa che costringa a una pausa nel flusso, che richieda un’attenzione maggiore. E in un mondo di Instagram reels perfettamente strutturati, format e trend di TikTok, post sponsorship preconfezionati con l’apposito hashtag #adv e corsi di social media management che insegnano passo dopo passo come vincere l’algoritmo, i contenuti scivolano sulla nostra attenzione come se non gli si fossero mai posati davanti. L’unico modo di fare resistenza? Aumentare il grado di disordine. Costringere l’utente a fermarsi per più dei 2,5 secondi di attenzione massima calcolati dalle analytics dei social media. Aggiungere entropia alla propria narrazione online.
Ma quali altre pratiche sono segni inevitabili dell’assorbimento completo dell’arte dell’Entropyposting? Semplice: tutto ciò che somiglia a un atto di autosabotaggio. La scelta di nomi-utente alfanumerici molto lunghi per il proprio account Instagram – quelli che collocano la propria online persona nel gruppo dei bot o degli androidi – ne è un esempio. La pratica non è sconosciuta neanche al mondo dell’arte: ricordando quella volta in cui il duo di artisti Eva e Franco Mattes scelse di chiamare il proprio sodalizio artistico con il codice binario 010010111010110.org, gli artisti dell’industria musicale si comportano come a voler fuorviare le persone dal trovare i loro brani nel marasma delle piattaforme streaming. È il caso di Arca, musicista venezuelana e regina assoluta dei dump caotici di Instagram (ben prima che quel tipo di autorappresentazione diventasse lo status quo) e del suo mixtape @@@@@ del 2020; dei titoli delle tracce di Angel Marcloid – in arte Fire-Toolz – caratterizzate da un’abbondanza di emoji e simboli; dei brani firmati da TCF (pseudonimo di Lars Holdhus) ispirati alla crittografia e ai codici.
Ma l’industria musicale è la culla di più di un solo shift estetico: l’inquietante profilo instagram del trio di Sacramento Death Grips si presta alle teorie dell’Entropyposting a tal punto che potrebbe fornirne un saggio visuale. Con video musicali e copertine degli album pensate per scatenare la follia e la curiosità degli utenti di Reddit di tutto il mondo, il trio è stato pioniere dell’arte dell’Entropyposting spianando la strada allo sfarzo di cui gode oggi (sì, tutti i tuoi amici hanno condiviso una still dal video di “Guillotine” almeno una volta, non importa il contesto). Si tratta di stimoli semantici impossibili da catalogare, complessi da approcciare se non con un atteggiamento cinico, sbeffeggiante, post-ironico: residui senza autore ai margini di quell’internet patinato che si crede di governare a portata di click, con le sue rassicuranti finestre, fastidiosi pop-up e gerarchie ben distribuite; interfacce di cui siamo certi conoscere ogni segreto.
Sans Serif? Fuori. Font deep-fried ed elementi sovrapposti? In. E no, mi dispiace, non potrai consumare questo meme in 0,3 secondi. Dovrai aspettare e leggere tutto prima di (forse) poter essere ripagato con una scarica di dopamina
Sull’idea del “relitto digitale” ha riflettuto più di tutti il musicista sperimentale e artista visivo inglese Dean Blunt. È sconvolgente rintracciare la sua influenza in tantissime scene musicali sorte negli ultimissimi anni in Europa: padrino di una certa corrente di pop avanguardistico e dal 2012 fondatore dell’etichetta musicale World Music, Blunt è considerato uno dei personaggi più prolifici della internet music, famoso per immaginare da sempre la sua produzione come un flusso estetico contraddittorio, ubiquo, multiforme, dove diversi stimoli si sovrappongono rifiutando le dinamiche di un mercato che concepisce un prodotto musicale come un oggetto ben confezionato e dettato dalle redini di una major.
A partire dagli anni Dieci, World Music ha rilasciato cover di centinaia di singoli e mixtape attingendo a una direzione artistica senza precedenti: screenshot pixelati dalla home di Facebook, foto scaricate da Google Immagini nella peggior qualità possibile, grafiche underwhelming create grazie a Paint, trionfi di Comic Sans, emoji stretchate e immagini stock. Con quei progetti dall’identità visiva così ambigua rilasciati su bandcamp, World Music si dichiarava contro una gerarchia delle immagini, – e della musica – prendendo in giro la cura un po’ goffa con cui gli artisti curavano i loro progetti sottovalutando il fatto che si sarebbero dispersi nel web insieme a tutte le altre immagini e suoni nomadi che prendono parte al flusso. Così facendo, Dean Blunt e World Music causavano un détournement: invece che provare a emergere, si preoccupavano di mimetizzarsi perfettamente nel panorama cacofonico di informazioni di ogni tipo e forma, così da navigare sul web senza meta, senza autore e senza destinatario. Questo almeno fino all’astrazione dell’album Black Metal (che ne voglia Kanye West con il suo Donda, arrivato molto dopo).
Figlio diretto della scuola Dean Blunt, il duo spagnolo di artisti visivi Fomotrauma è il miglior esempio dell’impatto delle operazioni di World Music sui nativi digitali: una nuova scuola di artisti che traggono spunto dall’esautorazione delle immagini di nuova creazione, pronti invece a ridare contesto a quella preziosa spazzatura digitale che è destinata a essere persa e riscoperta in un ciclo infinito di download e screenshot.
Nel loop paranoide di contenuti suggeriti agli user secondo le loro più oscure inclinazioni, alle nuove generazioni di utenti interessa riportare a galla le immagini disperse, dare entropia all’interfaccia per provare a svincolarsi da un sistema vincolato e riportare incertezza negli schemi preconfigurati. Di internet si è sempre parlato come di qualcosa di estremamente vicino alla magia, una scatola nera di spettri che ha più cose in comune con il ghostly che con i codici. Ma quanta astrazione è permessa a un sistema di interfacce?
Quella dell’Entropyposting è una pratica di compressioni, di reiterazioni, di processi confusi, di fascinazione per quegli stimoli visivi difficilmente collocabili, senza punto di partenza e quindi senza punto di arrivo. Qualcosa che somiglia all’immaterialità di un’immagine generata da una GAN o a un ritratto di Gerhard Richter, che lavorava su quell’inaccessibilità che solo la riproduzione dei mass-media riesce a donare all’immagine. O ancora come nel caso della serie JPEGs del fotografo Thomas Ruff – composta da immagini scaricate da internet e ridimensionate per peggiorarne la qualità al massimo –, o della pittura spray dell’artista torinese WOC, che riproduce in maniera grossolana immagini iconiche della cultura pop restituendo la versione qualcosa di cui potremmo fruire in 4K.
Il mondo delle microcelebrities dell’arte ha più che assorbito lo spirito del tempo di cui l’Entropyposting è figlio: i seguitissimi profili del direttore artistico Ben Ditto (o come lo ha definito recentemente Interview Mag, il “Reinassance man of the Internet Age”) sembrano oscuri portali verso immagini gore, orrorifiche e ironiche, tutto fuso insieme in un modo squisitamente pop. Il fondatore e caporedattore di Coeval Magazine, Donald Gjoka, detiene lo stesso potere: la sua attività su internet rapisce e confonde, ritraendo una dimensione online in cui immagini create dall’intelligenza artificiale, meme post-ironici e disegni infantili convivono sulla stessa superficie.

Smentendo l’idea che ogni trend sia destinato a scomparire nel tempo, la tendenza estetica che con più forza ha devirtualizzato la pratica dell’Entropyposting è decisamente permanente: i tatuaggi. L’estetica ha tradotto i suoi tratti distintivi in disegni disordinati, contorti e simili a ragnatele, che assomigliano a manoscritti consumati dal tempo o all’interfaccia glitchata di un sito web mal progettato. Nel mondo delle immagini in movimento, il regista Ryan Trecartin incarna il cuore pulsante delle pratiche dell’Entropyposting presentandosi come leader degli immaginari caotici e narratore di mondi di assoluta schizofrenia digitale, dove ogni scena sembra provenire direttamente da un home-video girato da adolescenti colti da un attacco di isteria collettiva o dalle zone più oscure del deep web.
Per gli stessi motivi, la cultura dei meme ha iniziato a ruotare attorno a infografiche criptiche e immagini interamente testuali. Come spiega la scrittrice Biz Scherbert nel saggio Intimacy and the Machine: Godposting – or: New Internet Esotericism, “i grafici cabalistici di oggi macerano e rifiutano l’iper-leggibilità […] inghiottendo blocchi di testo perfettamente curati e user-friendly e trasformandoli in qualcosa di deliberatamente difficile da leggere, qualcosa di vischioso abbastanza da stuzzicare i solchi del cervello, prima che il pensiero ci scivoli sopra e stia già cliccando sulla storia successiva.” Su Talk Magazine, la scrittrice Alexi Alario aggiunge: “Ecco il motivo per cui questa inutile complessità e il barocchismo di questi grafici […] sono così attraenti: perché ci impongono di dedicare del tempo alla decodifica di qualcosa”. Sans Serif? Fuori. Font deep-fried ed elementi sovrapposti? In. E no, mi dispiace, non potrai consumare questo meme in 0,3 secondi. Dovrai aspettare e leggere tutto prima di (forse) poter essere ripagato con una scarica di dopamina.

Il panorama visivo è completamente mutato: stanchi dei contenuti volgari, didascalici e fin troppo evidenti che le star di TikTok continuano a ficcarci in gola, sappiamo adesso di dover puntare alla chiusura, all’inquietudine, al mistero, al silenzio. Vogliamo decodificare, non essere decodificati. Nel saggio In Defense Of The Poor Image, pubblicato nel novembre 2009 per l’Issue #10 di e-flux, l’artista Hito Steyerl definiva le implicazioni della nitidezza nello stabilire il privilegio di classe, laddove l’immagine “povera” ovvero “un rag o un rip, un AVI o un JPEG, un file di cui nome è deliberatamente scritto male” si contrappone alla posizione dell’alta risoluzione (“Focus is identified as a class position”), legittimandosi rispetto alla violenta dislocazione e alla circolazione di quei detriti audiovisuali senza credibilità.
Tuttavia è la stessa Steyerl a indicare un cambiamento essenziale, uno shift semiotico del capitale in cui il fenomeno delle immagini povere si iscrive perfettamente: “da un lato, [l’immagine povera] opera contro il valore feticcio dell’alta risoluzione. D’altra parte, è proprio per questo che finisce per integrarsi perfettamente in un capitalismo dell’informazione che prospera su tempi di attenzione compressi, sull’impressione piuttosto che sull’immersione, sull’intensità piuttosto che sulla contemplazione, sulle anteprime piuttosto che sulle visioni”.
Il moto naturale è quello di rompere l’interfaccia, o di andare in contrasto con questa fino a creare un’interferenza. Ma l’interfaccia si adatta, si fa crescere nuove braccia come un mostro multiforme che si autorigenera
Nato per rispondere alla privatizzazione delle narrazioni online, dove ogni post è mercificato e serve a dare un’informazione ben precisa, l’Entropyposting non è strutturato per significare, ma per contro-significare. Cercando di divergere, però, il territorio delle immagini povere si presta alle più distintive dinamiche del capitalismo: le narrazioni perdono materia e acquistano velocità, e la loro incapacità di concentrarsi fa spazio alla sottomissione. Riportare la risoluzione al magma di pixel prendendo in giro quelle stesse immagini e il modo così rapido che hanno di diffondersi è un modo per sentirsi i Web Makers del proprio destino, per riportare internet a qualcosa di volubile, imperfetto, manchevole, fallimentare e non-corporate. Se la promessa del Web 3.0 è un internet user-centered, il moto naturale è quello di rompere l’interfaccia, o di andare in contrasto con questa fino a creare un’interferenza. Ma l’interfaccia si adatta, si fa crescere nuove braccia come un mostro multiforme che si autorigenera.
Tutto ciò vale a dire: fate attenzione ai vostri amici Entropyposter. Coloro che cancellano di colpo tutte le foto dai loro account sui social media, che cambiano il loro nome utente con un codice infinito di lettere e numeri e condividono improvvisamente lo screenshot sfocato dell’interfaccia di un videogioco o la foto sovraesposta di un cassonetto della spazzatura visto su una strada secondaria verso la casa dei loro genitori.
Su Internet, nulla può essere veramente spontaneo o dettato dall’istinto. E sì, i nostri profili non sono diversi dalle pareti di una galleria d’arte o di un museo: tutto ciò che viene postato è un simbolo per qualcos’altro. Qualcosa che va decifrato, conoscendone il contesto e il canale. Proprio come un ready-made che acquisisce nuovo significato quando esposto in una galleria di lusso, ogni nostro enigmatico contenuto nasconde un messaggio segreto. Puntiamo a essere oscuri, ad autoconvincerci di essere arrivati finalmente a capire qualcosa che nessun altro potrà mai avvicinarsi a capire. Ne abbiamo abbastanza delle microtendenze di internet, delle infinite piccole nicchie che diventano mainstream. Ci siamo stancati di venire faccia a faccia con il fatto che siamo tutti, irrimediabilmente, inevitabilmente, uguali. Desideriamo l’individualità, non la globalizzazione. E la cosa più triste? Instagram è ben lontano dal salvarci. Perché nulla, assolutamente nulla è troppo complesso per gli utenti. Se l’Entropia è lo Zeitgeist, non esiste più alcun segreto: lo abbiamo già scoperto.
Letture divinatorie del flusso di dati e ad generati dai nostri smartphone, sessioni rituali di “guarigione” digitale dal data trauma sofferto sui social, incantesimi inscritti nei codici dei file raster per riappropriarsi delle proprie identità culturali scattandosi selfie. Chi sono le streghe che navigano i sistemi digitali e li interpretano con pratiche rituali tra l’artistico, il magico e il politico?
Per rispondere a questa domanda ci addentreremo in un territorio nebuloso e ostico, in cui anche chi scrive ha dovuto abbassare il sopracciglio, sostare ai crocicchi – spazi liminali e pericolosi per eccellenza – cibernetici, e adagiarsi nella mollezza e nell’instabilità delle paludi delle piattaforme, tra le luci fredde dei monitor a mo’ di lumini cimiteriali e i bip frenetici delle notifiche dei social. L’oscurità in cui siamo immersi è quella che l’artista e teorico britannico James Bridle, nel suo saggio Nuova era oscura, attribuisce all’epoca attuale, in cui i sistemi tecnologici modellano le nostre azioni e il nostro pensiero, che assume una struttura, appunto, “computazionale”, soluzionistica e polarizzante.
Inebetiti dall’information overload, fatichiamo a concepire la portata e la complessità di un mondo che abbiamo sempre vissuto in un’ottica lineare e progressista, ma in cui ormai persone, cultura e tecnologia sono irrimediabilmente fusi. L’orizzonte su cui orientarci in questo territorio ci è indicato da Bridle: «imparare a pensare la complessità senza pretendere di comprendere ogni cosa». Così, provando a muoverci nell’incertezza, sapendo quanto questa «può essere produttiva, persino sublime», alla ricerca di nuove metafore per pensare le tecnologie, ci iniziamo ad avvicinare alle nostre nuove streghe.
Coloro che hanno deciso di indossare le vesti delle cyberstreghe sono perfettamente consapevoli del portato politico e sovversivo dell’incarnare l’archetipo della strega, memori dello sterminio delle più di 100.000 donne che, tra il 1450 e il 1750, furono condannate per stregoneria in Europa. In riferimento diretto alle ricerche della filosofa Silvia Federici, sanno che sono proprio le conoscenze e il potere sociale delle donne a essere state rese abominevoli agli occhi della società. Questi saperi e questo potere femminili erano percepiti come “pericolosi” per l’ordine sociale-culturale-corporeo adatto ai ritmi della produzione capitalistica. La stregoneria, pertanto, ha costituito la stereotipizzazione di ciò che andava escluso dall’ordine discorsivo e materiale capitalistico: un insieme di pratiche che, attraverso la manipolazione di simboli, corpi, oggetti, segni e ambienti, hanno come obiettivo la creazione e la modificazione del mondo.
Nella costruzione del modello di sfruttamento capitalista della società industriale è stato necessario distruggere un certo ordine del mondo identificato proprio con l’universo femminile, improduttivo, “altro” e magico, in quello che viene definito il processo di disincanto del mondo a favore di una visione meccanicistica della natura e del razionalismo scientifico come veicolo di progresso. Oggi, nell’era del tardo capitalismo, il sistema razionalista/modernista sta crollando; al suo posto, si sono formalizzate nuove forme di potere connesso alla pervasività delle tecnologie digitali. Come si colloca in questo contesto il ripristino e la rivendicazione delle pratiche delle streghe?
La cyberstrega propone delle contro-azioni rituali apotropaiche che agiscono tramite le stesse architetture computazionali (dispositivi, oggetti, spazi smart interconnessi) per sovvertirle e riappropriarle
Ginevra Petrozzi, artista e designer romana espatriata in Olanda, si definisce una strega digitale. «Ci sono ancora persone che mi dicono: “ma è ironico”? No, in realtà è molto serio per me. La digital witch è la strega che utilizza gli elementi dello spazio digitale come se fossero i suoi nuovi ingredienti: invece che rose e rosmarino, lavanda e candele, utilizza algoritmi, tastiere predittive, backup e sistemi operativi. La strega ha una serie di strati di significato, oltre a semplice “praticante di magia” è un archetipo molto potente: protofemminista, caretaker, hacker, ribelle… Questa figura è confluita nei miei temi perché cercare di ribellarsi ai sistemi di potere, nel mio caso, si riferisce ai sistemi di tecno-potere, quindi dal tecnocapitalismo al capitalismo della sorveglianza».
Nella sua pratica artistica, Ginevra reclama il nostro diritto naturale al futuro. L’obiettivo è quello di immaginare una forma di resistenza a quello che la sociologa Shoshana Zuboff definisce il “mercato dei comportamenti futuri”, secondo il quale le corporations tecnologiche di oggi, come Meta, Google e TikTok, non solo estraggono e monetizzano i dati ricavati da ogni nostra esperienza, ma ottengono i dati più predittivi intervenendo attivamente sui comportamenti delle persone, persuadendole ad assumere quelli che generano maggiore profitto. «La prima qualità della strega è quella di contro-agire e quindi di controllare la realtà intorno a lei con le proprie capacità, con le proprie parole, con i propri strumenti e azioni», spiega Ginevra. Così, la cyberstrega propone delle contro-azioni rituali apotropaiche che agiscono tramite le stesse architetture computazionali (dispositivi, oggetti, spazi smart interconnessi) per sovvertirle e riappropriarle.
In Digital Esoterism, Ginevra Petrozzi esplora il modo in cui gli strumenti di divinazione possano essere rimodellati per rivendicare un senso di controllo rispetto ai big data, che si sono a loro volta trasformati in un’entità quasi magica capace di prevedere e programmare il futuro. Storicamente, la divinazione è stata utilizzata come metodo per acquisire un senso di controllo su un futuro misterioso e immateriale. Attingendo alla pratica della lettura dei Tarocchi – strumento divinatorio per eccellenza – Ginevra esegue letture simili a partire dal flusso infinito di immagini, video, meme, numeri, pubblicità che gli algoritmi generano sui nostri smartphone, e offre tecniche per interpretare e riappropriarsi del loro significato. Si ricollega alla studiosa Elena Esposito, secondo cui il nostro atteggiamento nei confronti dei big data non è così nuovo. Così come nell’antichità il futuro appariva inconoscibile agli uomini, ma non alla divinità, oggi il futuro appare inconoscibile agli esseri umani, ma non agli algoritmi. «Come l’uomo abbia mantenuto lo stesso atteggiamento nei confronti di una tecnologia (anche i Tarocchi sono una tecnologia) che promette una soluzione all’incertezza, questo è quello che definisco esoterismo digitale», spiega Ginevra. «All’interno di questo atteggiamento, l’esoterismo digitale ha prodotto nuove pratiche magiche che rispondono a nuove entità onniscienti».
Nel progetto Prophětai, che ho sviluppato con il collettivo Erinni in una residenza partecipativa nel 2022, il diritto al futuro è reclamato in maniera ancora più esplicita cercando di intaccare il mercato dei comportamenti futuri con un incantesimo parlato collettivo, recitato direttamente al proprio smartphone. Su TikTok si è diffuso un trend in cui gli utenti cercano di influenzare gli algoritmi dei social media pronunciando ossessivamente determinate parole vicino allo smartphone di un’altra persona. In questo modo, il proprietario dello smartphone inizia a ricevere suggerimenti e inserzioni che lo manipolano e lo inducono ad assumere determinati comportamenti. Ad esempio, in uno di questi video, una ragazza pronuncia ossessivamente “anello di fidanzamento/borsa di prada” al cellulare del fidanzato.
Prophětai si basa sulla stessa “credenza” o leggenda metropolitana che gli smartphone ci ascoltino, un po’ come entità magiche spiritiche che sorvegliano le nostre vite senza che gli utenti sappiano fino a che punto. Durante il laboratorio della residenza si è costruito collettivamente un futuro desiderato, scavando nelle necessità e nei desideri profondi di ogni partecipante, riportandolo al presente e traducendo queste visioni in nenie e combinazioni di parole magiche. Si è creato un intensissimo coro a più voci per smartphone in cui venivano invocati futuri più equi, semplici e inevitabilmente femministi. «La tecnologia ha assunto tantissime caratteristiche proprie del pensiero magico», spiega Ginevra Petrozzi. «Tra le tante, il fatto di essere vista come un’entità che funziona (intenzionalmente, N.d.R.) in un modo a noi non sempre troppo chiaro, soprattutto quando si parla di sistemi predittivi, algoritmi, big data, – tutti concetti molto astrusi. Sono entità che vengono controllate molto lontano da noi, nella Silicon Valley, da persone che scrivono codici di algoritmi che controllano tutti i nostri device digitali. Già questo si associa alle preoccupazioni del mondo magico e dell’ineffabile».
Per Ginevra, il pensiero magico costruisce il cosmo come un regno interconnesso, in cui esistono forze invisibili che possono ostacolare o interferire con le intenzioni e i desideri umani. Praticare la magia significa cercare di controllare, influenzare o reindirizzare queste forze dal basso. Nello specifico, la pratica di Ginevra fa riferimento alla Chaos Magic: una forma eclettica di magia che, invece di riferirsi a tradizioni specifiche, si basa su sistemi di credenze ibridi e flessibili, volti a modificare la realtà secondo i propri obiettivi. Così la magia e la stregoneria diventano mezzi fai-da-te di liberazione dal potere.
Rimanendo su questo tema, passiamo la parola ad un’altrə stregə, Cy X (classe 1999), artistə black queer con sede a Brooklyn, NY. Per Cy X la magia è cambiamento, trasformazione e intenzione. «Credere nella magia significa credere nel cambiamento e credere nel potere di cambiare te stesso, il tuo ambiente e di fatto il collettivo, poiché è tutto connesso», spiega Cy X. «È importante non confondere magia e tecnologia a causa di un’apparente mancanza di autonomia e di controllo nei confronti di quest’ultima, perché gran parte della magia riguarda l’intenzione, non la “mancanza di conoscenza”: la confusione sulle nostre tecnologie è spesso parte intenzionale della loro progettazione e la loro oscurità è il prodotto del gatekeeping e degli strumenti proprietari» .
L’artista fa riferimento ad Aleister Crowley, occultista inglese che intendeva la magia come «l’arte e la scienza di provocare cambiamenti secondo la volontà». Per cui, spiega Cy X in riferimento alle tecnologie digitali, «cosa c’è di più magico che usare simboli, codici ed energia per costruire mondi completamente nuovi che modificano anche me, l’ambiente che mi circonda e coloro che lo sperimentano?». La prospettiva di Cy X è fortemente connessa alla sua ricerca olistica come energy worker e alla sua identità non binaria e black, che, come appartenente alla Gen Z, è riuscitə a sviluppare in primis attraverso social media e internet. Sebbene sia consciə della loro problematicità, queste piattaforme sembrano anche poter sbloccare nuove forme di espressione e nuove profondità di visibilità per le persone che sono state rese “altre” dalle forme tradizionali di media, oltreché per esprimere e diffondere rituali. In linea con il pensiero della femminista Legacy Russel, l’artista fa riferimento al glitch informatico come errore sovversivo all’interno di macchine pre-settate e in costante movimento produttivo. Nel suo saggio Glitch feminism, Russell evidenzia come la natura disturbante del glitch sia in grado di illuminare le patologie inerenti alla macchina capitalista permettendoci di lottare contro la normalizzazione dei suoi sintomi, tra cui razzismo, sessismo, omofobia e xenofobia. Per Cy X, il glitch diventa veicolo di rifiuto – l’imprevisto capace di imporsi – sia nella sua poetica artistica che nella sua pratica magica.
In Ritual for release, l’artista espone un rituale di “rilascio delle energie” alla visibilità del cyberspazio. Documenta ciò che normalmente è considerato privato e segreto e lo integra con il linguaggio della post-produzione con un’estetica internet ugly, incorporando scansioni 3D del suo corpo e degli oggetti rituali (candelabri e candele). L’intenzione è di operare in una dimensione che si oppone al binarismo virtuale/Away From the Keyboard (AFK), ma che le comprende entrambe. In questo spazio, le energie magiche possono essere trasmesse anche a partire dal linguaggio video e digitale, sfidando il taboo tecnofobico di alcuni ambienti in cui si pratica la magia. Nel video, un altro elemento che emerge è l’esposizione del corpo “nero” dell’artista, e come questo sia feticizzato, erotizzato e “macchinizzato” dalle tecnonologie.
Questo tema diventa centrale in Gaze Make Me Glitch, in cui Cy X esplora come lo sguardo della supremazia bianca si riflette nel linguaggio binario dell’infrastruttura tecnologica computazionale, andando a definire la “realtà” e influendo sulla costruzione e rappresentazione del sé on/off-line. What kind of file is the body? What kind of file am I? What is the difference between me and the code for me? Facendo riferimento alle terminologie di coding, all’architettura computazionale di tipo master-slave, ai bias dei software di telecamere che non registrano le persone nere, l’artista riflette su come le tecnologie del capitalismo e del colonialismo si basino sul mantenimento del “mondo unico”, che, secondo la definizione del sociologo John Law, «privilegia sé stesso e nega la presenza di altri mondi». «Questo mondo unico è il mondo del master, la sua proiezione, completa di un proprio algoritmo, l’insieme di regole, relazioni e ideologie che compongono tutto ciò che molti conoscono come verità e realtà ultime», racconta Cy X. «Questi insiemi di regole, relazioni e ideologie compongono anche quella che, nella mia comunità magica, chiamiamo consensus reality o l’insieme delle credenze generalmente considerate vere. Questo algoritmo è ciò che ci comunica ciò che è e ciò non è possibile, e attraverso esso funziona negando altri mondi e altre realtà».
Cy X quindi irrompe nel “mondo unico”, attaccando il codice del master con l’errore sotto forma di incantesimo. Dapprima utilizza la pratica del data bending, che è il processo in cui si carica un file in un programma progettato per aprire un altro tipo di file (pensiamo, ad esempio, all’apertura di un file .mp3 in Adobe Photoshop). L’artista apre file che riguardano il suo corpo e quello di altri corpi neri usando diversi software, che ovviamente non li riconoscono. What kind of file am I and what program was designed to open me? It feels like any attempt to upload myself would result in databending. Così, l’artista decide di intervenire direttamente nei codici, glitchando i suoi selfie e manipolando l’ASCII (l’American Standard Code for Information Interchange) alla ricerca dell’American Standard Code for blackness, fino a rendere le immagini irriconoscibili. In conclusion, give me my fuckin body back. My body don’t have no creative commons license.
«Sebbene questo sia stato un esercizio digitale, i risultati sono dolorosamente familiari e ricordano il piccolo divario, o meglio l’inesistente divario, tra lo schermo e il mio essere AFK. Il problema non è isolato allo schermo. Mi è stato evidente, attraverso la mia tecnologia corpo/mente, che sapevo esattamente come si sentiva un glitch», racconta l’artista. Cy X usa la stregoneria e pratiche alchemiche per rivendicare la sua blackness e condannare il razzismo intrinseco delle tecnologie, contestando il modello del “mondo unico” per aprire nuovi portali su mondi altri.
Per incontrare l’ultima strega torniamo in Europa, più precisamente a Parigi. Lucile Olympe Haute, artista e ricercatrice universitaria, ha scritto nel 2019 il Cyber Witches Manifesto, un testo che è stato fonte di ispirazione e di condivisione per tantissimə cyberstreghe. Il manifesto fa esplicito riferimento all femminismo postumanista di Donna Haraway, che con il celebre Manifesto cyborg (1985) ha proposto il cyborg come metafora per superare il binarismo essere umano/tecnologia, uomo/donna, umano/animale. Per Lucile, la strega oggi rappresenta «un doppio movimento, tra stigmatizzazione e inversione; l’inversione dello stigma è una richiesta, un grido d’appello. Quanto al “cyber” che ho aggiunto alla parola, è per affermare che il nostro divenire-cyborg sia un dato di fatto: le nostre estensioni digitali sono organi che estendono i nostri corpi in diverse materialità. Il “cyber” di “cyber sorceress” è in definitiva la parte più banale della parola». Il manifesto è un’invocazione al triplice incrocio tra consapevolezza politica, emancipazione tecnologica e spiritualità che collega i movimenti del cyberfemminismo con quelli del neopaganesimo e dell’ecofemminismo. Nasce dalla necessità di riunire tre mondi di cui lei stessa fa parte.
Dall’incantesimo come protesta ludica alla creazione di comunità, le cyberstreghe offrono un grande potenziale di cambiamento e sperimentazione nell’era digitale
«Io sono parte del Reclaiming, un movimento di origine americana che combina il neopaganesimo, che recupera tradizioni spirituali, con i principi ecologici e con l’attivismo femminista», spiega Lucile Olympe Haute. «Una delle sue attiviste più conosciute è la scrittrice femminista Starhawk. L’altro mondo è quello dell’attivismo tout court trasfemminista, queer, fortemente impegnato politicamente, per il quale la strega è un emblema di ribellione ma svuotato delle sue pratiche spirituali, magiche e di cura. Infine il mondo più difficile da coinvolgere che è quello della open source community, hacker e maker, e che è fortemente connotato da una presenza maschile». Il manifesto è un invito a riunirsi e ripensare collettivamente la questione della “sovranità tecnologica” ricalcando lo stile e i temi centrali dei manifesti dei molti gruppi di artiste e teoriche cyberfemministe del passato, che sin dalla prima diffusione di Internet hanno messo in evidenza le dinamiche di potere insite nella progettazione delle tecnologie. Tra queste, le pioniere VNS MATRIX già nel 1991 ci invitavano a sabotare il “paparino mainframe”.
«Uniamo le nostre voci: “Noi non difendiamo la natura, siamo la natura che difende sé stessa” […] Riconosciamo che gli strumenti del padrone non smantelleranno la casa del padrone. Le stesse tecnologie che erano motivo di sognare nuove forme di empowerment politico si sono rivelate mezzi di sorveglianza e controllo per tutti. È tempo di uscire dai labirinti dualisti. Ma non facciamo come Icaro: le Sirene sono nostre sorelle e siamo troppo appassionate della sensualità delle pietre e della tenerezza degli alberi per cedere all’orgoglio transumanista […] Professiamo l’autonomia tecnologica e tutte le forme di emancipazione e di empowerment. Ispiriamoci a W.I.T.C.H., VNS Matrix, Gynepunk, Reclaiming, tecnosciamanesimo, xenofemminismo, iperstizione, afrofuturismo e ancestorfuturismo senza aderire completamente all’uno o all’altro»
Il manifesto di Lucile presuppone «la magia come l’arte di cambiare prospettiva a piacimento», ricalcando la definizione di Dion Fortune, celebre occultista e psicoanalista inglese di inizio Novecento. L’idea centrale è la consapevolezza che “la finzione cambia il mondo”. Manipolare segni/significati, immagini e linguaggio dà forma al nostro ambiente, in quanto i simboli hanno efficacia sia psicologica che politica. «Le nostre apparecchiature tecniche contemporanee di tutti i giorni partecipano alle nostre forme rituali. Eseguiamo rituali tecnofili. Facciamo i gesti. Diciamo le parole. Manipoliamo gli oggetti. Evochiamo sopravvivenze archetipiche. […] Pratichiamo quest’arte di trasformare la coscienza secondo la nostra volontà. Diventiamo cyber-streghe».
Cy X, Lucile e Ginevra ci hanno accompagnato per mano in questa oscurità computazionale, abbracciandone la complessità senza volerci indicare direzioni prestabilite. Nel loro definirsi “cyber” o “digital” hanno intimamente superato il binarismo essere umano-macchina nella pluralità delle loro infinite combinazioni e configurazioni. Le tecnologie antiche, industriali o digitali sono rivendicate come processi trasformativi intrinsechi alla nostra esistenza, parte del nostro ecosistema. Come ci ha detto Lucile, nell’autodefinirsi “strega” c’è anche una presa di posizione politica e un cambiamento di paradigma. Assumendo questo ruolo, ci si fa portatrici di uno stile di vita che accoglie l’altro, ossia le forme di comportamento, le pratiche e le visioni che sono state escluse e condannate sin dalla caccia alle streghe nel progetto della modernità.
Tutte e tre le artiste ci offrono esempi per utilizzare l’arte e il design come metodo: le loro pratiche passano per i musei ma il fine ultimo è quello di tornare nella comunità e attivare relazioni. Ginevra organizza Holistic Technology Salon, incontri di comunità al museo in cui discutere di tecnologia e guarigione. Cy propone sessioni di guarigione e letture dell’aura tramite il creative coding, Lucille svolge quelli che definisce “micro rituali collettivi” e pratiche di divinazione femminista. Queste cyberstreghe propongono intime connessioni con il mondo attraverso la provocazione centrale della magia: attivare i sistemi di credenza in uno spazio in cui non dovrebbero essere attivati. E la credenza non religiosa sembra una precondizione per politiche conviviali di coesistenza, lavoro gioioso, cura e relazionalità non gerarchica.
Nell’incontro con le artiste in questione, ciò che ho trovato estremamente brillante (e politicamente prezioso) – ciò che mi ha concretamente spinta a rimodulare la mia prospettiva – è il fatto che le cyberstreghe operano facendo effettivamente deflagrare quello che Cy definisce “il mondo unico”: il mondo moderno e egemone, nato dalla coalescenza di colonialismo, capitalismo e scienza. Dando forma all’entropia e alla “miseria simbolica” che caratterizzano il momento attuale, queste nuove streghe ci indicano dei possibili pattern da seguire nel crollo di ogni universo ordinato di significati. Dall’incantesimo come protesta ludica alla creazione di comunità, le cyberstreghe offrono un grande potenziale di cambiamento e sperimentazione nell’era digitale, rivoluzionando il nostro immaginario e aprendo all’intuizione di altri mondi possibili oltre il disastro.
Questo contributo è parte della prima sezione del progetto di ricerca curatoriale di Arianna Forte “Casting a spell in computational regimes: pratiche rituali per una controapocalisse trans-femminista”, ed è il frutto di una primissima ricognizione sul tema. Il progetto è sostenuto dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura nell’ambito del programma Italian Council (2023). Di proposito in questa sede non sono state prese in considerazione le pratiche artistiche che hanno a che fare con il corpo, il biohacking e i pregiudizi e bias della medicina e della scienza, che sono al centro della seconda parte della ricerca in questione.
Può la cultura di Internet allo stato attuale resistere all’entropia e sfuggire alla registrazione infinita mentre fa fronte alla propria fine senza fine? Questa è la domanda che ci ha lasciato in eredità il filosofo francese Bernard Stiegler, scomparso nell’agosto 2020. Un’antologia su questo tema, intitolata Bifurcate: “There Is No Alternative”, è stata scritta durante i primi mesi del COVID-19: portata a termine poco prima della sua morte, è basata sul suo lavoro e redatta in consultazione con la generazione di Greta Thunberg. Bifurcate è anche un progetto per la giustizia climatica e l’analisi filosofica, firmato collettivamente sotto lo pseudonimo Internation. “Biforcare” significa dividere o bipartire in due rami. È un appello a ramificarsi, creare alternative e smettere di ignorare il problema dell’entropia, un quesito classico della cibernetica. Conosciamo il disordine nel contesto della critica di Internet come un problema dovuto al sovraccarico cognitivo, associato a sintomi psichici quali la distrazione, l’esaurimento e l’ansia, aggravati a loro volta dalle architetture subliminali dei social media estrattivisti. Stiegler chiamò la nostra condizione l’Entropocene in analogia con l’Antropocene: un’epoca caratterizzata dal “massiccio aumento dell’entropia in tutte le sue forme (fisiche, biologiche e informative)”. Come Deleuze e Guattari avevano già rilevato, “Non ci manca certo la comunicazione, anzi ne abbiamo troppa; ci manca la creazione”. Il nostro compito, perciò, è creare un nuovo linguaggio per comprendere il presente con l’aspirazione di fermare e superare l’avvento di molteplici catastrofi, esemplificate dal concetto plurimo di Extinction Internet.
Mentre Bernard Stiegler e altri hanno sottolineato come il disastro ecologico abbia bisogno di essere teorizzato sia a un livello fisico che biologico e psicologico, adesso l’enfasi dev’essere messa sulla riduzione dalla conoscenza all’informazione, alle conseguenze per le abitudini, le pratiche e le disposizioni psicosociali. Negli ultimi tempi, mi sono interessato a come la politica e l’estetica del rumore e della disattenzione influiscano sugli stati psichici (e ciò vale in special modo per le generazioni più giovani). Resta ancora da vedere se questi studi sull’ansia, la rabbia e la tristezza in rete possano fornire strumenti di partenza per la creazione di alternative valide.
Di recente ho iniziato a dubitare della mia tesi secondo cui un’analisi critica della desolazione psichica degli utenti digitali possa essere un primo, cruciale passo verso l’organizzazione, la mobilitazione e, infine, il cambiamento. La mia generazione ha scoperto in fretta che – per usare la terminologia di Derrida e Stiegler – Internet è un pharmakon: tossico e curativo. La critica agli assunti impliciti di Internet, a partire dalla Californian Ideology, è dunque sia un ripudio che un’affermazione. Ma quindi come possiamo riunire analisi e critica in reti di comunicazione radicali e funzionali per fare la differenza in termini di ricerca, politica e sviluppo di alternative?
Anzitutto la diagnosi, poi la riabilitazione. Questi sono i due passi fondamentali per intraprendere il processo di guarigione. Per quanto mi riguarda, queste idee mi riportano a due opere che hanno definito il mio Werdegang intellettuale. In primo luogo, Fantasie Virili di Klaus Theweleit, in relazione ai danni a livello psichico della classe operaia tedesca e come questi l’abbiano resa suscettibile alle promesse del partito nazista per la riconquista della propria dignità persa. E in secondo luogo, Massa e Potere di Elias Canetti, un classico dell’ormai defunta disciplina della “psicologia di massa” […]. Per ambedue, la storica domanda antifascista è, ancora una volta, la domanda di oggi: come demolire l’armatura psichica del fascismo? Come mai le persone sono sempre più suscettibili alle teorie del complotto, alle fake news e ai miti sull’immigrazione? Fornire informazioni “oggettive” e corrette non induce la smitizzazione. Il neopositivismo non ci porta da nessuna parte, ma si limita a riprodurre i modi dominanti propri della supremazia. C’è un’amara lezione che proviene dal passato: il dialogo non vincerà sul fascismo.

Provare a decifrare il codice fascista è stato uno dei tanti compiti della mia generazione: la generazione di mezzo cresciuta all’ombra della seconda guerra mondiale, della guerra fredda e del retaggio del Sessantotto. Il fascismo può anche essere stato sconfitto (a un alto prezzo) sul piano militare, ma le sue radici permangono. Durante la ricostruzione del dopoguerra, contrassegnata dalla guerra fredda e dall’accordo tra le classi, le radici del fascismo non vennero chiamate come si deve, figuriamoci estirpate. Non è un caso che la domanda sul come progettare e vivere una “vita antifascista”, per come l’ha formulata Michel Foucault, sia emersa negli anni Settanta, quando la recessione e l’austerità avevano fatto ritorno in Occidente. Andiamo avanti di cinquant’anni e la domanda può essere riformulata in questo modo: che tipo di “tecnologie digitali del sé” dovranno essere progettate per conoscerci in modi antitetici ai regimi normativi? Come vivere una vita fuori dalla piattaforma pur godendo dei benefici delle reti sociali?
Una delle componenti base per una critica dell’attuale stato tecno-sociale sarà una versione radicalmente rivista della psicoanalisi del XXI secolo. Ne Il Terzo Inconscio, il teorico italiano Franco Berardi propone una psicoanalisi che debba “assumere questo orizzonte di caos e di estinzione come un punto di partenza per una nuova riflessione”. Scrive poi della scoperta dell’inconscio nel XVIII e XIX secolo e di come abbia portato al fondamento della psicoanalisi al contempo come terapia e strumento di analisi culturale. In contrasto con l’accento che i suoi padri fondatori posero sulla negazione e la sublimazione, la seconda versione dell’inconscio associata a Lacan, e ancor di più a Deleuze e Guattari, sottolineò l’elemento della produzione: non la repressione ma l’iperespressione. Per questi ultimi, infatti, l’inconscio non era un teatro ma una fabbrica, gettato “all’inseguimento di una gioia che sfuggiva però continuamente, stimolando i frenetici tentativi di essere vincitori, generalmente frustrati dalla realtà”.
Come salvare il “tecno-sociale” dalle mani della Silicon Valley e del controllo statale senza necessariamente ricadere nel romanticismo offline o nel comunalismo difensivo e richiuso in se stesso?
Cinquant’anni dopo la liberazione del desiderio, Berardi propone di guardare le cose da una nuova angolazione: un terzo inconscio che ruota intorno all’analisi della dimensione tecno-sociale della psiche, in un mondo che non è più incentrato sulla crescita e sulla (schizo)produttività, ma sull’estinzione, l’ansia e la decrescita. Ketamina mescolata a Instagram e punk dal vivo. La mente umana ha raggiunto uno stato di saturazione. Berardi analizza e sottoscrive lo sviluppo di nuovi strumenti critici che possano aiutare a comprendere lo spettro odierno della sensibilità mentale e dell’attenzione emotiva. Dobbiamo esercitarci a “correre lungo la dinamica del disastro”, che egli reputa una descrizione accurata della “nostra condizione mentale durante l’attuale terremoto, che è anche un terremoto dell’anima e un terremoto mentale”. Secondo Berardi “il fascismo è una reazione psicotica all’impotenza”, come Theweleit ha dimostrato in precedenza nel suo Männerphatasien. La transizione senza interruzione dal COVID alla guerra in Ucraina, l’inflazione e la crisi energetica hanno soltanto rincarato il collasso del circuito bio-info-psichico sotto il peso dello stack delle crisi. A ogni nuovo shock ci muoviamo più in alto e ancora più in basso, sfogliando l’“atlante verticale” dei conflitti.
Nella mia lettura de Il Terzo Inconscio, le tecnologie dei media sono entrate nel corpo in modo tale che corpo e anima non possono più essere separate dall’infosfera semiotica. Non è solo la fisionomia a essere cambiata. Pensiamo, per esempio, ai neuroni nel nostro cervello che riorganizzano la possibilità stessa di come pensiamo, o ancora la fatica che sentiamo nei nostri occhi, nelle dita e in tutto il nostro corpo dopo l’ennesima sessione su Zoom. Questo è il modo in cui le tecnologie dell’estinzione operano per vie che si diramano attraverso tutta la società.
Franco Berardi rimane uno dei pochi intellettuali europei con una sensibilità sismografica fenomenale per gli stati oscuri delle menti delle ultime generazioni, incollate ai loro dispositivi. Leggere il polso in questo modo, in sintonia con la Gen Z – la prima generazione a sperimentare Internet come un dato di fatto, una sfera fissa – è qualcosa che Berardi condivide con Bernard Stiegler. C’è una strategia globale condivisa in gioco: una forte convinzione che la società debba, prima di ogni altra cosa, affrontare l’abisso. È qui che viene destinato il malcontento politico, nel cuore dell’inconscio sociale. È certo che la negazione accelererà ulteriormente le crisi in corso – ma nell’interesse di chi? L’ottimismo New Age va di pari passo con il controllo della percezione pubblica. Questo è il motivo per cui “pillola rossa o pillola blu” è il tema centrale della nostra epoca. Invece di somministrare un’altra volta procedure disfunzionali, una via d’uscita potrebbe essere quella di rappresentare – e mettere in pratica – l’atto farsesco della scomparsa e della ricomparsa (ma senza registrazione).
È tempo di sperimentare una procedura circolare di inizio e fine, in contrasto col ritorno senza fine dei tropi dell’ottimizzazione e dell’austerità. Secondo Berardi, il “circuito bio-info-psichico” deve essere elaborato prima ancora di varcare la soglia in cui ci troviamo. È necessaria un’elaborazione collettiva che si occupi di “segnali, gesti linguistici, suggestioni subliminali, convergenze subconscie. Questo è lo spazio della poesia, l’attività che plasma le nuove disposizioni della sensibilità” espressa in meme dai toni ironici, video divertenti, balli e gesti, recepiti in momenti di intossicazione estatica, i quali ci trascinano sempre più in profondità nel vortice della musica e dell’esperienza visuale.
Quali tipi di pratiche artistiche fanno la differenza in questo contesto? A mio parere, l’estetica investigativa, volta a mappare le prove raccolte, inventare concetti e critiche partendo dalla riorganizzazione della realtà, non può che esistere all’inizio di un processo di trasformazione radicale. In seguito, tutto ciò contribuirà a un più ampio movimento di scrittura e analisi della storia dell’arte nel campo umanistico: un nuovo paradigma, se vogliamo, che non si limiti a replicare il movimento Digital Humanities, ma che si distinguerà dalla tendenza di quest’ultimo a concentrarsi sulla digitalizzazione degli archivi, in aggiunta all’analisi dei dati, innamorata di numeri, grafici e scale di valori. Siamo andati al di là del tempo delle “competenze digitali” a scopo di beneficenza e ci siamo immersi nella politica globale dei bisogni digitali. In questa fase, il progetto dell’estetica investigativa non perde di vista la questione del potere: reindirizzando la contesa politica sulla verità, contrastandone le narrazioni sull’autorità e l’espediente egemonico con la veracità degli oppressi, si concretizza in ultima istanza attraverso un’estetica computazionale impostata lungo assi spaziali e temporali.
C’è un’estetica del collasso che la cultura di Internet trasmette, rappresenta e riproduce. Affrettiamoci a scrivere la storia della labile cultura online: gli altri non lo faranno per noi
Può il “sé digitale” sfuggire alla trappola del vanity marketing? È possibile sperimentare la libera cooperazione e l’azione collettiva per fuggire dalla gabbia dell’io? Come salvare il “tecno-sociale” dalle mani della Silicon Valley e del controllo statale senza necessariamente ricadere nel romanticismo offline o nel comunalismo difensivo e richiuso in se stesso? Questo è un progetto politico e appassionato di molti amici italiani con i quali ho il privilegio di lavorare, tra cui Donatella Della Ratta, Tiziana Terranova e innumerevoli altr*. Il punto di partenza è anzitutto un’inversione dialettica abbastanza convincente. Il sociale è visto come una forza catalizzatrice primaria: un potere sovrano che a sua volta innesca invenzioni e nuove forme di produzione e riproduzione, invece di venire ritratto come un prodotto di movimenti storici su larga scala, come il capitalismo, l’industrializzazione, l’imperialismo, il patriarcato o il colonialismo. Da qui, la rete sociale può essere meglio definita come il reale motore delle tecnologie immaginarie – di volta in volta bersaglio dell’espropriazione capitalistica – per loro natura reattive, ma che alla fine obbligano il sociale alla resa. Insieme dobbiamo invertire questa tendenza e restituire al sociale la sua autonomia e risolutezza. Nonostante le battaglie perse, il tecno-sociale detiene il suo potere trasformativo ed è tutt’altro che una vittima indifesa. Questa è un’intuizione importante se vogliamo ostacolare la società tecnologica durante la movimentata “seconda crisi del petrolio”, per esempio, andando oltre quel disastro energetico che sono i data center, progettando nuove architetture computazionali di ridistribuzione in grado di complementare il diritto esclusivo di navigare le nostre librerie offline.
Gli italiani ci insegnano a prendere molto sul serio questa domanda: che cos’è il sociale oggi? Quarant’anni fa avremmo risposto: “i movimenti sociali autonomi”. Trent’anni fa le comunità ispirate ai media tattici, vent’anni fa i social network e il Web 2.0 e un decennio fa la piattaforma. Cosa altro c’è da offrire, a parte una chiamata ben intenzionata a tornare ai valori del software libero? Sul piano interpersonale, Franco Berardi propone una “conversione psico-culturale in favore della frugalità e dell’amicizia”. Con il mio amico di Sydney, Ned Rossiter, ho pensato a delle “reti organizzate”; eravamo certi che queste reti avessero forti legami con un’estetica distribuita e sviluppata su numerosi nodi e località, in opposizione alle strutture di rete classiche che hanno legami deboli e tendono a disgregarsi facilmente. Le reti organizzate rimangono ancora una promessa e così anche il potenziale irrealizzato di una “critica di Internet”. Un ritorno dell’appartenenza a organizzazioni come un partito, come mezzo per rivendicare il potere politico, sembra ancora più improbabile di quarant’anni fa quando studiavo questo argomento. Come trasformare il malcontento e la contro-egemonia in un’efficace transizione di poteri nella tarda età della piattaforma? La questione dell’organizzazione rimane ancora molto rilevante, non soltanto per i vari movimenti di protesta, ma anche, nel nostro caso, per artisti e designer e altri lavoratori nomadi e precari.

“Convincimi che questa non è l’era oscura digitale”, ha esordito Regina Harsanyi su Twitter nel 2022. La perdita di spazio privato sembra reale. E per molti versi lo è. Siamo stati trascinati in un buco nero virtuale. Eppure, c’è bellezza nel collasso. La ricerca sui meme radicali ce lo insegna da anni. C’è un’estetica del collasso che la cultura di Internet trasmette, rappresenta e riproduce. Affrettiamoci a scrivere la storia della labile cultura online: gli altri non lo faranno per noi. Dopo tre decenni, c’è una sensazione ancora più pressante che incombe su di noi e che va oltre la mappatura passata della regressione e della stagnazione, inclusi i loro rispettivi stati oscuri. Come disse Brecht: “Poiché le cose sono come sono, le cose non rimarranno come sono”. Ora la possibilità dell’estinzione di Internet è pensabile. Questo è il momento della nostra Scomoda Verità. Non solo infinite possibilità sono implose a causa del realismo digitale, ma ci affacciamo anche sull’orizzonte esistenziale della finitezza. Ma non è quello dei protocolli TCP/IP o della commutazione di pacchetto. Extinction Internet segna la fine di un’epoca di immaginazione collettiva che per molti versi ha dimostrato come organizzazioni tecnologiche verticali e orizzontali erano alternative possibili. Non uno stack ma molti piani.
La stagnazione e la recessione sono state cartografate in dettaglio; il compito è ora quello di teorizzarne la fine. La distruzione si sussegue alla decostruzione. L’ottimismo istituzionale non ricompenserà nessuno per gli allarmismi sul disastro, così come le critiche di Internet e le sue alternative sono cadute nel vuoto nel periodo pre-apocalittico. È tempo di infondere il freddo approccio manageriale della governamentalità algoritmica con l’hauntologia di Mark Fisher. Dobbiamo svegliarci e capire che il blackout è diventato sistemico. Le mode cripto-nichiliste del “far soldi facili” sono tecnologie dell’Ultimo Giorno. Ma che succede dopo che l’invisibile è diventato visibile e siamo andati oltre la vuotezza del nostro pensiero? L’odore dell’estinzione è nell’aria. Il realismo darwinista afferma che è una tua scelta quella di rimanere povero e disconnesso, al freddo, al caldo, nella siccità o nell’inondazione. È il momento di fare uno sciopero, uno sciopero contro l’ottimizzazione. Basta fare migliorie. Fermiamo l’incremento dell’efficienza e l’aumento della produttività. È tempo di insegnare il problem design. È ora di inventare dei provocatipi.
Consultiamo Angelicism01, la mia Greta Thunberg nichilista, una poetessa e-girl, teorica e personaggio virtuale tutto assieme, che scrive: “Internet è impossibile. Non ci penso perché mi schiaccia. Un giorno su Internet è tutto. Non posso dire se Internet finirà. Tuttavia, so che l’estinzione è vicina”. E aggiunge: “L’estinzione cambia. L’estinzione è uno scambio. L’estinzione stessa sta cambiando. Questo è ciò che dicono le macchine della trasformazione. Questo è ciò che significa andare fino in fondo con la mutazione. Internet e l’estinzione sono indissolubilmente legati. Far esperienza di Internet significa far esperienza dell’estinzione”.
Che cosa potrebbe occupare il vuoto nella nostra psiche deframmentata dopo che Internet ha lasciato la scena? E in cosa potrebbe consistere la vita dopo che le nostre fragili menti non saranno più aggredite dagli effetti anestetizzanti e deprimenti del doom scrolling?
La tecnica in quanto tale non estromette dagli interrogativi. Solo perché siamo immersi in questo sistema non significa che siamo catturati dalla sua presunta totalità. I social media sono progettati per fare doom scrolling. La deautomatizzazione di Internet in questo contesto basterebbe a spezzare le abitudini ripetitive che penetrano nelle viscere dei corpi connessi. C’è qualcosa di liberatorio nel perdere il proprio profilo per un qualche atto di dimenticanza. Che cosa potrebbe occupare il vuoto nella nostra psiche deframmentata dopo che Internet ha lasciato la scena? E in cosa potrebbe consistere la vita dopo che le nostre fragili menti non saranno più aggredite dagli effetti anestetizzanti e deprimenti del doom scrolling? I neuroni post-Internet sono il regno di una nuova e duratura riserva di immaginazione e reinvenzione della cognizione, i mattoni fondamentali della società. Questa era la lezione di Stiegler.
Extinction Internet non è semplicemente una fantasia apocalittica della tecnologia digitale che un giorno sarà spazzata via da un impulso elettromagnetico, scatenato da un’arma di distruzione di massa in un breve istante. Extinction Internet è la fine di un’era di possibilità e speculazioni, e in cui l’adattamento non è più un’opzione. Il lutto per la scomparsa di Internet ha avuto inizio da prima, quando la piattaforma estromise l’immaginario collettivo. Sembra che un altro Internet non sia più possibile. L’utente-programmatore è condannato a vivere come uno zombie, scorrendo con il dito e scrollando senza pensare: non più padrone della propria attività. Mentre in un passato recente avevo descritto questo comportamento a un livello subliminale o subconscio, nella fase successiva l’intermediario è decretato cerebralmente morto. Mentre uno stato di profondo sopore sta rapidamente emergendo, i nostri gesti informatici di tutti i giorni funzionano ancora in maniera automatica.
Lo sforzo dovrebbe essere quello di allungare il tempo, rivendicare e squattare il futuro di Internet e insieme progettare configurazioni spaziotemporali autonome che consentano a riflessioni e attività inutili di essere sviluppate. Il post-Internet sarà venduto come una tecnologia irreversibile. Come contrattacco dobbiamo ripensare gli attuali sistemi che stanno causando un deficit di memoria e conoscenza. Il progetto non è soltanto quello di affermare l’estinzione del protocollo Internet, ma allo stesso tempo di superare la sua corrispondente depressione programmata.
“Le crisi, siano quelle del capitalismo oppure della protesta”, scrive Matt Colquhuon, “non generano più nessun cambiamento; la negatività distrugge il vecchio ma non produce più il nuovo”. Allo stesso modo, ho dovuto provare sulla mia pelle che né la critica della rete né la psicoanalisi collettiva del sé digitale porteranno al cambiamento. Il nostro compito sarà, per usare le parole di Bernard Stiegler, “mettere gli automatismi al servizio di una disautomatizzazione negentropica”. La strategia per superare l’entropia può includere la disautomizzazione di tutto, da un esodo dai social media, alla demolizione dei centri dati, al reindirizzamento dei cavi in fibra ottica, al ritiro di Siri e Alexa.

Invece di prendercela con discipline accademiche già affermate, dobbiamo andare al di là e fare un’analisi amorale della situazione attuale, in cui avremo prefigurato la scomparsa di Internet. “Internet non esiste”, scrive Angelicism01. “Forse esisteva soltanto poco tempo fa, tipo due giorni fa. Ma ora rimane solo in quanto sfocatura, specchio, doxa, scadenza, reindirizzamento, 01. Se mai è esistito, non potevamo vederlo. Internet è scomparso, nessuno può portarci con sé. Quando non esisti, lo spazio in te continua a fingere di essere”.
Paul Virilio e Jean Baudrillard mi hanno insegnato fin dall’inizio l’esistenza di un’estetica della scomparsa. Dobbiamo scoprire come mettere in scena un’estinzione elettronica alternativa e radicale invece di affrettarci a dichiarare: “Internet è morto, lunga vita a Internet”! Un’altra fine è possibile. Questo non avverrà semplicemente prendendo d’assalto i generatori di energia elettrica come stanno facendo gli invasori russi in Ucraina o installando, rimuovendo e reinstallando una tra le connessioni Star Link di Elon Musk. Forse abbiamo già esaurito il tempo restante per fare della ricerca essenziale; il minimo che possiamo fare è dare supporto agli artisti, ascoltare attentamente la loro immaginazione cosmotecnica e “cli-fi”.
Non solo nella biosfera, ma anche nell’infosfera, la perdita di diversità è entropica, è sterilizzante e fragile: collassa su se stessa. Reti sociali al servizio della critica in rete, computing al servizio del digital detox e progettazione di app alternative in nome della prevenzione dei dati, non solo della protezione. Che cos’è la decrescita di Internet, il machine unlearning, l’idiozia artificiale? Questo è il modo in cui il pensiero farmacologico e i flussi della riflessione possono essere riconvertiti in prassi funzionali per la progettazione. La sfida allora, nello spirito di Stiegler, consiste nell’introduzione di improbabili e incalcolabili biforcazioni nell’istruzione superiore per mettere in pratica concetti, protocolli e prototipi di ripristino. Con Anaïs Nin, possiamo dire che il canale di comunicazione che ci piace “deve essere un’ascia per rompere il mare di ghiaccio che è dentro di noi”.
La proposta riguarda una concezione delle reti sociali con un accento sulla cura, nonché gli strumenti per il calcolo intergenerazionale a loro volta utili per la risoluzione dei problemi a ciascun livello dello stack di crisi. Questo è il tipo di pensiero integrato in cui la questione non è più su cosa fare del flusso infinito di app scaricabili che vanno e vengono, da TikTok, Ethereum, Dall-E, Zoom e Clubhouse a BeReal e i loro secondi fini legati all’estrazione informatica. Piantiamola di costruire soluzioni alla Web3 per problemi che non esistono, e promuoviamo strumenti che decolonizzano, ridistribuiscono i significati, cospirano e organizzano. Come Bogna Kronior ha spiegato in un tweet: “Non voglio la libertà di parola. Voglio una rete che non sia connessa al meatspace e che non renda tutto un concorso di popolarità e narcisismo gravato da dipendenza da dopamina. Bisogna spersonalizzare, fare padroni i nostri occhi e i nostri sistemi nervosi; basta con l’economia dell’identità. Non più dipendenti dalle piattaforme, controllati da autorità invisibili e distanti”.
Il nostro compito in veste di teorici, artisti, attivisti, designer, sviluppatori, critici e altri irregolari sarà quello di andare oltre la ripartizione e sviluppare una modestia radicale per quanto riguarda le potenzialità del digitale. Dobbiamo biforcarci in modo da poterci muovere verso nuovi orizzonti
Cos’è la decrescita di Internet nel momento in cui il numero dei suoi utenti ha superato i cinque miliardi? Jean Baudrillard ci ha insegnato che l’esplosione dell’informazione è vissuta come un’implosione. Che succede quando le smart cities collassano nel buco nero del metaverso? Quando le società post-COVID si misurano con il rifiuto del lavoro? Che significa quando rappiamo “dicendo la verità alla piattaforma” e condividiamo video di “propaganda climatica”? Che significa la parresia nel contesto di Internet, al di là della libertà di parola democratica? Quali sono le nostre preoccupazioni ambientali al di là dell’uso di elettricità dei centri dati e le procedure di cripto-mining, estremamente inefficienti dal punto di vista energetico?
Il nostro attuale stato cosmotecnico, come lo chiama Yuk Hui, è definito da un inquietante groviglio di accelerazione degli eventi storici e stagnazione sociale. La cosmotecnica ha luogo quando non c’è più ritorno alla fase innocente della globalizzazione, e aggiungiamo l’incertezza sulla questione della resistenza all’isolazionismo geopolitico. Questo stato di confusione porta a tecno-mostruosità: dall’ideologia cripto della destra libertaria, a fake news e deep fake, ai bias dell’intelligenza artificiale. L’aspettativa che le decisioni politiche guidino e tengano a bada questi progressi tecnologici è stata quasi del tutto abbandonata. Neppure i mercati lo faranno. Insieme a Pieter Lemmers, Yuk Hui scrive: “La verità del nostro tempo è una verità a cui, secondo Stiegler, praticamente tutti preferiscono chiudere gli occhi poiché è troppo traumatica, inconcepibile e spaventosa. Parla non solo del possibile, ma anche della fine piuttosto probabile e imminente dell’umanità, o almeno della civiltà umana come la conosciamo”. Anche quei pochi e ricchi “prepper” che si rifugiano nei bunker sepolti in Nuova Zelanda, o che si preparano a un esodo nello spazio, sono altrettanto condannati. Nessuno sfugge al collasso della civiltà combinato al disastro climatico. La notizia dell’estinzione di specie è un dato incontrovertibile.
Le fini di Internet che conosciamo, o più precisamente, la fine delle culture della rete per come le abbiamo conosciute (e studiate), è sempre più vicina. Nell’ultimo decennio Internet è rapidamente cambiato da uno stadio freddo e positivo a essere esso stesso parte del problema, incapace di invertire le proprie tendenze distruttive. Forse abbiamo già passato il punto di non ritorno. Zittire i non-umani non funziona più come una volta. Come rispondere alla domanda retorica di Douglas Rushkoff (“programma o sarai programmato”) adesso che l’open source e il software libero sono moralmente in bancarotta a causa dei loro sell-out aziendali e, di conseguenza, hanno perso il loro fascino sulle generazioni del futuro? Che succede quando neanche i tedeschi riescono ad affrontare le loro shitstorm e i francesi riportano in voga gli insegnamenti della collassologia? In breve, che significa quando diciamo che Internet ha compiuto una svolta catastrofica ed è diventato irreparabile?
Pensiamo un attimo a Infinite Detail di Tim Maughan, una storia di fantascienza dell’immediato futuro sviluppata attorno al concetto di un interruttore d’emergenza. Un attacco informatico spegne definitivamente Internet, provocando la fine del mondo per come lo conosciamo. Il taglio dei cavi oceanici e gli attacchi alle telecomunicazioni e ai centri dati stanno accadendo mentre stiamo parlando. Stiamo ritornando alle origini militari della cibernetica e di Internet, alle opere di Paul Virilio e Friedrich Kittler che hanno determinato le mie basi intellettuali fino ad oggi. Se Internet prometteva resilienza, il collasso è ormai reale.

Extinction Internet concerne la decrescita, la fine dell’estrazione dei dati e, sì, anche quei momenti in cui gli schermi diventano neri e il doom scrolling si arresta di colpo. Ma è anche una questione di progettazione d’emergenza, una promessa radicale che afferma che l’implementazione dei principi di prevenzione dei dati nei dispositivi e nelle app è ancora possibile se diamo per assunto che raggiungeremo presto il “picco dei dati” e che i provvedimenti in corso come l’intelligenza artificiale “etica” e i “buoni dati” non saranno in grado di produrre né giustizia sociale né la fine del capitalismo razziale né la scongiura della catastrofe climatica. Per dirla in termini post-apocalittici e fantascientifici: non solar punk ma lunar punk.
A livello di stati psichici, negli ultimi tempi ci siamo concentrati principalmente sul deficit d’attenzione indotto dalla piattaforma, sull’impotenza riflessiva e sull’edonia depressiva, come le aveva descritte Mark Fisher. Questa situazione d’allarme ha trovato il suo corrispettivo nella solastalgia, “una forma emergente di depressione e angoscia causata dai cambiamenti ambientali, come i cambiamenti climatici, i disastri naturali, le condizioni meteorologiche estreme e/o altre alterazioni negative o sconvolgenti dell’ambiente o della propria casa”. Con milioni di rifugiati climatici, siamo sfidati a pensare insieme a uno “stack di crisi” in cui la dipendenza dalla piattaforma è solo una tra le nostre tante e urgenti preoccupazioni.
Il fatto che Internet stia accelerando i problemi del mondo e divenendo sempre più una parte del problema sta raggiungendo il consenso generale. I protocolli presumibilmente “buoni” e la decentralizzazione attraverso le “rete di reti” si sono entrambi rivelati incapaci di tenere testa alle piattaforme centralizzate e al controllo autoritario. Al contrario, questi approcci si sono dimostrati suscettibili a un ulteriore controllo, inadeguati a “ruotare attorno” alla politica globale e “interpretarla come qualcosa di dannoso”, come si cantava una volta in coro negli anni Novanta. Mentre gli organi di governo sono amministrati da ingegneri ben intenzionati e funzionari dei ministeri delle telecomunicazioni, è triste pensare che, mentre Facebook e Google occupano le posizioni di spicco, le possibilità di una rivoluzione strutturale sono minime. Questo rende sempre più necessaria la stesura di tabelle di marcia con iniziative concrete su come riprenderci Internet. Soprattutto qui, ad Amsterdam, coi suoi centri della tecnofinanza, lo strategico Amsterdam Internet Exchange e i suoi stravaganti edifici. Dopotutto, aspettare Bruxelles è come aspettare Godot. In aggiunta, come possono le università essere affrancate dalla loro dipendenza da Google e Microsoft? Come possono gli artisti sperare di essere liberati da Adobe e Instagram?
Nella conclusione di Le Paludi della Piattaforma ho tracciato come potrebbe essere intrapreso un esodo dalla piattaforma. A tal scopo, ho usato il termine “stacktivismo”, una forma di attivismo di Internet che diventa consapevole delle dipendenze interconnesse delle sue proposte alternative e della sua forma stratificata, dai repository pubblici, alle infrastrutture decentralizzate e ai sistemi operativi su software aperti e gratuiti, fino a interfacce non manipolative, filtri AI e forum con pratiche decisionali libere. Allunghiamo e apriamo il tempo, progettiamo configurazioni spaziotemporali autonome in grado di lasciare spazio alla riflessione. Cruciale è che tutto questo non suoni né criptico né utopico. Infatti, non supporto le fantasie mondiali di “calcolo su scala planetaria” e “terraformazione” promulgate da Benjamin Bratton, l’autore di The Stack, o tanto meno la metafisica della cosiddetta “teoria digitale”.
La scomparsa della possibilità di un cambiamento è ormai in corso da un decennio o più: al suo posto ci sono interfacce utente di facile navigazione e video di gattini
Ma quindi, come possiamo “disturbare i disturbatori”? Per prima cosa, dobbiamo assicurarci che i nostri concetti e progetti possano essere effettivamente scalati e messi in pratica. Questo è il caso del passaggio da un modello di business di tipo estrattivista a quello che Bernard Stiegler e collaboratori hanno definito “economia contributiva”. Il modello, per fare un esempio, in cui i pagamenti peer-to-peer si aggiungono a un’economia circolare, sostenibile e globale che lavora per la ridistribuzione della ricchezza e delle risorse, a livello sia locale che globale. Sono convinto che questa sia la dimensione decoloniale del problema informatico, un’area che richiede ancora del lavoro sull’impronta carbonica, sull’estrazione di materie rare e sulla questione dei rifiuti elettronici prodotti dal mondo digitale.
Come afferma la Filosofia per Passeggeri di Michael Marder: “Dopo che il viaggio nel mondo finisce, ecco che inizia il viaggio della comprensione”. Capire Internet. Il nostro compito in veste di teorici, artisti, attivisti, designer, sviluppatori, critici e altri irregolari sarà quello di andare oltre la ripartizione e sviluppare una modestia radicale per quanto riguarda le potenzialità del digitale. Dobbiamo biforcarci in modo da poterci muovere verso nuovi orizzonti, aprendo la strada a quello che Stiegler chiama il Negantropocene. Rispetto al disastro climatico in corso e alla crescente disuguaglianza sociale, lo sforzo computazionale è relativamente minore. Dopotutto, un codice può essere riscritto, nuovi sistemi operativi costruiti, cavi e segnali reindirizzati, centri dati decentralizzati e infrastrutture pubbliche installate.
Come Walter Benjamin aveva osservato: “Che le cose vadano avanti così è la catastrofe”. Il problema qui non è che Internet crolli da un momento all’altro – e che la tesi sulla sua estinzione venga in qualche modo falsificata. Ci sono già abbastanza blackout nel mondo, come i miei amici in Ucraina mi ricordano. Oltre all’“alleggerimento automatico del carico”, ci sono filtri, paywall, gli algoritmi e l’intelligenza artificiale, la censura di stato, gli hack, le patch fallimentari e la moderazione dei contenuti, tutti grazie alla manodopera a basso costo. Avremo a che fare con sempre più “eventi improbabili” al di là della cyberguerra hacker del passato. Questo mondo post-naturale sta per fare strani salti e balzi. Il mistero cosmotecnico sorprenderà coloro che credono in una connettività fluida e stabile. Ma quello che è veramente in gioco è un collasso dell’immaginazione collettiva di un sistema tecnologico che sta giocando un ruolo così cruciale nella vita quotidiana di miliardi di persone e che nonostante tutto può essere modellato, governato, progettato, e piegato in virtù di fini non ufficiali. La scomparsa della possibilità di un cambiamento è ormai in corso da un decennio o più: al suo posto ci sono interfacce utente di facile navigazione e video di gattini.
Sono stati fatti progressi lenti ma costanti nello sviluppo di app online alternative. Oltre ai già consolidati Linux, Wikipedia e Firefox ci sono DuckDuckGo, Signal, Telegram, Mastodon e il Fediverse, deepl, OpenStreetMap, Jitsi e Cryptpad; la lista è in crescita. Tuttavia, gli strumenti di social networking, ora più che mai necessari, si sono rivelati estremamente difficili da decifrare. Durante il decennio perduto di Internet, abbiamo ridisposto le sedie a sdraio sul Titanic sotto la guida ispiratrice della classe aziendale. Purtroppo, l’ottimismo sistemico ha prevalso sulle critiche. Questa è la vera tragedia della critica di Internet, made in Europe. Dov’è la nostra resilienza ora che ne abbiamo bisogno? Mentre l’attenzione si è rivolta alle cripto, alla blockchain e ai sistemi di pagamento, il tecno-sociale è stato trascurato. È possibile tornare dalle piattaforme ai protocolli? C’è ancora tempo per scrivere codici e creare nuovi script di connessione? Con livelli di angoscia e rabbia in aumento, molti sentono che sarà fatto troppo poco e troppo tardi. È avanzata poca pazienza per le varie cerimonie di consenso burocratico, ora che le soluzioni sono state ancora una volta delegate ai responsabili delle pubbliche relazioni, ai “mercati” e agli ingegneri (che non sono così “neutrali”) che avrebbero dovuto risolvere il problema.

Non ho l’ambizione di diventare la Cassandra della piattaforma, né sto morendo dalla voglia di scrivere l’elogio funebre per il mio amato medium. Eppure la paura legata alla sua scomparsa pare essere così diffusa che il suo stesso nome è citato raramente come segno di rispetto per i defunti. “Usiamo i social media, non più l’i-…”. Nel 1995, Bruce Sterling, scrittore cyberpunk, aveva già preparato il terreno con il suo Dead Media Project – come tra l’altro uno si aspetterebbe da un autore di fantascienza di questo calibro. Il sito web puntava a mettere insieme tecnologie di comunicazione obsolete e dimenticate, annotate in una guida ai fallimenti, ai collassi e ai nefasti errori dei media. Sterling e i suoi collaboratori hanno ormai aggiunto funzionalità di testo come telnet, gopher e newsgroup al loro necrologio di media defunti. Prima o poi anche Internet potrà essere messo in lista; è molto probabile che questa notizia ci sarà venduta in nome del progresso e della convenienza dell’utente.
Aumentare l’entropia, mettere i meme sottosopra, far ballare gli schermi e scrollare tutta la notte. All’alba l’umanità si preoccuperà di cose più urgenti. Alcuni rinnegati ricorderanno la “breve estate di Internet”, seguita da un lungo regno dei Titani, fino a quando una rottura non ricoprì le culture della rete con uno spesso strato di cenere semiotica, soffocando i dialoghi e gli scambi restanti. Come ci ricorda Walter Benjamin nelle sue Tesi di Filosofia della Storia, scritte poco prima di morire in fuga dai nazisti, è nostro compito di cronisti recitare gli atti minori all’interno di questo episodio notevole della storia della comunicazione. Ci invita così a “impadronirsi di un ricordo come esso balena nell’istante di un pericolo”. Lasciarsi alle spalle la breve epoca della libertà di Internet con tutte le sue stranezze e difetti non è un segno di progresso irrefrenabile. Ci sono mucchi di rifiuti informatici davanti a noi. È nostro compito quello di rifiutare di schierarci con i miliardari e altri governanti autoritari, combattere la tecno-nostalgia e perseguire di nuovo “come suo compito passare a contrappelo la storia”.
Rivendicando la fine, l’energia è liberata per la creazione di nuovi inizi.
Vorrei ringraziare Ned Rossiter, David Berry, Patricia de Vries, Nadine Roestenburg, Niels ten Oever, Chloë Arkenbout e Sabine Niederer per le loro preziose correzioni e commenti. Pubblicato originariamente su networkcultures.org. Traduzione dall’inglese di Alessandro Sbordoni.