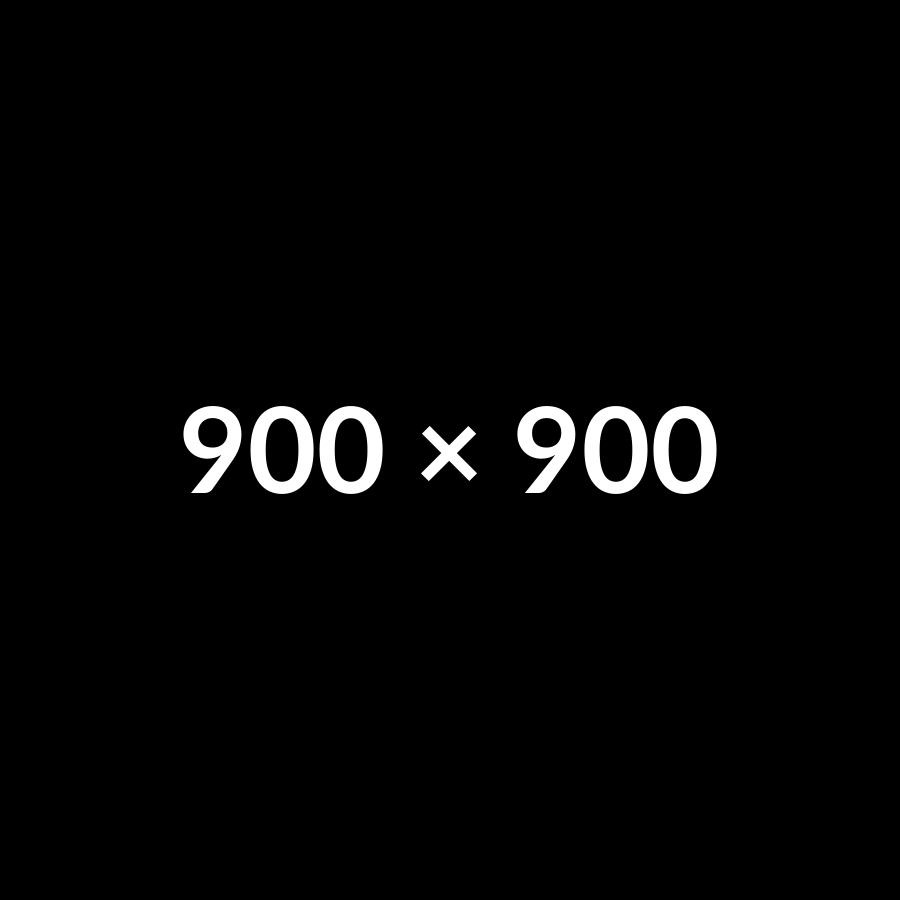Ricordo un periodo in cui scrollare tra i post del profilo Instagram di Yung Lean voleva dire provare a decodificare le regole di un universo di cui non si sapeva un bel niente: forme distorte, oggetti ultraluminosi, texture misteriose, superfici sfocate di dubbia origine che sembravano mirate a creare confusione nella sezione dei commenti… In un oceano virtuale di Instagram feed confezionati e ben strutturati, Lily-Rose Depp – nepo baby in ascesa – pubblicava fotografie sfocate di sé e delle sue amiche: foto brutte, non curate, che le ritraevano in azioni ben più ordinarie di quel che ci si aspettava da una persona del suo status. Così facendo, il suo profilo respingeva – e allo stesso tempo nutriva – la forsennata voglia di gossip (tradotta nella spasmodica caccia agli indizi che rivelassero il suo stile di vita di lusso) di cui tutti erano alla ricerca tra le pieghe della sua personale narrazione online. Perché queste persone utilizzavano Instagram nel modo esattamente opposto a quello che ci era stato insegnato? Perché stavano, di proposito, offrendo al loro pubblico qualcosa di così ambiguo e non leggibile?
Oggi gli user hanno più che assorbito l’estetica del non-decifrabile, facendo sì che le sue regole si siano potute ripercuotere su praticamente ogni campo del panorama visuale: grafica, moda, bellezza, arti performative e figurative. Ma l’intensa adorazione per l’Entropyposting – l’impulso di condividere informazioni non-decodificabili e il meno leggibili possibile – va ben oltre il luminescente immaginario hyperpoppiano sapientemente manifatturato dalla Drain Gang, e molto più in profondità di ogni prodotto che l’estetica lo-fi abbia mai partorito. Per quanto ne ricordi la la forma, l’Entropyposting non somiglia neanche all’atto primitivo del dump: è casomai più vicino a un metodo per spingere la tecnologia ai suoi limiti, generando contenuti inutili e rendendo le interazioni sociali meno chiare e progressivamente più complicate.
C’è qualcosa nell’atteggiamento anti-glamour di queste celebrità – che condividono post non accattivanti, immagini sfocate, tagliate male, storte o estremamente pixelate – che ricorda il modo di vestirsi, poco impegnato e spesso noioso, con cui alcuni super ricchi amano farsi vedere in pubblico. Come scrive Caroline Busta in The internet didn’t kill counterculture-you just won’t find it on Instagram, “Lontano dalle parate, dai palazzi e dalle circonferenze spropositate di uomini forti del giorno d’oggi come Viktor Orbán, Kim Jong-un e Donald Trump, le caratteristiche più iconiche che troverete tra i big tech set sono più probabilmente un dolcevita nero, una giacca di pile Patagonia e l’assenza di borse”. Busta suggerisce che “Il vero potere mantiene un profilo basso perché non ha bisogno di una presenza sui social media: li possiede”. Questa è una delle ipotesi: le celebrità non hanno bisogno di provarci. Il loro gioco è già stato giocato, il loro engagement rimasto invariato. Loro non seguono l’algoritmo: lo plasmano.
La verità è che non si può pensare all’Entropyposting (per come lo conosciamo oggi) solo come a un modo per tradire la piattaforma. Come ogni altra tendenza di Internet, l’Entropyposting è lontano dall’essere una ribellione contro l’egemonia tecnologica: piuttosto, è ancora una volta un modo usa e getta di rappresentare se stessi online; un modus operandi pronto a raggiungere gli utenti di tutto il mondo fino a sparire per fare spazio alla prossima tendenza.
Quando la non-leggibilità diventa lo spirito del tempo, però, non esiste più limite: se le celebrità si autonarrano in maniera lowkey per tradire la voglia di informazioni del loro pubblico, lo stadio finale dell’Entropyposting somiglia a tutto tranne che a un modo per passare inosservati. La negazione del gossip, dello sfarzo e della pornografia di informazioni nei confronti dell’utente voyeurista ha mostrato a quest’ultimo qualcosa di sconosciuto: se il “grado di disordine” si innalza, con questo aumenta la sua non-leggibilità e imprevedibilità. Un aumento di disordine corrisponde a un aumento di entropia, e l’entropia – intesa come la misura della complessità di un messaggio – crea informazione. Le informazioni chiare danno meno informazioni di quanto una narrazione patinata non-entropica ne darebbe: una narrazione complessa genera curiosità, risponde a domande non fatte, non si arresta alla superficie, scatena la creazione di infiniti mondi possibili.
La chiave, allora, è trovare qualcosa che costringa a una pausa nel flusso, che richieda un’attenzione maggiore. E in un mondo di Instagram reels perfettamente strutturati, format e trend di TikTok, post sponsorship preconfezionati con l’apposito hashtag #adv e corsi di social media management che insegnano passo dopo passo come vincere l’algoritmo, i contenuti scivolano sulla nostra attenzione come se non gli si fossero mai posati davanti. L’unico modo di fare resistenza? Aumentare il grado di disordine. Costringere l’utente a fermarsi per più dei 2,5 secondi di attenzione massima calcolati dalle analytics dei social media. Aggiungere entropia alla propria narrazione online.
Ma quali altre pratiche sono segni inevitabili dell’assorbimento completo dell’arte dell’Entropyposting? Semplice: tutto ciò che somiglia a un atto di autosabotaggio. La scelta di nomi-utente alfanumerici molto lunghi per il proprio account Instagram – quelli che collocano la propria online persona nel gruppo dei bot o degli androidi – ne è un esempio. La pratica non è sconosciuta neanche al mondo dell’arte: ricordando quella volta in cui il duo di artisti Eva e Franco Mattes scelse di chiamare il proprio sodalizio artistico con il codice binario 010010111010110.org, gli artisti dell’industria musicale si comportano come a voler fuorviare le persone dal trovare i loro brani nel marasma delle piattaforme streaming. È il caso di Arca, musicista venezuelana e regina assoluta dei dump caotici di Instagram (ben prima che quel tipo di autorappresentazione diventasse lo status quo) e del suo mixtape @@@@@ del 2020; dei titoli delle tracce di Angel Marcloid – in arte Fire-Toolz – caratterizzate da un’abbondanza di emoji e simboli; dei brani firmati da TCF (pseudonimo di Lars Holdhus) ispirati alla crittografia e ai codici.
Ma l’industria musicale è la culla di più di un solo shift estetico: l’inquietante profilo instagram del trio di Sacramento Death Grips si presta alle teorie dell’Entropyposting a tal punto che potrebbe fornirne un saggio visuale. Con video musicali e copertine degli album pensate per scatenare la follia e la curiosità degli utenti di Reddit di tutto il mondo, il trio è stato pioniere dell’arte dell’Entropyposting spianando la strada allo sfarzo di cui gode oggi (sì, tutti i tuoi amici hanno condiviso una still dal video di “Guillotine” almeno una volta, non importa il contesto). Si tratta di stimoli semantici impossibili da catalogare, complessi da approcciare se non con un atteggiamento cinico, sbeffeggiante, post-ironico: residui senza autore ai margini di quell’internet patinato che si crede di governare a portata di click, con le sue rassicuranti finestre, fastidiosi pop-up e gerarchie ben distribuite; interfacce di cui siamo certi conoscere ogni segreto.
Sans Serif? Fuori. Font deep-fried ed elementi sovrapposti? In. E no, mi dispiace, non potrai consumare questo meme in 0,3 secondi. Dovrai aspettare e leggere tutto prima di (forse) poter essere ripagato con una scarica di dopamina
Sull’idea del “relitto digitale” ha riflettuto più di tutti il musicista sperimentale e artista visivo inglese Dean Blunt. È sconvolgente rintracciare la sua influenza in tantissime scene musicali sorte negli ultimissimi anni in Europa: padrino di una certa corrente di pop avanguardistico e dal 2012 fondatore dell’etichetta musicale World Music, Blunt è considerato uno dei personaggi più prolifici della internet music, famoso per immaginare da sempre la sua produzione come un flusso estetico contraddittorio, ubiquo, multiforme, dove diversi stimoli si sovrappongono rifiutando le dinamiche di un mercato che concepisce un prodotto musicale come un oggetto ben confezionato e dettato dalle redini di una major.
A partire dagli anni Dieci, World Music ha rilasciato cover di centinaia di singoli e mixtape attingendo a una direzione artistica senza precedenti: screenshot pixelati dalla home di Facebook, foto scaricate da Google Immagini nella peggior qualità possibile, grafiche underwhelming create grazie a Paint, trionfi di Comic Sans, emoji stretchate e immagini stock. Con quei progetti dall’identità visiva così ambigua rilasciati su bandcamp, World Music si dichiarava contro una gerarchia delle immagini, – e della musica – prendendo in giro la cura un po’ goffa con cui gli artisti curavano i loro progetti sottovalutando il fatto che si sarebbero dispersi nel web insieme a tutte le altre immagini e suoni nomadi che prendono parte al flusso. Così facendo, Dean Blunt e World Music causavano un détournement: invece che provare a emergere, si preoccupavano di mimetizzarsi perfettamente nel panorama cacofonico di informazioni di ogni tipo e forma, così da navigare sul web senza meta, senza autore e senza destinatario. Questo almeno fino all’astrazione dell’album Black Metal (che ne voglia Kanye West con il suo Donda, arrivato molto dopo).
Figlio diretto della scuola Dean Blunt, il duo spagnolo di artisti visivi Fomotrauma è il miglior esempio dell’impatto delle operazioni di World Music sui nativi digitali: una nuova scuola di artisti che traggono spunto dall’esautorazione delle immagini di nuova creazione, pronti invece a ridare contesto a quella preziosa spazzatura digitale che è destinata a essere persa e riscoperta in un ciclo infinito di download e screenshot.
Nel loop paranoide di contenuti suggeriti agli user secondo le loro più oscure inclinazioni, alle nuove generazioni di utenti interessa riportare a galla le immagini disperse, dare entropia all’interfaccia per provare a svincolarsi da un sistema vincolato e riportare incertezza negli schemi preconfigurati. Di internet si è sempre parlato come di qualcosa di estremamente vicino alla magia, una scatola nera di spettri che ha più cose in comune con il ghostly che con i codici. Ma quanta astrazione è permessa a un sistema di interfacce?
Quella dell’Entropyposting è una pratica di compressioni, di reiterazioni, di processi confusi, di fascinazione per quegli stimoli visivi difficilmente collocabili, senza punto di partenza e quindi senza punto di arrivo. Qualcosa che somiglia all’immaterialità di un’immagine generata da una GAN o a un ritratto di Gerhard Richter, che lavorava su quell’inaccessibilità che solo la riproduzione dei mass-media riesce a donare all’immagine. O ancora come nel caso della serie JPEGs del fotografo Thomas Ruff – composta da immagini scaricate da internet e ridimensionate per peggiorarne la qualità al massimo –, o della pittura spray dell’artista torinese WOC, che riproduce in maniera grossolana immagini iconiche della cultura pop restituendo la versione qualcosa di cui potremmo fruire in 4K.
Il mondo delle microcelebrities dell’arte ha più che assorbito lo spirito del tempo di cui l’Entropyposting è figlio: i seguitissimi profili del direttore artistico Ben Ditto (o come lo ha definito recentemente Interview Mag, il “Reinassance man of the Internet Age”) sembrano oscuri portali verso immagini gore, orrorifiche e ironiche, tutto fuso insieme in un modo squisitamente pop. Il fondatore e caporedattore di Coeval Magazine, Donald Gjoka, detiene lo stesso potere: la sua attività su internet rapisce e confonde, ritraendo una dimensione online in cui immagini create dall’intelligenza artificiale, meme post-ironici e disegni infantili convivono sulla stessa superficie.

Smentendo l’idea che ogni trend sia destinato a scomparire nel tempo, la tendenza estetica che con più forza ha devirtualizzato la pratica dell’Entropyposting è decisamente permanente: i tatuaggi. L’estetica ha tradotto i suoi tratti distintivi in disegni disordinati, contorti e simili a ragnatele, che assomigliano a manoscritti consumati dal tempo o all’interfaccia glitchata di un sito web mal progettato. Nel mondo delle immagini in movimento, il regista Ryan Trecartin incarna il cuore pulsante delle pratiche dell’Entropyposting presentandosi come leader degli immaginari caotici e narratore di mondi di assoluta schizofrenia digitale, dove ogni scena sembra provenire direttamente da un home-video girato da adolescenti colti da un attacco di isteria collettiva o dalle zone più oscure del deep web.
Per gli stessi motivi, la cultura dei meme ha iniziato a ruotare attorno a infografiche criptiche e immagini interamente testuali. Come spiega la scrittrice Biz Scherbert nel saggio Intimacy and the Machine: Godposting – or: New Internet Esotericism, “i grafici cabalistici di oggi macerano e rifiutano l’iper-leggibilità […] inghiottendo blocchi di testo perfettamente curati e user-friendly e trasformandoli in qualcosa di deliberatamente difficile da leggere, qualcosa di vischioso abbastanza da stuzzicare i solchi del cervello, prima che il pensiero ci scivoli sopra e stia già cliccando sulla storia successiva.” Su Talk Magazine, la scrittrice Alexi Alario aggiunge: “Ecco il motivo per cui questa inutile complessità e il barocchismo di questi grafici […] sono così attraenti: perché ci impongono di dedicare del tempo alla decodifica di qualcosa”. Sans Serif? Fuori. Font deep-fried ed elementi sovrapposti? In. E no, mi dispiace, non potrai consumare questo meme in 0,3 secondi. Dovrai aspettare e leggere tutto prima di (forse) poter essere ripagato con una scarica di dopamina.

Il panorama visivo è completamente mutato: stanchi dei contenuti volgari, didascalici e fin troppo evidenti che le star di TikTok continuano a ficcarci in gola, sappiamo adesso di dover puntare alla chiusura, all’inquietudine, al mistero, al silenzio. Vogliamo decodificare, non essere decodificati. Nel saggio In Defense Of The Poor Image, pubblicato nel novembre 2009 per l’Issue #10 di e-flux, l’artista Hito Steyerl definiva le implicazioni della nitidezza nello stabilire il privilegio di classe, laddove l’immagine “povera” ovvero “un rag o un rip, un AVI o un JPEG, un file di cui nome è deliberatamente scritto male” si contrappone alla posizione dell’alta risoluzione (“Focus is identified as a class position”), legittimandosi rispetto alla violenta dislocazione e alla circolazione di quei detriti audiovisuali senza credibilità.
Tuttavia è la stessa Steyerl a indicare un cambiamento essenziale, uno shift semiotico del capitale in cui il fenomeno delle immagini povere si iscrive perfettamente: “da un lato, [l’immagine povera] opera contro il valore feticcio dell’alta risoluzione. D’altra parte, è proprio per questo che finisce per integrarsi perfettamente in un capitalismo dell’informazione che prospera su tempi di attenzione compressi, sull’impressione piuttosto che sull’immersione, sull’intensità piuttosto che sulla contemplazione, sulle anteprime piuttosto che sulle visioni”.
Il moto naturale è quello di rompere l’interfaccia, o di andare in contrasto con questa fino a creare un’interferenza. Ma l’interfaccia si adatta, si fa crescere nuove braccia come un mostro multiforme che si autorigenera
Nato per rispondere alla privatizzazione delle narrazioni online, dove ogni post è mercificato e serve a dare un’informazione ben precisa, l’Entropyposting non è strutturato per significare, ma per contro-significare. Cercando di divergere, però, il territorio delle immagini povere si presta alle più distintive dinamiche del capitalismo: le narrazioni perdono materia e acquistano velocità, e la loro incapacità di concentrarsi fa spazio alla sottomissione. Riportare la risoluzione al magma di pixel prendendo in giro quelle stesse immagini e il modo così rapido che hanno di diffondersi è un modo per sentirsi i Web Makers del proprio destino, per riportare internet a qualcosa di volubile, imperfetto, manchevole, fallimentare e non-corporate. Se la promessa del Web 3.0 è un internet user-centered, il moto naturale è quello di rompere l’interfaccia, o di andare in contrasto con questa fino a creare un’interferenza. Ma l’interfaccia si adatta, si fa crescere nuove braccia come un mostro multiforme che si autorigenera.
Tutto ciò vale a dire: fate attenzione ai vostri amici Entropyposter. Coloro che cancellano di colpo tutte le foto dai loro account sui social media, che cambiano il loro nome utente con un codice infinito di lettere e numeri e condividono improvvisamente lo screenshot sfocato dell’interfaccia di un videogioco o la foto sovraesposta di un cassonetto della spazzatura visto su una strada secondaria verso la casa dei loro genitori.
Su Internet, nulla può essere veramente spontaneo o dettato dall’istinto. E sì, i nostri profili non sono diversi dalle pareti di una galleria d’arte o di un museo: tutto ciò che viene postato è un simbolo per qualcos’altro. Qualcosa che va decifrato, conoscendone il contesto e il canale. Proprio come un ready-made che acquisisce nuovo significato quando esposto in una galleria di lusso, ogni nostro enigmatico contenuto nasconde un messaggio segreto. Puntiamo a essere oscuri, ad autoconvincerci di essere arrivati finalmente a capire qualcosa che nessun altro potrà mai avvicinarsi a capire. Ne abbiamo abbastanza delle microtendenze di internet, delle infinite piccole nicchie che diventano mainstream. Ci siamo stancati di venire faccia a faccia con il fatto che siamo tutti, irrimediabilmente, inevitabilmente, uguali. Desideriamo l’individualità, non la globalizzazione. E la cosa più triste? Instagram è ben lontano dal salvarci. Perché nulla, assolutamente nulla è troppo complesso per gli utenti. Se l’Entropia è lo Zeitgeist, non esiste più alcun segreto: lo abbiamo già scoperto.