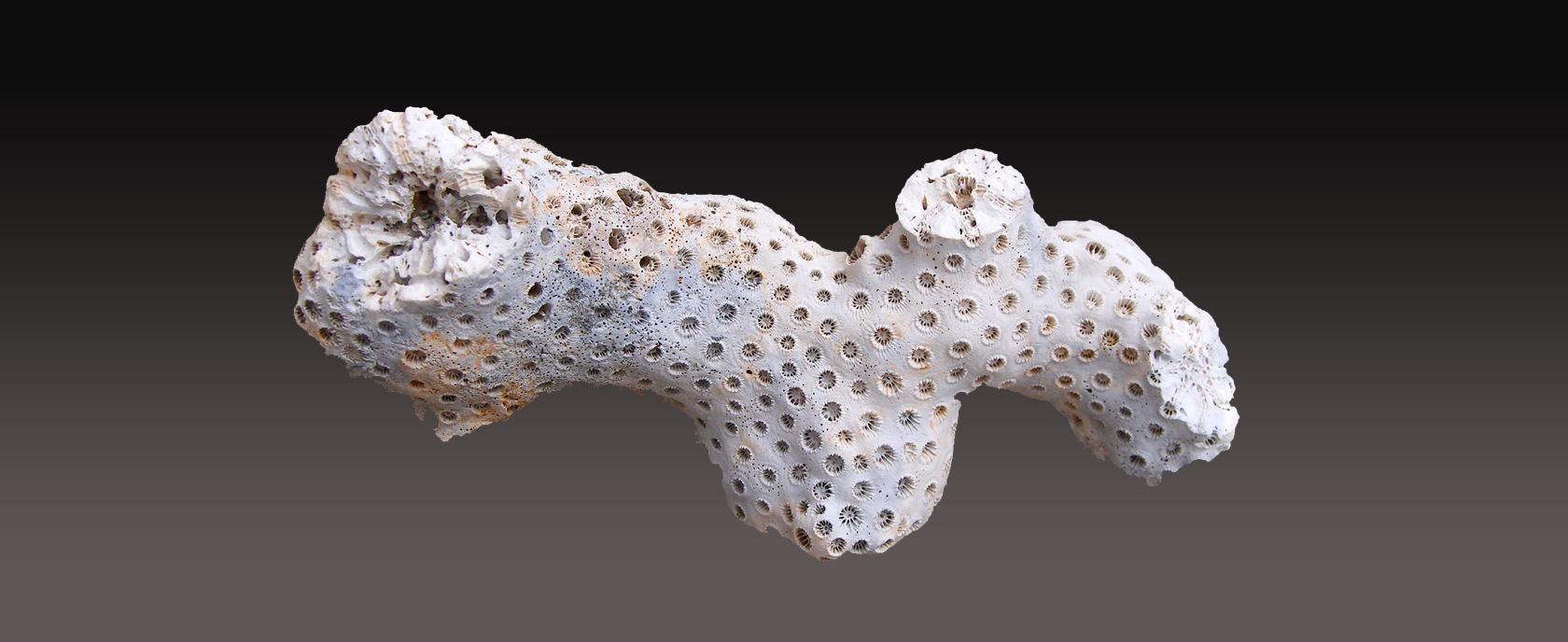L’esaurimento
«la philosophie antique nous apprenait a accepter notre propre mort,
la philosophie d’aujourd’hui la mort des autres»
(Michel Foucault)
Trumpismo
In un libro di prossima pubblicazione per Caja Negra (Buenos Aires) il filosofo argentino Diego Sztulwark si chiede: «Può tornare il fascismo? Né Trump né Le Pen, né Bolsonaro ripetono il fascismo storico. Probabilmente sarebbe meglio parlare di fascismo postmoderno, un tipo specifico di vitalismo che afferma una certa essenza o purezza etnica, di classe o nazionale attraverso una violenza intollerante e l’inferiorizzazione di intere popolazioni, che si tratti di migranti, di neri, di donne o di omosessuali».
Parto da questa definizione di fascismo postmoderno per poter far emergere la specificità del movimento neoreazionario di massa contemporaneo rispetto al fascismo classico del XX secolo, e rispetto all’assolutismo capitalista che ha preso la forma ideologica di neoliberismo. Sztulwark sottolinea l’effetto di precarizzazione e di fragilizzazione che il neoliberismo ha avuto a ogni livello dell’esistenza umana, e giustamente suggerisce che qui forse si trova il filo di continuità tra assolutismo neoliberale e movimento neoreazionario.
Per sfuggire all’ambiguità di espressioni come «fascismo postmoderno» definisco trumpismo questo movimento neoreazionario di massa, e mi chiedo in cosa il trumpismo ricalchi il fascismo classico e in cosa se ne differenzi, ma al tempo stesso mi chiedo in cosa il trumpismo si differenzi o si intrecci con l’assolutismo del capitale neoliberista.
Osservo di sfuggita che la parola «trumpismo» funziona abbastanza bene come significante: si riferisce al nome dell’attuale presidente americano, ma anche al significato del verbo «to trump» che significa – oltre che scoreggiare – anche surclassare, sconfiggere, umiliare. Insomma condensa abbastanza bene il suprematismo bianco e la volgarità scoreggiona del popolo che trent’anni di shitstorm e di violenza economicista hanno sedimentato, un popolo strutturalmente ignorante e patologicamente arrogante, irriducibile alla ragione e impermeabile alla sensibilità umana.
Scrive ancora Sztulwark: «Le micropolitiche neoliberali riescono a perdurare attraversando il caos per estrarne nuove possibilità vitali. Per questo il neoliberismo conta su tutti quei consumi che funzionano come protesi soggettive per attenuare la fragilità. Esiste così un’intimità essenziale tra queste micropolitiche e il terrore della vulnerabilità, tra la fobia della tormenta e il rifugio reazionario che si esprime in tendenze paranoiche, aggressive e razziste. L’inconscio colonialista identifica ogni destabilizzazione come una minaccia e tende ad aggrapparsi all’identità: in questo modo si disegna il profilo delle politiche neoliberali».
La specificità del trumpismo risiede proprio in questo: si tratta di una reazione alla percezione di precarietà, alla psicosi da deterritorializzazione, all’umiliazione psicopolitica e all’impoverimento sociale che l’assolutismo capitalista ha inflitto alla società negli ultimi trent’anni. È espressione del desiderio di vendetta delle vittime impotenti del capitalismo assoluto.
La trappola neoliberale ha sottomesso culturalmente la sinistra, creando una narrazione politica fondata sulla percezione che non c’è alternativa al capitalismo e che il capitalismo deve liberarsi dal welfare, dalla solidarietà, e dalla stessa democrazia per mantenere il suo equilibrio.
La ragione per cui il capitalismo ha avuto bisogno di entrare in una fase assolutista e di distruggere l’eredità della democrazia sociale del passato sta nel fatto che le condizioni antropologiche ambientali e culturali per la crescita economica non esistono più, per cui solo depredando la società e riducendo i salari è possibile rendere possibile l’accumulazione di capitale.
La vecchiezza del mondo
La fine dell’espansione moderna è dovuta a tre fenomeni irreversibili della tarda modernità: esaurimento delle risorse fisiche che resero possibile l’espansione industriale, esaurimento delle energie nervose che hanno sostenuto lo sviluppo dell’economia digitale, e l’invecchiamento della popolazione (il cosiddetto declino demografico).
In poche parole: la fine della crescita è iscritta semplicemente nell’invecchiamento del mondo. E l’invecchiamento non recede né si ferma con protesi tecnologiche, checché ne dicano i fanatici nazi-liberali del transumano.
La cultura politica, compresa quella della ben intenzionata sinistra pentita (poco) del suo passato subalterno, è incapace di accettare che la possibilità di espansione è finita, in ogni senso della parola. L’esaurimento non si può vedere né pensare nell’ambito della cultura politica. E questa è la ragione per cui la ragion politica è costitutivamente incapace di comprendere l’epoca in cui siamo entrati.
In un articolo intitolato Genba de no taiketu nash ni shakai-henkaku wa nai, «Non c’è trasformazione senza scontro diretto» (Weekly Friday, 20 settembre 2019) il filosofo giapponese Jun Fujita Hirose critica la sinistra, non solo giapponese, perché si mostra incapace di uscire dalla trappola concettuale della crescita economica.
Negli ultimi trent’anni, dice Hirose, la sinistra ha sostenuto il programma neoliberale e in questo modo ha preparato l’attuale reazione etno-nazionalista. Ora, dopo il rovesciamento spettacolare che comincia nel 2016, dopo il trionfo mondiale dei movimenti neoreazionari, molti segni mostrano che i rappresentanti dei partiti di centrosinistra tentano di superare l’errore passato e virano verso una strategia di riforme il cui scopo sarebbe quello di restaurare la crescita. «Fermiamo il cedimento alla logica finanziaria, e torniamo alla buona vecchia crescita economica per rimediare all’impoverimento della società» dicono le forze socialdemocratiche e parte del fronte liberal-democratico. Ma questo pentimento non serve e questo programma non funziona, dice Fujita Hirose, perché le condizioni (economiche, sociali, ambientali, tecniche) per la crescita sono scomparse, e non torneranno. Per questo il capitalismo è entrato nella fase assolutista chiamata neoliberismo, e per questo a partire dal 2016 il trumpismo ha iniziato una guerra civile mondiale.
Ora, trenta anni dopo il 1989, il capitalismo globale è entrato nel suo momento brezhneviano, destinato a essere però molto più doloroso di come fu il crollo dell’impero sovietico; perché la classe dirigente sovietica, per quanto autoritaria, era molto meno barbarica e cinica dell’élite finanziaria di oggi, e anche perché la crisi attuale non riguarda la gestione politica del sistema ma le forme di vita che si sono sedimentate durante secoli di capitalismo, colonialismo e devastazione dell’ambiente fisico del pianeta e del sistema nervoso del genere umano.
Anche se è legittimo comparare il trumpismo con il fenomeno nazifascista, a mio parere questa analogia è fuorviante. Gran parte del contesto mitologico e ideologico del fascismo è tornato, e alcune dinamiche sociali che condussero Mussolini e Hitler al potere sono riapparse nel ciclo di rapina finanziaria, ma il contesto storico e il sistema tecnico sono totalmente differenti. E soprattutto è diverso, anzi opposto, il sistema di aspettative culturali legate alla mutazione demografica.
Il Fascismo fu un movimento di giovani che combattevano per il loro futuro, per l’espansione e la conquista coloniale, e per il primato della loro nazione. Il Nazismo fu l’affermazione della potenza antiumana di una civiltà fondata sulla funzionalità tecnica. Il retroterra culturale dell’ascesa fascista fu il Futurismo, la celebrazione della potenza tecnica e della potenza maschile. Quanto differente è lo psico-scape contemporaneo, quanto differente il quadro demografico. E soprattutto quanto differente è la tendenza economica e la prospettiva sociale dell’epoca attuale, che segue all’esaurimento.
Stagnazione
L’economia, soprattutto in Occidente, è andata in una direzione che si può definire con la parola «declino». Ma la parola declino ha un suono negativo che dovemmo mettere in discussione: questo è il punto cruciale se vogliamo interpretare il senso delle tendenze dell’era trumpista.
A livello economico il concetto di stagnazione secolare (coniata negli anni Trenta del Novecento da Alvin Hansen, un discepolo di Keynes, e riproposto recentemente dall’economista harvardiano Lawrence Summers), sembra adatto a spiegare la tendenza di lungo periodo che le politiche di quantitative easing tentano di contrastare (con limitato successo).
Contrariamente alla versione ufficiale, secondo cui il rallentamento della crescita è una congiuntura che si deve affrontare e possibilmente superare con interventi finanziari delle banche centrali, Summers pensa che si tratti del sintomo di un cambiamento strutturale che si afferma sul lungo periodo: la stagnazione secolare tra le cui cause Summers vede la trasformazione tecnologica legata all’emergere della cosiddetta nuova economia.
Scrive Summers: «Forse la cosa più importante è che la nuova economia tende a conservare il capitale. Apple e Google, per esempio, sono le due compagnie americane più grandi e puntano a spostare in avanti le frontiere della tecnologia, eppure entrambe nuotano nella liquidità e sono sotto pressione perché si decidano a distribuire ai loro azionisti. Pensiamo all’impatto di Airbnb nella costruzione di hotel. Pensiamo all’impatto di Uber sulla domanda di automobili, all’impatto di Amazon sulla costruzione di grandi magazzini, o in generale all’effetto della tecnologia di informazione sulla domanda di copiatrici, stampanti e spazi per uffici. In un periodo di rapido cambiamento tecnologico può avere senso rimandare gli investimenti per evitare che la nuova tecnologia li renda rapidamente obsoleti».
Occorre aggiungere a mio modesto parere che le nuove tecnologie hanno reso possibile un aumento enorme della produttività del lavoro e questo aumento ha paradossalmente provocato un impoverimento dei lavoratori e della società in generale. Il principale effetto dell’aumento di produttività è che occorre meno lavoro, così, dato che la riduzione del tempo di lavoro è impensabile in regime capitalista, i salari tendono a scendere, la domanda a diminuire, e la deflazione prende il posto dell’inflazione.
Dal punto di vista degli economisti – cioè dal punto di vista del Capitale – questa tendenza può definirsi come declino. Ma se fossimo capaci di pensare al di fuori del contesto epistemico dell’economia, se fossimo capaci di pensare in termini di utilità sociale della produzione, piuttosto che in termini di profitto e accumulazione, ciò che oggi viene identificato come declino potrebbe invece apparire come la condizione di possibilità di una liberazione del tempo sociale dall’obbligo del lavoro salariato.
Stiamo parlando qui della fine della possibilità stessa della crescita economica: questa fine tuttavia non è solo conseguenza di un mutamento tecnico del processo produttivo ma anche di una tendenza demografica e dell’esaurimento delle risorse fondamentali che hanno reso in passato possibile la crescita industriale. Infatti sul piano demografico, come sappiamo, sta accadendo qualcosa di rilevante: con la notevole eccezione dell’Africa e del mondo islamico, la popolazione mondiale sta invecchiando, e questo cambia radicalmente le scelte economiche della popolazione e la motivazione psicologica che mobilita (o non mobilita) l’azione sociale. Le aspettative euforiche di futuro furono il propellente culturale dell’espansione moderna, da Faust al Futurismo: ora la parola «futuro» non significa più niente, e la provocazione nichilista della cultura punk si è trasformata nel senso comune della maggioranza.
Se non si rinuncia al principio della crescita e dell’accumulazione non c’è speranza di uscire dal ciclo infernale della devastazione. Non c’è green economy che tenga.
Il capitalismo è devastazione
Inoltre la corsa a saccheggiare le risorse del pianeta ha raggiunto il suo punto culminante: la devastazione non sta affatto rallentando, al contrario assistiamo all’ascesa politica di una nuova classe di entusiasti devastatori come Trump e Bolsonaro, secondo i quali la prosperità economica (della minoranza) è molto più importante che la sopravvivenza del pianeta e della maggioranza del genere umano. Così la devastazione ambientale è diventata irreversibile, e le risorse fondamentali della vita come l’acqua e l’aria respirabile stanno esaurendosi. L’esaurimento non concerne solo le risorse fisiche, ma anche l’energia nervosa della popolazione, la cui attenzione è sottoposta ad un assedio permanente e il cui cervello tende all’esplosione psicotica.
Un movimento senza precedenti (una vera e proprio Crociata dei bambini, di coloro che sanno di dover vivere in un pianeta in cui la sopravvivenza sarà quasi impossibile) chiede a gran voce alle forze politiche di cambiare drasticamente la direzione delle scelte di governo. Ma questo movimento non riuscirà a modificare neppure di un millimetro quella direzione se non saprà passare dai buoni propositi alla critica radicale dell’economia di profitto. Se non si rinuncia al principio della crescita e dell’accumulazione non c’è speranza di uscire dal ciclo infernale della devastazione. Non c’è green economy che tenga, perché solo l’abbandono del principio economico a favore di un principio ecologico, solo l’abbandono del principio della crescita a favore di un principio della sobrietà e della redistribuzione potrà ridurre la pressione distruttiva sull’ambiente. Se la green economy pretende di mantenere i livelli di profitto e di crescita del capitalismo industriale è nata morta.
La combinazione di esaurimento delle risorse, invecchiamento, riduzione dei salari e della domanda ha prodotto una riduzione dei margini di profitto cui il capitale ha reagito con l’aggressione finale contro la società, chiamata neoliberismo, cui ora si accompagna il cinismo trumpista. George Monbiot scrive sul Guardian del settembre 2019: «Il neoliberismo puntò a ridurre le tasse, privatizzare i servizi pubblici tagliare le protezioni ambientali e creare mercati dove i mercati non esistevano. La dottrina fu imposta dalle banche centrali, dal Fondo Monetario dal Trattato di Maastricht e dal World Trade Organisation, e creò una sorta di capitalismo totalitario. Questo è fallito: lungi dal creare prosperità generale la crescita è diminuita e i suoi frutti sono stati appropriati dai ricchi. Lungi dallo stimolare un’economia dell’impresa ha creato rendite d’oro. Lungi dall’eliminare la burocrazia ha creato un sistema kafkiano di folli obblighi e controlli rigidi. Ha fomentato crisi finanziarie, ecologiche, sociali e politiche culminate nel crash del 2008. Eppure domina ancora le nostre vite. Prevedibilmente la gente ha reagito all’assenza di alternative, ma poiché il neoliberismo è stato adottato anche dai democratici e dalle sinistre, molti hanno risposto con il nazionalismo».
Trent’anni dopo il collasso dell’Impero sovietico, la reazione trumpista delle popolazioni umiliate e impoverite si mescola paradossalmente con il tentativo finale di rilanciare il profitto l’accumulazione e la crescita. Ma la crescita non ritorna, così la sola maniera di realizzare accumulazione è devastare ulteriormente il pianeta, impoverire ulteriormente la società, diffondere ulteriormente violenza e guerra.
La democrazia liberale si sfascia in questo tentativo disperato e la globalizzazione entra in una crisi che potrebbe essere finale oppure no. La crisi di globalismo e democrazia divide la società in due parti che sono in guerra: i globalisti urbani, coloro che si aspettano ancora qualcosa dal mercato e non possono rinunciare all’illusione neoliberale perché hanno investito in quella tutto il loro futuro; e coloro che invece vivono in territori extraurbani che sono emarginati dal mercato del lavoro e cercano vendetta contro la violenza che la globalizzazione ha scatenato contro di loro. Mentre la globalizzazione cade a pezzi, la guerra civile diviene globale.

Stare dalla parte del divenire
L’umanità è invecchiata male, è inacidita e vuole vendetta contro chi l’ha umiliata, ma soprattutto non è capace di accettare il declino come una prospettiva naturale che potrebbe riservare sorprese positive. L’assuefazione alla crescita l’ha resa incapace di immaginare un altro mondo oltre l’invecchiamento protratto innaturalmente.
I medici hanno fatto benissimo il loro lavoro, che è quello di rendere possibile un prolungamento indefinito del tempo di vita; ma i filosofi non hanno fatto altrettanto bene il loro, che sarebbe distinguere tra vita naturale e vita cosciente, tra la necessità biologica e possibilità esistenziale della singolarità desiderante.
Sottrarre la morte singolare alla necessità biologica per farne oggetto di una scelta cosciente è forse il compito politico e filosofico più difficile che abbiamo di fronte, ma è anche il più urgente. Così come è urgente leggere Donna Haraway, e particolarmente il suo libro più inquietante ed enigmatico (ma anche paradossalmente più rilassante e più chiaro), ovvero Staying with the Trouble, recentemente tradotto in italiano come Chthulucene.
Di che parla Haraway? Parla delle visioni fideistiche o apocalittiche del futuro, parla della catastrofe inimmaginabile che l’aumento della popolazione terrestre è destinata a produrre, parla del diritto femminile alla riproduzione, ma anche della necessità di considerare quel diritto sullo sfondo delle conseguenze che la soglia di undici miliardi di persone alla fine del secolo è destinata a produrre. Ma è inutile che io provi a riassumere quello che dice Donna Haraway. È meglio che io traduca qui alcuni brani dalla Introduzione a questo libro strabiliante. Tradurrò (liberamente) l’espressione «staying with the trouble» con le parole «stare dalla parte del divenire», e collegherò le frasi senza pretendere di dare una visione d’insieme del libro [nell’edizione italiana pubblicata da NERO, a curare la traduzione sono Clara Ciccioni e Claudia Durastanti].
«…Stare dalla parte del divenire non richiede una relazione al tempo chiamato futuro. In effetti stare dalla parte del divenire richiede piuttosto essere davvero nel presente, non inteso come punto di fuga tra passati spaventosi oppure paradisiaci e futuri apocalittici oppure salvifici, ma inteso intrecciarsi di miriadi di critters (creature, animaletti) in miriadi di configurazioni incompiute di luogo tempo materia e significato.»
Il presente è l’incompiuto, il continuo divenire che non prende forma in alcuna identità, e dunque non può essere ridotto alla soggettività umana, cui Haraway propone di sfuggire, riconoscendo la continuità tra umano e post-umano, o piuttosto sub-umano, in un’opposizione al disumano.
E poi:
«Mi sono un po’ scocciata di due risposte che sento troppo spesso agli orrori dell’Antropocene e del Capitalocene. La prima risposta è facile da descrivere e anche da scartare, una fede un po’ comica nelle soluzioni tecnologiche, di tipo laico o religioso: la tecnologia in qualche modo verrà in soccorso dei suoi figli un po’ cattivelli ma alla fine molto intelligenti, oppure, in modo simile Dio verrà in soccorso dei suoi figli un po’ disobbedienti ma sempre pieni di speranza…
La seconda risposta, più difficile da mettere da parte, è quella probabilmente più distruttiva: i giochi sono fatti, è troppo tardi, non ha senso tentare di fare le cose un po’ meglio, o avere qualche fiducia uno nell’altro… Alcuni degli scienziati che conosco esprimono questo tipo di amaro cinismo, anche quando lavorano duro per migliorare qualcosa. Alcuni che si descrivono come teorici critici o progressisti in politica esprimono questo tipo di idee… Talvolta pensiamo di saperne abbastanza per giungere alla conclusione che la vita umana sulla terra che in qualche modo sia tollerabile è davvero finita, e che l’apocalisse è davvero molto vicina. Questo atteggiamento ha certamente senso nel mezzo della sesta grande estinzione sulla terra, in mezzo a guerre che ci travolgono, estrazioni e immiserimenti di miliardi di persone e di altri animali per qualcosa che si chiama profitto o che si chiama potere, o che si chiama Dio. La visione da game over si impone nella burrasca soprattutto quando pensiamo al fatto che la popolazione umana raggiungerà gli undici miliardi nel 2100. Questa cifra significa che in 150 anni la popolazione è cresciuta di nove miliardi, tra 1950 e il 2100, con conseguenze enormemente diverse per i poveri e per i ricchi…»
Smettiamola dunque di sperare che la tecnica possa salvarci dall’inferno che abbiamo costruito con le nostre mani (o piuttosto con la nostra incapacità psico-culturale di uscire dal capitalismo). Non ci salverà. Ma al tempo stesso smettiamola di temere l’apocalisse. L’estinzione è certa se la tendenza demografica si confermerà, nonostante il fatto che negli ultimi decenni in metà del mondo la curva demografica tende finalmente verso il basso. E l’estinzione, diciamolo chiaro e tondo, non è la prospettiva più tremenda. Ben più tremenda è la sopravvivenza di un’umanità impoverita, imbestialita, accalcata in condizione climatiche infernali.
Ma il combinato di espansione demografica complessiva e invecchiamento del nord del mondo dovuto alla riduzione del tasso di natalità promette di essere enormemente depressivo e devastante al tempo stesso. Non esiste un’uscita politica dalla persistente esplosione demografica, soltanto una immensa (e altamente improbabile) inversione culturale e psichica della tendenza (autolesionista) a riprodursi potrebbe disinnescare la bomba.
Ma contro questa improbabile eventualità di riduzione della pressione demografica milita il bisogno di identità degli individui che, vivendo una vita intollerabile, affidano alla procreazione la speranza (totalmente irragionevole) di una vita migliore, e milita il bisogno di identità delle comunità (come la comunità palestinese, o quella uighur) che vogliono nel lungo periodo sopravvivere e imporsi contro gli oppressori (israeliani o cinesi nei casi in questione) mettendo al mondo molti figli così da consegnare loro l’ossessione di sopravvivenza comunitaria e la certezza di una vita infernale di umiliazione e di povertà.
Solo il femminismo possiede la chiave per affrontare questa questione, questa garanzia di inenarrabile miseria e di estinzione; ma finora, dice Haraway, non ha voluto o potuto usare questa chiave, sia pure per ragioni comprensibili.
«Le femministe hanno insistito giustamente sul potere e sul diritto di ogni donna, giovane o anziana, di scegliere di NON avere figli. Consapevoli di quanto facilmente questa posizione può avvicinarsi all’arroganza dell’imperialismo, le femministe che hanno la mia stessa visione insistono sul fatto che la maternità non è il fine delle donne e che il diritto riproduttivo di una donna è più importante delle pretese del patriarcato o di ogni altro sistema…
Per eccellenti ragioni le femministe che io conosco hanno preferito non insistere sulle politiche di controllo delle nascite perché spesso queste politiche rappresentano gli interessi degli stati piuttosto che il benessere delle donne. Ma secondo la mia esperienza le femministe non hanno finora voluto prendere seriamente la questione della Grande Accelerazione numerica della popolazione, per timore che in questo modo avrebbero potuto incorrere nei pericoli del razzismo, del classismo, del nazionalismo, del modernismo e dell’imperialismo.
Ma questo timore non basta. Evitare di considerare l’aumento insensato della popolazione a partire dal 1950 può diventare simile al modo in cui alcuni Cristiani evitano di parlare di cambiamento climatico perché questo rischia di mettere in questione il nucleo della loro fede.»
Non vorrei aggiungere nulla a queste ultime parole di Haraway. Ha detto tutto quel che restava da dire.