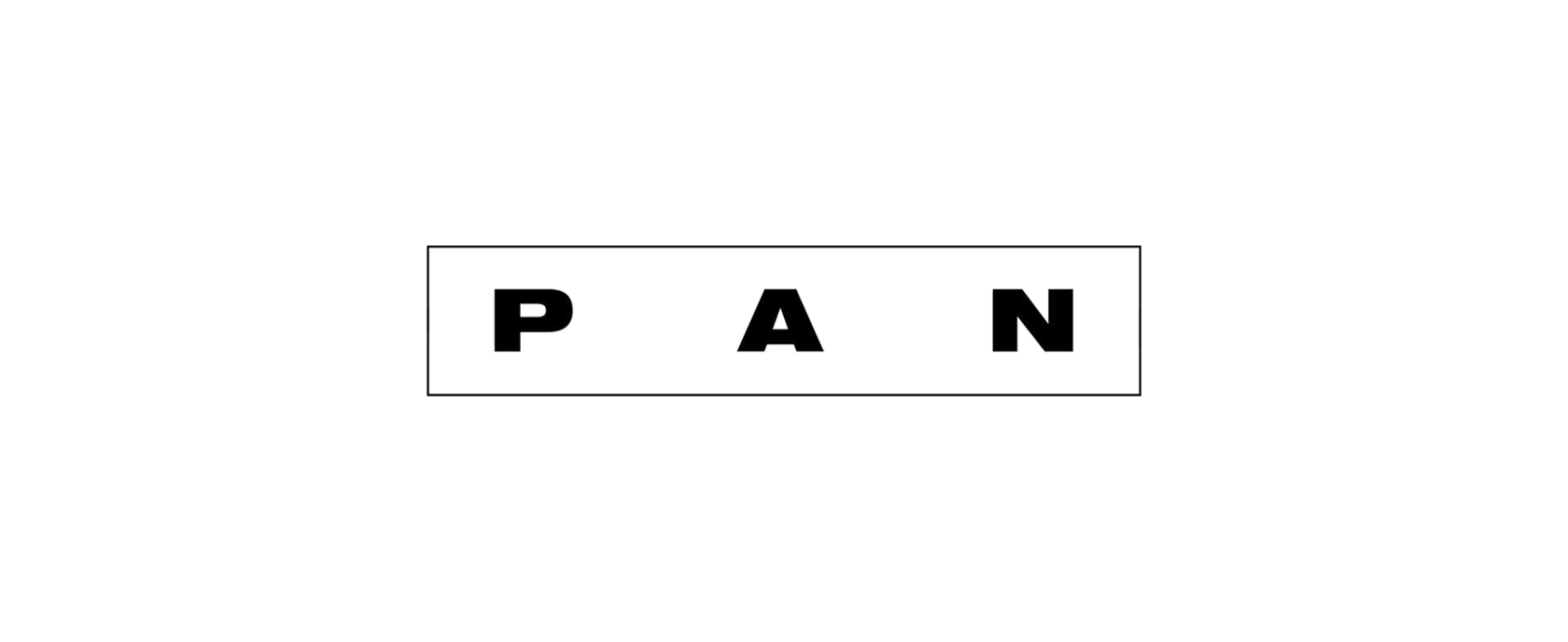La PAN è sempre qui
La PAN è, senza troppi giri di parole, una delle più importanti etichette discografiche dell’ultimo decennio. Forse la più importante, perlomeno presso un certo tipo di pubblico: quello che, affascinato dalla sua estetica austera, futuribile e minacciosa, ha contribuito a innervare la scena elettronica post-retromaniaca di una serie di vocaboli e aggettivi che hanno fatto la gioia tanto degli appassionati di musiche sperimentali quanto dei festival di mezza Europa.
Deconstructed club, conceptronica, elettronica “hi-tech”, musica “accelerazionista”: senza la griffe PAN, nessuno di questi termini avrebbe finito per inondare (qualcuno direbbe infestare) le grammatiche post-techno che tuttora dettano legge nei club come nelle gallerie d’arte. Su PAN sono usciti dischi fondamentali di artisti come Arca, Amnesia Scanner, M.E.S.H., Elysia Crampton, Lee Gamble. Nonostante un catalogo tutto sommato eterogeneo, capace di spaziare dagli ariosi blizzard di Eartheater ai vocalismi rituali di Marina Herlop, la tipica estetica PAN è immancabilmente glaciale e al contempo massimalista, ansiogena e ostinatamente cerebrale, sempre e comunque attraversata da un soffio da “fine dei tempi” ribadito da quelle che Simon Reynolds chiamerebbe “prese di posizione testuali”: ad abbondare sono non solo i suoni tagliati col laser e i bombastici sound effects in 3D, ma anche i riferimenti alla filosofia, alla politica, all’arte, al pensiero radicale, e a teorizzazioni che ti aspetteresti di trovare più in un prestigioso panel tra accademici che sulla pista da ballo di un club di periferia (un esempio tra i tanti: “the LP uses music as a mechanism for delivering ideas central to the group’s moral and political ethos […] themes of power, identity, surveillance and environmental justice”. Eccetera eccetera).
In questo senso, è molto difficile separare la PAN dagli ambienti artistico-culturali della città di cui l’etichetta è (suo malgrado?) specchio ed espressione: Berlino. Come da statement ufficiale dell’etichetta, “PAN taps into and reflects the multi-national and innovative nature of the city’s unique music scene, nurturing and connecting its talent and experiments to a wider international scene“. Per certi versi, possiamo persino azzardarci a suggerire che è anche grazie alla PAN, alle sue copertine che virano le estetiche post-internet in una chiave acida e apocalittica, alla sua aura intellettuale ma anche perversamente orgiastica e decadente, che Berlino (una certa Berlino) è la città che meglio ha saputo convogliare i sapori, le inflessioni, le anticipazioni ma anche i vezzi dei recenti immaginari nati dalla fine della storia. Per il suo pubblico più integralista, non è tanto la PAN a essere un’etichetta di Berlino: è Berlino che è la città della PAN. Persino l’apparente paradosso della pressoché totale assenza in catalogo di artisti nati e cresciuti in Germania può essere preso come inconfutabile prova del ruolo di magnete transnazionale che la capitale tedesca si è conquistato da almeno quindici anni. Il suo stesso fondatore è in fondo un greco apolide che ha cominciato producendo indigeribili rumorismi in bassa fedeltà, e che adesso si ritrova controvoglia nella prestigiosa ma anche scomoda posizione di arbitro del gusto di tutto ciò che suona “moderno” e “contemporaneo” nella più moderna e contemporanea capitale europea: Bill Kouligas. Di questo e di altro ancora ho parlato direttamente con lui, in vista della sua partecipazione all’edizione di quest’anno di Club To Club, dal 3 al 6 novembre a Torino (l’esibizione di Bill è prevista il 4).
Ciao Bill, spero tutto bene. Immagino che tu non te lo ricordi, ma noi ci siamo già incontrati tanto, tanto tempo fa.
Davvero?
Sì, saranno passati più di dieci anni. Eri in giro col tuo progetto dell’epoca, i Family Battle Snake.
Oh mio dio! [ride] Coi Family Bat- [ride]… Cristo… E dove ci saremmo incontrati?
A Roma, in un posto chiamato Fanfulla…
Oddio, oddio… [continua a ridere, palesemente imbarazzato]
…Ehm…
[ride]
Come mai questa… reazione?
Oh, be’… Sai, sono passati anni… Non frequento più molta gente di quel periodo… Era tanto tempo fa…
Capisco. Non hai un bel ricordo di quegli anni?
Sì, sì, certo… Ma sai, era tutto molto naif… [vuole palesemente tagliare corto]
Ci tenevo a partire da lì perché, dopotutto, se la PAN esiste è proprio per via dei Family Battle Snake. Insomma, agli inizi era praticamente la tua etichetta personale, no?
Sì, più o meno… Ero molto giovane, avevo cominciato come batterista e poi mi ero dato alla sperimentazione elettronica, e da lì… Diciamo che la PAN nacque dal desiderio di mettere in piedi una piattaforma dove pubblicare i dischi miei e delle persone che all’epoca mi interessavano. Un’altra funzione dell’etichetta era quella di fare da vetrina per il mio lavoro come graphic designer, visto che vengo da quegli studi lì. Ma parliamo del 2007, 2008… Da allora le cose sono molto cambiate. L’aspetto curatoriale si è parecchio evoluto, come PAN adesso curiamo installazioni, performance… Ormai siamo più uno studio che lavora su diversi formati, capisci? Ed eccoci ancora qui, quindici anni dopo.
Va bene, ma restiamo per un momento a quindici anni fa: tanto la PAN quanto i Family Battle Snake appartenevano – possiamo dirlo – a una comunità molto precisa, che per comodità riassumerei nella formula “scena noise”…
Possiamo dire così, sì. All’epoca la cosiddetta “scena noise” era una specie di movimento internazionale composto da musicisti ultra-underground totalmente disinteressati al mainstream, tutta gente che provava a sperimentare con suoni e musiche non convenzionali. In ogni città dove andavi, c’era una piccola comunità di artisti che si autoproduceva cassette, edizioni limitate, vinili con artwork fai-da-te… All’epoca sembrava qualcosa di molto grande, un vero movimento coeso e ramificato, ma a ripensarci adesso parliamo di scene minuscole composte da non più di cinquanta persone, che si tenevano in contatto attraverso scambi, piccoli tour e ovviamente MySpace, che adesso suona come qualcosa di antidiluviano. Era davvero poco più che una nicchia, molto ingenua, molto… piccola, ecco.
Era senz’altro un movimento di nicchia ma, se ci pensi, un sacco di gente viene da lì – compresi diversi musicisti che hanno avuto un ruolo piuttosto cruciale per la musica elettronica degli ultimi dieci anni: James Ferraro, Oneohtrix Point Never… Oppure, per restare in casa PAN, l’italiano Simone Trabucchi, adesso attivo col progetto STILL.
Con Simone in effetti ci conosciamo praticamente dagli inizi. Mi ricordo che lui saliva spesso a Berlino col suo progetto del periodo, Dracula Lewis, e in cambio lui organizzava le date per i Family Battle Snake in Italia – quasi sicuramente, quando ci siamo incontrati a Roma è stato per merito suo [confermo, ndr]. Eravamo molto amici, ma è anche vero che nel frattempo siamo parecchio cambiati, sia come persone che come musicisti e produttori. Sai com’è: gli anni passano, vieni esposto a nuove cose, nuove sonorità, non puoi continuare a fare la stessa roba in eterno…
Le cose che produci adesso con PAN sono in effetti molto diverse dal noise fai-da-te di metà anni Zero…
Cambiano le forme, ma l’approccio resta lo stesso: sperimentare, esprimersi attraverso una ricerca che è innanzitutto molto personale.
Hai accennato a Berlino: tu quando ci sei arrivato?
Circa quattordici anni fa. Nel gennaio 2009, se non sbaglio.
E prima eri a Londra, giusto? È lì che hai fondato la PAN…
Sì, ma a Londra ci sono rimasto pochi mesi in tutto. È solo quando mi sono trasferito in Germania che l’etichetta ha cominciato ad avere senso. Di fatto, il posto in cui la PAN è realmente nata è Berlino, perché è a Berlino che ho cominciato a essere esposto a tutta una serie di suoni, influenze, situazioni…
Tu però sei originario di Atene…
Sono nato e cresciuto lì, sì.
E non ti ha influenzato in alcun modo? Te lo chiedo perché, a parte un paio di casi isolati, nella PAN non c’è granché traccia dei tuoi trascorsi in Grecia.
Be’, la Grecia è senz’altro affascinante: tutta la sua storia, tutto il patrimonio artistico che viene dal passato… [sbuffa]. Ma è anche un posto che non ha mai conosciuto un vero rinnovamento culturale, almeno rispetto ad altri paesi europei. Ti ritrovi con questa eredità gloriosa e gigantesca, e poi un enorme vuoto in cui il tempo si è come fermato, anche per via di tutta una serie di vicende storiche succedute alla Seconda Guerra Mondiale… È una delle ragioni per cui ad Atene non è praticamente possibile avere una carriera artistica, specie se lavori nella musica. Ovviamente ci sono tante persone che si occupano di queste cose qui, ma niente di paragonabile a quello che succede nel resto d’Europa.
Dici? Io ad Atene ci sono stato e mi è sembrata al contrario una città piuttosto vivace, piena di realtà interessanti. Certo, capisco che non sia Berlino…
Eh no.
Ma ero curioso di sapere se sentivi ancora qualche legame con questo tuo retroterra mediterraneo. Ho visto che qualche mese fa hai partecipato a una specie di rassegna chiamata Mediterranean Futures che si è svolta proprio ad Atene (tra i partecipanti c’era anche Simone/STILL). Puoi spiegarmi meglio di cosa si tratta?
È una nuova stazione radio che si chiama Movement Radio: all’inizio doveva essere un festival di pochi giorni soltanto, poi la risposta è stata talmente entusiasta che la fondazione responsabile della rassegna [la Onassis, ndr] ha deciso di tenere in vita il progetto attraverso tutto un programma di talk, dibattiti, eventi… Il tema di fondo sono le connessioni sonore che vengono dall’intreccio di culture che si affacciano sul Mediterraneo: tutti questi paesi, ciascuno con le proprie tradizioni e le proprie rotte che rimbalzano tra Sud Europa, Medio Oriente, Africa… Trovo che sia un argomento estremamente affascinante: di sicuro, c’è un mucchio di roba che andrebbe indagata a riguardo.
Però non mi sembra che con la PAN tu stia lavorando in modo particolare sul tema – oppure sbaglio? Sì, hai pubblicato musicisti italiani, spagnoli… Ma, come dici tu, la PAN è pur sempre un’etichetta molto… berlinese, ecco. Le sue coordinate mentali sono spostate parecchio più a nord.
Dissento fortemente. Va bene, siamo di base a Berlino, ma il nostro catalogo è in tutto e per tutto internazionale: ci sono musicisti che vengono dall’Asia, dall’America, dall’Africa, dalla stessa Italia… Ora che ci penso, pubblichiamo più artisti italiani che tedeschi!
Ok, non fraintendermi: ne facevo più una questione di impronta curatoriale, se capisci cosa intendo. O se preferisci, di immaginario: che è sempre molto freddo, concettuale, con un sacco di teoria in mezzo e con questa estetica così algida, austera, “nordica”…
Ok, ho capito cosa intendi. Di sicuro, se dovessi trovare un aggettivo per PAN, l’ultimo che utilizzerei sarebbe “mediterraneo” – e questo nonostante io sia nato e cresciuto in Grecia. Ma per come la vedo io, la PAN è innanzitutto la voce di molti artisti diversi: naturalmente io sono il curatore dell’etichetta e sono sempre io che mi preoccupo delle diverse uscite, ma non ridurrei la PAN a una mia visione personale e univoca. Ogni artista rappresenta qualcosa a sé, ogni artista porta con sé differenti estetiche, differenti voci, differenti immaginari…
È interessante quello che dici. Perché in realtà, se c’è qualcosa che solitamente viene riconosciuta alla PAN, è proprio un’identità molto forte, coerente e definita. Un’uscita PAN non è mai solamente un disco: è innanzitutto… “un disco PAN”. È praticamente l’etichetta attorno alla quale Simon Reynolds ha costruito tutta la sua idea di conceptronica, che immagino sia una definizione che tu detesti…
Ovvio che la detesto! [ride] Senti, io rispetto molto Reynolds, lo seguo da sempre e credo di intuire cosa abbia voluto intendere con quel suo articolo, ok? Ma alla fine questa cosa della conceptronica mi è sembrata soltanto l’ennesimo tentativo di inscatolare tante cose diverse in un’unica categoria, per giunta orribile.
E però, quello che Reynolds sosteneva in quell’articolo era in fondo molto semplice e tutto sommato incontrovertibile: l’importanza che, in determinati circoli della musica elettronica “decostruita”, ha cominciato a rivestire il Significato con la S maiuscola. Ammetterai che i dischi della PAN strabordano di concetti, no? Basta leggere i comunicati stampa, sempre densi di riferimenti teorici, politici, filosofici, se non accademici in senso stretto…
E va bene, ma non capisco perché la musica non possa riflettere altri temi o essere ispirata da riflessioni più ampie. Chiaramente, gli ascoltatori sono liberi di pensare alla “musica e basta” e di disinteressarsi a quello che c’è dietro: perché in fondo la musica è anche un linguaggio molto fisico, che lavora innanzitutto su anima & cuore, e su questo non si discute. Ma lavora anche sul tuo cervello, e quando fai musica ci sono tante cose diverse che possono ispirarti… Magari un giorno ti svegli, leggi un libro, e quello ti fa venire voglia di comporre una traccia. Oppure vuoi riflettere sullo stato delle cose da un punto di vista politico, e anziché scriverci un articolo sopra lo fai attraverso il suono…
Il che è senza dubbio stimolante. Ma voglio leggerti un recente intervento del producer egiziano (ma di stanza a Berlino anche lui) Abadir, un musicista che – a sua volta – certo non difetta in retroterra teorico-politico-speculativo: “Finiamola con queste pretenziose descrizioni pseudo-accademiche [per dischi] mediocri e banali. […] Il risultato sono sempre più ascoltatori ormai affascinati da musiche tutto tranne che avventurose [e] musicisti felici di sguazzare in una comfort zone tanto musicale quanto concettuale”.
Ma sì, alla fine sono d’accordo con lui. È vero, è insopportabile questa specie di linguaggio pseudo-accademico, pseudo-teorico e pseudo-politico che adesso imperversa ovunque. Ogni tanto mi capita sotto mano un comunicato stampa, lo leggo e, sì, anche io porto gli occhi al cielo e dico: “oh mio dio, davvero hai bisogno di blaterare tutte queste cose?”
Non pensi che, alle volte, la stessa reazione possa suscitarla anche qualche comunicato PAN?
Sì, immagino di sì. Ma magari c’è anche chi legge il comunicato stampa e, grazie a quello, trova la musica ancora più interessante. Dipende sempre da quanto sei in sintonia col tema che viene affrontato. D’altra parte, c’è anche l’effettivo rischio di sovra-teorizzare cose che non hanno davvero a che fare con la musica in sé, e che tutti questi riferimenti, collegamenti e rimandi non abbiano un effettivo legame col contenuto musicale che viene proposto. Ma questo sta all’onestà dei musicisti – innanzitutto con loro stessi.
Forse ad aver contributo a questa “sovra-teorizzazione” è anche il legame sempre più stretto che determinati circuiti musicali intrattengono col mondo dell’arte, un altro ambiente che ormai da diversi anni insiste su una dimensione politica-filosofica piuttosto dubbia… Hai sempre il sospetto che, dietro all’abbraccio enfatico di tutti i vari ismi più o meno “radicali” pescati dal mondo della theory, si nasconda un intento non esattamente limpido (il fatto che a sua volta il sistema dell’arte flirti in maniera così esplicita con altre industrie come quella del fashion alimenta a sua volta altri sospetti ancora). Così alla fine ti ritrovi con intere opere ispirate a, chessò, “un approccio decoloniale alla queerness per un post-antropocene post-capitalista” e ti domandi “quanto di tutto questo è sincero, quanto è mero posizionamento?”
Senz’altro è un fenomeno reale. Ma parliamo comunque di persone che sfruttano e oggettificano tematiche che al momento appaiono “di tendenza” al semplice scopo di ottenere un po’ di visibilità e farsi un nome qua e là, e il cui lavoro non riflette in alcun modo – se non a livello puramente superficiale – gli argomenti che pretendono di sollevare. Soprattutto, nel momento in cui si affrontano tematiche per così dire sensibili secondo un approccio che vuole sembrare “radicale”, il loro impatto politico è nullo. Cos’altro posso dire? Alla fine è parte del sistema: capitalizzare su temi, parole e idee per puro profitto, o se va bene per scopi promozionali.
È anche illuminante come, nel momento in cui certe tematiche si fanno finalmente più concrete, la reazione del mondo dell’arte sia spesso di paura se non proprio di rigetto. Pensa a quello che è successo quest’anno a Documenta: a curarla viene chiamato il collettivo indonesiano Ruangrupa, così da dare un’effettiva spolverata “decoloniale” alla rassegna, e però ecco che loro se ne escono con una serie di interventi che le istituzioni locali considerano “controversi” e a essere ribadito è il predominio eurocentrico delle buone maniere e del controllo dall’alto. Insomma: ve bene essere impegnati, ma alle nostre condizioni.
Già.
Voglio dire: hanno letteralmente neutralizzato il motivo stesso per cui in teoria i Ruangrupa erano stati invitati a Kassel. Tu hai seguito la vicenda?
Sì, certo che l’ho seguita.
…E? Insomma, che idea ti sei fatto?
Be’, sai…
Ok, ho capito: meglio non parlarne.
Ma non è che non voglio parlarne, è che preferirei parlare delle cose che mi riguardano, di quello che faccio io, non di quello che fanno gli altri…
E va bene, allora parliamo delle ultime uscite PAN. Come mai questa ristampa in cassetta di DJ Spanish Fly? Te lo chiedo perché anch’io sono un appassionato di Memphis Rap…
È stato un atto di puro amore, un gesto molto spontaneo. Sono cresciuto con un sacco di musica diversa, tra cui Spanish Fly, e questo voleva essere il mio personale omaggio. Sono anch’io un fan del Mamphis Rap, mi piace la sua atmosfera dark, ossessiva, maniacale…
L’ultimissima uscita invece è X, wheel dell’italiano Heith.
Sì, lui è il cofondatore dell’etichetta milanese Haunter e io sono un suo fan sin dall’inizio. È capitato di incontrarci un po’ di volte in giro e quando lui ha notato il mio entusiasmo per la sua musica mi ha chiesto se ero interessato a pubblicare il disco che stava registrando, e io ovviamente ho accettato. È un lavoro veramente molto bello, perché unisce un sacco di influenze diverse: dal prog al folk all’heavy rock, tutto frullato in un linguaggio molto unico, personale. Ci ha lavorato per anni e nel disco trovi anche un sacco di collaborazioni, non solo musicali ma anche visive.
Senti, per chiudere: torniamo a un’uscita un po’ più vecchia e parliamo finalmente dell’unico (almeno credo) artista greco che hai pubblicato: Jar Moff.
Jar Moff! Sono contento che te lo ricordi!
Che fine ha fatto? Mi ricordo di aver comprato il suo disco Financial Glam a un tuo banchetto nel 2013 perché attratto dal titolo, e quando ho scoperto che era originario di Atene il mio entusiasmo è salito a mille. Perché nel 2013 la Grecia era nel pieno della Grande Crisi, c’erano tutti questi diktat del Fondo Monetario Internazionale, i famigerati prestiti di salvataggio, le speculazioni dei mercati finanziari, queste notizie drammatiche che arrivavano ogni giorno da Atene… Ed ecco che davanti avevo un disco che non solo nel titolo era un chiaro commento alla situazione politica-economica che la Grecia stava attraversando in quel periodo, ma che questa situazione riusciva a renderla anche musicalmente, in maniera molto drammatica ma anche fresca, nuova…
Lui è stato veramente fondamentale per l’etichetta. Più ci ripenso, più mi convinco che sia Financial Glam che il suo disco precedente (Commercial Mouth) hanno contribuito enormemente a rendere la PAN quella che è adesso. È un peccato che quasi nessuno se lo ricordi più… Jar Moff era un mio vecchio amico di Atene – un nome molto underground, non particolarmente conosciuto neanche all’epoca. Ha lasciato la musica già da qualche tempo, adesso è abbastanza isolato ormai e non lo vedi molto in giro. Come musicista faceva questi collage audio affilati e caotici che, come dici tu, erano davvero lo specchio esatto di tutta la disperazione, tutto lo smarrimento che si respirava nella Grecia di quegli anni. Penso tuttora che siano dischi non solo molto belli ma anche molto onesti, sinceri: li ascoltavi e riuscivi esattamente a percepire quello che volevano dire, e tutto questo unicamente attraverso la musica, senza bisogno di inutili descrizioni dal sapore didattico che ti spiegavano cosa, come, dove e perché.
Niente tortuosi riferimenti alla theory, insomma.
No: mettevi la puntina sul disco e, bum, capivi e basta.
Allora è possibile: conceptronica senza bisogno di sparare i concetti in cartella stampa.
Ahahah, sì, si può fare!