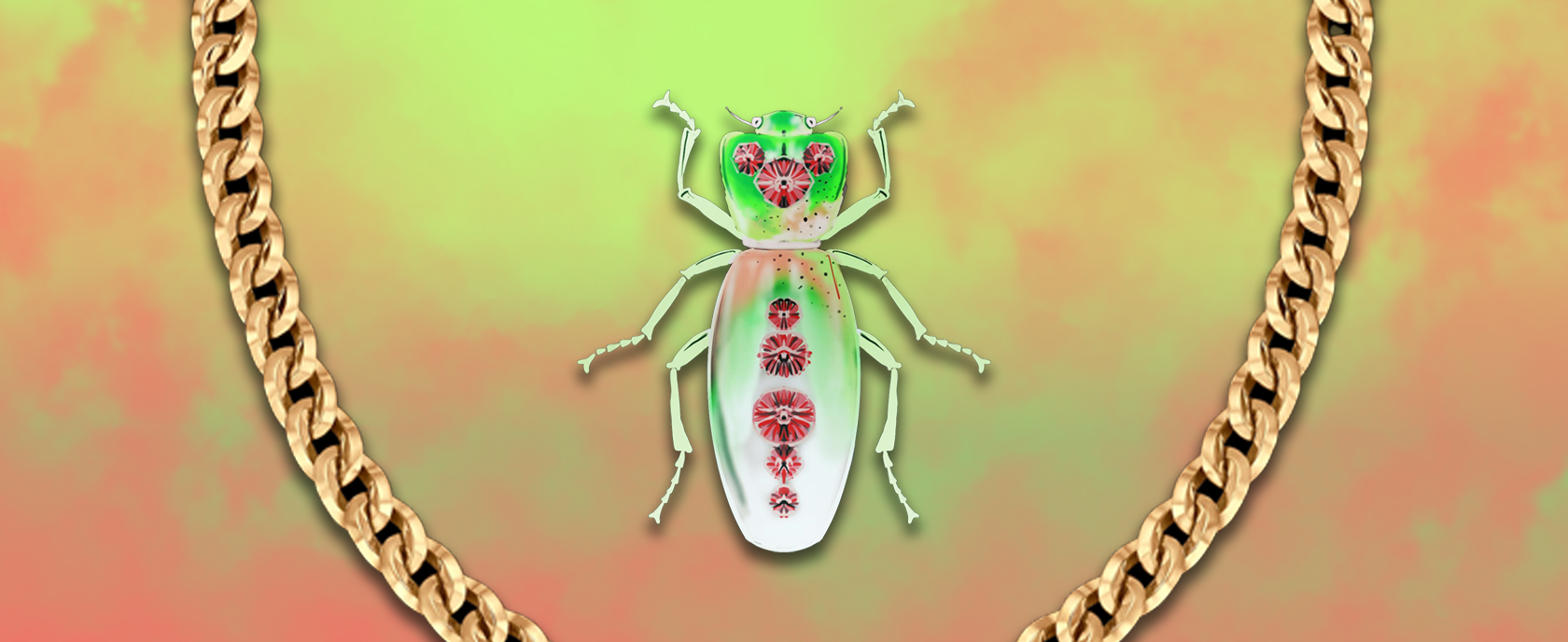L’anello mancante e quello di troppo
Questa è la storia di un poderoso scarabeo nato nelle terre selvagge dell’America Centrale del XIX secolo. Un giorno, mentre si trasformava ignaro nella quiete del suo bozzolo, fu portato via, destinato a diventare il gioiello domestico di una ricca signora. Trasferito dalla sua pupa alle attente mani di un orafo, l’insetto si ritrovò improvvisamente adornato da una raffinata selezione di gemme. Divenne così testimone silenzioso e onnipresente della vita della sua padrona. Divisi tra una minuscola gabbia e variegate architetture di tessuti, i giorni dello scarabeo prigioniero erano ormai riempiti da lunghe passeggiate solitarie. I suoi occhi compositi vagavano tra orizzonti avvolgentie l’occasionale merletto labirintico. I peli sensibili del suo corpo scivolavano su colletti inamidati e si divincolavano attraverso trame ingigantite. Le sue antenne si agitavano tra innumerevoli odori e suoni corporei. Oli profumati e ormoni, chiacchiere e starnuti fragorosi: tutto ciò sovrastava ogni altro elemento percettibile, mantenendo lo scarabeo isolato da qualsiasi cosa si trovasse a più di un paio di metri di distanza.
Il tempo passava nell’alternarsi tra questa routine metafisica e i ricordi sfocati di larva libera. Una delicata catena d’oro, tuttavia, teneva il coleottero intorpidito ben ancorato al suo presente. Finché, in un’afosa sera d’estate, accadde l’impensabile. Mentre stava sonnecchiando su un nastro di seta, una complessa stratificazione di vibrazioni pervase l’aria. La stanza cominciò a vorticare al ritmo della musica, il petto di Doña si strinse a quello di qualcun altro. Un’ondata di profumi seducenti avvolse le sue antenne, turbando il fino ad allora placido scarabeo. Una mano raggiunse il petto di lei per giocare con il filo di perle: il battito cardiaco di lei aumentò, e l’odore divenne ineluttabile. I feromoni riempirono i pori dell’insetto, risvegliandone l’istinto primordiale. Improvvisamente memore della propria missione, trascorse i giorni successivi ricordando l’aroma di quella secrezione e bramando messaggi chimici corrisposti. L’imperativo della riproduzione non poteva più aspettare; lo attendevano delicate carezze d’antenna e tronchi marci in cui accasarsi. Il suo tempo come prigioniero di lusso era finito. Così, lo scarabeo iniziò a progettare la sua fuga d’amore. Al riparo da occhi indiscreti, trascorse le notti di isolamento a rosicchiare il primo anello del guinzaglio metallico.
Un giorno, una volta posizionatosi nel posticino abituale, iniziò a girare silenziosamente intorno al fermaglio. Dopo numerosi giri eseguiti con noncuranza, l’anello si piegò dolcemente, offrendo un’apertura invisibile all’occhio umano, ma abbastanza grande da sconvolgere la vita di questo audace scarabeo. Le antenne fremettero, l’eccitato assaggio di libertà passò inosservato. Ora o mai più. Lo scarabeo si lanciò nel vuoto, ignaro del fatto che la sua elitra era composta da un’unica sezione e non presentava la spaccatura centrale che gli avrebbe consentitodi spiegare le ali. Un anello lo separava dalla libertà, ma un altro lo separava da centinaia di migliaia di parenti volanti. L’euforia lasciò il posto a uno sgomento dilaniante. “Cara, ti è caduta la spilla nel tè”.
Foto di Kristen Stipanov e Brendan McCabe
Il protagonista di questa storia è un esemplare di Zopherus Chilensis. Questo possente scarabeo è originario dell’America Centrale e particolarmente diffuso nello Yucatan, dove è noto anche come Maquech o Makech. Questo soprannome è preso in prestito da una leggenda Maya, secondo la quale un re trasformò l’amante segreto della figlia, già promessa in sposa a un altro uomo, in un insetto-gioiello per permetterle di tenerlo sempre con sé, vicino al cuore. Ancor prima della leggenda però, il destino del disgraziato coleottero parrebbe segnato dal suo nome scientifico: zopher, dal greco antico “cupo, malinconico”. Purtroppo, sia la classificazione linneana che l’epiteto vernacolare portano ancora sfortuna a questa specie di scarabei. Trafficati senza regolamentazione a causa di una legge messicana per la protezione degli animali che non contempla gli insetti, gli Zopherus Chilensis sono tuttora cacciati e venduti legalmente nel paese. Migliaia di coleotteri vivi che, ornati di pietre e incatenati a spille, vedono nella nell’incapacità di volare la propria maledizione.
Questa speculative fiction, ispirata alle antiche favole che spesso hanno animali non umani come protagonisti, è stata recentemente pubblicata da Cthulhu Books nel libro Making Kin – animal series. La stesura del volume ha coinvolto dodici autrici e autori che si sono cimentati in un’incarnazione interspecie e che hanno creato contributi che esplorano diversi modi di vivere l’alterità. La citazione al “fare parentela” di Donna Haraway rimanda all’essenza del genere xenofiction, che in questo progetto propone un esercizio di ricerca e immaginazione etologica, invitando chi scrive e chi legge a porre il proprio corpo nella prospettiva di un altro. Questo racconto vuole quindi accelerare la realtà socializzata degli animali non umani. Descrive un rapporto interspecie che a un primo sguardo potrebbe apparire estremo, ma che in realtà, a un qualche livello, è specchio di qualsiasi altra relazione animale in ambito domestico Vuole porre l’accento su come l’inclusione animale in un ambiente dominato dagli umani sia permessa solo secondo poche coordinate specifiche – a volte attraverso una non così metaforica catena d’oro.
Dalla comparsa del sedicente Homo Sapiens, le dinamiche relazionali tra animali umani e non umani sono state dettate dai primi in base a come le loro esigenze potessero venire soddisfatte dai secondi. Ed è così che gli animali non umani, in base alle rispettive evoluzioni, si sono ritrovati divisi in due categorie: desiderabili e indesiderati. La natura apparentemente non addomesticabile degli insetti, unita al fatto che la loro presenza in ambienti umanizzati sia percepita come un’invasione del selvatico incontrollabile, infestante, insalubre) li ha ovviamente posizionati nel gruppo degli esseri sgraditi. Col passare dei secoli, la repulsione verso gli insetti si è esacerbata soprattutto nel mondo occidentale che, salvo qualche rara eccezione, ha progressivamente iniziato a considerarli sintomo di sporcizia e povertà. La cultura del Centro America è invece di tutt’altro avviso: non solo gli insetti non hanno dovuto aspettare l’epoca vittoriana per veder compreso il proprio fascino, ma si sono ritrovati al centro delle pratiche cosmetiche che l’essere umano aveva fino ad allora riservato a sé.
Docilità e dimensioni ridotte li rendono un’ideale spilla vivente, e da presenza malaccetta a feticcio romantico, il passo è breve. Eccoci quindi a familiarizzare con la più grande classe di animali terrestri attraverso quello che sembra essere l’unico modo in cui siamo in grado di generare vicinanza con gli altri animali: l’antropomorfismo. Se l’antropocentrismo che preserva il nostro vantaggio nella gerarchia animale è largamente basato sull’enfatizzazione delle differenze interspecie e sulla segregazione che ne consegue, anche il concetto di antropomorfismo si basa sull’affermazione della natura umana. Paradossalmente, l’antica pratica di vestire gli altri animali, farli parlare e camminare sulle zampe posteriori non li avvicina a noi, ma ci ricorda chi siamo. Rimarca indirettamente l’eccezionalismo umano, ricollocandoci incessantemente al centro del nostro universo e forzando questa cosmovisione sul resto. Al tempo stesso, il senso di appartenenza a un più vasto regno animale è un ricordo talmente lontano che questa tendenza innata a travisare la realtà per comprenderla ci restituisce uno spiraglio di immedesimazione.
Foto di Kristen Stipanov e Brendan McCabe
Bloccati in un loop nel quale trascendere la prospettiva umana appare impossibile, assecondiamo questa dinamica contraddittoria e continuiamo a umanizzare gli altri animali per riuscire a empatizzare con loro. Che si tratti di un passaggio obbligato? Se desideriamo una relazione paritaria con le nostre controparti animali, forse un antropomorfismo creativo è un passo necessario: come scrive Teresa Castro, “un antropomorfismo creativo, in grado di farci comprendere la diversità e l’alterità della vita e dei viventi, un mezzo per diventare diversamente umani”. Se un’antropomorfizzazione consapevole e non condiscendente è possibile, come superare l’approccio Silly Symphonies e trovare nuovi modi di sfumare i confini tra la prospettiva umana e quella non umana? Come avvicinarci all’altro, e permettere all’altro di avvicinarsi a noi?
Crudeli o rispettose, sofferte o partecipate, tutte queste pratiche sono accomunate da un fattore: l’intrinseca mancanza di considerazione per la volontà degli animali che ne sono protagonisti.
Ben prima della pubblicazione di questo breve racconto, diversi esseri umani hanno tentato di traslare altri animali nella propria dimensione attraverso l’ingioiellamento di un esoscheletro o di un carapace. Uno di questi maldestri tentativi è descritto dal decadentista Joris-Karl Huysmans nel suo romanzo À rebours del 1885, il cui protagonista è l’aristocratico Des Esseintes. Il giovane, stanco della mondanità parigina, decide di ritirarsi a una vita solitaria, interamente dedicata alla maniacale soddisfazione di ogni possibile esercizio estetico. Le sue giornate si dividono tra incessanti sessioni di arredamento, degustazione di vini, miscelazione di profumi e cura di fiori esotici. Culmine di questo delirio è l’acquisto di una tartaruga, il cui carapace viene placcato d’oro e ricoperto da un intricato motivo di gemme. Il nevrotico alternarsi di ripensamenti e correzioni stremano la testuggine, che a opera compiuta si scopre essere morta sotto il peso delle incastonature.
Un’altro esempio si presenta invece sotto la forma di una tendenza frammentata, che negli ultimi decenni si è affacciata nelle pratiche di diversi artisti. Tra gli esempi più noti c’è il lavoro di Hubert Duprat, che a partire dagli anni ‘80 ha iniziato una serie di sperimentazioni con le larve di tricottero. Queste camole si distinguono per la maestria con cui si proteggono durante lo stadio pupale, costruendo un astuccio di frammenti organici di ogni tipo, incollati tra di loro con un filo appiccicoso prodotto dall’animale. L’intervento di Duprat consiste nell’inserire questi insetti in ambienti controllati, dove gli unici materiali a disposizione sono pagliuzze d’oro, perle e pietre preziose. Le larve diventano così piccoli orafi inconsapevoli, che una volta pronti allo sfarfallamento lasciano dietro di sé una distesa di preziosi bozzoli.
Hubert Duprat, Trichoptera larva with case, 1980-2000, foto di Frédéric Delpech
Un altro animale il cui guscio protettivo è stato oggetto di interesse artistico è il paguro: nel 2009 Aki Inomata ha iniziato diverse serie di lavori in cui offriva a dei paguri dei gusci in acrilico di ispirazione architettonica, e nel 2011 Pierre Huyghe ne ha vestito uno con una versione in miniatura della musa dormiente di Brancusi, nell’opera Zoodram 5. Crudeli o rispettose, sofferte o partecipate, tutte queste pratiche sono accomunate da un fattore: l’intrinseca mancanza di considerazione per la volontà degli animali che ne sono protagonisti.
Quando ho steso la prima bozza di questo racconto avevo deciso di scriverlo in prima persona, dando meno informazioni possibili sulla voce narrante, in modo che fino alla fine non fosse possibile identificarne la natura. Avevo iniziato descrivendo la routine dello scarabeo, le cui giornate si dividevano in due attività principali: stare nella gabbia nella quale dormiva e dalla quale osservata la sua padrona vestirsi e truccarsi, e partecipare a eventi mondani, legato a un guinzaglio di cui lei aveva il controllo. Inutile dire che, rileggendo la prima facciata, l’ipotesi che il protagonista della storia fosse uno slave particolarmente taciturno appariva più che fondata.
Aki Inomata, Why Not Hand Over a “Shelter” to Hermit Crabs? White Chapel, 2014
Se da una parte questo stratagemma narrativo è stato bocciato perché rendeva il racconto troppo astratto e oscuro, dall’altra è una prospettiva interessante da recuperare: svela in maniera diretta la natura abusiva di questa relazione interspecie, altrimenti opacizzata da un romanticismo che a volte è difficile scrollarsi di dosso. A prescindere dalla sensibilità e dalle intenzioni, tutti gli approcci finora descritti falliscono nel rispettare l’impossibilità degli animali di acconsentire ai trattamenti subiti. Da questa ovvietà si affaccia quindi un’attitudine dicotomica: agire dando per scontato che ciò che facciamo agli animali gli stia bene, continuando a ignorare il tema della consensualità, oppure interagire con loro nel modo più rispettoso ed etico possibile. Ammirarli da lontano, o tuttalpiù cercare contatti delicati e cortesi, senza forzarli in ambienti poco consoni alla loro natura né tantomeno intervenire sui loro corpi per piegarli ai nostri capricci. Chiederci se il gesto più amorevole che possiamo fare verso un cane è vestirlo quando fa freddo, oppure lasciar proliferare la sua razza nelle regioni climatiche che ne hanno modellato il corredo genetico.
Ritornando al concetto del fare parentela, o making kin, vale la pena porre attenzione su una sua declinazione più specifica, il making oddkin. Il termine odd (in italiano bizzarro, strano) viene utilizzato da Haraway nel testo Making Kin in the Chthulucene: Reproducing Multispecies Justice per immaginare relazioni di parentela pensate non come una
relazione riproduttiva ma come un’alleanza multispecie, trasversale e creativa. Un rapporto che faccia leva sulla reciprocità; sull’ascolto delle soggettività e sull’incontro di corpi diversi tra loro; sul creare narrative ibride che contemplano un’infinita diversità di punti di vista, descrivendo altrettante esperienze. Senza storie non si genera la Storia, e raccontarla non può più essere prerogativa dell’essere umano.