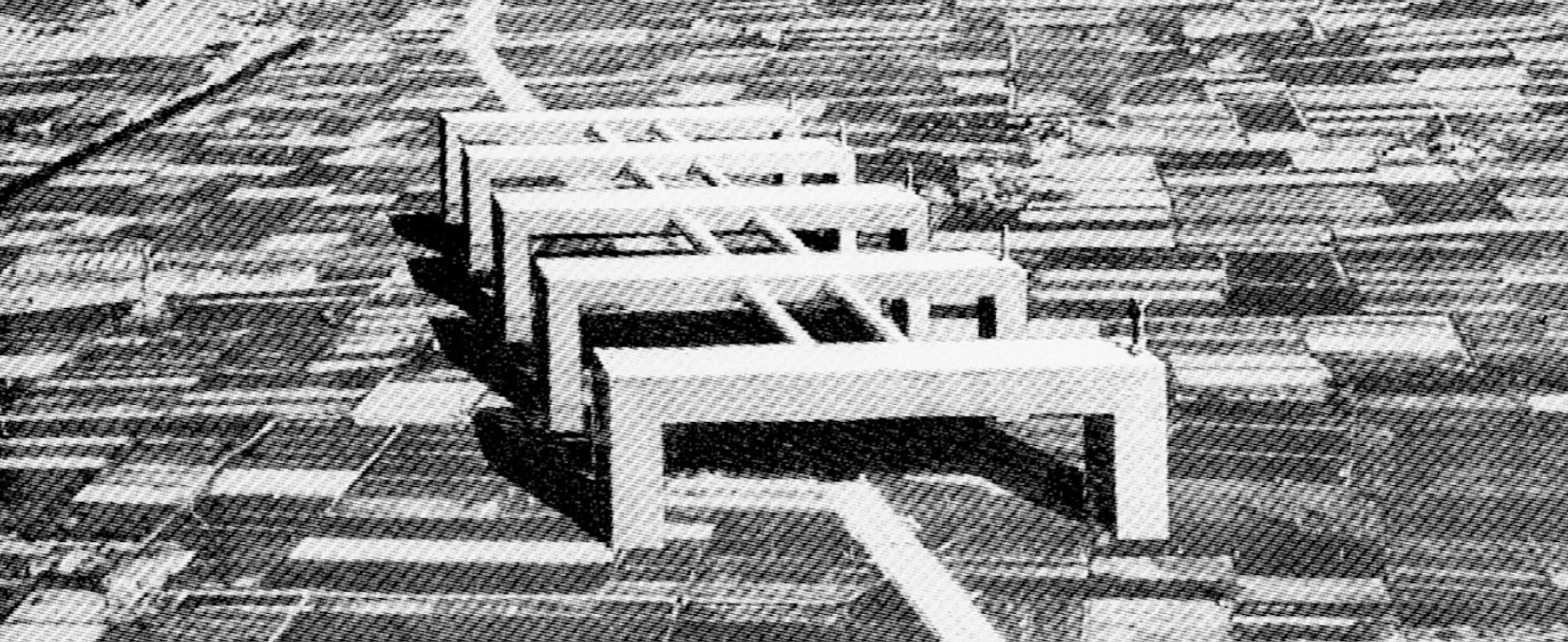Ipotesi per un’architettura accelerazionista
In un precedente contributo per Not, Edmund Berger ha analizzato quel «continuum occulto» che lega l’accelerazionismo hi-tech degli anni Duemila a una lunga tradizione di controculture acide. Qui Tommaso Guariento prova ad analizzare come le categorie accelerazioniste possono essere applicate all’architettura e – più in generale – all’esperienza urbana contemporanea, tra tentazioni ultraliberiste e ipotesi emancipatorie. L’accelerazionismo sarà inevitabilmente una delle parole chiave di Interregno, il festival su «futuro, tecnologie e utopia» che si tiene a Roma dal 20 al 22 ottobre, che con questa serie di articoli vi andiamo a presentare.

Haute Baroque Capitalism: uno dei progetti architettonici di Mark Foster Gage
Nell’ormai lontano 2013 Nick Srnicek e Alex Williams pubblicano il Manifesto per una politica accelerazionista, un documento che analizza le deficienze e i fallimenti dei movimenti anticapitalisti degli ultimi vent’anni (dall’altermondialismo a #Occupy e dintorni). Il progetto accelerazionista afferma la necessità di passare da un modello localista, immediato e orizzontale di opposizione politica (la folk politics) a una fase propositiva, egemonica e tecno-positiva.
Nel 2015 il manifesto viene formalizzato e ampliato in Inventing the future: postcapitalism and a world without work (in uscita a inizi 2018 per la collana Not di NERO col titolo di Inventare il futuro) dove però scompare il riferimento all’accelerazionismo, sostituito da un più sobrio «postcapitalismo». Il libro di Srnicek e Williams si compone di una pars destruens nella quale viene approfondita la critica alla folk politics e da una serie di proposte per la costruzione di una piattaforma socialista (automazione completa, riduzione della settimana lavorativa, reddito di esistenza incondizionato, esautorazione dell’etica del lavoro). L’elisione del riferimento all’accelerazionismo è stata una precisa scelta strategica, per evitare possibili accostamenti al suo vero profeta, il «rinnegato» Nick Land, cofondatore della CCRU di Warwick, fanatico di Deleuze, Guattari, Bataille e di romanzi cyberpunk, che nel frattempo è diventato un «pericoloso reazionario» e che a sua volta ha rilanciato con una propria versione dell’accelerazionismo epurata dai residui di umanismo utopico che (a suo dire) caratterizzano la visione di Srnicek e Williams.
Questa variante razzista, apocalittica e inumana dell’accelerazionismo, nella quale il progresso tecnologico è legato a doppio filo alla deterritorializzazione neoliberale, è caratterizzata da una filosofia della storia rigidamente teleologica, che si conclude con l’estinzione della specie umana e la nascita di un nuovo soggetto astratto, razionale e cibernetico. Significativo è anche come la trasformazione del pensiero di Land coincida (più o meno) con il suo spostamento dal Regno Unito a Shanghai, attraverso l’osservazione e l’approfondimento di quello che Žižek ha chiamato «capitalismo con valori asiatici».

Architetture accelerazioniste nei Jetsons (1962)
Quando ho cominciato a pensare a una rappresentazione dell’architettura accelerazionista, la prima immagine che mi è venuta in mente è stata quella del mondo automatizzato dei Jetsons, una serie animata di Hanna-Barbera cominciata nel 1962. L’immaginario tecno-utopistico dei Jetsons era composto da scale mobili, automobili volanti, tapis-roulant infiniti, edifici globulari sopraelevati, capsule geodetiche, e automi col grembiule. Negli anni Sessanta l’American way of life era al suo apice, e il futuro immaginato era quello di una società consumistica del post-lavoro, distantissima delle distopie contemporanee del «realismo capitalista». Certamente si trattava di una strampalata operazione ideologica volta a diffondere valori consumistici, ma la strana estetica capsulare dei Jetsons corrispondeva in qualche modo ai progetti dell’architettura radicale dell’epoca.
In realtà, non si trovano molte informazioni sull’architettura accelerazionista – almeno su internet: gli unici articoli degni di menzione sono quello di Benjamin Noys intitolato Architectures of Accelerationsm (testo di una conferenza tenuta presso l’Architectural Association School of Architecture il 20 Febbraio 2015) e Haute Baroque Capitalism di Toby Shorin, dell’11 aprile 2017. L’articolo di Noys prende spunto da un testo di Nick Land (Templexity: Disordered Loops through Shanghai Time) dedicato all’analisi di Looper (2012), film sci-fi di Rian Johnson che ha come tema le complicazioni politiche dei viaggi nel tempo. Al di là della trama del film, ciò che interessa a Land è la presenza della città di Shanghai, che emerge come rappresentazione paradigmatica del futuro delle metropoli. Questo tema è approfondito anche da Anna Greenspan, che, parlando dell’immaginario contemporaneo della megalopoli cinese, ricorda che in Her (2013) di Spike Jonze la rappresentazione del futuro di Los Angeles avviene proprio per mezzo di una dislocazione spaziale a Shanghai (le riprese del film sono state fatte in entrambe le città).
In Templexity Land discute della natura architettonica e spaziale della rappresentazione del futuro. Ritornando su temi già affrontati nei primi anni Duemila in testi come Meltdown o CyberGothic, afferma che le città funzionano come macchine del tempo, ovvero, convogliando iperstizionalmente le tendenze innovatrici disperse nel presente, e accelerando il processo di modernizzazione. Commentando il libro di Land, Noys afferma che la posizione del filosofo inglese rispetto all’architettura si trasforma appunto con il suo trasferimento a Shanghai. Mentre negli anni Novanta e Duemila il futuro della città è immaginato nelle modalità narrative dei romanzi di William Gibson e di film come Apocalypse Now, Terminator e Blade Runner, arrivato in Cina Land inizia a vedere la sua materializzazione urbanistica nella forma stratificata delle metropoli asiatiche. A questo punto Land ha già deciso quale sarà lo stile della sua architettura accelerazionista: l’Art déco.
L’Art déco è preferibile in quanto stile anomalo: moderno ma non modernista, instabile ma non postmodernista. Nel caso di Shanghai, la città del futuro «si avvolge in avanti e indietro», attraverso l’iterazione e la reiterazione di questo stile. Per dirla con le parole di Land, «la sua complessità può sembrare schiacciante, si ripiega in modo esorbitante in ciò che già si era ripiegato in se stesso», ed esprime così un «cosmopolitismo positivo».
Per Land lo stile déco mescola «epistemologia coloniale» e «tecno-scienza metropolitana».
Eppure la scelta dell’Art déco è piuttosto… inusuale: è uno strano intreccio di Art Nouveau e Modernismo, diffusa in Francia, Olanda, Germania e Stati Uniti fra gli anni Venti e Trenta del Novecento, e si ispira in particolar modo all’arredamento dei transatlantici di lusso. Se la sua rappresentazione paradigmatica è espressa in Metropolis di Fritz Lang (1927), per Land l’architettura contemporanea di Shanghai è neo-moderna proprio nel senso déco del termine.
Negli anni Sessanta e Settanta, in contrapposizione ai rigidi dettami del CIAM (i congressi internazionali di architettura del Movimento Moderno), nacquero innumerevoli movimenti e progetti che tendevano a localizzare l’astrattezza ideale della lezione di Le Corbusier e relativi eredi: tra questi, ricordiamo il collettivo inglese Archigram, il metabolismo giapponese, la New Babylon di Constant, Yona Friedman, e ovviamente gli italiani Superstudio e Archizoom. Una delle critiche più interessanti al Movimento Moderno fu quella mossa dagli studiosi di «architettura vernacolare» espressa in Architecture without architects (mostra del 1964 al Moma di New York e testo di Bernard Rudowsky). Nelle ciniche parole di Rem Koolhaas:
«Si gettano le fondamenta ideologiche di una idealizzazione critica rovesciata, in cui le masse indistinte del Terzo Mondo sono percepite come antidoto alla sterilità della modernizzazione: si suppone che i “valori” del sottosviluppo incarnino una ideologia antimaterialista; si traggono lezioni da terre “non sfruttate” come Cina, Vietnam, India, Africa – culture più comunitarie rispetto a quelle dell’Occidente individualista e atomizzato; si raccolgono nuove concezioni provenienti dall’Asia, presumibilmente più sottili, imperscrutabili, stoiche.»
Anche l’Art déco si ispira alle costruzioni vernacolari e alle ricerche etnografiche, ma lo fa in un modo decisamente coloniale. Meglio ancora, per Land lo stile déco mescola «epistemologia coloniale» e «tecno-scienza metropolitana»: è ornato da rovine egizie, templi cinesi e sfingi, e sovra-codificato da un simbolismo arcano e opulento. Questo insieme eterogeneo di elementi vi ricorda qualcosa? Immagino di sì, e la risposta è chiaramente Blade Runner TRUMP. L’art déco è decisamente lo stile d’arredamento degli appartamenti del neopresidente americano: marmo, oro, stucchi, lampadari immensi, caratteri tipografici fascisti. In altre parole, «haute baroque capitalism»:
«Il capitalismo barocco sostituisce gli altri stili non solo perché è più accattivante dal punto di vista visivo. È anche filosoficamente più avanzato rispetto alle vecchie posizioni intellettuali e alla loro estetica. Lo stile barocco-capitalista rifiuta la formulazione modernista, che impone restrizioni alla forma e allo stile, ed anche la teoria critica dell’architettura, che si oppone fondamentalmente alla crescita e alla natura di sfruttamento del capitale. Il capitalismo barocco è l’opposto del minimalismo di lusso. Invece di nascondere la decorazione visiva, l’estetica Trump la abbraccia al massimo, perdendo ogni parvenza di razionalità man mano che fioriscono intricate forme dorate» (Toby Shorin).

A sinistra, l’interno della Penthouse di Donald Trump a Manhattan. A destra, la prima classe del transatlantico francese Normandie (1935-1946)
Questa ricostruzione dello stile architettonico accelerazionista è parziale, e considera solo i suoi aspetti più reazionari, opulenti e coloniali – si tratta, in altre parole, della versione accelerazionista fatta propria dall’Alt-Right. La mia ipotesi però è che sia possibile tracciare una genealogia alternativa di un’architettura accelerazionista, left-oriented, che si discosta sia dalle posizioni neo-vernacolari di antropologi e sociologi come Henri Lefebvre e Marc Augé, che dalle utopie panarchiche della Silicon Valley. È una genealogia che comincia con il Manifesto dell’architettura futurista di Antonio Sant’Elia (1914), nel quale si afferma:
«Nella nostra vita sono entrati elementi di cui gli antichi non hanno neppure sospettata la possibilità; vi sono determinate contingenze materiali e si sono rilevati atteggiamenti dello spirito che si ripercuotono in mille effetti; primo fra tutti la formazione di un nuovo ideale di bellezza ancora oscuro ed embrionale, ma di cui già sente il fascino anche la folla. Abbiamo perduto il senso del monumentale, del pesante, dello statico, ed abbiamo arricchita la nostra sensibilità del gusto del leggero, del pratico, dell’effimero e del veloce. Sentiamo di non essere più gli uomini delle cattedrali, dei palazzi, degli arengari; ma dei grandi alberghi, delle stazioni ferroviarie, delle strade immense, dei porti colossali, dei mercati coperti, delle gallerie luminose, dei rettifili, degli sventramenti salutari.»
Posizione interessante quella di Sant’Elia, che sembra anticipare di un secolo il Manifesto accelerazionista e i suoi difetti. La critica mossa da Benjamin Noys al Manifesto di Srnicek e Williams potrebbe in effetti essere tranquillamente rivolta anche a Sant’Elia: esiste un rapporto contraddittorio fra l’elaborazione di un’architettura fluida ed effimera e la necessità d’installarsi materialmente in un territorio. Facendo proprie le critiche di Toni Negri al Manifesto, Noys evidenzia come, se la proposta di Land è connessa a un immaginario specifico (l’Art déco e il modello delle città-Stato asiatiche), gli accelerazionisti di sinistra elidono completamente il problema dello spazio.
Questo è in parte falso: in Inventare il futuro, una parte estremamente importante del quinto capitolo è dedicata all’analisi delle forme attuali del «surplus di popolazione» e al problema dei fenomeni migratori. Lo spazio è qui affrontato secondo l’ottica della deindustrializzazione e dell’impoverimento delle zone periferiche (ghetti americani, banlieues francesi, new towns inglesi). In modo particolare, stando ai loro dati, la percentuale della popolazione inattiva del pianeta – fra precari, disoccupati, inoccupati, disabili, lavoratori in nero e studenti – sarebbe fra il 40 e il 70%: in questo senso, le analisi di Srnicek e Williams potrebbero essere espresse nella dicotomia fra Il pianeta degli slums e i Paradisi maligni del neoliberalismo (per citare i titoli di due importanti libri di Mike Davis) e narrate nelle distopie di Hunger Games (2012-2105) ed Elysium (2013). Un immaginario neofeudale caratterizzato dall’opposizione fra un’orda di individui impoveriti e rancorosi e un’élite inamovibile al comando.

A sinistra: Antonio Sant’Elia, La città nuova (1914). A destra: Tony Garnier, Cité industrielle (1904/1917)
Tornando al Manifesto di Sant’Elia: è noto come il progetto per la Città Nuova (1914) dell’architetto italiano abbia condizionato l’immaginario di Metropolis. Nonostante la pomposità della prosopopea futurista, è possibile associare la Città Nuova alle idee utopico-socialiste di Fourier e alla Cité Industrielle di Tony Garnier (1904). Quest’ultima era un vera e propria «fabbrica sociale», sgomberata dagli edifici religiosi e dalle istituzioni repressive. A questo punto la nostra ricostruzione genealogica inizia a diventare interessante, perché l’idea di «fabbrica sociale» è uno degli elementi chiave dell’operaismo italiano degli anni Sessanta, i cui legami con l’architettura sono stati recentemente ricostruiti da un importante libro di Vittorio Aureli. Secondo gli operaisti la forma che il nuovo capitalismo aveva assunto nei processi d’innovazione dell’industria fra gli anni Sessanta e Settanta aveva prodotto un’estensione del modello capitalista dal confinamento spaziale delle fabbriche all’intera società. Nelle parole di Negri:
«Oggi attraversare una metropoli è attraversare una fabbrica immateriale. E nella stessa maniera in cui nelle fabbriche fordiste coabitavano la durezza della produzione e la gioia dell’incontro, dello stare assieme, del costruire la classe, così nella metropoli coabitano ora la solitudine e la moltitudine. La metropoli è il capitale costante in azione, è un’espropriazione forsennata della forza-lavoro.»
La citazione proviene da un articolo scritto da Negri a commento di alcuni testi dell’architetto olandese Rem Koolhaas. La mia ipotesi è che vi sia un legame diretto fra le idee politiche e architettoniche di Koolhaas e quelle di Nick Land. Per dirla con una formula: Meltdown sta a Junkspace come Templexity sta a Singapore Songlines. In particolare quello che colpisce è il cinismo pervasivo dei testi, un’ironia corrosiva rivolta alla crisi delle politiche ideologiche del socialismo. Ma non si tratta solo di questo: l’idea centrale che accomuna Land e Koolhaas è l’atteggiamento disincantato e positivo rispetto a quegli elementi alienanti, razionalistici e (non c’è un modo diverso di dirlo) neoliberali che caratterizzano le attuali forme asiatiche del capitalismo. Nella sua elegia della trasformazione di Singapore da colonia britannica a incubatore del nuovo capitalismo, Koolhaas afferma:
«Se la transizione dallo slum inglese al complesso residenziale è stata traumatica, il salto dalla shophouse cinese – tipologia che concentra negozio, officina, residenza in un caseggiato raccolto attorno ad un cortile – agli altri contenitori di Singapore è anche più spietato, non solo in termini di differenza materiale – dall’asiatico all’occidentale – ma perché i nuovi abitanti, tagliati fuori dalle reti connettive di relazioni, tradizioni, abitudini familiari, sono brutalmente costretti in un’altra civiltà: la stecca residenziale come macchina del tempo.»
Vediamo qui descritta in termini completamente disincantati la stessa idea di urbanizzazione come «macchina del tempo» espressa da Land in Templexity. Singapore funziona per Koolhaas come modello paradigmatico per la futura politica ed architettura cinese: un misto di autoritarismo e securizzazione, di elementi vernacolari manipolati a piacere, di alienazione e grandiosità.
In altre parole sia Land che Koolhaas sono affascinati dal «sinofuturismo», un concetto originariamente coniato dalla stessa CCRU e che recentemente è stato approfondito dall’artista Lawrence Lek in opere come Sinofuturism (2016) e Geomancer (2017). Per Sinofuturism Lek intende l’incubazione di un futuro modello di umanità (un processo d’individuazione collettiva, per dirla con Simondon), che emerge dalla convergenza di sei «stereotipi» o «invarianti» della cultura cinese contemporanea: l’utilizzo massivo delle tecnologie informatiche, l’industria legata alla copia di prodotti del mercato statunitense ed europeo, l’emergenza di comportamenti additivi nel mondo del lavoro, del gioco online, del gioco d’azzardo e dello studio. Dall’unificazione di questi elementi emergerebbe un’umanità de-individualizzata, sclerotizzata, competitiva, tech-oriented, che non punta a vincere un posto d’onore nella scacchiera geopolitica, ma a sbaragliare gli avversari per mezzo della sua tenacia e resistenza. È l’emergenza del general intellect preannunciato dagli operisti negli anni Settanta, ma in una forma inattesa, nella sua versione lobotomizzata e docile. Il sinofuturismo ha anche un suo fascino visivo e narrativo – la conflagrazione di elementi vernacolari (i mercati, lo street food, le biciclette) con megastrutture architettoniche inglobanti. Così come in Her, anche le prime, iconiche immagini di Blade Runner sono permeate di sinofuturismo. Ma la Cina attuale non ha bisogno d’immaginare un futuro che sia cronologicamente distante: le basta edificarlo.

A sinistra: Ridley Scott, Blade Runner (1982): Los Angeles. A destra: Bing Thom Architects e Ronald Lu & Partners, Xiqu Centre (Hong Kong, in realizzazione)
Dal punto di vista architettonico, il sinofuturismo è descritto da Land come un’oscillazione fra temporalità contrastanti, stili architettonici premoderni o arcaici innestati in modernissime strutture di vetro e cemento. Tutto questo sembrerebbe preludere ad un’interpretazione postmoderna del fenomeno, null’altro che un mero esercizio di copia degli stili americani ed europei. D’altronde lo storico dell’architettura Charles Jencks definisce in questo modo una tipica costruzione postmoderna:
«È un edificio ibrido, che drammatizza la mescolanza di periodi contrapposti – passato, presente e futuro – al fine di creare una time-city in miniatura. È dunque basato su codici multipli, che combinano tecnologia universale moderna e cultura locale, in un “double-coding”, o doppia codificazione, riconoscibile, il suo stile caratteristico. Il tipico edificio postmoderno parla contemporaneamente a livelli diversi, alla cultura alta e bassa, e riconosce la situazione globale nella quale nessuna cultural può parlare da sola per il mondo intero.»
Però, a ben vedere, Land non parla di compresenza di tratti architettonici cronologicamente e stilisticamente eterogenei, ma di loop temporali, in una contaminazione molto più instabile. Questo perché nelle metropoli contemporanee si realizzerebbe una versione particolare della fine della storia, nella quale il tempo, ciberneticamente, si riavvolgerebbe in se stesso, in un continuo cortocircuito cronologico. Non si tratta di postmodernismo, ma di metamodernismo – secondo la recente caratterizzazione di Timotheus Vermeulen e Robin Van den Akker:
«Ontologicamente, il metamodernismo oscilla tra moderno e postmoderno. Oscilla tra l’entusiasmo moderno e l’ironia postmoderna, tra speranza e malinconia, tra naïveté e conoscenza, empatia e apatia, unità e pluralità, totalità e frammentazione, purezza e ambiguità. Infatti, oscillando avanti e indietro, il metamoderno negozia tra moderno e postmoderno.»
A questo punto la storia diventa ancora più interessante, perché l’edificio paradigmatico al quale si riferiscono Vermeulen e Van der Akker da un lato e Charles Jencks dall’altro è lo stesso, ovvero il CaixaForum di Madrid, progettato dagli svizzeri Herzog e De Meuron. Come a dire che la stessa struttura può essere interpretata come combinazione contraddittoria di elementi diversi (postmoderno) o come oscillazione dinamica di temporalità eterogenee (metamoderno).

Herzog e De Meuron, CaixaForum (Madrid, 2007)
A questo punto, possiamo tirare le fila del nostro ragionamento e stilare una breve tipologia delle forme dell’architettura accelerazionista, ispirandoci liberamente a un articolo di Alejandro Zaera-Polo, The politics of the envelope. Neanche a farlo apposta, l’architetto spagnolo utilizza ampiamente opere di Herzog e De Meuron come esemplificazione della sua classificazione. Zaera-Polo s’ispira alla filosofia di Bruno Latour e Peter Sloterdijk e identifica nella forma dell’involucro («envelope») la matrice di tutte le forme più innovative dell’architettura contemporanea. L’involucro si presenta come una struttura semplice e allo stesso tempo complessa: è un modulo strutturale che separa interno ed esterno e non possiede la facciata identitaria dei palazzi Seicenteschi e Settecenteschi. L’involucro è frutto di nuove tecnologie produttive, preannunciate nelle strutture reticolari dalle capsule di Buckminster Fuller. L’involucro ha anche una precisa connotazione politica: è legato alla Dingpolitik di Latour, e questo significa che si tratta di una forma post-ideologica, che intercetta trasversalmente problemi legati al riscaldamento globale, alla migrazioni e alla sovrappopolazione. È una politica delle reti, delle mediazioni tecnologiche, delle associazioni e delle traduzioni: una politica fondata sui problemi più che sulle tesi programmatiche. L’aspetto più interessante dell’envelope è che si tratta di una megastruttura, ovvero uno spazio collettivo stratificato, atto a ospitare diverse funzioni: una città o un frammento di paesaggio incarnato in un edificio. Non è un caso se molte delle future megastrutture saranno costruite in Cina, in Corea o a Singapore: si tratta dell’emergere di quella che Sloterdijk ha chiamato «società capsulare»:
«Questa società capsulare e i suoi fenomeni come il provincialismo globale, la politica di climatizzazione e gli uteri sociali descrivono un nuovo paradigma che richiede non solo un ripensamento delle tecnologie e dell’economia dell’involucro edilizio, ma delle sue implicazioni politiche, sociali e psicologiche.»

A sinistra: Warren Chalk, Capsule (1964). A destra: Kishō Kurokawa, Capsule Tower (Tokyo, 1972)
L’idea di una struttura architettonica capsulare e allo stesso tempo effimera, fluida, accelerazionista è stata avanzata per la prima volta nel progetto della Capsule (1964) di Warren Chalk, ma si è concretamente realizzata nella Capsule Tower (1975) dall’architetto metabolista Kishō Kurokawa. Come afferma Koolhaas, mentre in Europa si progetta, in Asia si realizza.
La ripresa contemporanea dell’architettura capsulare non è però un banale sfoggio d’immaginazione spaziale, ma un sintomo delle recenti trasformazioni geopolitiche; si tratta, in altre parole, della manifestazione urbanistica di un paradigma politico policentrico, legato alla crisi dello Stato-nazione e all’emergere di piccole enclaves, micro-nazioni o città-Stato dotate di un sistema giuridico, politico ed energetico autosufficiente. Fra i promotori di questo modello ci sono ovviamente i miliardari della Silicon Valley, con l’ipotesi tecno-utopistica del seasteading, ovvero la costruzione di paradisi fiscali e tecnologici nell’oceano, un po’ come la Rapture di BioShock. Un progetto, che era stato ipotizzato negli anni Sessanta dai metabolisti con l’idea della Marine City (1958) di Kiyonori Kikutake. Alcuni l’hanno chiamato paradigma dell’assedio, altri panarchia.

A sinistra: Kiyonori Kikutake, Marine City (1958). A destra: Seasteading Institute, Floating Island (Polinesia francese, in realizzazione)
Per un tipologia delle architetture accelerazioniste:
Spazi Capsulari: Così come i passages parigini per Benjamin e Coney Island per Koolhaas, le architetture capsulari sono l’oggetto architettonico paradigmatico nel quale si riflettono le tendenze della seconda decade del XXI secolo. Si presentano in forma di monolocali (le capsule di Kurokawa), in quella mega-strutturale della Pechino durante le Olimpiadi del 2008 e infine nella realizzazione di vere e proprie città-Stato isolate (il progetto del Seasteading Institute). Legati a un immaginario politico libertario, piratesco e anarcocapitalista, gli spazi capsulari offrono il giusto mix di sicurezza, distanza e avventura. Di contro, rappresentano il fallimento delle idee democratiche del multiculturalismo, il ritorno a un ordine giuridico medievale e la fuga da quel coacervo di relazioni, mediazioni e traduzioni che caratterizzano la Dingpolitik concreta.
Retrotopie: Si tratta di quegli spazi industriali, carcerali e medicali legati al XIX e agli inizi del XX secolo: prigioni, ospedali, sanatori, new towns, fabbriche. Dispensati dalla funzione coercitiva e produttiva che hanno avuto il secolo scorso, queste zone sono state invase dall’immaginario delle narrazioni New Weird, infestate da mostri, fantasmi e altre presenze hauntologiche. Sono spazi molto importanti per l’immaginario contemporaneo, perché costituiscono allo stesso tempo il nostro passato, e si riflettono nel nostro modo di rappresentare il futuro. L’immaginario post-apocalittico di film come The Road (2009) e videogiochi come Fallout (1997-2015) si nutre di questi luoghi, e li usa come palinsesti per la proiezione di paure e speranze. Ne ho parlato qui.

Retrotopia: foto del Buzludzha Monument (Bulgaria)
Ipertopie: Sono gli spazi virtuali come quelli costruiti da architetti convertiti al mercato dell’arte, nonché qualsiasi RPG o FPS. Si possono suddividere in spazi di simulazione (ne ho parlato qui) o progetti di realtà aumentata (di cui discuto qui). Contrariamente a quello che si potrebbe pensare, gli spazi virtuali e immateriali non sono legati all’estetica accelerazionista contemporanea, quanto alle paure pre-11 settembre. La barriera fra reale e virtuale si è liquefatta con l’introduzione di smartphone e altri portable devices, rendendo di colpo obsoleti tutti i discorsi di Baudrillard, Marc Augé e altri. È per questo che siano passati a una fase successiva, una meta-riflessione sulla cultura virtuale, come nelle ultime opere di Harun Farocki, Hito Steyerl e il già citato Lawrence Lek.
Spazi astratti: Il vero problema di concepire un’architettura accelerazionista che non ricada nelle fantasie feudali del seasteading o nella glorificazione dello stile coloniale dell’Art déco è la necessità di conciliare la spinta moderna della critica all’architettura vernacolare (pace Augé e Lefebvre e la folk politics) con la completa realizzazione sinofuturista di una città perfetta dalla quale sono stati espulsi anche gli esseri umani. Aureli ci rinvia alla No-Stop City (1971) di Archizoom, uno spazio di riconversione del modello dei «nonluoghi» (aeroporti, supermarket, magazzini). Uno piano astratto ma allo stesso tempo trasparente, che rende visibile la natura ineguale dello spazio urbano. Una mappa per orientarsi nel paesaggio iposignficativo della metropoli contemporanea. Insomma, ancora una volta, il problema politico è quello di capire quanto dentro e quanto contro dobbiamo situarci rispetto al realismo capitalista.