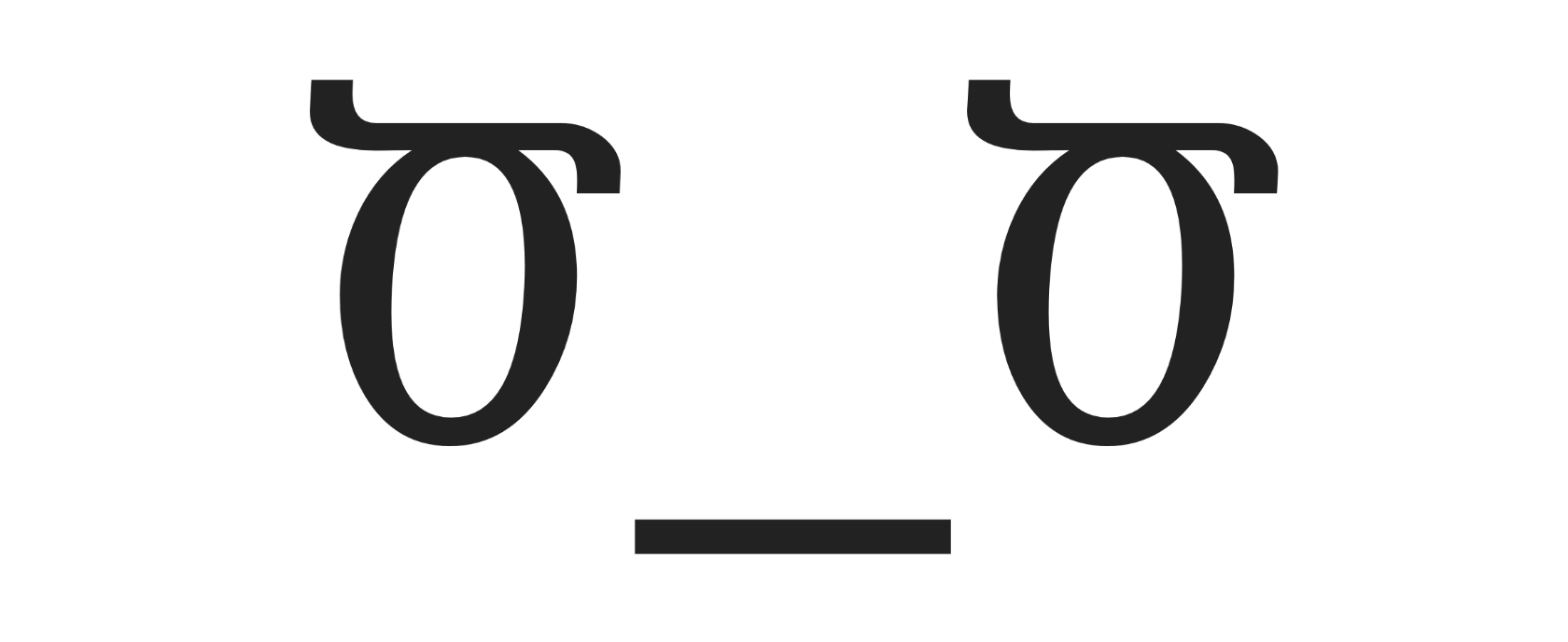Uscire dal realismo capitalista della mente
Sono passati quarant’anni dall’approvazione della legge 180/1978, più comunemente nota come Legge Basaglia dal nome del suo promotore, e i manicomi in Italia per fortuna non esistono più. In compenso anche in Italia, come in tutto il resto dell’Occidente, vengono utilizzati sempre più psicofarmaci: 1,6% in più di antidepressivi nel 2017 rispetto all’anno precedente secondo i dati Federfarma (che registrano comunque un aumento più contenuto rispetto al resto dell’Europa: +1,9% in Germania, +2,9% in Spagna e il solito prevedibile record del Regno Unito, che totalizza un +5,4% confermandosi il Paese delle Pillole). Per non parlare degli Stati Uniti, dove secondo il Scientific American una persona su sei fa uso di qualche tipo di psicofarmaco. C’è un collegamento tra i due eventi? I successi dell’antipsichiatria hanno qualche rapporto col trionfo degli stabilizzatori d’umore?
È una domanda che può apparire provocatoria, se non direttamente mal posta. Eppure forse può aiutarci a illuminare il nesso che lega il disagio psichico col più ampio contesto politico e sociale in cui viviamo. Per provare a rispondere, cominciamo quindi ripercorrendo in breve la storia di Basaglia. Nel farlo ci baseremo sul documentatissimo libro di John Foot pubblicato per Verso nel 2015, The Man Who Closed the Asylums, tradotto in italiano come La «Repubblica dei Matti» da Feltrinelli.

Breve storia di Basaglia e dei basagliani negli anni Sessanta
Franco Basaglia comincia il percorso che l’avrebbe reso una delle figure chiave dell’antipsichiatria a Gorizia nel 1961. Veneto, figlio di una famiglia borghese, durante la guerra è stato un antifascista militante, esperienza che l’ha portato a trascorrere del tempo in prigione. Dopo aver «scelto un corso di studi a caso» (parole sue) ed essersi laureato in Medicina, per dieci anni fa l’assistente ricercatore all’Università di Padova. Quando si stufa di lavorare non pagato decide di cercare un lavoro vero e vince il concorso di direttore dell’ospedale psichiatrico di Gorizia.
La situazione che Basaglia trova a Gorizia somiglia a quella di un carcere: pazienti legati ai letti per la maggior parte del giorno, filo spinato sulle mura dell’edificio, lobotomie e varie forme di tortura fisica e psichica. A regolare la «cura» dei pazienti negli ospedali psichiatrici è una legge del 1904, non proprio all’avanguardia. Per un intellettuale politicamente schierato, quella situazione somiglia un po’ troppo alle prigioni fasciste. Siccome a nessuno importa di quello che succede a Gorizia, Basaglia si mette a lavorare in autonomia pressoché totale a un approccio diverso al problema della salute mentale, convocando attorno a sé una squadra di colleghi (Antonio Slavich), parenti (la moglie Franca Ongaro) e persino futuri rivali (come Giovanni Jervis). I reparti chiusi vengono aperti, i muri abbattuti, il filo spinato rimosso, i pazienti slegati dai letti. Si istituiscono assemblee settimanali. I medici si tolgono il camice e i pazienti vengono prima invitati a lavorare e poi, in certi casi, a tornare nel mondo «reale», almeno per periodi limitati di tempo.
Si tratta di una rivoluzione epocale, tanto che già nel 1965 il gruppo di Basaglia è abbastanza famoso da aver sollevato un dibattito nazionale. Nello stesso 1965 il Ministro della Sanità socialista Luigi Mariotti, che aveva conosciuto Basaglia l’anno prima, paragona gli ospedali psichiatrici ai lager nazisti in un famoso discorso tenuto a Milano. Nel 1967 Mariotti introduce con toni entusiastici Che cos’è la psichiatria?, il primo libro dell’equipe di Gorizia curato da Basaglia. L’anno dopo Mariotti riforma una prima volta gli ospedali psichiatrici (nel contesto di una più ampia riforma delle istituzioni ospedaliere) e Basaglia pubblica il secondo libro dei goriziani, L’istituzione negata, che contro ogni più rosea previsione diventa un bestseller, nonché uno dei libri cardine del Sessantotto.
Basaglia lascia Gorizia nel 1969, come vedremo. Negli otto anni trascorsi, nel frattempo, nel mondo sono capitati l’omicidio Kennedy, la marcia su Selma, la Summer of Love, l’allunaggio e, in Italia, l’autunno caldo. Il che ci porta ad allargare un po’ la prospettiva.

Breve storia dell’antipsichiatria
L’anno in cui Basaglia arriva a Gorizia, il 1961, è lo stesso in cui Michel Foucault pubblica Storia della follia. Nel suo primo grande libro, il filosofo francese sostiene che la condizione del «folle» cambia tra il Rinascimento e quella che chiama l’«Età Classica» tra il XVIII e XIX secolo. In quel periodo, l’affermarsi della ragione come principio guida delle società occidentali esclude ogni forma di «diverso» dal tessuto sociale, segregandolo nei manicomi. Oltre che essere un testo fondamentale degli anni Sessanta, Storia della follia è anche il primo tassello nella formulazione del concetto di «istituzione totale», che Foucault formulerà compiutamente in Sorvegliare e punire (1975).
Solo l’anno prima, nel 1960, lo psichiatra scozzese R. D. Laing aveva dato alle stampe L’io diviso, in cui proponeva il suo approccio «esistenziale» alla psicanalisi: per Laing il disagio psichico andava letto come una forma di strategia messa in atto dal soggetto per far fronte a richieste ambientali impossibili o dolorose. Le teorie di Laing, che aveva cominciato a elaborare già dalla metà degli anni Cinquanta, erano molto vicine a quelle di Gregory Bateson, che già nel 1956 parlava di «doppio legame» e di cause sistemico-relazionali alla base del disagio psichico. Per Bateson come per Laing, il problema della schizofrenia andava ricercato nelle famiglie degli schizofrenici, che gettavano sul «malato» di casa un disagio generazionale facendone, in sostanza, il capro espiatorio di un problema più ampio. Sempre 1961 data invece un’altra esperienza che sembra solo apparentemente separata: la pubblicazione di La terra del rimorso di Ernesto De Martino, libro che raccoglie gli studi del grande antropologo italiano sui riti di possessione del Meridione. Uno degli assistenti di De Martino era Giovanni Jervis, fondatore dell’etnopsichiatria italiana e dal 1962 parte del gruppo di Gorizia.
Alla metà degli anni Sessanta questa internazionale della psichiatria radicale era più forte che mai. Il suo nucleo geografico era il Regno Unito, che già negli anni Cinquanta aveva inaugurato quelle therapeutic communities che sarebbero diventate il modello per Gorizia. Dalla Scozia, dove si trovava la più famosa – diretta da Maxwell Jones – il modello delle therapeutic communities si era trasferito a Londra grazie al lavoro di seguaci di Jones come Laine e David Cooper. Nel 1967 proprio Copper aveva coniato il termine «antipsichiatria» con la pubblicazione del libro Psichiatria e antipsichiatria. Nello stesso 1967 Laing, Cooper e Gregory Bateson avevano tenuto alla Roundhouse di Londra un convegno intitolato The Dialectic of Liberation che sarebbe rimasto celebre come uno dei più grandi eventi della psichiatria radicale. Poi anche qui arrivò il Sessantotto, e quella che fino ad allora era stata un’esperienza tutta interna al mondo della psichiatria assunse una decisa coloritura politica.

Antipsichiatria e Sessantotto
Con l’arrivo del Sessantotto l’antipsichiatria comincia a confondersi con altre battaglie che vedono nell’istituzione e nel sistema capitalista il vero nemico da combattere. Alcuni degli esponenti dell’antipsichiatria sono contenti di questa evoluzione, altri no. Molti, tra cui Basaglia, assumono posizioni ambigue, talvolta rifiutando la connessione e talvolta appoggiandola. Già in Che cos’è la psichiatria?, ad esempio, si trovano passi come questo:
Ogni società, le cui strutture siano basate soltanto su una discriminazione economica, culturale e su un sistema competitivo, crea in sé delle aree di compenso che servono come valvole di scarico all’intero sistema. Il malato mentale ha assolto questo compito per molto tempo, anche perché era un «escluso» che non poteva conoscere da sé i limiti della sua malattia e quindi ha creduto – come la società e la psichiatria gli hanno fatto credere – che ogni suo atto di contestazione alla realtà in cui è costretto a vivere, sia un atto malato, espressione della sindrome di cui soffre.
Il libro di Foot su Basaglia mostra bene come a questo punto la psichiatria radicale si componga in realtà di due movimenti sovrapposti. Il primo, più fedele all’idea originale, è concentrato sostanzialmente sul discorso medico e sulle istituzioni psichiatriche. Il secondo vede nell’abbattimento delle distinzioni tra «follia» e «normalità» un mezzo per ribaltare l’ordine sociale esistente e sconfiggere il capitalismo. Capire quale di questi due approcci sia più radicale è meno semplice di quello che sembra. Ad esempio, il movimento britannico è quello più vicino agli ambienti hippie e controculturali, eppure non mette mai in discussione l’esistenza degli ospedali psichiatrici.
Sul finire degli anni Sessanta, invece, il discorso di Basaglia si concentra via via sempre di più sul ruolo dell’istituzione psichiatrica: per Basaglia antipsichiatria e chiusura dei manicomi diventano quasi sinonimi, e infatti non è un caso che la Legge 180 rimanga sostanzialmente un unicum in Occidente. Come spiega ancora Foot, le ragioni di questa specificità sono molteplici. La prima è la formazione culturale di Basaglia, antifascista, la cui opera è ispirata dal Primo Levi di Se questo è un uomo: come nel caso dei lager nazisti, l’istituzione e il Male che incarna finiscono per coincidere. La seconda ragione è di altra natura.

Nel 1968 Giovanni Miklus, uno dei pazienti dell’ospedale di Basaglia, viene temporaneamente rilasciato, torna a casa e uccide la moglie a colpi di martello. Questo è l’evento che mette fine all’esperimento di Gorizia. Basaglia lascia l’ospedale poco dopo, nel 1969. Dopo due anni di peregrinazioni per il centro Italia viene nominato direttore dell’ospedale psichiatrico di Trieste, e da quel momento in poi comincia a lavorare in maniera focalizzata alla chiusura totale delle «istituzioni totali» che si trova suo malgrado a rappresentare. Nel 1973 fonda Psichiatria Democratica, un’associazione che si ripropone di:
- Continuare la lotta all’esclusione, analizzandone e denunciandone le matrici negli aspetti strutturali (rapporti sociali di produzione) e sovrastrutturali (valori e norme) della società.
- Continuare la lotta al «manicomio», come luogo dove l’esclusione trova la sua espressione paradigmatica più evidente e violenta, rappresentando insieme la garanzia di concretezza al riprodursi dei meccanismi di emarginazione sociale.
- Sottolineare i pericoli del riprodursi dei meccanismi istituzionali escludenti, anche nelle strutture psichiatriche extramanicomiali di qualunque tipo.
Per gli ospedali psichiatrici si tratta dell’inizio della fine. Nel 1977 riesce a far chiudere il manicomio di cui è direttore. Nel 1978 viene approvata la Legge 180, ad oggi l’unica al mondo a decretare la chiusura dei tradizionali ospedali psichiatrici, che diventa operativa tra il 1994 e il 1998 attraverso il cosiddetto Progetto Obiettivo. Nel 1980, quando Basaglia muore improvvisamente per un tumore al cervello, il suo sogno si è ormai fatto realtà. Ma lo scenario politico nel mondo è radicalmente cambiato rispetto agli anni Sessanta e, con esso, anche l’approccio al disagio mentale.

Capitalismo vs. schizofrenia
Facciamo un piccolo passo indietro. Nel 1972, quando i moti degli anni Sessanta hanno già cominciato a trasformarsi in qualcosa di diverso, esce un libro che avrebbe segnato i successivi trent’anni come pochi altri: L’Anti-Edipo di Deleuze e Guattari, primo capitolo di un’opera sul tema «capitalismo e schizofrenia». La pubblicazione del magnum opus di Deleuze e Guattari è importante per il nostro discorso, perché, come ricorda anche Wikipedia, «Si può, a partire da Freud e dall’espansione della psicanalisi, tracciare di nuovo una genealogia culturale ed intellettuale che, da Reich (La funzione dell’orgasmo) a Marcuse (Eros e civiltà) passando per Foucault (Storia della follia nell’età classica), l’antipsichiatria (La politica dell’esperienza di Laing) o ancora Lawrence (Eros et les chiens) e Miller (Amleto), sfocia ne l’Anti-Edipo. Esso fa parte di quelle opere che, alla maniera di qualche contemporaneo, (Foucault, Lyotard, Castoriadis, Baudrillard), spingono a riconsiderare la questione del potere, soprattutto riguardo ai meccanismi per i quali il potere repressivo venga introiettato dagli oppressi».
Ora, come è noto L’Anti-Edipo è un libro che assume nei confronti del capitalismo una posizione a tratti ambigua. Alla pari di un altro libro «scandaloso» della sinistra francese post-Sessantotto come Economia libidinale di Lyotard, sostiene che la maniera migliore per sconfiggere il Capitale sia «non ritirarsi dal processo, ma andare oltre, “accelerare il processo”, per dirla con Nietzsche»; e aggiunge che «su questo versante, la verità è che non abbiamo ancora visto niente». Da un lato questa è naturalmente la teoria su cui si fonda l’accelerazionismo, ma si tratta anche di un’arma a doppio taglio: come ha scritto Frédéric Vandenberghe, «il capitalismo contemporaneo è nella pratica, se non negli intenti, deleuziano. Come rete di reti, esso è rizomatico, flessibile, chaosmotico, in evoluzione, in espansione». Identificare dove si trova il nemico diventa improvvisamente problematico.
Ora, intendiamoci: dio mi scampi dall’entrare nella terribile diatriba tra chi pensa che il Sessantotto conteneva già in sé i semi del trionfo neoliberale e coloro che pensano che il neoliberismo abbia fagocitato la natura antisistema del Movimento in un classico esempio di sussunzione. Possiamo però dire che c’è una linea che va dal Maggio francese all’Anti-Edipo all’affermarsi del neoliberismo negli anni Settanta, e che questa linea segue le direttive del desiderio. Il desiderio era quello che faceva dire agli studenti parigini «lavoratori di tutto il mondo, divertitevi!», uno slogan che suona in maniera inquietante come una pubblicità Mediaset anni Novanta; il desiderio è alla base della «schizoanalisi» deleuziana e della produzione di bisogni alla base del consumismo; il desiderio è quello che oggi gli accelerazionisti vogliono spingere fino a ben oltre le sue estreme conseguenze.
Se quindi società conformiste come quelle pre-Sessantotto possono vedere nella malattia mentale una minaccia dalla quale è necessario difendersi, rinchiudendo i «malati» in una città separata dal resto del mondo in cui vengono sospesi i diritti umani, il neoliberismo ha tutto l’interesse che i manicomi vengano chiusi: più sguardi diversi ci sono, più sono le nicchie di mercato. Bene che i Giovanni Miklus vengano rimessi in libertà, significa che ci sono più martelli da vendere! Il Movimento che voleva uccidere i padri ha portato, in maniera piuttosto coerente e per dirla con Lacan, alla morte del Padre, cioè di una entità normativa capace di dire chi è sano e chi è malato. O almeno questo è vero in un certo senso.

Capitalismo vs. disagio psichico
Se quando oggi leggiamo Mark Fisher sembra che stiamo ascoltando le parole di un alieno caduto sulla Terra, questo si deve solo al fatto che abbiamo poca memoria storica: come abbiamo visto, il discorso del rapporto tra capitalismo e disagio mentale su cui Fisher ha fondato una parte tanto importante del proprio discorso ha radici che risalgono almeno all’inizio degli anni Sessanta.
Con la sua codificazione del concetto di «realismo capitalista» e la sua analisi della depressione come conseguenza dell’assenza di futuro, Fisher ha riportato nel discorso pubblico il grande tema dell’antipsichiatria, quello per cui il disagio individuale ha, almeno in parte e forse in grossa parte, anche cause sociali. Fisher in questo campo è davvero un pensatore importante, perché riprende il discorso laddove gli esponenti dell’antipsichiatria l’avevano lasciato all’inizio degli anni Ottanta, quando l’idea di una rivoluzione della maniera in cui concepiamo la malattia mentale si era inabissata nel ritorno al privato. Per metterla in maniera molto banale, tra Basaglia e Fisher erano successe due cose importanti, capitate a distanza di pochissimo tempo e intimamente connesse: nel 1987 era stato commercializzato il Prozac, il primo antidepressivo di nuova generazione e il vero progenitore dell’odierna epidemia di psicofarmaci; e nel 1989 era caduto il Muro di Berlino, un evento che aveva reso il There Is No Alternative thatcheriano da wishful thinking a evidenza incontestabile.
In quanto sistema economico-politico dell’epoca del realismo capitalista, il neoliberismo ha bisogno degli psicofarmaci per diventare sempre più efficiente. Gli stabilizzatori d’umore sono, per citare in maniera infedele Byung-Chul Han, i lubrificanti che permettono ai flussi di informazione, persone e capitali di muoversi attraverso le reti rizomatiche senza incontrare resistenza. Il punto è spiegato bene da Luigi Esposito, professore associato alla Barry University, che in un articolo intitolato Neoliberalism and the Commodification of Mental Health spiega:
«[Il neoliberismo] avanza un’immagine della realtà [che] normalizza la medicalizzazione della vita umana. Siccome successo, virtù, e felicità in un mercato neoliberista sono spesso associate con il benessere materiale, il prestigio e “l’essere in cima alla scala sociale”, ne deriva che la normalità stessa è tipicamente concepita lungo questi obiettivi reificati. Utilizzare servizi e/o prodotti che possono aiutare le persone a raggiungere questi risultati è dunque visto come giusto e forse indispensabile nella ricerca di una vita produttiva e soddisfacente. Quello che inoltre suggerisce è che l’integrazione, la salute mentale e il benessere umano diventano largamente funzioni del consumismo. Noi intendiamo mostrare come un’enfasi sulla medicalizzazione, specialmente l’utilizzo dei farmaci psicotropi, può essere fatta risalire alla rivoluzione farmacologica della metà del XX secolo e la sua ossessione di situare la malattia all’interno dell’individuo. Dunque trattiamo il modo in cui questa ossessione per la medicalizzazione e la tendenza a trattare la “malattia mentale” come un problema interno all’individuo continua a essere supportato dalla logica neoliberale egemone, che minimizza la dimensione sociale, tratta gli individui come soggetti chiusi in se stessi, e patologizza pensieri e comportamenti che deviano da ciò che il mercato definisce come funzionale, produttivo o desiderabile».
Serve aggiungere altro?

Pillole ovunque
Mi sembra evidente che il neoliberismo ha fatto al discorso sulla salute mentale quello che ha fatto alle lotte razziali o al femminismo: va benissimo che tu sia nero finché compari nella pubblicità della Benetton, o che sei femminista finché questo serve a vendere più minigonne. Essere «matto» oggi è cool, e la narrazione dominante ci ha riempito la testa di weirdos e psicotici brillanti, da David Foster Wallace fino a John Nash. Naturalmente questa immagine romantica si infrange quando le persone in questione si suicidano, ma a quel punto scatta un altro meccanismo difensivo: quello per cui «non possiamo entrare nella testa delle persone» e giudicare le loro scelte individuali (altro mantra neoliberista, sarà un caso?)
I manicomi sono stati chiusi, ma non perché il giudizio della società sul disagio mentale sia del tutto cambiato, come non è del tutto cambiato sui rapporti di genere o sui pregiudizi razziali. Sono stati chiusi perché qualsiasi forma di «devianza» è stata rimossa alla radice da muri ben più efficaci eretti dentro la tua testa e senza che tu te ne renda conto. Hai un attacco di panico durante il quale ti sembra che tutta questa società sia una follia, il tuo posto di lavoro un ricettacolo di dolore e la tua famiglia un concentrato di nevrosi? Prendi una pillola e tutto tornerà normale. Philip K. Dick ci aveva visto lungo.
Non fraintendetemi, con questo non intendo certo sminuire l’esperienza di Basaglia. La chiusura degli ospedali psichiatrici è stato un enorme passo avanti nel campo dei diritti umani, e ha fatto sicuramente avanzare il discorso sul disagio mentale rispetto ai tempi in cui qualsiasi forma di diversità veniva fisicamente rimossa dal mondo. Le cose sono cambiate, in parte, nel senso che è meno comune finire legati a un letto e lobotomizzati di quanto lo fosse cinquant’anni fa. E questo è sicuramente importantissimo. Ma i progressi non sono stati così profondi come solitamente ci piace pensare.
Innanzitutto perché i casi di depressione sono sempre in aumento. Questo significa due cose: primo, che le cause sistemiche che producono questo malessere non sono state risolte, anzi casomai sono peggiorate. E secondo che nemmeno la nostra risposta al problema del disagio mentale non ha fatto passi in avanti. Se si diffonde, come si è diffusa nell’ultimo trentennio, l’idea che l’unico modo per curare il disagio mentale siano gli psicofarmaci, non si fa altro che perpetuare un’idea di società sbagliata e di conseguenza produrre più disagio mentale, che cureremo con più psicofarmaci facendo la felicità solo delle aziende farmacologiche.
Non so se ve ne siete accorti, ma il tabù che circonda oggi i problemi psichici è pressapoco lo stesso che c’era un secolo fa. Oggi non si parla più di «matti» e di «lunatici» e si usano formule iper-tecniche come «OCD» e «ADHD», ma il succo cambia poco: se vivi qualche forma di disagio mentale ti conviene non dirlo, perché verrai allontanato e marginalizzato da un mondo che richiede come virtù principale l’efficienza – la prima cosa che il disagio mentale, per sua natura, vuole negare, perché il suo scopo principale è quello di farti fermare e riflettere. Oggi è molto più facile ammettere di essere omosessuale che ammettere di essere depresso: e va naturalmente benissimo che i diritti delle persone gay abbiano fatto grandi progressi, ma è anche preoccupante che quelli delle persone depresse non si siano evoluti altrettanto rapidamente.

Il realismo capitalista della mente
Negli ultimi anni bisogna dire che il problema dell’iperdiffusione degli psicofarmaci ha cominciato a venire a galla. L’avete visto quel documentario di Adam Curtis? Avete letto quell’articolo sul rapporto tra musica contemporanea e Prozac? Avete ascoltato quella canzone di St Vincent? Anche qui su Not si è parlato del tema di recente, e siccome di questo argomento in Italia si discute pochissimo, ogni accenno al problema è positivo.
Oggi si sta discutendo molto di come uscire dal realismo capitalista, e le risposte sono spesso radicali: automazione, post-lavoro, esplorazione spaziale, rivoluzione psichedelica… Questa dimensione utopica è ciò che di più interessante ci sia in giro dopo decenni di rassegnazione alla fine della Storia, ma il discorso sulla psiche non è avanzato come quello politico o sociale. La ragione, almeno in parte, è che queste correnti prendono avvio dal grande calderone dei posthuman studies: e il postumano, con tutti i suoi pregi, ha qualche difficoltà ad avere a che fare con una dimensione tanto specificamente umana come quella della mente. Il discorso che ci si avvicina di più è forse proprio quello sugli psichedelici, che infatti ha le sue radici nella stessa «rivoluzione mancata» degli anni Sessanta da cui prendeva spunto l’antipsichiatria.
Penso che la lezione dell’antipsichiatria oggi andrebbe recuperata, perché è fondamentale per uscire dall’impasse sociale, politica e culturale che ci troviamo a vivere in Occidente da decenni e che oggi, per la prima volta da molti anni, sembra poter almeno cominciare a cambiare. Alla base del pensiero di Basaglia c’era l’idea che il disagio mentale fosse un grande Altro con cui la società doveva imparare a confrontarsi invece di rimuoverlo e segregarlo lontano dalla vista. Nel mondo della pluralità infinita del XXI secolo, come ricorda ancora Byung-Chul Han nel suo ultimo libro, non abbiamo imparato più di prima a confrontarci con l’Altro: piuttosto ci chiudiamo tutti dentro la nostra bolla, confermandoci a vicenda i nostri pregiudizi. La frattura che Basaglia voleva portare nella società è stata neutralizzata. In questo, il suo progetto ha fallito.
Quello che l’antipsichiatria aveva capito profondamente, e che oggi sembriamo aver dimenticato, è che il disagio mentale è una forma radicale, forse la più radicale perché la più intima, di mettere in discussione l’esistente, sia esso una società, una famiglia o anche una condizione di vita del tutto individuale. Come ha spiegato Foucault, le società premoderne lo sapevano, e conferivano al «matto» un ruolo importante nel tessuto sociale: quello di incarnare un’alterità che altrimenti la società non avrebbe potuto esprimere. Se l’età moderna ha normato il diverso e l’ha confinato nelle istituzioni, quella contemporanea l’ha lasciato libero ma ne ha depotenziato la carica sovversiva fino a renderla una semplice commodity. Ma se la società deve cambiare anche questo deve cambiare, perché come è noto la rivoluzione comincia prima di tutto dalla mente delle donne e degli uomini.