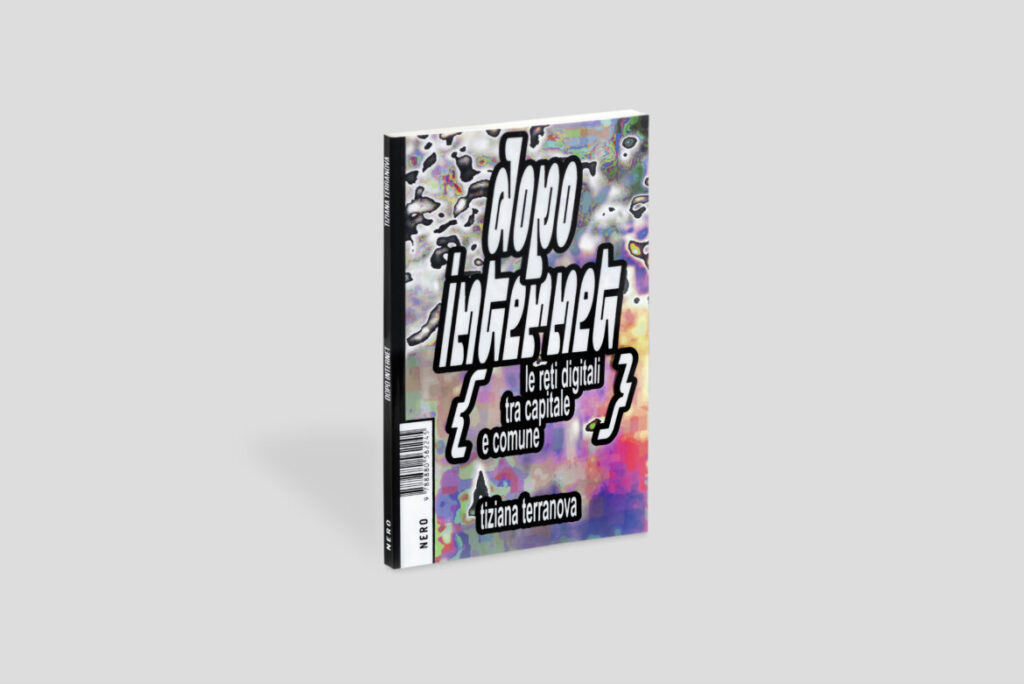Questo saggio discute la rappresentazione in scala attraverso quattro punti d’ingresso. La scala si dimostra essere un cardine infrastrutturale, fortemente in risalto nei media digitali eppure irriducibile alle tecnologie digitali. La scala diventa una nozione generativa, sia perché è intrinseca alla logica della simulazione (la realtà è un effetto scalare) sia perché deve ricollegarsi alla politica progressista delle altre scale della politica femminista e queer.
Concretizzazione mal posta
C’è davvero qualcosa che funziona in scala 1:1, quella scala che si presume sia la visualizzazione standard della “realtà così com’è”? Partiamo dal presupposto che non sia così. Ogni cosa è premuta e spinta di qua e di là in una varietà di scale in competizione tra loro che raffigurano, misurano e immaginano ogni cosa posizionandola su assi di riferimento opposti. Un’altra versione di questo potrebbe affermare che niente è davvero mai identico a se stesso. Tutto è mediazione. Tutto ha fondamentalmente a che fare con scale, relazioni e attrito.
Al di là della filosofia, una storia della cartografia e della Terra saprebbe dirci tanto: la cartografia è una storia di guerra (e colonialismo) attraverso una conoscenza operativa dei territori che abbiamo abitato o immaginato. Le mappe sono, alla fin fine, un gran brutto vizio, considerato che operano all’interno di rivendicazioni di proprietà, operazioni militari, ma anche nella quotidianità dell’esperienza di fare shopping. In quanto atti di ridimensionamento, ciò che le mappe fanno è eseguire operazioni di indirizzamento, che di per sé riguardano sostanzialmente un’invenzione: “questo va qui” significa che ambedue le parti di questa piccola operazione (“questo” e “qui”) sono chiamate in causa durante il loro processo di mappatura. Indicare e indirizzare non sono solo utili ma ribaditi dal potere stesso implicito nella questione: questo dovrebbe andare qui. Questo è forzato ad andare qui. Gli oggetti non sono localizzati soltanto nello spazio, come i sistemi di imaging sembrerebbero dirci per primi, ma negli stessi sistemi di ridimensionamento che sembrano “trovarli”. Nelle parole di Bernhard Siegert, la mappa è il territorio; ecco allora che tecniche culturali come queste fondano “ordini epistemici e le lotte di questi ultimi per il dominio su altri ordini epistemici”.
La cultura digitale ha fatto esplodere i molteplici significati e usi dei modelli in scala, riguardanti tanto la domanda sul numero (un miliardo di sensori, un milione di immagini, mille click in una click farm, infiniti loop di opzioni di scelta su software automatizzati) quanto sul cosa. Quest’ultima assume un angolo più qualitativo per la nostra problematica, dal momento che non si tratta più soltanto di una numerazione irrazionale oltre ogni immaginazione, ma della domanda fondamentale sul perché scale pronte a esplodere siano entrate in scena. Ci sono tante risposte possibili: l’economia politica, il potere, l’estetica e così via. Questo perché il fuori scala arriva a perseguitare non soltanto gli oggetti ma anche la loro logica organizzativa come database che sempre più spesso devono confrontarsi con le varie definizioni di scala.
Così sia: la cultura digitale riguarda essenzialmente la scala di massa che sposta l’attenzione su questo e di qua, su mappe cognitive e territoriali, nonché sul loro luogo d’appartenenza secondo il senso comune, mentre categorie culturali fanno posto ad altre categorie di dati operativi. I soggetti vengono trasformati e allungati, così come le categorie stesse. Gli oggetti sono fatti rimbalzare su altri oggetti, alcuni più effimeri o informativi di altri. Ciò nonostante la scalabilità infinita è soltanto uno degli immaginari prodotti nel mezzo della cultura digitale dei decenni passati. Altri immaginari riguardano ancora la circolazione intensiva di affetti, informazione e valore. Gli affetti circolano attorno le reti dati del pianeta; forse lo shitposting è davvero il sentimento condiviso a livello globale nella cultura digitale. Un video su TikTok di cinquanta secondi produce una risonanza a livello geopolitico; il famoso effetto farfalla della teoria del caos sembra una proposizione modesta se paragonata ai circuiti di informazione-azione-disinformazione nei quali particelle microscopiche interrompono i processi di produzione e distribuzione globali, mentre una città è ferma per un malfunzionamento algoritmico e l’armamento dei dati spazia dai crimini d’odio di quartiere a una strategia geopolitica. Le operazioni militari hanno i propri account su X; le immagini di metano che, nonostante sia invisibile, irrompe dal fondo del mare non possono riassumere le cause o la portata degli eventi, eppure i server sono ciò a cui ci teniamo stretti come ancore temporanee in attesa di qualche effetto di realtà. La battuta del filosofo Alfred N. Whitehead sulla “concretizzazione mal posta” è soltanto lo stato normale delle cose; questo non è di certo dove sta il gioco perché è già da qualche altra parte, un’astrazione di n dimensioni che può provocare una forma di paranoia complottista o qualcosa di leggermente più progressista e utile.
Molte delle attuali rappresentazioni e modelli in scala provengono dal cuore della guerra fredda: dal film di Eames Potenze di dieci, ai discorsi su megastrutture come la sfera di Dyson, ai frattali di Mandelbrot, fino al lavoro sulle nanoscale
Al di là di grande o piccolo
Il modello in scala è stato determinante per lo sviluppo della cartografia, la climatologia e innumerevoli altri campi di studio che hanno dovuto negoziare come riportare un’astrazione in modo comunicabile e concreto. Una discussione sul modello in scala implica dunque una storia mediatica degli strumenti di questo modello: gli strumenti che misurano e organizzano secondo una norma, suggerendo allo stesso tempo l’esistenza di altri universi alternativi in scala dove le cose potrebbero essere organizzate diversamente. In quanto tale, il modello in scala potrebbe andare a finire in un sottocampo delle scienze dei dati o praticamente qualsiasi cosa abbia a che fare con l’ordinamento e l’organizzazione. Le cose sono tenute insieme per mezzo di bilance standardizzate, per il momento. Questo è il motivo per cui gli studi scientifici e tecnologici hanno un vantaggio in partenza su un gran numero di intuizioni sulla scala, avendo essa a che fare con l’infrastruttura e la logistica alla base della conoscenza.
Molte delle attuali rappresentazioni e modelli in scala provengono dal cuore della guerra fredda: dal film di Eames Potenze di dieci, ai discorsi su megastrutture come la sfera di Dyson, ai frattali di Mandelbrot, fino al lavoro sulle nanoscale che diventarono in seguito un punto di riferimento per ciò che il modello in scala rappresentava per l’immaginario collettivo e l’ingegneria. Negli anni Ottanta Baudrillard scriveva sui modelli scalari delle simulazioni, mentre gli anni Novanta hanno dato voce a discorsi come quello di S, M, L, XL in architettura.
Poco tempo prima, un testo classico ed eccezionalmente leggibile come quello di Richard Feynman sulla nanoscala, intitolato There’s plenty of room at the bottom (traducibile in italiano come C’è ancora tanto spazio sul fondo) ha introdotto un inventario di tecniche ed esperimenti mentali su come le cose piccole possano funzionare. Il suo “invito a entrare in un nuovo campo della fisica” del 1960 espone il ruolo delle tecniche di miniaturizzazione in interrogativi come “perché non possiamo scrivere le intere ventiquattro colonne dell’Enciclopedia Britannica [sic] sulla testa di uno spillo?” fino a “che cosa succederebbe se potessimo organizzare gli atomi uno per uno come noi vogliamo?”, passando dall’immaginazione della scienza popolare di quello che è piccolo alle tecniche culturali di base per l’operazione su altre scale. Il resoconto di Feynman è tutto racchiuso nella questione della mediazione e della tecnica, in quanto concerne il modo in cui scriviamo – e leggiamo – in piccolo ma anche la progettazione del piccolo, aggiungendo ai due secoli di industrializzazione questo nuovo regime di lavoro: “Diciamo allora che io voglia costruire un miliardo di minuscole fabbriche, l’uno il modello dell’altra, che producano simultaneamente, scavino fori, stampino parti e così via.” Considerando che questo testo fu scritto agli albori delle industrie informatiche, è anche il riflesso di una trasformazione verso regimi di conoscenza post-industriali: da circuiti elettrici su scala nanometrica alla graduale scomparsa di enormi apparecchiature elettroniche e ancora la sfera dell’informatica odierna in sviluppo ma a malapena riconoscibile. Sono stati necessari ancora un paio di decenni perché questo tema diventasse più pronunciato.
C’è ancora tanto spazio sul fondo deve essere letto come parte di una lunga storia di esperimenti con il modello in scala che pian piano sono andati a formare la spina dorsale dell’imaging scientifico e il loro effetto su un pubblico più esteso. L’imaging scientifico, la microcinematografia e le nuove tecniche di animazione come modi di vedere rappresentano il fascino di inizio del XX secolo con la possibilità di una conoscenza in una scala diversa da quella semplicemente “naturale”. Lo spesso citato “inconscio ottico” di Walter Benjamin fa parte di un ridimensionamento attraverso le immagini tecniche.
Invece, per quanto riguarda la microcinematografia, la questione della scala era ancora più impellente, in quanto rappresentava la capacità non soltanto di “ingrandire”, per così dire, ma di lavorare su scale temporali, la visibilità dinamica del cambiamento e la possibilità di comparazione che ne deriva. Tali caratteristiche furono riprese nella prima teoria cinematografica, per esempio negli scritti di Siegfried Kracauer: le nuove immagini tecniche davano accesso alla “realtà di un’altra dimensione”. Prendiamo in considerazione l’animazione: le scale esplodono, mondi impossibili sono fatti apparire magicamente, le cose si piegano in modi impensabili non appena le linee si attorcigliano e si ingarbugliano. Il fascino per le linee nell’arte moderna è stato proseguito dai fumetti di Felix the Cat, in cui “le pagine divertenti erano piene zeppe di scene dove le componenti della linea stessa sono indipendenti e variabili con la coda di Felix che diventa una canna da pesca o un punto interrogativo, a seconda della necessità”. Non passò molto tempo, tuttavia, prima che la linea dall’andamento eccessivamente sinuoso venisse addomesticata nelle prime industrie culturali (gli animali prodotti in serie della Disney).
Attraverso i media e l’estetica, la scala è ormai operativa all’interno e nelle tecniche del sapere: come si confronta questo con quello, in che modo questo è un sostituto di quello? Che cosa, quanto velocemente, quanto lentamente, a quale ritmo di cambio? L’apparente semplicità della misurazione innesca una serie di loop scalari che rivelano qualcosa di essenziale sulla scala stessa: è il mezzo di un fascio di forze frapposte. Come afferma Zachary Horton, “qualsiasi media è il mediatore di una scala, stando nel mezzo di due o più scale e producendo i loro effetti attraverso un confine scalare”. Tuttavia, questo non è soltanto un modello in scala, ma un processo di mediazione trasformativo: le scale standardizzano e possono potenzialmente destabilizzare, alla pari di una qualsiasi tecnica multimediale con una potenza simile.
Feynman era assolutamente consapevole del fatto che il piccolo non è piccolo soltanto secondo una scala lineare, ma tocca un’altra branca della fisica; la scala non riguarda soltanto la misurazione secondo una scala fissa di punti quantificati ma grazie a differenze qualitative. All’insegna di misure qualitative, diverse, alternative, variabili, interscambiabili, resistenti e alternate, il problema della scala diventa il principale operatore in causa. Non è più una nozione di calcolo; al contrario, la scala diventa una nozione di produzione generativa che catalizza una diversa concezione epistemica ed estetica. Per intenderci, le cose non sono magicamente ridimensionate senza attrito, lavoro e cambiamento. Piuttosto che un argomento contro la scala, questa è la prova che non abbiamo bisogno di essere semplicistici sulla definizione di scala.
Come operazione generativa con un effetto qualitativo, la scala stessa diventa un’operazione di simulazione e modellazione. Inizia a generare mondi che non si limitano a riprodurre le realtà esistenti ma giocano la loro partita con un insieme di regole specifiche.
Siamo arrivati a una situazione in cui la scala non riguarda semplicemente la rappresentazione della realtà (quando lo è mai stata?) ma la sua ingegnerizzazione.
Ancora tanto spazio
Cinema, animazione e fotografia non sono più le nostre ottiche primarie, dal momento che le immagini che possediamo – o che ci possiedono – riguardano il calcolo di un altro regno di realtà statistiche. Un tale calcolo potrebbe essere eseguito sulla superficie dell’immagine sezionata nelle sue parti costituenti (come lettura dati) o come parte di banche dati immense per quanto riguarda potenziali di scambio finanziari; queste sono le limitazioni per il lavoro di chi li produce. Ci sono certamente ancora altre tecniche specifiche nella fotografia computazionale che nell’ultimo decennio hanno eretto una diversa relazione tra rilevamento e computazione dentro quell’apparato chiamato macchina fotografica e che producono un’immagine del mondo estremamente diversa da quella di un soggetto che percepisce il proprio esterno. Non c’è da stupirsi perciò che la nostra cultura dell’immagine promuova nozioni come quella di “immagini scorrelate” per fare riferimento alla natura ambigua delle immagini che fondamentalmente operano su scale (microtemporali) che non corrispondono alle capacità percettive dei mondi in scala 1:1. Tuttavia, è vero anche il contrario: per comprendere il regno digitale del rilevamento, del calcolo e della modellazione, i nostri modelli potrebbero essere “scorrelati” dalla presenza di ciò che sta accadendo, per esempio, nell’IA – invece, ci tiriamo dietro una vecchia proiezione antropomorfa che ignora il nocciolo della simulazione.
In mezzo a ogni tipo di simulazione, il modello in scala funziona come un elemento operativo centrale per creare le condizioni della sua coerenza interna. La scala esiste come un particolare tipo di marcatore, detto fiducial marker, nella machine vision, nella realtà aumentata e in altri campi in cui una serie di scale devono essere mappate all’interno di un sistema di conoscenza coerente. Al centro delle lotte per il potere non ci sono soltanto oggetti e soggetti, ma anche i fiducial marker. Un accendino, una mela, una banana per la scala. Gli studi scientifici e tecnologici la potrebbero chiamare la lotta per lo standard. Siamo arrivati a una situazione in cui la scala non riguarda semplicemente la rappresentazione della realtà (quando lo è mai stata?) ma la sua ingegnerizzazione. In sintesi, le scale sono state incluse nelle simulazioni, riproduzioni tecniche di realtà, in cui operano e costruiscono le posizioni dei soggetti nei modi più materiali mentre ne modulano la mappa percettiva, il contenuto e la risposta emotiva.
Con o senza soggetti al centro dell’immagine, sono in gioco operazioni all’interno di complesse catene ricorsive. Le immagini che misurano, prendono anche le dimensioni del sistema di misura. Alcuni misurano il soggetto di misurazione, altri misurano le relazioni di quella stessa misurazione. Tecniche e feed di dati e calcolo diverse sono inserite in un loop con effetto a cascata e nel più grande traffico di immagini della rete. La banalità delle scale di immagini digitali come queste ci dispensa dal bisogno di realtà e ci fa restare appiccicati alla colla affettiva che arriva in veste di una regina trasformata in un ologramma o illusioni come quella del fantasma di Pepper che ritornano come spettri negli spettacoli contemporanei. Deep fake, GAN e modelli di diffusione diventano allora il prototipo di come la realtà visibile è costruita secondo un canale di dati–computazione–previsione–modellazione. Niente di tutto questo rientra nel registro classico della visualità. Per essere precisi, fa parte di ciò che Adrian Mackenzie e Anna Munster hanno denominato “invisuale”: “Mentre le tecniche e le pratiche visive continuano a proliferare – dalla visualizzazione dei dati alle tecnologie LIDAR per catturare immagini non ottiche – la visualità stessa come paradigma della vista e dell’osservazione è eliminata e quello spazio vacante è ora occupato da un altro tipo di percezione.” A questo punto, gli autori introducono il concetto di platform seeing, che mi piacerebbe ampliare per includere la logica più generalizzata del modello scalare. Questa nozione di scala comprende l’estetica digitale tanto come una certa sfera simulata di nozioni divergenti del modello scalare, che come infrastruttura, logistica e riformattazione elementare che ha luogo attraverso una combinazione di guerra, ecocidio e altre operazioni mirate al terreno e all’atmosfera.
Una nozione generativa di scala include realtà frammentate, investimenti affettivi, giochi di potere infrastrutturali, militarizzazione dell’incertezza e incertezze sulla militarizzazione stessa (“erano tutte notizie false, propaganda di opposizione”) come parte di psy-ops in scala che rappresentano ormai la condizione generalizzata della cultura contemporanea dei media. C’è ancora davvero tanto spazio per generare mondi all’interno degli stack geopolitici che non sono messi da parte come semplici piani malvagi ma che si fondono in assemblaggi eterogenei di confusione. Queste simulazioni non sono soltanto giochi mentali, sono mondi reali progettati con un impatto materiale. I pluriversi sono sia l’obiettivo critico che contravviene a una standardizzazione egemonica che la strategia delle bolle di isolamento, regressive, violente e dannose, come i negazionisti del COVID e i neonazisti. Il titolo di questo articolo, dunque, fa riferimento non soltanto a quei cambiamenti nel modo in cui vediamo il globale e la nanoscala come S, M, L o XL. Dopotutto, le comunità immaginate riguardano ogni sorta di tecniche scalari in grado di creare illusioni artificiali di una qualche unità coerente; gli Stati-nazione sono ancora delle visioni inebrianti, così come dimostra anche solo uno sguardo ad alcune delle politiche europee, russe o statunitensi, e la violenza che ne deriva.
Mentre gli Stati-nazione sono allucinati al potere, la rappresentazione in scala inizia a contare nella logistica degli spostamenti, indipendentemente dal fatto che questo traffico riguardi una categoria epistemica o una merce vera e propria, una simulazione o una distribuzione materiale. Ciò che non vedi è quello che ricevi: anche se un’interfaccia per altre scale non esiste, dobbiamo trovare dei modi per attingere alle scale di cui abbiamo bisogno. Se la nozione di simulazione di Baudrillard rappresenta uno dei prodotti per eccellenza degli anni della Guerra Fredda – come ha sostenuto in modo convincente Ryan Bishop – quale potrebbe essere il suo equivalente nella politica infrastrutturale multiscalare della nostra era?
Modi di ridimensionamento
Le scale sono delle tecniche mediali e degli immaginari collettivi che insieme funzionano come le trappole progettuali di base della nostra era: definire qualcosa in una certa scala significa essere in grado di controllarlo. La questione estetica, politica, perfino etica di questa era riguarda le scale sulle quali esistiamo, percepiamo e modifichiamo le nostre scale (di condizionamento) esistenziali. Sono infatti queste scale che presuppongono azioni e immaginari di emancipazione, sia nel bene che nel male. Che tipo di magia senti ci sia dietro un software che gestisce dei database immensi? Che tipo di evocazione serve per immaginare che tutte le cose si ridimensionino in assenza di attrito?
Gran parte del mio interesse ha a che fare col navigare nel paesaggio mutevole dei fiducial markers in zone simulate che sono localizzate nella realtà delle energie planetarie e interplanetarie. Mentre la “scala” è diventata una parola d’ordine nell’economia digitale, mi sono focalizzato di più sulla ricerca di un paradigma etico-estetica. Chiamiamoli pure “modi di ridimensionamento” – una variazione di Modi di vedere di John Berger, il libro e la serie di documentari televisivi degli anni Settanta che è stato poi aggiornato a Ways of Machine Seeing e che descrive un progetto che indaga le modalità di lavoro, alienazione e visualità nel contesto dei Big Data e della machine vision. I modi di ridimensionamento rispondono alle preoccupazioni condivise per quanto riguarda la produzione, la distribuzione, il lavoro e l’ecologia politica dei modelli scalari. Sono, per necessità, condizionati da due o più temi intersecati: una critica della scalabilità attraverso uno sviluppo continuo di ciò che Anna Tsing ha chiamato intuizioni teoriche (e pratiche) sulla non scalabilità. “La scalabilità è possibile solo se gli elementi del progetto non formano relazioni trasformative che potrebbero altrimenti cambiare il progetto man mano che vengono aggiunti nuovi elementi.” Oltre alla critica, questa nozione di ridimensionamento generativo deve essere poi utilizzata per usi più progressivi degli immaginari in assenza di attrito. In altre parole, è necessario creare metodi per altre scale sulle quali sono distribuite l’azione, le risorse e le differenti dimensioni temporali (sia passati che futuri). Tale progettazione e sperimentazione di scale può essere interpretata come una scrupolosa pratica etica che ha a che fare con il nostro coinvolgimento con le varie scale del pianeta. È collegato alla richiesta di Joanna Zylinska di un’etica minima per l’Antropocene. Un’etica della scala e del ridimensionamento di questo tipo va dall’universale al situato: “Come orizzonte della nostra ricerca può fungere da promemoria della parzialità di una storia che possiamo narrare, o di un intervento che possiamo compiere, o ancora della localizzazione dei molteplici concetti e valori che noi umani abbiamo sviluppato attraverso ogni sorta di ristretta scala storica.” A questo punto, Zylinska è vicina all’etica postumana di Rosi Braidotti che riconosce la situazione delle nostre posizioni ma è anche consapevole di altre scale esistenziali, altri modi di essere (da qui il titolo ‘Noi’ siamo qui insieme, non siamo la stessa cosa). La storia dell’alterità e delle posizioni dei soggetti minoritari implica anche ciò che in termini contemporanei fa parte della politica della rappresentazione in scala che si occupa degli “altri esseri meno che umani, disumanizzati”, che sono stati storicamente “gli altri sessi (donne, LGBTQ+), le altre razze (non europei, indigeni), e gli altri regni naturali (animali, piante, la Terra)”.
Le procedure di rappresentazione in scala sono definite da una coscienza della potenzialità di cambiare grazie alla lettura di storie come questa che non sono già posizionate all’interno e non si sono mai adattate ai modelli standard 1:1 imposti a una certa categoria di corpi. Di conseguenza, la politica della scala è la produzione di attrito e la capacità di altre scale di generare relazioni. Per citare Max Liboiron: “I sistemi di conoscenza come l’ecologia politica, la geografia culturale e la giustizia ambientale sono soltanto alcuni dei modi di vedere come i sistemi di valore e conoscenza siano in grado di generare relazioni. La scala è un altro.”
Traduzione di Alessandro Sbordoni
Pubblicato originariamente da Akisoma – Institute for Contemporary Art, Ljubljana, giugno 2023 all’interno della serie PostScriptUM.