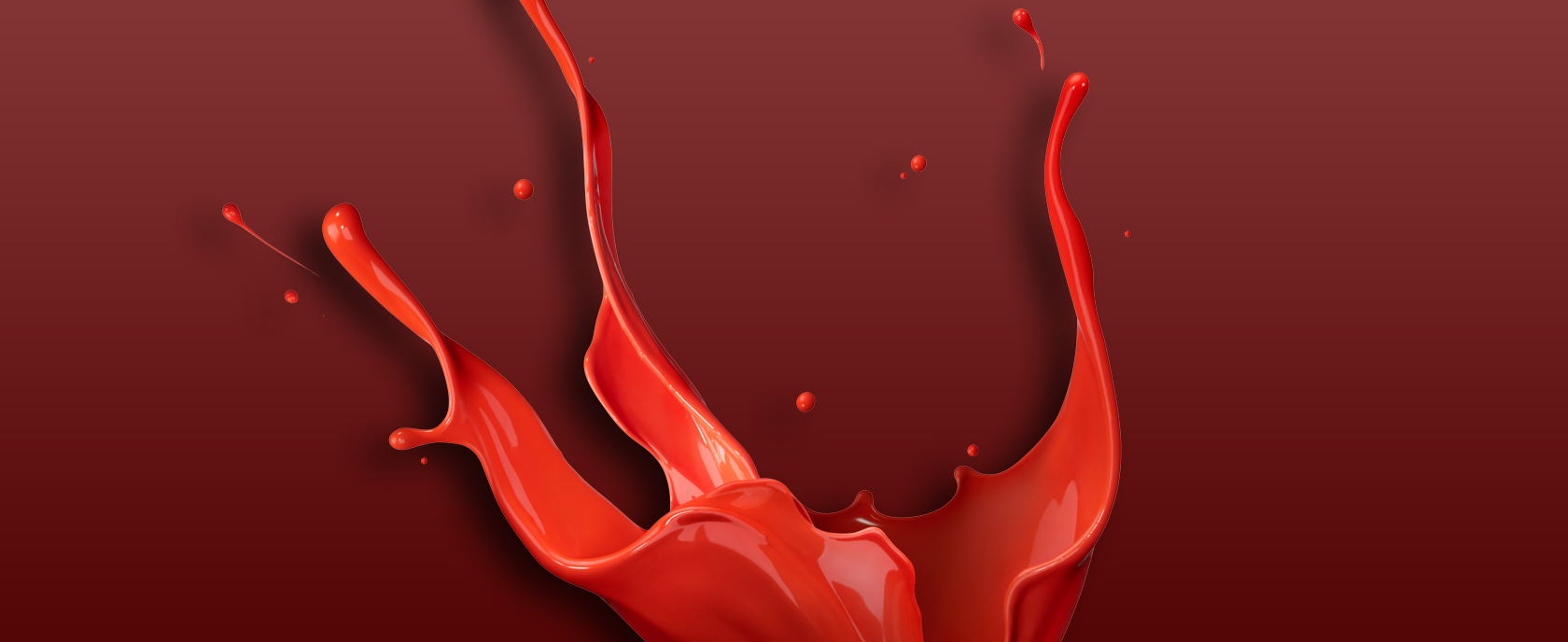Viva la droga e sia fatta la sua volontà

Sogno un grande Rospo seduto sul tempo. Una Testuggine ancestrale sorvola l’Antartide, placida e possente come solo una divinità può essere. Gli anni del Corvo sono finiti, entriamo nell’era della Libellula. Viva la droga e sia fatta la sua volontà.
Hai mai nuotato nelle vasche profonde e nere, negli abissi uterini dove le uniche luci sono le creature elettriche?
Ti sei mai immersa in un pensiero tanto in profondità da vedere la pelle dell’idea riempirsi di crepe per la troppa pressione? Ecco: ci vuole coraggio per nuotare ancora più in basso di così. Ma noi che siamo senza cielo non possiamo che muovere verso il baratro. Allora vedrai l’epidermide dei concetti staccarsi dal corpo in piccole scaglie leggere, sottili come lamine d’oro. Continua a muovere tutti i muscoli che hai, divincolati ancora verso il basso: il nucleo di ogni idea è un amalgama tensionale di luce e ombra, un’oscurità incendiata. Non tornerai mai a respirare.
Sono sicuro che sai di cosa parlo: si può essere, in effetti, dipendenti dalla paura. È lì che nuoto, ogni volta che chiudo gli occhi.
Quello è il mio regno. Dove, se vorrete cercare, mi troverete sempre.
Mi troverai sempre.
Per sbarcare il lunario lavoro in un’enoteca. È un luogo, per utilizzare un linguaggio che non mi appartiene, grazioso e accogliente, ricercato ma informale. Serviamo anche vini molto costosi, il che rende la nostra clientela mediamente ricca, borghese ed educata.
Nonostante sul luogo di lavoro abbia stretto rapporti molto stretti con colleghi e alcuni avventori abituali, non riesco proprio a sopportare certi clienti: sono boriosi, altezzosi, tronfi e pieni di sé, come solo i ricchi sanno essere. Immobili e rubicondi nella loro vanagloria, credono che non ci sia dolore o dispiacere che non possa essere dimenticato con un bicchiere di pinot nero della Borgogna. Non hanno nessun riguardo per noi baristi e camerieri, ai loro occhi sembriamo non esistere. Tutto quello che dobbiamo fare con quel genere di clienti è non dire, fare o sembrare qualcosa di sbagliato che possa in qualche modo turbare la loro incantevole serata. Sono invece molto interessati a entrare nelle grazie del proprietario, forse più per esibire la propria intimità col potere di turno che per accaparrarsi uno sconticino sul pagamento finale. Sconticino di cui, manco a dirlo, non hanno nessun bisogno.
Certe volte spalancherei loro la bocca fino a sentire lo spezzarsi delle mandibole.
Il mio aspetto li ripugna: i tatuaggi anomali, lo smalto alle unghie, le occhiaie, barba e capelli non curati, le magliette zebrate, gli orecchini penzolanti, le camicie da donna. Ma non è questo a suscitare il loro senso di superiorità: d’altro canto sono abituati a giustificare simili stravaganze, laddove esse siano giustificate, concesse e codificate, come nel caso di attori, musicisti e artisti d’indubbia fama. Non si sognerebbero mai di inveire contro i loro amati Freddie Mercury o David Bowie, per farla breve. La sussunzione da parte del Capitale è fondamentale. Come dice Luca Cristiano, in un’ottica capitalista e postcolonialista una donna ricca è un uomo, un nero ricco è un bianco, un gay ricco è un eterosessuale, un musulmano ricco è un cristiano. La verità è che si credono migliori di me perché sono un barista – dando per scontato che uno che nella vita è finito a fare il barista non possa essere un loro pari.
Ma sono pagato anche per sorridere. Sono pagato anche per reagire con gentilezza alla loro costante incuria nei miei confronti, all’ironia mediocre, sono pagato anche per sopportare la loro ignoranza politica, culturale e artistica. Se la sparano troppo grossa o si lasciano sfuggire uno sfondone madornale, allora non resisto e li correggo: in quel caso reagiscono con un’occhiataccia bieca e mi trattano come se fossi il contadino della Val d’Arno che sa a memoria la Commedia.
Se solo sapessero, i maiali.
Ho molti problemi a lavorare, dopo le mie vicissitudini mediche: spesso perdo la voce a metà turno, motivo per cui prima di andare a lavoro passo giornate intere in completo silenzio, comunicando con i miei coinquilini con gesti, post-it e messaggi su WhatsApp, cercando di racimolare quel minimo di voce che mi permetta di arrivare a fine serata. Quando racconto queste cose ai miei colleghi reagiscono per lo più con una risatina divertita: ho l’impressione che non mi credano. Ti regalo un esempio di conversazione tipo:
Collega: Come stai?
Io: Non molto bene, queste sono le prime parole che dico da stamattina, e considera che sono le sette di sera.
Collega: Ahahah!
Io: Che cazzo ridi?
Inoltre, nelle serate di grande affluenza, il brusio costante interferisce con il mio udito mutilato, e tutti i suoni, le voci e gli acufeni si fondono in un groviglio frequenziale incomprensibile. Sono costretto a leggere le labbra o a chiedere al cliente di alzare la voce, se voglio sperare di capire qualcosa.
È molto comune che mi chiedano un tovagliolo e io, sorridente, porti loro un bicchiere di nebbiolo.
In enoteca indosso un grembiule nero e un sorriso laborioso. Questo, professoressa, è uno Chablis Premier Cru Cote de Lechet 2014 di Sylvain Mosnier, chardonnay del nord-ovest della Borgogna, solo acciaio come da tradizione, grande mineralità e acidità, eleganza e austerità: è buonissimo, garantisco io. Le faccio assaggiare un goccio per sentire se è a posto. Che dire, ingegnere? Al Comté dello Jura, rimanendo in zona, abbinerei senz’altro uno dei loro vini filo-ossidativi: questo è un Vin Jaune 2008 di Domain De la Borde, 100% savagnin, ben settantacinque mesi di botte scolma: frutta candita, marzapane e nocciola per questo vino complesso, tropicale, inaspettato.
Durante la favella, preparo una trota iridea affumicata e marinata per i miei facoltosi clienti. Le trote provengono dai torrenti gelati delle mie montagne, le stesse che da piccoli ci divertivamo a pescare con le mani. Dopo aver tolto le poche lische rimaste con una pinzetta, taglio finemente uno dei filetti polposi, con un taglio diagonale, per ottenere fette più grandi. Le metto da parte e mi occupo della marinatura. Privo delle scorze due limoni e un’arancia, stando attendo a non intaccarne l’albedo, la parte bianca e amara, quindi le taglio a metà e le spremo per ottenerne il succo, che poi vado a filtrare col colino. Prendo il migliore dei miei coltelli e, velocemente, con taglio esperto, trito a polvere le scorze. Quindi metto il succo in uno shaker. Aggiungo olio extra vergine d’oliva di Valentini, il produttore di vino famoso per i suoi trebbiano, cerasuolo e montepulciano d’Abruzzo. Aggiungo anche un goccio di aceto di vino bianco, qualche fiocco di sale Maldon affumicato, pepe nero di Kampot, un pizzico di zucchero. Chiudo lo shaker e agito vigorosamente. Impiatto. Adagio su un piccolo piatto di cristallo qualche fettina di trota, le affogo con l’emulsione agli agrumi, spolvero con le scorze tritate, guarnisco con qualche foglia di basilico fresco.
Mentre sorrido e presento il piatto, penso che esattamente in questo istante qualche essere umano starà affogando nelle profondità del Mediterraneo.
Ah, che bontà, dicono i clienti. Questa è arte, dicono. No, penso io.
Non ha niente a che fare con l’arte ingozzare un’oca con un tubo fino a farle scoppiare il fegato, quindi adagiarlo sul pan brioche e cospargerlo con una presa di sale speziato. Non ha niente a che fare con l’arte abbuffarsi di fois gras e Sauternes e nel frattempo commentare entusiasta Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino senza smettere di lamentarsi degli immigrati.
Non riesco a credere che l’arte abbia a che fare con la bellezza, con le cose buone e con la bella vita. Credo invece che consista in un incubo capillare e teso, scaturito dalla perdita della bellezza e dall’impossibilità della purezza e dell’infinito. Non riesco a identificare l’arte con il bello, con il buono, con il gesto creatore, benefico e simmetrico. Non riesco a identificarla con la virtù o la destrezza, e meno che mai con la ricerca della perfezione. L’arte mi appare come un’infiorescenza demoniaca, un’indagine ossessiva sul dolore causato dalla perdita della vita e dell’amore. L’arte è una malattia, e l’artista è un suicida con gli occhi incendiati e le budella esposte al freddo del mondo. E così sia.
Chi non la pensa così non ha conosciuto artisti, ha conosciuto piccoli imprenditori.
E nessuno, nessuno mai, è stato più ossessionato dalla bellezza e dalla perfezione dei nazisti.
Le poche volte in cui quel tipo particolare di cliente si degna di rivolgermi parola, è perché gli cade lo sguardo sul più emblematico dei miei tatuaggi. Cos’è successo alle 4 e 48?, mi chiedono, scommetto che è l’ora in cui sei nato, chiedono sornioni, convinti di aver detto qualcosa di molto acuto. No, rispondo io educatamente, è parte del titolo dell’ultimo dramma di Sarah Kane. Sarah Kane?, mi chiedono, con un sorrisetto paternalista mascherato da curiosità. Strano che non l’abbiate mai sentita nominare, rispondo simulando sorpresa, era una drammaturga molto famosa e molto studiata. Mi diverte farli sentire ignoranti una volta ogni tanto.
Non hanno idea di cosa stia parlando, ma da buoni elettori del PD leggono romanzi e frequentano i teatri – teatri comunali o stabili, nei quali sperano di poter vedere qualche scena di nudo integrale per poterlo raccontare agli amici con una posata indifferenza morale – e provano un fastidio imbarazzato nell’essersi fatti beccare con le braghe calate: non possono, non devono saperne meno di un mediocre barista. Rappresentano pur sempre l’élite culturale del paese, Cristo Santo.
Uno dei miei colleghi, avvertendo la situazione di stallo, decide di intervenire. Io penso: no, ti prego, non farlo. Dovete sapere che lui è uno scrittore, dice. Segue una breve pausa drammaturgica. Quindi saresti uno scrittore?, chiede il cliente usando il condizionale. No, rispondo io. Scrivo, questo sì. Niente di più.
A questo punto seguono sguardi complici tra i clienti. Più tardi, quando saranno usciti da questo posto, nel taxi che li starà riportando a casa, uno dei due dirà all’altro deve essere proprio bravo a scrivere, se è lì a versarci da bere, l’altro riderà, assieme rideranno, e andranno avanti con le loro vite perfette. Ma adesso, sul momento, dovranno pur dire qualcosa, qualcosa che risulti acuto ed educato e che, al contempo, permetta loro di smettere di parlare di me. E quello che decidono di dire, quasi sempre, è ancora una volta una variazione sul tema che segue: Be’, in fin dei conti il buon vino, il cibo e l’arte sono tutte cose collegate, no?
Penso a Dylan Thomas, a Schiele, a Van Gogh. Penso a Erofeev e penso al vino cattivo, quello pieno di rame e libellule, quello che attorciglia il fegato e rende le labbra viola e l’alito pesante. Penso ai centri storici delle città europee, bistrot montmartriani in cui si abbinano gli orange wine biodinamici agli hamburger gourmet. Penso alle donne curde massacrate dallo Stato islamico prima e dall’esercito turco poi.
Ma non dico niente. Non dico mai niente.
Sì, rispondo ai miei clienti mentre servo loro del pan brioche caldo e fragrante e un fegato esploso. Sono tutte cose collegate.