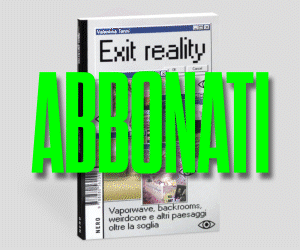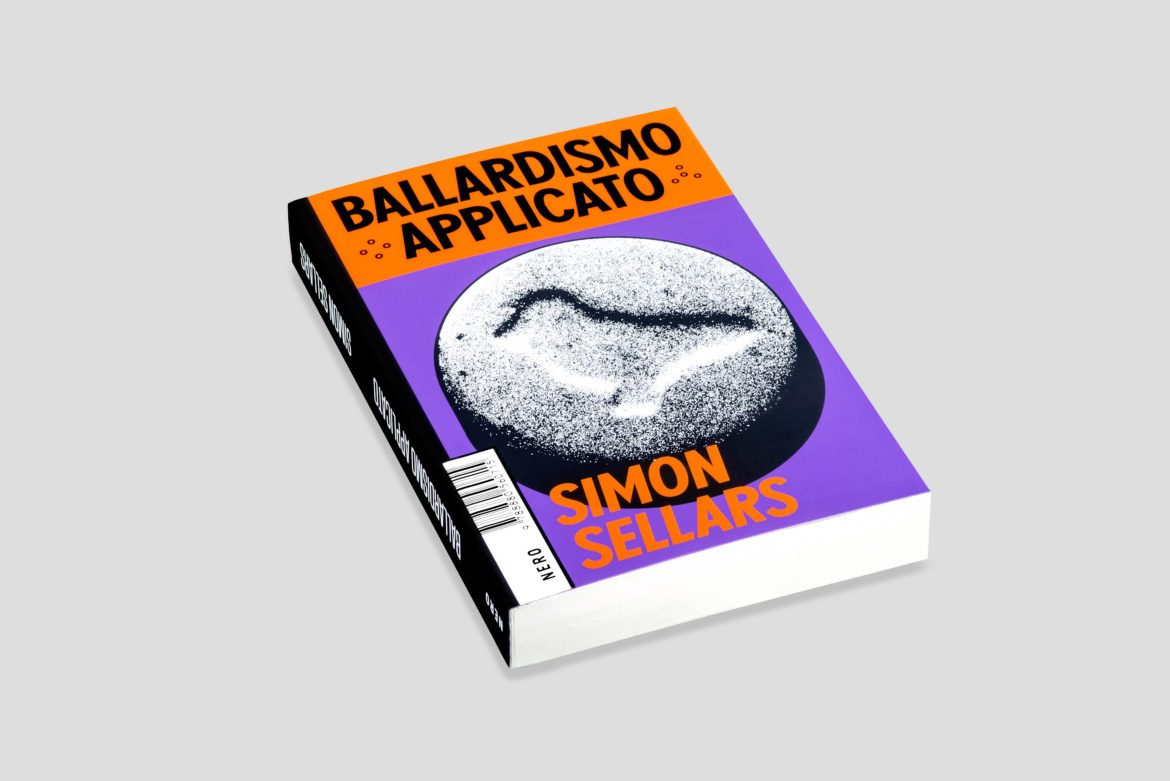La città è una tecnologia, notava lo scrittore di fantascienza William Gibson: i grandi agglomerati urbani segnano un’accelerazione nell’evoluzione umana perché implicano un substrato sempre più complesso di dispositivi e procedure tecnico-macchiniche. Al tempo stesso, suggeriva il suo collega Arthur C. Clarke, ogni tecnologia sufficientemente complessa è indistinguibile dalla magia: e allora qual è il sortilegio, l’incantesimo scatenato da quell’entità tecno-sovrannaturale che chiamiamo città? Quali sono i suoi effetti?
Se le si lascia agire indisturbate, le grandi città hanno la capacità di alterare in maniera irrimediabile la nostra percezione dello spaziotempo. Infettano la nostra psiche e i nostri corpi secondo le caratteristiche tipiche del contagio, e producono modificazioni biochimiche e funzionali. In questo senso, la città non è solo una tecnologia, non è solo una “magia”: è una patologia.
la conclusione a cui siamo giunti è che gli stadi attraverso i quali si articola la patologia Roma sono in tutto sette: come i metalli della trasmutazione alchemica
In questo primo studio introduttivo, ci proponiamo di analizzare i differenti stadi di quella patologia che va sotto il nome di Roma, a partire dalla forma concreta della città. Per “forma concreta” intendiamo non qualche insondabile qualità “psicogeografica” dell’oggetto di analisi, ma i veri e propri esiti urbanistici e architettonici che determinano la trasmissione della malattia: lo scopo è capire in che modo la manifestazione materiale di edifici, quartieri e strade, il loro aspetto tangibile e concreto, la loro mera presenza, riescano a produrre uno stato morboso il cui quadro clinico è il diretto esito di un agente eziologico inscritto nel semplice “essere città”.
Il protocollo diagnostico al quale ci siamo affidati non poteva che partire da una rilettura critica della storia dell’urbanistica romana per come tramandata dalla letteratura accademica e scientifica ufficiale. Su questa, abbiamo innestato gli strumenti analitici che, in quanto MAGUS – Metropolitan Association for Geographical and Urban Studies, orientano la nostra ricerca.
Sulla scorta delle differenti discipline da cui il MAGUS deriva la propria metodologia (neuroarchitettura, urbanistica occulta, topografomanzia, schizogeografia) e incrociandole a branche limitrofe quali psicogeografia, ley lines e teoria del nastro di pietra, la conclusione a cui siamo giunti è che gli stadi attraverso i quali si articola la patologia Roma sono in tutto 7: come i metalli della trasmutazione alchemica, come i sigilli la cui rottura, secondo l’apostolo Giovanni, annuncerà la fine del mondo, al suono delle 7 trombe suonate dai 7 angeli dell’Apocalisse. Di seguito, per ciascuno stadio viene fornita una breve scheda descrittiva corredata da un’analisi concreta dei vettori urbanistico-architettonici della patologia.
Stadio 1
DISTURBO PERCETTIVO ONCOGENO
Neorealisticopoli, 1946-1950

Roma nasce nel 1946 sul sito precedentemente occupato da un antico agglomerato urbano dello stesso nome. Il rito di fondazione della nuova città prevede la costruzione di un grande solco circolare chiamato GRA – Grande Raccordo Anulare, da allora suo principale monumento.
Causa scatenante della nascita di Roma è il tracollo seguito all’evento bellico conosciuto come Seconda Guerra Mondiale, le cui macerie sembrano essere la materia prima a cui attingono le maleodoranti favelas composte da baracche fai-da-te, che nell’immediato dopoguerra sorsero per rispondere a quella che gli storici ufficiali chiamarono ai tempi “emergenza abitativa”.
Sorte fuori da ogni progetto o piano regolatore, sin dagli anni Quaranta del Novecento borgate come Mandrione, Pigneto, Certosa, Quadraro, Centocelle Vecchia, Ostia Idroscalo, diventano lo sfondo per il primo poema epico della neonata città: il cosiddetto cinema neorealista, che della patologia Roma può essere considerato il primo e più celebre sintomo.

Dal punto di vista urbanistico-architettonico, la Neorealisticopoli è caratterizzata da quella che gli specialisti chiamano “edilizia spontanea”: case edificate abusivamente dalle stesse persone che poi andranno ad abitarvi, e che per questo non hanno mai una forma compiuta.
Da una parte, trattandosi di case autocostruite senza alcuna vera nozione di “architettura”, sembrano come essere spontaneamente generate dal territorio che le ospita; dall’altra, prevedono sempre la possibilità di ulteriori sviluppi, ulteriori stanze, ulteriori piani in altezza (in gergo urbanistico: “superfetazioni”), perché le famiglie possono allargarsi e quindi occorre pensare in anticipo a ipotetici, ulteriori spazi.
Visivamente, i “quartieri spontanei” della Neorealisticopoli sono un suq piranesiano di stradine e casupole perennemente incompiute, precarie, in altre parole deformi: nessuna logica razionale tiene assieme questi agglomerati antieuclidei battuti da un sole che acceca; tutto sembra al contempo putrefatto, corrotto dal di dentro e aperto a future, imponderabili trasformazioni – tutto è temporaneo, instabile, in potenza.
Non è dopotutto un caso se la popolazione della Neorealisticopoli è storicamente composta da marginali; nel dopoguerra: gli sfollati, i derelitti del nuovo sottoproletariato urbano; nei decenni successivi: trans, immigrati, tossicomani. Tutta una carrellata di esseri mostruosi, i cui gli stessi corpi portano i segni di uno stato in between causato da agenti mutageni che impattano sulla realtà facendola scivolare in una dimensione liminale e tanto precaria quanto le architetture che danno vita un’urbanistica tumorale, divorata dal cancro dell’errore, dello sbaglio e della devianza.
La mutazione in senso precocemente degenerativo prodotta dal panorama urbano della nuova città è il primo stadio del morbo, e agisce sul doppio livello dell’equilibro fisico e psichico, alterando sin da subito il piano su cui la futura metropoli è chiamata a svilupparsi.
In altri termini: lasciarsi infettare dall’agente mutageno da cui nel 1946 nasce Roma è il prerequisito per comprendere tutti i differenti stadi della malattia che seguiranno.
Stadio 2
CRONOSI
Città fantasma, 1950-1960

Per venire incontro alla crisi abitativa del dopoguerra, già nel 1949 lo Stato inventa il cosiddetto piano INA Casa: la costruzione, su tutto il territorio italiano, di nuovi quartieri degni di una democrazia moderna, grazie a un tipico strumento delle socialdemocrazie postbelliche: l’edilizia pubblica – vale a dire finanziata, progettata e costruita dallo Stato stesso, e destinata alle classi meno abbienti del corpo sociale.
In altre parole: quella forma di ingegneria sociale ai più nota col nome di “case popolari”.
In quanto città più popolosa della nazione, è a Roma che si concentrano gli esempi più numerosi di quelli che da allora andranno sotto il nome di “quartieri INA casa”; in tutto sono undici – il simbolo del portale, le colonne gemelle attraversate le quali inizia il passaggio –, sparsi a pioggia in quella che all’epoca è ancora una periferia in costruzione: Tiburtino, Valco San Paolo, Tuscolano I, Tuscolano II, Tuscolano III, Ponte Mammolo, Villa Gordiani, Torre Spaccata, Colle di Mezzo, Acilia, Ostia.

Consegnati alla popolazione tra il 1950 e la metà del decennio successivo e progettati da alcuni dei più noti architetti del periodo, dal punto di vista tipologico i quartieri INA Casa provano a far convivere due tendenze sulla carta opposte: da una parte, l’applicazione rigorosa di standard razionali e “moderni” quali netta separazione tra aree abitative e aree commerciali, attenta pianificazione degli spazi verdi e distanza tra i fabbricati tale da consentire il passaggio di aria e luce; dall’altra, un preciso gusto neorurale pensato per “far sentire a casa” i nuovi abitanti dei suddetti quartieri, quasi tutti provenienti dalle campagne.
Il risultato è una straniante forma di idillio bucolico proveniente dal futuro: tetti spioventi e tegole in terracotta poggiano su ardite nervature in cemento armato; facciate in laterizio e murature a cortina incorniciano modernissime finestre a nastro; cortili alberati e giardini a orto sfilano accanto a sinuose strade pensate per il traffico automobilistico a scorrimento veloce.
Il sogno vernacolare dei quartieri INA Casa ha vita breve. Conclusosi il periodo eroico della pianificazione comunitaria centralizzata, presto a restare sono nient’altro ce le vestigia di un’Utopia abbandonata, e l’osservatore si scopre unica presenza viva in un pianeta disabitato, tra la Nube purpurea di Shiel e la Dissipatio H.G. di Morselli.
Le strade sono deserte. Di negozi non vi è più traccia. In giro non c’è nessuno. Tutto sembra galleggiare rarefatto in una nebbia sospesa, e i profili al contempo graziosi e ultramoderni degli edifici firmati da architetti quali Adalberto Libera e Mario Rifoldi trasmettono il tipico silenzio della città fantasma.
Ed è in effetti un fantasma quello che qui viene evocato: quello della promessa non mantenuta.
I quartieri INA casa sono le rovine, i ruderi sopravvissuti di un’era leggendaria e oramai dimenticata, quando lo sguardo benigno dello Stato sociale provvedeva a pianificare i destini dell’umanità come un Grande Fratello buono. Un futuro passato, un tempo che mai si è compiuto e che pure ritorna già morto, come un revenant. Non è morto ciò che mai è nato, e in strane ere anche il futuro può dimenticare di compiersi: ad accelerare la mutazione propiziata dal disturbo percettivo oncogeno attuato dalla Neorealisticopoli, interviene ora la cronosi – la malattia del tempo.
Stadio 3
LABIRINTITE BINARIA
Piccolo modernismo, 1955-1970

L’edilizia pubblica finanziata dallo Stato, da sola, non riesce a sopperire alla vera e propria fame di case che perseguita la neonata città di Roma. E quando in Italia scoppia il boom del miracolo economico, la soluzione diventa principalmente una: costruire ovunque e senza controllo.
Singoli privati si armano di permessi edilizi (e a volte nemmeno di quelli) per tirare su case dove più gli aggrada, in una sorta di replica sotto steroidi della città spontanea.
Protagonista assoluta dell’architettura romana del periodo diventa allora la palazzina: un tipo di costruzione a uso residenziale dalle dimensioni contenute (non più di quattro o cinque piani, e quindi facilmente edificabile anche da privati dalla disponibilità economica limitata), distaccata dagli edifici limitrofi (ha tutti e quattro i lati liberi), che in gergo urbanistico va sotto il nome di “edilizia puntiforme”.
Ogni palazzina è quindi un “punto” isolato. Solo che i “punti” sono tantissimi e tra loro vicinissimi: visti dall’alto i quartieri di palazzine assomigliano a un intricato foglio punzonato in fitto codice Braille – un labirinto di impulsi on/off attivati in rapidissima successione, fino a produrre un rumore inestricabile dato dalla continua interferenza di segnali tra loro contrastanti.
Evoluzione macchinizzata dell’abusivismo fai-da-te che aveva originariamente partorito la Neorealisticopoli, la palazzina è altrettanto disfunzionale, irrazionale e a conti fatti invivibile. Ma a differenza delle casupole piranesiane degli anni Quaranta, è concepita per accogliere non le mostruose creature della marginalità urbana, quanto la nascente piccola borghesia graziata dal boom.
Le avveniristiche, ipermoderne architetture dei piani di zona sono tentativi extra-umani di immaginare un mondo in cui non è l’urbanistica ad adattarsi ai bisogni degli abitanti, ma l’esatto contrario
E infatti, alle aberranti forme di Neorealisticopoli, la palazzina romana sostituisce il brivido ottimista del miracolo economico e dell’era atomica, mimando nelle sue forme gli aspetti più esteriori del linguaggio architettonico moderno.
E così ecco pensiline esageratamente sporgenti che richiamano gli alettoni di un aereo, balconi sagomati in modo da enfatizzare il movimento futurista delle linee spezzate, finestroni a nastro, nervature a vista, pilastri inclinati in maniera audace senza altro obiettivo che suggerire un’idea a conti fatti allucinatoria di “modernità”.
Se, nella storia del pensiero architettonico, il “modernismo” è il tentativo razionale di progettare abitazioni funzionali sulla base di una precisa tassonomia di bisogni abitativi, la palazzina della piccola borghesia romana battezza un piccolo-modernismo in tutto e per tutto irrazionale, delirante e talmente denso da rivelarsi caotico.
Da est a ovest, da nord a sud della città, in quartieri come Centocelle, il Portuense, Montesacro, i “punti” si accavallano al punto da collidere tra loro come dentro un acceleratore di particelle. Lo sguardo si perde tra le mille prospettive date alla continua successione di spazi pieni (gli edifici) e vuoti (i balconi nel nulla, lo spazio lasciato libero tra un “punto” e l’altro). L’enfasi futuribile, spezzettata, cacofonica di questo telaio Jacquard fatto di pensiline ad alettone e balconi inclinati precipita l’osservatore in una vertigine senza fondo – e la vertigine è come sappiamo un sintomo, il campanello d’allarme di una condizione patologica più grave.

I quartieri di palazzine sono dei labirinti in cui l’utopia razionale della modernità viene rovesciata in una generale condizione di instabilità e perdita di equilibrio – gli stessi effetti di quella che non a caso va sotto il nome di labirintite, la malattia dell’apparato acustico che fa sì che le informazioni che raggiungono il cervello siano diverse da quelle inviate da sensi sani, provocando segnali disturbati, interferenze caotiche, rumore, glitch.
Stadio 4
SINDROME ESTINTIVA ANTICIPATORIA
Ipermodernismo, 1968-1980

Le palazzine con balcone sono il sogno di una piccola borghesia vasta e trasversale. Ma per il sottoproletariato urbano resta il problema: di alloggi non ve ne sono, e l’unica soluzione rimangono le case popolari finanziate dallo Stato, la cui richiesta cresce in maniera esponenziale.
Archiviate le bucoliche ipotesi degli anni Quaranta e Cinquanta, l’edilizia pubblica compie quindi un deciso salto di scala: non più quartieri a misura d’uomo concepiti come villaggi neorurali nel cuore della città, ma immani astronavi in calcestruzzo e cemento armato dalle dimensioni sempre più grandi e dal disegno sempre più ardito, sempre più temerario e sempre meno umano.
Nel gergo urbanistico, sono i quartieri ultraperiferici ideati tra anni Sessanta e Settanta che vanno sotto il nome di “piani di zona”. In tutto ne verranno costruiti quarantotto, annunciati da una prima avanguardia che in tutto ne conta nove: come i cerchi dell’inferno.
Corviale è un unico palazzo per abitazioni alto dieci piani e lungo un chilometro. Laurentino 38 è una sfilata di torri di quindici piani collegate tra loro da ponti sospesi nel vuoto. Tor Sapienza è un’unica, immane fortezza brutalista disposta a quadrato attorno a un cortile che assomiglia a un buco nero. Casilino 23 è una delirante successione di palazzi dall’altezza sempre crescente disposti a ventaglio come se ruotassero attorno a un misterioso centro propulsore. Vigne Nuove è la materializzazione di un’allucinazione costruttivista in cui tunnel e passaggi soprelevati confondono prospettive e punti cardinali. Tor Bella Monaca, Quartaccio, Torrevecchia, Cinecittà Est, Spinaceto, sono pianeti paralleli provenienti da una galassia in cui ormai tutto è artificiale, come ad anticipare gli infiniti panorami hi-tech di Blame!, il manga “architetturista” di Tsutomu Nihei.

Le avveniristiche, ipermoderne architetture dei piani di zona sono tentativi extra-umani di immaginare un mondo in cui non è l’urbanistica ad adattarsi ai bisogni degli abitanti, ma l’esatto contrario: è la popolazione che qui vi abita a dover prendere le misure di monumentali entità aliene, che parlano una lingua incomprensibile e le cui leggi sono altrettanto inscalfibili.
Le cronache locali eleggono i quartieri popolari del periodo a incubo distopico dominato da pericolose bande di disperati e criminali di tutti i tipi: Tor Bella Monaca, Corviale e Laurentino 38 diventano sinonimo di degrado, violenza, delinquenza minorile, deprivazione generalizzata. Ma la realtà è che le astronavi che vanno sotto il nome di piani di zona aggiornano e aggiustano le distorsioni temporali dei quartieri INA Casa: lì era la promessa non mantenuta di un futuro passato che si manifestava sotto forma spettrale; qui è il futuro che atterra nel presente come presagio di ciò che ci aspetta di là dalla soglia: annichilimento dell’umano, mera sopravvivenza, adeguamento dei bisogni biologici al freddo diktat macchinico.
L’ipermodernismo è una forma di dislocazione temporale che solo per abitudine siamo abituati a chiamare distopia, e il cui termine più appropriato sarebbe semmai profezia. E come insegna il mito di Cassandra, quello della profezia non è un dono ma una maledizione, un complesso di sintomi che tutti assieme compongono una sindrome. In questo caso: la manifestazione morbosa di un’estinzione già avvenuta nel futuro.
Stadio 5
DEREALIZZAZIONE
Alto Brutalismo, 1970-1985

Le pericolose bande di disperati che popolano le nuove astronavi provenienti dal futuro obbligano la borghesia a prendere contromisure adeguate.
L’obiettivo è rintanarsi in luoghi sicuri e inattaccabili: vere e proprie fortezze ballardiane che, nelle forme, ricorrono allo stesso linguaggio ipermoderno della controporte di classe, ma invertendolo di segno.
A partire dagli anni Settanta, nel disinteresse generale e quasi in clandestinità, nella parte sud di Roma vengono edificati una serie di giganteschi insediamenti tanto avveniristici quanto i vari Corviale e Laurentino 38, ma che già nel nome tradiscono un’ideologia dalla precisa componente escapista.
Fonte Meravigliosa. Prato Smeraldo. Rinnovamento. Sogno. Roma 70. Eccoli, i nomi che la borghesia sceglie per i propri quartieri ipermoderni e iperfunzionali, come a voler velenosamente sottolineare che non sono le ardite architetture dall’aria brutalista a produrre comportamenti devianti, ma la semplice composizione di classe.
Nei mastodontici, vertiginosi, ultrafuturisti quartieri alto-brutalisti costruiti nei dintorni della grande via dedicata al Tintoretto (non a caso, maestro del manierismo e delle drammatiche prospettive tardorinascimentali), vivono in pace decine di migliaia di persone, prima ipotesi di una futura armonia dall’inquietante sottotesto survivalista.

Il cemento armato diventa una rigida barriera che separa il dentro dal fuori.
La pianta circolare che ossessivamente ritorna nei progetti dei nuovi insediamenti, produce fortezze introverse concepite al preciso scopo di tenere a distanza le orde di barbari contagiati dalla malattia dell’Urbe.
I ponti sospesi, i passaggi pedonali soprelevati, la “separazione delle funzioni” (aree residenziali distinte da aree commerciali ecc.) suggeriscono un catalogo lineare di comportamenti a cui la popolazione si adegua senza alcuna riluttanza, e anzi con la sottaciuta gioia di poter finalmente delegare tutto quanto è umano all’algido efficientismo della Macchina.
L’incubo distopico alla Blame! viene rivestito da una rassicurante patina composta in egual misura da melassa, fibre artificiali e psicofarmaci – pallido placebo per quel disturbo oramai incurabile che va sotto il nome di derealizzazione.
Stadio 6
ALLUCINOMA TERMINALE
Santuari, 1985-2015

A partire dai primi anni Ottanta, dopo aver quasi raggiunto il picco di tre milioni di abitanti, la popolazione di Roma comincia a declinare.
L’emergenza abitativa sembra sulla carta risolta: di nuove case, di nuovi quartieri residenziali, a quanto pare non c’è più bisogno.
L’edilizia pubblica scompare. Lo stesso concetto di “case popolari”, dopo i fallimenti tanto dei quartieri INA Casa quanto dei piani di zona, viene gettato nella pattumiera della storia assieme a tutto quanto odori di “Stato sociale”, sostituito dal trionfo dell’individuo di impronta neoliberale.
In questo panorama, in cui le necessità umane primarie vengono eclissate da un disinteresse diffuso, nelle periferie romane emerge un nuovo protagonista: il centro commerciale. Un fantasmagorico monumento all’effimero, perfetto per la nuova era urbana dominata dal consumo.
Il primo centro commerciale moderno sorge a Roma alla metà degli anni Ottanta nella periferia sud e si chiama Cinecittà Due. Un lunare santuario hi-tech il cui aspetto dichiara precise ambizioni liturgiche quando non ostentatamente esoteriche: a dominarne l’architettura sono piramidi dorate e tamburi neo-egizi che, una volta penetrati, si rivelano scintillanti cappelle transdimensionali.
Il tema del doppio, apertamente evocato dal nome del centro (Cinecittà Due), prelude all’oltre lo specchio: la mente sconfina in una landa onirica in cui le merci hanno definitivamente preso il posto dell’umano, il tempo si dilata.
Il sogno è quello di rimanere qui per sempre.

Cinecittà Due è lo stimolo primario che, tra gli anni Novanta e il secondo decennio dei Duemila, porta alla costruzione di una serie infinita di nuovi centri commerciali, di volta in volta sempre più grandi, sempre più maestosi, sempre più irreali, tutti in periferia: i Granai, Romanina, Porta di Roma, Roma Est, Euroma 2, Parco Leonardo, Maximo… Spazi dalle dimensioni progressivamente incontrollabili, che oramai dominano il territorio trasformandolo in una sorta di perturbante paese delle meraviglie a metà tra il render e l’esperienza lisergica.
La città ha vinto, la malattia è entrata nella sua fase terminale, gli organi sensoriali non servono più a nulla, compromessi come sono dall’inarrestabile incedere della malattia. Tutto è allucinazione.
Stadio 7
NECROSI
Quarto paesaggio, 2000-∞

Per il biologo e paesaggista francese Gilles Clemént, con l’espressione “terzo paesaggio” vanno indicate tutte quelle aree che non sono né città né natura incontaminata, e che sono segnate dall’assenza dell’attività umana: aree industriali dismesse, zone cosiddette “di risulta” abbandonate a loro stesse dove crescono rovi e sterpaglie…
Di terzi paesaggi Roma abbonda. Cresciuta in maniera disordinata grazie alla spinta caotica propiziata dal surreal-abusivismo di Nerealisticopoli e dal delirio puntiforme del piccolo modernismo palazzinaro, indifferente a qualsiasi proposta di piano regolatore, vista dall’alto la città è un agglomerato informe che si dispone a macchia di leopardo attorno a dei vuoti senza alcun vero statuto: né parchi né riserve naturali, sono dei semplici, sterminati pratoni che separano i diversi quartieri rendendoli tra loro persino più distanti di quanto appaiono sulla mappa.
La loro presenza esercita una sorta di potere radioattivo sul resto della città, contaminandola con lo spettro terrificante dell’horror vacui: la natura, ricorda Aristotele, “aborrisce il vuoto”; e infatti questi vuoti si sono infine riempiti, sebbene di presenze che, in una specie di aggiornamento della definizione di Clément, con l’attività umana non hanno più nulla a che fare – nel senso letterale dell’espressione.
Ridotti a discariche abusive e stracolmi di rifiuti abbandonati, i terzi paesaggi della Roma moderna sono diventati il teatro di ciò che resta dell’uomo: un museo a cielo aperto composto da scarti, scorie e pattume, testimonianza di una specie – quella umana – che qui riversa le miserabili vestigia del suo passaggio in Terra.

Attratta dai rifiuti, una nuova fauna ha cominciato a popolare questo habitat compiutamente alieno perché de-umanizzato – un quarto paesaggio in cui convivono resti umani e animali di tutti i tipi: cinghiali, volpi, gabbiani, lupi…
La loro natura bestiale è un affronto allo stesso concetto, quintessenzialmente umano, di città; ma per cinghiali e gabbiani è solo il primo passo: dai pratoni abbandonati che si innervano nel tessuto urbano, eccoli che timidamente si spingono dentro l’abitato, rovesciando cassonetti e planando sui passanti.
Ad alimentare queste creature, è dopotutto l’esito ultimo della patologia-città: la perdita di qualsiasi funzione vitale, lo stato di necrosi che prelude a una decomposizione di cui prova definitiva è l’immondizia marcescente sotto la quale Roma, questa città putrefatta, questa malattia senza cura, da sempre annega.