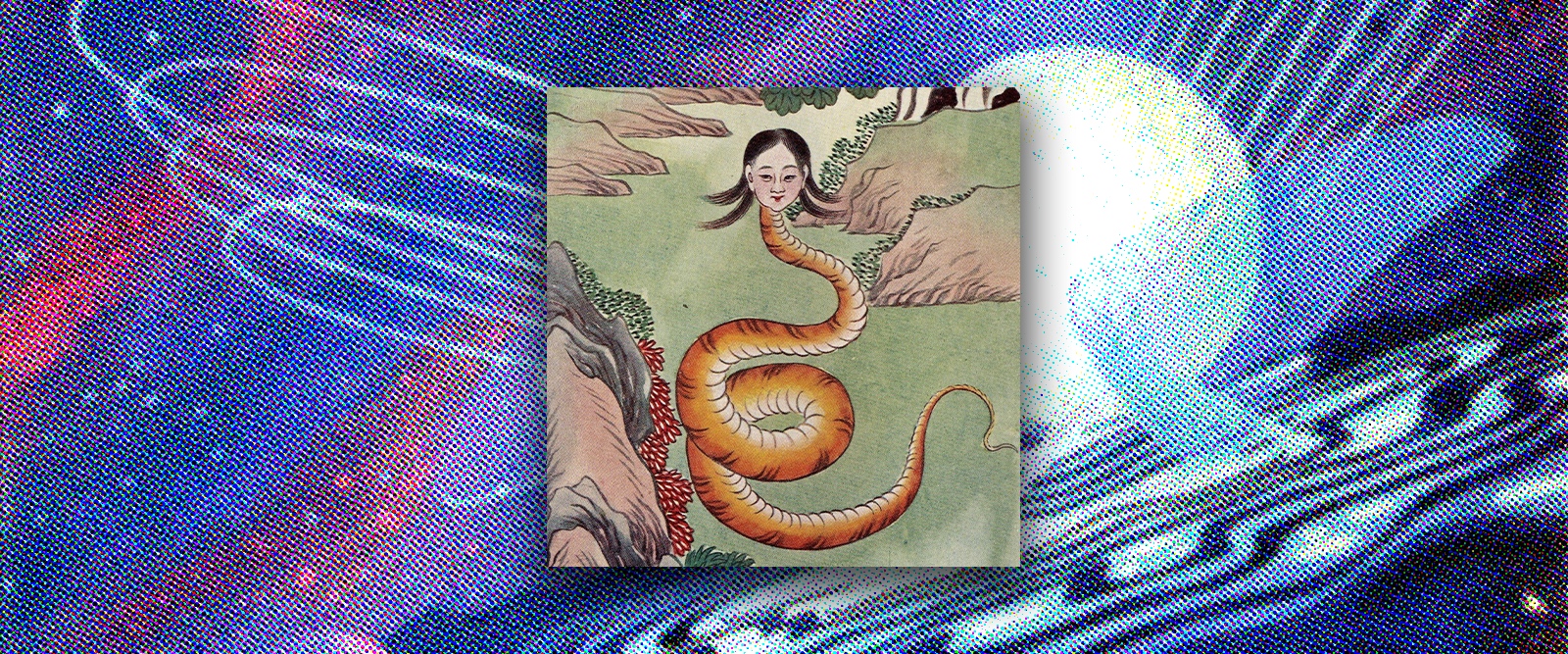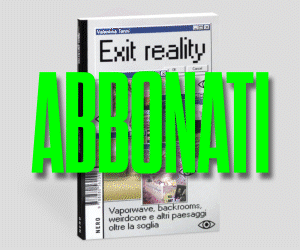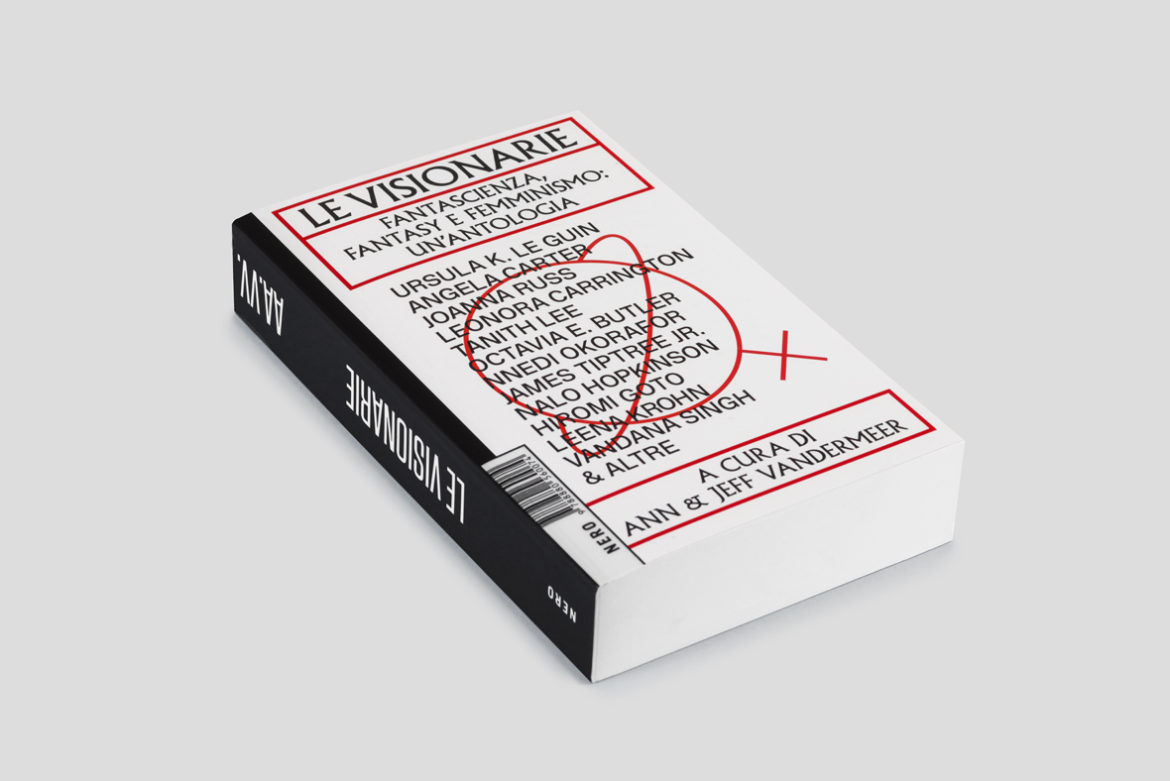Tutte le persone che incontrava parlavano in modo sconclusionato, come se fossero impazzite. Pian piano, capì di trovarsi in un mondo dove tutti vivevano doppie vite, portando il peso di due identità e due memorie. Solo un individuo fuori posto, cioè quello che aveva causato la fusione dei due mondi, era in grado di distinguere tra l’universo originale e quello alternativo.
Regina Kanyu Wang, Il giardino d’inverno
Il primo romanzo di fantascienza cinese a immaginare una società utopica femminile fu scritto molto probabilmente da un uomo. Come racconta Regina Kanyu Wang (王侃瑜) in un articolo uscito su Vector, The Evolution of Nüwa: A Brief “Herstory” of Chinese SF, si tratta di 女娲石 (La pietra di Nüwa), dove Nüwa è la dea mitologica cinese che riparò il cielo spezzato e modellò gli esseri umani dall’argilla. Scritto nel 1904 sotto lo pseudonimo 海天独啸子 (Hǎitiān dúxiào zǐ), il romanzo immagina donne competenti in arti marziali, scienza e medicina, impegnate nella salvezza della patria. Tuttavia, i loro strumenti d’azione restano intrappolati in stereotipi di genere «feudali»: ragazze carine vengono addestrate per sposare e assassinare funzionari governativi, frequentano bordelli per acquisire armi di seduzione. Tutte strategie che trasformano il corpo femminile in arma di stato. È difficile definire quest’opera come il primo esempio di fantascienza femminista in Cina, ma ci offre un punto di partenza storico.

Spostandoci sul presente, sono ormai passati dieci anni da quando Il problema dei tre corpi di Liu Cixin (刘慈欣) ha vinto il celebre premio Hugo, portando per la prima volta la fantascienza cinese sotto i riflettori globali. Da allora, il genere ha guadagnato spazio, ma le voci più celebrate – Liu Cixin, Wang Jinkang (王晋康), Han Song (韩松), Chen Qiufan (陈楸帆) – restano quasi esclusivamente maschili. Anche Ken Liu (刘宇昆), cruciale come traduttore, appare spesso accanto a questi nomi. Festival, premi e traduzioni hanno consolidato l’attenzione internazionale, ma anche reso evidente la parzialità dello sguardo. Ancora una volta, la fantascienza è stata raccontata come un territorio maschile.
Scrivere questo testo è stato un viaggio in territori poco esplorati, in cerca di piccole oasi, come il catalogo di Future Fiction, che negli anni ha pubblicato diverse autrici di fantascienza cinesi. Le omissioni sono inevitabili, ma spero perdonabili. Può sembrare paradossale che, in un’epoca di traduzioni automatiche e intelligenze artificiali, esplorare queste letterature continui ad avere il sapore di un’impresa temeraria.
Come sottolinea Tang Fei (糖匪) in un’intervista su Words Without Borders dal titolo Sexism and Science Fiction, l’invisibilità delle autrici non è solo questione numerica: riguarda lo sguardo con cui si leggono le loro opere, spesso ridotte a “tema”, a “curiosità di genere” o a parentesi estetiche. Non si tratta di aggiungere autrici a una lista per riequilibrare il conteggio, ma di ascoltare come la loro voce riscrive le coordinate stesse del genere: come destabilizza potere, desiderio, tecnologia. Tang Fei ci invita a rovesciare la domanda: non perché una donna scriva fantascienza, ma cosa diventa la fantascienza quando attraversa l’esperienza di chi ha imparato a sopravvivere ai margini.
La sua narrativa, ad esempio, lo dimostra con forza. In Call Girl, pubblicato da Apex Magazine, Tang Fei affronta con sottigliezza temi come la mercificazione del corpo femminile e l’autodeterminazione della protagonista, ribaltando le aspettative del lettore. Xiaoyi, liceale apparentemente coinvolta in un giro di prostituzione, si rivela invece una venditrice di esperienze: non offre sesso, ma storie che trasformano, in un’epoca in cui il desiderio autentico è merce rara. Tang Fei ci consegna così una riflessione inquieta e poetica sul bisogno umano di connessione e sul prezzo, non sempre monetario, delle emozioni vere.
Una storia di corpi e potere: dal maoismo al femminismo
Le scrittrici che ho incontrato in questo percorso guardano alla tecnologia non come strumento di dominio, ma come lente per ripensare intimità, relazioni, corpi, possibilità. La strada è stata lunga dal 1904 a oggi, e vale la pena segnalare tre tappe storiche per collocare questa produzione letteraria nel contesto cinese.
Con la fondazione della Repubblica Popolare di Cina nel 1949, alle donne cinesi venne detto che “Uomini e donne sono uguali” (男女都一样) e che “Le donne sorreggono metà del cielo” (妇女顶起半边天). Tuttavia, mentre le lavoratrici venivano celebrate come forza lavoro fondamentale per costruire la giovane nazione, al pari degli uomini, oltre a occuparsi della patria dovevano anche essere responsabili del lavoro domestico, della cura e del lavoro di servizio.
Dopo il periodo di “Riforma e Apertura”, a parte dalla fine degli anni ’70, gli intellettuali cinesi iniziarono a divorare il pensiero occidentale, mettendo in discussione alcuni pilastri del pensiero maoista. Anche su questa spinta, intorno alla metà degli anni ’80, in Cina emerse il concetto di “letteratura femminile”, introdotto per distinguere la scrittura delle autrici. Se da un lato questa può essere considerata la prima ondata di discussioni di genere nella Cina contemporanea, come in effetti ben illustra un recentissimo studio che ricostruisce la genealogia degli Studi di genere in Cina negli ultimi quarant’anni, bisogna aspettare gli anni ’90 perché avvenga il passaggio da una visione delle donne come meri oggetti di ricerca a un riconoscimento della loro agentività.
In preparazione alla Quarta Conferenza Mondiale sulle Donne, tenutasi a Pechino nel 1995, il governo cinese promosse attivamente la ricerca sulle donne e la diffusione delle conoscenze correlate. Di conseguenza, gli studi di genere diventarono un campo accademico molto visibile e le prospettive di genere iniziarono a prendere forma nel discorso scientifico. È proprio intorno alla Conferenza di Pechino che sorsero le categorie di “letteratura femminista” (女性主义文学) e “scrittura femminile” (女性写作), ma il mercato spinse molte autrici verso filoni come la “scrittura del corpo” o della “bellezza”, neutralizzandone il potenziale critico.
È difficile dire quanto tutto ciò abbia influenzato la scrittura fantascientifica femminile in Cina in quel periodo, poiché, a partire da una campagna del 1983, la fantascienza in generale era sottoposta a critiche per “inquinamento spirituale”, a causa dei suoi “elementi capitalistici”, considerati dannosi dal punto di vista politico.
Ma come ben evidenziato da Simone Pieranni nel suo libro Tecnocina, le scienziate, ricercatrici e imprenditrici hanno giocato un ruolo cruciale nello sviluppo tecnologico cinese, e proprio in quegli anni due donne hanno hanno contribuito in modo decisivo.. Sarà infatti Zhang Shuxin (张淑欣) a fondare il primo provider cinese di Internet della storia, Yinghaiwei, nel 1995. E nel 1998, a capo del neo-ministero della Scienza e della Tecnologia ci sarà Zhu Lilan (朱立兰), nata a Shanghai e laureata in chimica in Unione Sovietica.
Le comunità online, sin dalla fine degli anni ’90, avranno un ruolo centrale nel far crescere il numero di lettrici donne, a partire dalla prima piattaforma online di letteratura femminile, hongxiu.com (Fragrant Red Sleeves), fondata già nel 1999. Successivamente, dagli anni 2010, anche grazie al #MeToo, le scrittrici di fantascienza hanno iniziato a integrare nelle loro opere questioni di genere, identità, sessualità, disuguaglianza, in maniera più sistematica e sofisticata. La stessa Regina Kanyu Wang parla di un percorso personale di consapevolezza femminista, nato nel tempo, anche perché costretta a confrontarsi con l’idea di una fantascienza percepita come dominio occidentale e maschile.
Intimità, tecnologia e identità in trasformazione
Wang è una delle poche autrici tradotte in italiano. Nuvole e nebbia, pubblicato in Italia da Future Fiction in edizione bilingue, è una novella che si muove tra cyberpunk intimista e distopia psicologica. Ambientato in una Cina del futuro dove la condivisione dei pensieri e dei ricordi attraverso un cloud mentale ha trasformato radicalmente l’identità individuale, Wang sfrutta l’impianto speculativo del libro come uno strumento per indagare la coscienza, il senso del sé e la natura dell’autonomia. In questa città avvolta da nebbie simboliche e reali, dove i confini tra sé e altri si sfaldano, la sua scrittura si fa densa, sensoriale, attraversata da tensioni etiche profonde: fino a che punto possiamo essere connessi senza smarrire la nostra singolarità? Quale memoria è veramente nostra? E cosa significa amare, o scegliere, quando i pensieri non ci appartengono più del tutto? Nuvole e nebbia interroga la promessa di trasparenza totale delle tecnologie affettive, restituendoci un futuro inquieto, stratificato, a tratti lirico, dove ogni relazione è anche un rischio di dissoluzione.
Un altro esempio chiave della sua poetica è The Winter Garden, racconto disponibile su Clarkesworld in inglese. Anche qui Wang si confronta con il tema della scelta. Esplora l’identità come campo mobile, stratificato, poroso: la protagonista si confronta con una versione alternativa di sé proveniente da un universo parallelo, e tra le due si innesca un cortocircuito di desiderio che sfiora l’eros, ma che è soprattutto un’esplorazione di possibilità e riconoscimento. L’incontro non è solo un gioco speculare, ma un’esperienza liminale: toccare l’altra sé significa esplorare il limite tra io e non-io, tra intimità e alienità. La narrazione mette in crisi le categorie binarie di soggetto e oggetto, mostrando come l’identità non sia mai fissata, ma sempre in divenire, moltiplicata, rifratta.
Wang lavora sulla messa in discussione delle strutture: non tanto “più voci”, ma altre griglie, altre mappe, altre logiche. Nei suoi racconti, la tecnologia non è semplicemente un ambiente o un dispositivo esterno, ma un’estensione della psiche e della relazione, un elemento capace di far esplodere i confini del sé.
In quasi tutti i racconti, la tecnologia non è spettacolare o centrale nel senso tradizionale della sci-fi più “dura”, ma agisce come interfaccia sottile.
Tanto nella scrittura narrativa quanto nella sua ricerca accademica, Wang sfrutta l’immaginabile offerto dalla tecnologia per minare il pensiero binario, ricorrendo allo stesso pensiero tradizionale. In una tavola rotonda dal titolo, Can Chinese Science Fiction Transcend Binary Thinking?, si è soffermata sulla coppia concettuale della cosmologia cinese antica: yin (阴) e yang (阳), che hanno ancora oggi un’enorme influenza nella Cina contemporanea. Yin e yang possono rappresentare femminile e maschile, ma anche oscurità e luce, inanimato e animato, fiume e montagna. Yin e yang sono intrecciati l’uno nell’altro, costituendo una vitalità fluida (qi 气). Questo concetto pone l’accento sulla distribuzione del potere d’azione tra diverse soggettività, piuttosto che sulla loro separazione. In questo contesto, la circolazione della vitalità fluida tra entità e soggettività diverse costituisce l’elemento centrale dell’individualità, più che le differenze di genere. In alcuni racconti di fantascienza cinese c’è la tendenza a mostrare questo equilibrio, nell’interazione e nell’interdipendenza di yin e yang: sono racconti che non si concentrano necessariamente sul genere, ma mettono in scena forze interdipendenti che cercano un bilanciamento.
Frutto di questo campo di interesse è l’antologia curata dalla stessa Wang insieme a Yu Chen (于晨), The Way Spring Arrives and Other Stories: A Collection of Chinese Science Fiction and Fantasy in Translation from a Visionary Team of Female and Nonbinary Creators (Tor Books, 2022). Qui la sfida è duplice: da un lato dare visibilità a una scena narrativa che in Cina è stata a lungo marginalizzata, dall’altro ridefinire le coordinate stesse della speculative fiction, intrecciando genere, identità, ecologia, linguaggio e appartenenza. La raccolta non solo dà voce ad autrici e persone non binarie, ma intreccia storie con saggi critici e riflessioni teoriche, creando un dialogo continuo tra narrazione e interpretazione. È un progetto che si presenta come opera letteraria, ma funziona anche come dispositivo metanarrativo: un laboratorio in cui si ragiona apertamente su cosa significhi scrivere, tradurre, leggere in un’epoca di trasformazioni radicali.
Che si tratti di riflettere sulla memoria, sul corpo, sul linguaggio, le autrici e le persone non binarie raccolte in The Way Spring Arrives mettono al centro l’instabilità, la trasformazione, la possibilità. In quasi tutti i racconti, la tecnologia non è spettacolare o centrale nel senso tradizionale della sci-fi più “dura”, ma agisce come interfaccia sottile. È spesso la tecnologia della connessione, della trasformazione, e della rottura delle gerarchie (umano/non umano, centro/periferia, maschile/femminile, umano/postumano).
La fantascienza, nelle loro mani, diventa uno strumento per immaginare non solo altri mondi, ma altri modi di essere al mondo. L’antologia è chiaramente un gesto politico, ma anche una dichiarazione poetica. È una raccolta che non cerca di normalizzare o includere, ma di disturbare e ridisegnare.
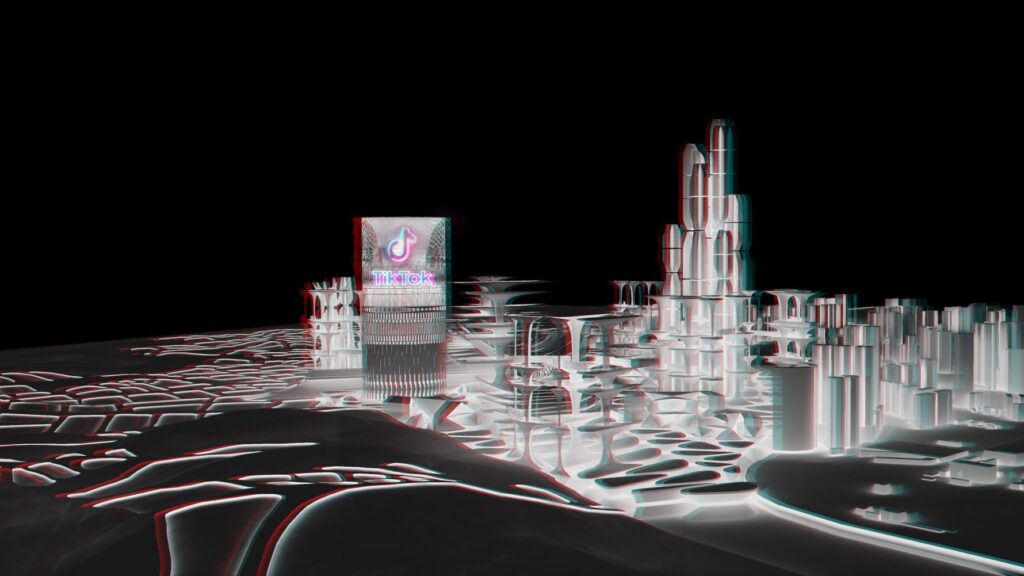
Algoritmi sociali e segregazione
Si posiziona su un piano ugualmente politico Pechino pieghevole di Hao Jingfang (郝景芳), pubblicato in italiano nella collana Asia, che curo per add editore insieme a Ilaria Peretti. Qui, l’autrice immagina la capitale cinese divisa in tre livelli temporali che si alternano come pieghe di carta, una Pechino che si piega letteralmente su sé stessa per assegnare spazi, ore, risorse e possibilità a tre diverse classi sociali: i ricchi vivono sei giorni alla settimana, la classe media due giorni, e gli ultimi della scala sociale appena 24 ore, durante le quali devono lavorare. Quando una città intera si piega e si dispiega per dare spazio, letteralmente, a vite che non devono incontrarsi, Hao Jingfang ci parla della segregazione sociale, ma anche delle promesse mancate del progresso: un futuro tecnologico che non porta giustizia, ma riproduce – e spesso amplifica – le disuguaglianze che già conosciamo. L’architettura urbana in questa novella, premiata anch’essa con l’Hugo (prima e unica autrice donna cinese a ottenerlo), diventa algoritmo sociale, segregazione codificata.
Ciò che rende il racconto memorabile non è solo la precisione della costruzione distopica, ma la capacità di restituire l’esperienza quotidiana di chi abita queste fratture. I personaggi si muovono all’interno di un paesaggio regolato tecnologicamente, ma portano dentro sogni, desideri, malinconie. Il futuro, in questo immaginario, non è solo uno spazio di oppressione, ma anche un terreno fragile di contatto e possibilità. Le crepe nel sistema non vengono idealizzate, ma diventano i luoghi in cui la politica si fa esperienza vissuta.
La scrittura di Xia Jia (夏笳) si muove sul crinale sottile tra fantascienza e filosofia, tra sperimentazione narrativa e riflessione sul linguaggio. Nei suoi racconti, popolati da fantasmi e robot (si veda ad esempio uno dei più celebrati, L’estate di Tongtong, disponibile in italiano), sperimenta loop, alternanze di registro, per costruire un ambiente affettivo in cui tecnologia e umanità non sono mai opposti, ma intrecciati in un unico respiro. Non sorprende che, anche quando sceglie di scrivere direttamente in inglese, Xia Jia lo faccia come se stesse giocando a un gioco speculativo: nel racconto What Does the Fox Say, descrive il suo processo creativo come una sorta di “algoritmo” costruito in collaborazione con motori di ricerca e software di traduzione, spingendo la scrittura oltre la soglia dell’umano. Per Xia Jia, la letteratura diventa un laboratorio in cui esplorare l’intertestualità che plasma il nostro tempo – collage, citazione, parodia – ma sempre con la consapevolezza che un algoritmo, per quanto perfetto, non potrà mai cogliere il piacere sottile del riconoscimento, il momento in cui un lettore umano sussurra “so da dove viene questa frase”. È in questa tensione tra macchina e umanità, tra codice e intimità, che la sua scrittura rivela la sua natura più filosofica: una continua interrogazione su cosa significhi essere vivi, connessi, consapevoli.
Se Xia Jia lavora sulla soglia tra umano e postumano esplorando il linguaggio come spazio d’ibridazione, Lin Hsin-Hui (林新惠) radicalizza lo sguardo sul corpo. Qui mi sono concessa un passo fuori dalla Cina continentale, pur restando nell’ambito sinofono: Lin Hsin-Hui è infatti un’autrice taiwanese, erede di un’incomparabile tradizione queer radicata sull’isola. Ho voluto deliberatamente oltrepassare i confini statali, proprio per tracciare un gesto che fosse, paradossalmente, l’opposto dell’imperialismo cinese che rivendica Taiwan come propria provincia. Intravedo in questa scelta un potenziale di solidarietà transnazionale, offerto da una letteratura di genere radicale che non conosce frontiere. Sarebbe stato un errore, credo, tralasciare un testo così attuale e inquietantemente plausibile nel raccontare un possibile sguardo sulla tecnologia. Il suo romanzo Intimità senza contatto (ed. originale del 2023, ed. italiana uscita del 2025), racconta un mondo governato da un’intelligenza artificiale che, sulla base dei dati raccolti sull’intera popolazione terrestre, ha decretato che la radice dell’infelicità umana è il contatto fisico. Qui la sperimentazione non è solo narrativa, ma profondamente politica: un programma di accoppiamento tra umani e androidi in cui i corpi sono stati “neutralizzati” – senza sesso, razza, età, genitali – promette un’uguaglianza radicale, ma l’identità incarnata resiste. La protagonista percepisce la mancanza del proprio corpo originario, cerca tra le gambe una fenditura che non c’è più, ricorda ciò che la tecnologia pretendeva di cancellare. In questa società, l’intimità non è più un’esperienza, ma una performance normata, misurabile, sorvegliata. L’amore diventa asset, capitale relazionale, indice di valore sociale. La dissidenza si insinua in gesti minimi: un abbraccio, un contatto, un ricordo. Anche la madre della protagonista, segnata dalla perdita del marito per “contaminazione emotiva”, insegna alla figlia a evitare il tocco, confondendo protezione e isolamento. Ma la distanza non salva: il dolore si sposta, si trasforma, si accumula.
Metamorfosi riproduttive, dissidenza e futuri ibridi
Ci vorrebbe un focus esclusivo sul tema del ruolo riproduttivo della donna nella società cinese e la sua rappresentazione e interpretazione nella fantascienza. Ma per ragioni di spazio mi soffermerò su un lavoro pionieristico di Zhang Jing (张静), nata nel 1938 e attiva nella fantascienza dal 1985. In L’amore di Nüwa (女娲恋, 1991), con cui ha vinto il suo terzo Galaxy Award quell’anno, racconta la storia di una ragazza aliena che si assume la responsabilità di garantire la riproduzione della specie umana. La protagonista ha il nome della dea che, nella mitologia cinese, “ripara il cielo spezzato e crea gli esseri umani”. È un testo che non a caso esce in quel periodo storico in cui, in alcuni circoli intellettuali in dialogo con idee provenienti anche dall’estero, il ruolo della donna nella società iniziava a essere messo in discussione. Prosegue su questa scia Chi Hui (迟卉), nata nel 1984, e autrice di Nido di insetti (虫巢, 2008), racconto in cui interroga la violenza epistemica e di genere radicata nelle strutture di potere umane. Il racconto immagina un pianeta pacifico e matriarcale in cui le specie convivono in simbiosi e hanno un sistema riproduttivo collettivo, distribuito. Questo mondo è incomprensibile per i colonizzatori terrestri, ostili a un modello di potere femminile. Il racconto riflette sulla violenza coloniale, maschilista e antropocentrica, e sulla difficoltà degli umani a comprendere forme di vita e organizzazione sociale radicalmente diverse, in cui le tecniche riproduttive hanno frantumato le categorie binarie e spalancato mondi ibridi, dove la metamorfosi è la norma e l’identità è costantemente negoziata.
Ciò che accomuna queste scrittrici è un rifiuto delle semplificazioni. Non offrono né incubi tecnologici né utopie salvifiche: costruiscono scenari aperti, esperienze di vita, possibilità. Il critico Mingwei Song (宋明炜) ha definito questa corrente “neo-barocco”, un paradigma estetico e conoscitivo che la interpreta come una risposta ai cambiamenti radicali nella cultura e nella scienza contemporanea in analogia con la crisi epistemologica del Barocco storico. Il termine, come l’autore spiega in Fear of Seeing. A poetics of Chinese Science Fiction,è debitore ai testi La piega: Leibniz e il Barocco di Gilles Deleuze, che descrive il barocco come una funzione operativa che genera pieghe infinite, e a Neo-Baroque: A Sign of the Times di Omar Calabrese, che lo legge come lo “spirito del tempo” nella cultura contemporanea. Come nel Barocco, il neo-barocco rifiuta una visione lineare del tempo e dello spazio, proponendo invece immagini che riflettono la complessità del presente e una conoscenza in continua trasformazione. In questo contesto, la fantascienza neo-barocca “genera nuove modalità di discorso letterario che alienano ciò che diamo per scontato, aprono gli occhi a conoscenze insorgenti e immagini sovversive, ed evocano una gamma di sensazioni (ir)reali o virtuali che vanno dall’infernale al sublime, dallo spettrale allo spettacolare, dall’inebriante all’esuberante, dal trascendentale all’apocalittico, dall’umano al postumano, e così via. La tesi di Mingwei Song è che la produzione contemporanea che rientra in questo universo letterario mostri la futilità del pensiero binario.
Attraversando queste storie, capiamo che non parlano solo di futuri remoti; ci riportano al presente, ci costringono a rivedere i nostri spazi, le nostre relazioni, le nostre infrastrutture emotive. Ci domandano: Chi ha diritto al futuro? Di chi è il tempo? Quali corpi possono sopravvivere all’impatto della tecnologia? E, soprattutto, come possiamo imparare a convivere senza annientarci?
Traduzioni disponibili in italiano
Questo articolo rappresenta un tentativo parziale di tracciare una panoramica delle autrici cinesi di fantascienza contemporanea, con un’attenzione particolare al loro sguardo sulla tecnologia. La riflessione si basa sulle poche opere disponibili in traduzione italiana e inglese, e si avvale anche di fonti secondarie e del lavoro di divulgazione di studiose come Regina Kanyu Wang. Per completare il quadro, segnalo di seguito le traduzioni disponibili in italiano, dove compaiono altre autrici che non ho potuto approfondire nel corpo del testo.
Duan Ziqi e Francesco Verso, Zendroide, Future Fiction, 2022
Gu Shi, Il continuo di Möbius, Future Fiction, 2024
Hao Jingfang, Pechino pieghevole, add editore, 2020
Lin Hsin-Hui, Intimità senza contatto, add editore, 2025
Mu Ming, Colora il mondo, Future Fiction, 2021
Regina Kanyu Wang, Nuvole e nebbia, Future Fiction, 2019
Tang Fei, Spore, Future Fiction, 2022
Xia Jia, Festa di primavera, Future Fiction, 2022
Antologie (tra parentesi i nomi delle autrici tradotte)
AA.VV., Nebula. Fantascienza contemporanea cinese, Future Fiction (Xia Jia), 2018
AA.VV., Sinosfera. Fantascienza contemporanea cinese, Future Fiction (Fan Yilun, Tang Fei), 2018
Caratteri n.9, Mondi futuri, Foreign Languages Press (Xia Jia, Mu Ming, Tang Fei), 2019
AA.VV., ArtifiCina. Fantascienza contemporanea cinese, Future Fiction (Fan Yilun, Tang Fei, Peng Simeng), 2019
AA.VV., Il sole cinese, Future Fiction (Xia Jia, Mu Ming, Tang Fei, Chi Hui, Su Min), 2021
AA.VV., Futugrammi. Fantascienza contemporanea cinese, Future Fiction, 2020 (Bella Han, Su Min), 2021
AA.VV., Il colibrì e la pagoda, Future Fiction, 2023 (Wang Kanyu), 2023
Chen Qiufan (a cura di), Il Tao delle macchine, LUISS (Gu Shi e Mu Ming), 2025