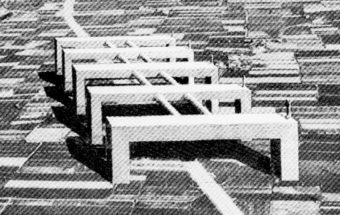Per un’architettura dell’antropocene
È il 2010 quando, nel pieno degli studi al Politecnico di Milano, Stefano Colombo, Eugenio Cosentino e Luca Marullo fondano il collettivo di architettura Parasite 2.0. Interessati a una ricerca che non si limiti alla pratica costruttiva in senso stretto, i tre si fanno presto notare nel panorama prima milanese e poi italiano per il loro mix di design, arti visive, urbanistica e sociologia, e per uno sguardo che punta alla revisione degli esempi storici attraverso una narrativa quasi cyberpunk. Il salto di qualità arriva nel 2016, quando i tre vincono il concorso per giovani architetti YAP MAXXI, organizzato dal museo romano in collaborazione con il MoMA PS1 di New York, il Constructo di Santiago del Cile, l’Istanbul Modern e l’MMCA di Seoul. Il progetto di Parasite 2.0, chiamato MAXXI Temporary School, manifestava la loro attenzione per il concetto di «partecipazione» tramite l’allestimento di una scuola temporanea che potesse ospitare workshop e dibattiti, piuttosto che un elaborato finito basato su una formalizzazione concreta. Da allora i Parasite 2.0 hanno firmato progetti che vanno da uno strano «parco giochi» per il festival Terraforma a «piattaforme culinarie» che parodiano i riti dell’happy hour, passando per le «architetture incerte per l’Antropocene» presentate alla XX biennale di architettura e urbanistica di Valparaiso in Cile. Noi li abbiamo intervistati per parlare di tutto questo, e più in generale per discutere delle dinamiche che intercorrono tra controculture, spazi fisici e internet dal punto di vista della nuova generazione di architetti che opera nello spazio della pratica non convenzionale e in un contesto di generalizzata isteria produttiva.
Parasite 2.0, Dark Matter Architecture Agency
Trovo degli interessanti punti di contatto tra quello che definite «architetto neofiliaco» – un architetto cioè che rifiuta di conformarsi alla norma e ricerca spasmodicamente nuove soluzioni costruttive – e la figura dell’outsider descritta da Markus Miessen in The Nightmare of Participation, ovvero colui che interviene senza essere invitato in un dibattito. Dopotutto, sia voi sia Miessen identificate nell’architetto il ruolo di rivoluzionario dell’antropocene. Siete dell’idea che neofiliaco e outsider indichino la stessa cosa?
Per essere neofiliaco non bisogna per forza essere outsider, anzi. Forse il neofiliaco è più vicino al concetto di cross-bencher applicato in senso stretto al termine da Miessen: un protagonista indipendente e proattivo che non opera per ottenere consenso, ma per offrire il suo punto di vista critico nel processo democratico. Il neofiliaco è interessato a rivedere criticamente qualsiasi formulazione, a maggior ragione in un’era a parer nostro piena di contraddizioni e molto oscura e in continua evoluzione. Da qui l’idea di un progetto come Dark Matter Architecture Agency, per l’esplorazione di questi spazi oscuri.
Ma in tutto questo che ruolo occupa il dibattito sull’antropocene?
Lo scontro con il concetto di antropocene è sostanzialmente l’origine di tutte queste riflessioni. Quello che più ci interessa è la necessità di ripensare completamente il «fare umano» nell’era dell’«impatto umano definitivo», partendo dalle errate modalità di antropizzazione (occidentale) che sono ormai chiare e facili da riconoscere (un grande passo avanti a riguardo è stato recentemente fatto ad esempio da Gabrielle Hecht in un saggio intitolato The African Anthropocene). Essendo l’architettura la matrice base dell’antropizzazione, proprio l’architetto diventa una figura cruciale di tale ripensamento. Questo però è solo parzialmente vero: in effetti, oggi l’architetto è una figura del tutto marginale nei processi di trasformazione dell’habitat e nella definizione visibile di città. Finanza, politica e burocrazia: sono loro i veri attori dell’antropizzazione. L’architetto oggi è più o meno relegato a disegnare il vestito degli edifici e quindi della città, o a elaborare tesi di dottorato e ricerche spesso irrilevanti – anche perché l’architetto ha parzialmente perso il background teorico e ideologico. In questo senso, se si è interessati a riflettere su nuove modalità di dare forma all’habitat in cui viviamo, bisogna allontanarsi dalla pratica in senso stretto, insomma dall’architetto come progettista di edifici. Piuttosto, bisogna migrare in altri campi e allargare le possibilità di riflessione. È questo che in un certo senso stiamo provando a fare: la visione che si potrebbe realizzare attraverso la nostra pratica è concentrata sull’architetto stesso, su una possibile revisione critica di questa figura.

Primitive Future Tribalism
Nel progetto Primitive Future Tribalism per Librino – il quartiere periferico di Catania epicentro della criminalità organizzata – parlate di una «ricerca che concepisce il quartiere di Librino come un’isola radicale nel futuro primitivo e immagina le forme tribali metropolitane che lo popoleranno», il tutto per arrivare a «forme nuove e indipendenti di società». Cosa intendete esattamente?
Come sappiamo bene, diverse politiche molto diffuse dal dopoguerra in poi hanno portato all’allontanamento dalla città «ufficiale» – quella ritenuta pulsante, importante, rilevante anche solo per valore economico – di alcune precise fasce della società. Librino è uno di questi casi. Per spiegare meglio un progetto come Primitive Future Tribalism, pensiamo all’assurdo caso del «palazzo di cemento», la torre di sedici piani inizialmente progettata da Kenzo Tange e poi abbandonata a se stessa fino a diventare una delle principali piazze criminali del quartiere; ora: nell’abbandono, questi luoghi sono davvero liberi di strutturare sistemi di organizzazione spaziale e sociale autonomi e completamente emancipati (e qui entra il concetto di isola deserta come luogo in cui la vita non può esistere, ma può paradossalmente esistere tutto, una nuova formulazione). A Librino non esiste controllo, se non quello mafioso. Ci si può quindi permettere di appropriarsi di un palazzo intero – come il mitico «palazzo di cemento», appunto – e trasformarlo nella roccaforte di una visione diversa della vita, che però purtroppo in questo caso è di tipo mafioso. Ma se invece si utilizzasse questa possibilità per provare a immaginare una modalità nuova di vivere la vita collettiva e i suoi spazi? Noi abbiamo immaginato una società emancipata del futuro, nell’antropocene più estremo, che abita questo luogo distopico frutto del conflitto tra uno dei più grandi architetti della storia – Kenzo Tange, padre del metabolismo – e il connubio Stato-Mafia che ha dato vita a un quartiere come Librino. Partendo dallo stato in cui il quartiere si trova – un habitat in cui nelle architetture è come impresso una sorta di romantico feticismo futurista, assieme a una sorta di terzo paesaggio selvaggio visibile nell’abbandono degli spazi verdi o nelle operazioni di modifica e superfetazione spontanee – abbiamo provato a immaginare le sue tribù nel futuro. L’idea era quella di provare a immaginare un futuro spazio caratterizzato da una compenetrazione tra natura e artificio, tra futurismo e tribalismo. Da qui simboli come la capanna, il focolare, il totem, accompagnati da un background sonoro che mescolava musica neomelodica con i suoni della giungla e i miti della tecnocrazia contemporanea come i droni o la stampa 3D.
Nel saggio Cosmology, subcultures and urban wilderness analizzate diverse sottoculture – dal punk alla cultura rave – che hanno organizzato forme tribali di resistenza al potere nei quartieri di periferia lasciati a se stessi. Possiamo legare anche questo al concetto di Primitive Future Tribalism?
Torniamo al caso di Librino; noi abbiamo immaginato il quartiere di Catania come un deserto: un luogo cioè dove è possibile formulare e dare vita a nuove cosmologie, nuove costruzioni sociali e sistemi di convenzioni nell’interpretazione del mondo, dell’habitat e della vita. Bene, i tribalismi di cui parli possono solo trovare spazio nei deserti della nostra società. Le tribù urbane di cui parliamo in Cosmology, subcultures and urban wilderness sono le sottoculture più strutturate che siamo riusciti a individuare, ma già chiamarle sottoculture – come ci è stato rimproverato da Matteo Guarnaccia – è sbagliato: perché esiste solo una cultura, unica, quella di tutta l’umanità. Una sottocultura – cioè una cultura sottomessa alle altre – premette quindi che ne esista un’altra dominante. I deserti invece dimostrano la possibilità di molteplici culture, che poi sono cosmologie, cioè costruzioni e spiegazioni del reale, del mondo. Il problema serio è come mantenere queste reazioni pure, vere. L’hip hop è il caso più eclatante; la lotta razziale e l’affermazione di una minoranza è diventata l’inseguimento degli ideali capitalisti: l’oro, le macchine, lo sfarzo più ridondante che troviamo nei video di molti rapper. Basta osservare il fenomeno della trap per comprendere l’entità di questo spostamento ideologico. Di fatto, gli ultimi quindici anni di storia dell’hip hop hanno mistificato e distrutto l’incredibile processo emancipatorio a cui pochi sconosciuti diedero vita. Questo è il problema: l’appropriazione e mistificazione che la presunta cultura dominante riesce a costruire su qualsiasi alternativa.
Voi avete insistito più volte sulle sottoculture come vere e proprie genitrici dell’evoluzione urbana. Ma allora quali possono essere le evoluzioni della «disobbedienza» nella costruzione di una comunità che non solo si ribella alle istituzioni ma che crea proprie forme di vita collettiva?
Per rispondere a questa domanda è necessario prima definire cosa si intende per disobbedienza, partendo dalla descrizione che ne dà Thoreau nel suo Disobbedienza Civile. Per comprenderla non è strettamente necessario chiamarla, in maniera forse romantica, «disobbedienza»: ciò a cui si disobbedisce è solo un insieme di regole e concetti dominanti. Il concetto di disobbedienza accetta l’esistenza di un sistema ideologico a cui obbedire. Si disobbedisce a qualcosa che viene riconosciuto come autorità. Quello su cui crediamo ci sia il bisogno di lavorare è la possibile affermazione di molteplici visioni del mondo tra loro conviventi, che si compenetrano e rispettano reciprocamente. Non c’è nulla a cui disobbedire: semmai, bisogna affermare il diritto di vivere la vita nel modo in cui si preferisce, nel rispetto del mondo e di tutti gli esseri viventi. In passato siamo stati accusati di sentirci portatori quasi di un ruolo «evangelico»: ma cosa c’è di male nell’immaginare e richiedere un mondo più egualitario, e – visto che siamo architetti – nel farlo partendo dalla definizione degli spazi e dal ruolo della propria professione? Tornando alla possibilità di costruire non sistemi egemonici, ma molteplici mondi e cosmologie, crediamo che alcune politiche dell’estraneazione spaziale – come il concetto di periferia di matrice borghese – presentino possibilità per la costruzione di nuove collettività non gerarchiche. Ciò avviene perché, paradossalmente, l’allontanamento di determinate classi sociali «scomode» di cui abbiamo parlato prima permette una loro emancipazione, grazie anche alle recenti possibilità tecnologiche e di interconnesione. Quindi questa «disobbedienza» sta nella possibilità di formulare nuove socialità, di creare e organizzare la vita collettiva. Assistiamo da sempre a questi tentativi: il problema come dicevamo è come mantenerli puri, non farli ingoiare e digerire dalla cultura dominante. Il caso dei Provos ad Amsterdam, che nel momento in cui si sono sentiti minacciati dalla cultura mainstream hanno deciso simbolicamente di suicidarsi e dare fine al loro esperimento, la dice lunga sulla necessità di elaborare strategie sociali e spaziali di sopravvivenza alternative. Crediamo inoltre che la creazione di un proprio habitat, con le sue caratteristiche e i suoi simboli, sia proprio un passaggio fondamentale per l’affermazione di queste nuove socialità.

The Tramezzino Stack
Un altro riferimento da voi più volte citato, è il modello di «Stack» formulato da Benjamin Bratton: sostanzialmente, un’immensa piattaforma che si concretizza in un modello computazionale planetario, che a sua volta vede l’insieme degli apparati informatici come una nuova architettura governativa…
The Stack di Bratton ė un testo importante, ma manca a parer nostro di un grado critico che crediamo sia fondamentale. In un progetto esplicitamente ironico come The Tramezzino Stack (o anche nella lecture Urban Communalities. Subcultures, Blockchain and the myth of the algorithm tenuta allo Z33 di Hasselt), abbiamo quindi provato a osservare queste criticità. Ad esempio, se i sistemi di Planetary Scale Computation possono aprire nuove possibilità verso la decentralizzazione nella gestione dell’intera società, ci si sta però davvero interrogando su chi detiene il controllo di questi sistemi? Oppure, questi cambi nell’ordine geopolitico mondiale, causati dalla nuova struttura dello Stack, ci porteranno davvero verso un sistema più aperto, orizzontale e a una decentralizzazione dei sistemi di potere? Queste domande rimangono aperte. Ma la cosa che più ci ha colpito nel testo di Bratton è proprio il concetto di piattaforma, che non a caso rimanda a quello che è stato definito Platform Capitalism o «capitalismo delle piattaforme». La piattaforma sembra oggi sostituire l’istituzione, pubblica o privata che sia, nelle gerarchie e nei gradi di supremazia. Questo ci rivela la possibilità di costruire infinite piattaforme nella crisi istituzionale contemporanea, e di conseguenza di poter trasformare i deserti e le sue tribù in realtà vere e proprie, parti del dibattito contemporaneo. Allo stesso tempo però, oggi vediamo all’opera piattaforme che funzionano nel modo opposto: una grande polarizzazione del potere che ricorda più un feudalesimo medievale o le dittature basate sul culto della personalità. Basti pensare alla dichiarazione del neo-monarchista Curtis Yarvin aka Mencius Moldburg (uno dei guru dell’alt-right) che afferma di sognare Elon Musk come un «CEO-King» dei futuri Stati Uniti.
Sempre sul tema del deserto, avete collaborato recentemente con la Libreria 121+ di Milano; qui il vostro intervento è stato duplice: avete legato un’installazione modificabile fatta di spugne (che ricreava nel mezzo di un deserto la storica Ville Savoye di Le Corbusier) a una serie di testi scelti per l’occasione. Quali sono tre libri fondamentali secondo voi? E perché?
I testi scelti sono sessanta, e tra questi è difficile trovarne tre. Però ci proviamo. La Bibbia lo è sicuramente. Diciamo che è una sorta di origine dell’interpretazione del deserto come luogo emancipatorio, di rinascita. La teologia biblica del deserto ci racconta appunto della nascita di una cosmologia durante un viaggio lungo quarant’anni in uno dei luoghi in assoluto tra i più ostili per la vita umana.
Un altro testo fondamentale è Utopie Pirata di Hakim Bey, che per l’occasione però si firma col suo vero nome, ovvero Peter Lamborn Wilson. Nel libro l’autore presenta diverse storie di corsari Mori e rinnegati europei: ci racconta di eretici, disertori, omossesuali, esiliati politici, spie ed eroi che diedero vita alla forma di politica più evoluta tra le comunità di pirati tra il XVI e il XIX secolo, la Repubblica di Salè. Il terzo libro potrebbe essere uno tra gli innumerevoli manuali prodotti tra gli anni Sessanta e Settanta in Europa e Stati Uniti, tra cui ad esempio Autoprogettazione? di Enzo Mari. All’interno di questi tipi di testo si parla degli strumenti – i cosiddetti tools – che possono essere utilizzati per la formazione di realtà altre, di nuove cosmologie.

Libreria 121+, Milano
A proposito: in un testo come Primitive Future Office vi soffermate su manuali come Cool Tools: A Catalog of Possibilities di Kevin Kelly e Whole Earth Catalog di Stewart Brand, notandone l’importanza in quanto cataloghi che effettivamente possono attivare la creatività del lettore presentando attrezzi per la progettazione e strumenti utili, a basso costo, e che abbracciano diversi campi di applicazione. Avete in mente di produrre anche un manuale tutto vostro?
No, sinceramente. Crediamo che oggi non sia necessario. Qualche anno fa abbiamo realizzato un giunto per strutture leggere stampabile in 3D e scaricabile gratuitamente. Poi ci siamo accorti che il web era pieno di 3D gratuiti simili, e che differivano solo nella forma o nella costruzione concettuale alle spalle. I manuali sono ovunque. Su YouTube è possibile trovare qualsiasi tutorial, da come realizzare uno stupido prank al costruire una bomba. É un mondo completamente diverso rispetto al 1971 in cui William Powell scrive il famoso The Anarchist Cookbook e scatena un pandemonio. Nell’era della pistola 3D di Cody Wilson ci sembra un’operazione ridicola. Ci sono però dei passaggi che riportano al concetto dei «liberi strumenti», peraltro già trattato da Ivan Illich in Tools for Conviviality. Torniamo per esempio a un manuale come Cool Tools. Cosa differenzia Cool Tools dal tempio del consumo di Amazon, visto che anche in un testo come Cool Tools ogni strumento proposto viene accostato proprio a un link di Amazon? Il problema della cosiddetta «progettazione aperta» o Open Design sta appunto in quelle contraddizioni che portano da manuali come lo stesso Autoprogettazione? di Mari alla sua sedia venduta da Artek a centinaia di euro. Queste operazioni sono insomma state assorbite e minimizzate come estetiche alla moda, non sono rimaste azioni emancipatorie per le fasce marginali della società. Possiamo fare un esempio evidente e facile: l’estetica del do-it-yourself che diventa la quintessenza dei bar yuppie-hipster con i pallet e le cassette della frutta.
In Primitive Future Office mettete anche in discussione la tesi di Carlo Ratti sulla cosiddetta «architettura open source» e la sua idea di «progettazione aperta»…
Per mettere in discussione la tesi di Ratti, non è necessario leggere il suo libro: basta osservare le sue azioni. Si può prendere l’esempio del suo nuovo progetto per l’ex area Expo. Basta vedere i render per capire che quel masterplan e le sue architetture potrebbero essere state pensate da qualsiasi architetto contemporaneo più o meno noto legato al mercato del real estate. L’idea della smart city, dell’incontro tra fisicità della città e una sua possibile ubiquità, mescolata all’ormai esasperante connubio sostenibilità/green washing, lì non è altro che un marchio accattivante per il real estate di lusso. Quella che lui immagina non è la città open source, ma l’emblema di un approccio top-down.
L’open source architecture fa parte di un movimento più ampio, quello dell’Open Design, che mira allo sviluppo di progetti secondo una logica partecipativa e pubblicamente condivisa… Mi pare di capire che però per voi quella dell’open design non è altro che pseudo-partecipazione, e che non sia in questi movimenti che covino le spie del «design del futuro»…
Le spie del design del futuro sono l’opposto dell’Open Design. Basti pensare ad esempio agli algoritmi. Sono blindati. Non siamo noi a dare forma alla nostra bolla di filtraggio, non ne scriviamo noi i codici, le intenzioni, le regole. Se vogliamo parlare di pseudo-partecipazione, il caso più eclatante è la stessa Internet di Facebook o Google. La vecchia idea dei sistemi aperti, dell’emancipazione dell’utente, delle libere piattaforme, oggi è solo una nuova egemonia: il mondo dei Big Five assomiglia molto a un nuovo medioevo con pochi re, piuttosto che a un mondo dove il potere è decentralizzato. Come poi una pratica come la nostra possa evitare questa pseudo-partecipazione, è un altro discorso. Prima di tutto va specificato che la nostra pratica non si concentra sull’elaborare manufatti che entrino direttamente in un grado di influenza con la vita quotidiana. La nostra pratica lavora all’interno della pratica stessa, sollevando dubbi e scavando sempre di più all’interno delle contraddizioni che la contraddistinguono, verso una sua eterna e continua messa in discussione, per uno stato di crisi perpetuo.

Terraforma Playground
Ultima domanda. Quali sono i vostri progetti e le vostre prospettive per il futuro?
Come detto prima, il cuore del nostro modo di operare è un continuo ripensamento di dogmi e certezze. In questo momento il ripensamento si concentra sui sistemi di regole e norme ereditate dalla modernità e che hanno definitivamente condizionato la formazione dell’habitat, legandola definitivamente alla figura dell’uomo maschio bianco occidentale. L’esempio lampante è il mitico Modulor di Le Corbusier. Stiamo applicando questi concetti anche a numerosi progetti di allestimento per mostre o eventi culturali, che progressivamente stanno diventando uno dei campi su cui siamo più concentrati. Siamo anche molto interessati alla realizzazione di oggetti e arredi che in un certo senso nascono proprio da queste riflessioni più teoriche. Da un lato riflettiamo su come sovvertire la norma elaborando dei sistemi aperti, in cui la possibilità di comporre autonomamente il proprio habitat è già una forte negazione dello standard top-down. Anche nell’attività d’insegnamento stiamo proprio esplorando questi temi e il rapporto con gli studenti ci sta aiutando molto. Questo processo passa però non solo attraverso un ripensamento dei canoni estetici, ma anche di concetti come la proporzione, la simmetria… Siamo molto colpiti ad esempio da ciò che sta accadendo nel mondo della moda con il fenomeno chiamato Ugly Fashion. Se si va oltre l’hype, in alcune operazioni possiamo leggere, ribaltare e negare una serie di questioni di distinzione tra i generi, estetica, valore materiale, arrivando anche a mettere in crisi la centralità dell’uomo all’interno dell’intero ecosistema. Crediamo che rivedere l’antropocentrismo che ha caratterizzato la storia dell’uomo sia il primo passo verso un radicale ripensamento dell’azione dell’uomo stesso, per la formulazione di nuove forme di vivere la vita collettiva.