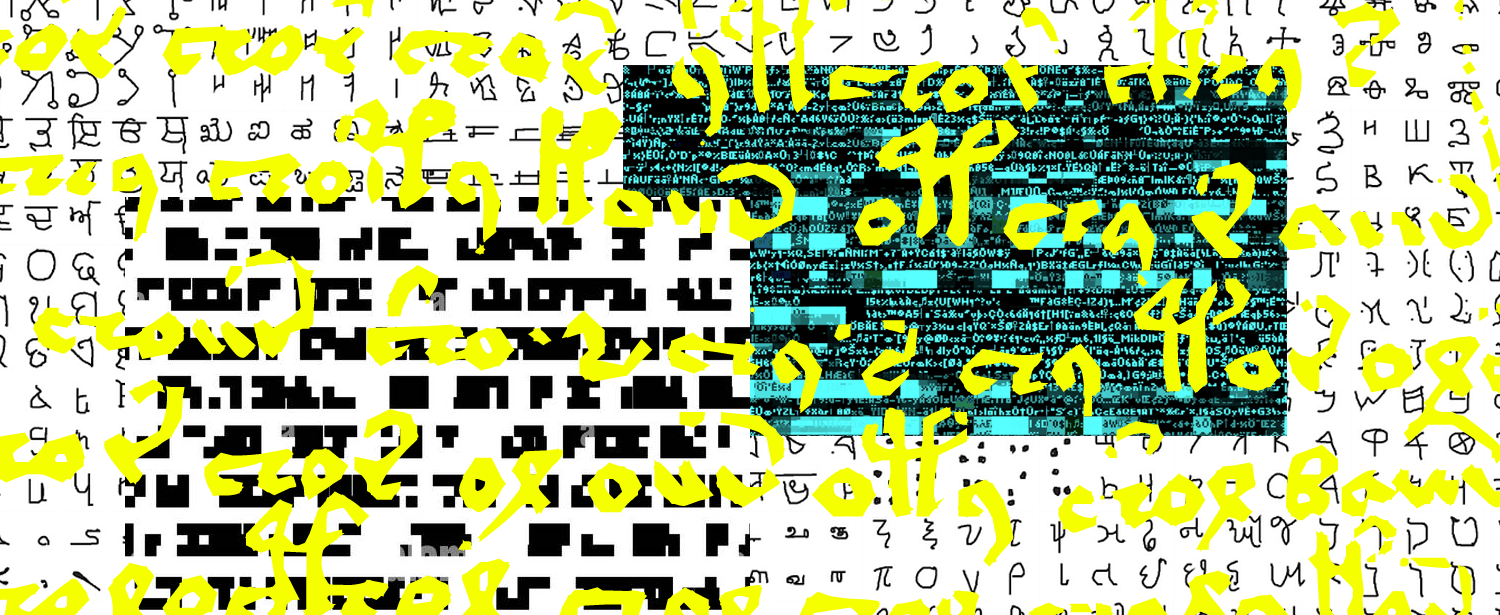La lingua italiana ha un pessimo rapporto con se stessa: dal De vulgari eloquentia al Cinquecento, passando dal caso del Vocabolario Cateriniano, opera che voleva decretare con derisione la superiorità del senese sul fiorentino e che, ancora incompleta, fu data pubblicamente alle ceneri nel 1717 (si era arrivati solo alla lettera R), per non parlare del conflittuale rapporto con i dialetti, che secondo Pasolini, nel 1975, erano “l’ultima possibilità di difesa dall’omologazione linguistica”. Che sia nel dibattito privato o pubblico, colto o popolare, la lingua italiana non ha mai trovato pace. Questo idioma si è sviluppato come strumento appannaggio di una comunità di dotti e letterati. Antonio Gramsci, in Quaderni dal Carcere, ha riconosciuto la lingua come enorme dispositivo di potere. Gramsci ha insistito a lungo sul carattere elitario della lingua, modellata dalla formazione della classe dirigente e la riorganizzazione dell’egemonia culturale, che impedivano agli “strati sociali” meno privilegiati l’accesso alla lingua italiana al fine di trattenerli in una condizione subalterna.
La macchia fascista
Quando si parla di lingua e potere, è difficile non ricondurre la memoria a eventi infausti, violenti e repressivi vecchi poco più di cent’anni, rispolverati di recente dai bizzarri deliri di onnipotenza della destra, con ispirazioni sanzionatorie esibite in proposte di legge dal pomposo nome di “Disposizioni per la tutela e la promozione della lingua italiana e istituzione di un Comitato per la tutela, la promozione e la valorizzazione della lingua italiana”. La proposta regola, tra le altre cose, l’obbligo di utilizzo dell’italiano per la fruizione di beni e servizi pubblici e vieta le denominazione straniere, al fine di una “salvaguardia nazionale e di difesa identitaria”. A tal proposito è seguita un’interessante risposta dell’Accademia della Crusca.
Poco più di un secolo fa, il 20 Marzo 1923, la Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia pubblicava sul n. 66 il decreto n. 352, articolo 4, che prevedeva un’imposta quadrupla sull’esibizione pubblica di forestierismi nelle insegne commerciali. I forestierismi erano i nemici pubblici del regime, i termini in lingua inglese responsabili della corruzione del processo di Italianizzazione, vale a dire la politica linguistica del fascismo, caratterizzata da una connotazione ideologica di purismo lessicale. Inizialmente l’obiettivo era la rimozione del bilinguismo italiano e sloveno nelle scuole: attraverso provvedimenti di legge, l’italianizzazione avrebbe modificato in italiano la toponomastica e i cognomi di persone di origine slovena e croata. L’insieme degli atti normativi che si impegnava a sbarazzarsi violentemente delle minoranze linguistiche si chiamava “Riforma Gentile”, «la più fascista» delle riforme, come la definì Mussolini stesso.
L’onta e la macchia fascista dell’italiano forzato non sono rimaste confinate nel paese nativo ma si sono trasposte, ovviamente, come lingua coloniale. Tuttavia, i progetti coloniali iniziarono già dal 1869, durante il primo approdo del Regno d’Italia in Eritrea con l’accordo dell’acquisto della baia di Assab, il cavallo di Troia che permise (sottocopertura) al Regno di fondare la prima colonia italiana in Africa, dove si parla ancora italiano in alcune scuole.

Processo di decolonizzazione, lotte sociali contemporanee e anglicismi
È proprio dalla lotta al colonialismo che la presa di coscienza dei movimenti sociali globali ha estratto la sua forza per mettere in crisi l’Eurocentrismo, la cui coscienza sporca di violenze del passato è rimasta indisturbata per secoli. Le piattaforme online hanno chiaramente concorso in alta percentuale a diffondere con maggiore rapidità il messaggio di esortazione alla mobilitazione, instillando un senso comune e coeso di sentimento di lotta locale e globale. Nel corso degli anni recenti, abbiamo assistito nel 2016 alle imponenti proteste a Standing Rock contro la costruzione del Dakota Access Pipeline, un oleodotto statunitense imposto sul territorio Sioux, e questo, indipendentemente dagli sviluppi successivi, è divenuto un momento trasformativo per i diritti delle persone indigene.
I movimenti di decolonizzazione contemporanei, diversi dal processo politico attraverso il quale le colonie ottennero l’indipendenza nella seconda metà del XX secolo, hanno raggiunto visibilità a livello transcontinentale, in particolare in Sudafrica nel 2015 con il movimento #RhodesMustFall. Il movimento prende il nome da Cecil Rhodes, autore della frase «Il colonialismo è filantropia più il 5 percento». Questo movimento ha superato la mera simbolicità, sostenendo una trasformazione sociale ed economica nel contesto post-apartheid sudafricano. ll movimento Black Lives Matter, già attivo nei primi anni 10, ha ottenuto un riconoscimento planetario nel 2020, e, sotto la sua influenza, i movimenti di decolonizzazione si sono estesi alle ex capitali imperiali europee, come dimostrato dall’abbattimento delle statue emblema del suprematismo bianco e degli imperi che non accettano la loro morte. Nel 2021, un processo significativo si attiva nell’università di Aberdeen e nei musei Europei, con la richiesta di restituire le opere d’arte saccheggiate durante periodi coloniali in Africa ai paesi legittimi proprietari, a guisa di riparazione.
Decolonizzare tutto, si, ma forse abbiamo lasciato indietro qualcosa: la presa in carico del linguaggio. Possiamo considerare una lingua dominante come forma di colonizzazione contemporanea?
Oggi, questi movimenti si estendono a diverse forme di pedagogia, arte e attivismo, concrete e creative, con ampio uso della parola d’ordine decolonize. Decolonizzare tutto, sì, ma forse abbiamo lasciato indietro qualcosa: la presa in carico del linguaggio. Queste grandi manifestazioni di resistenza e lotta, particolarmente legate a parole chiave, hanno preso piede anche in contesti culturali geograficamente distanti, non solo perché questi contesti sono tutti macchiati dal crimine coloniale da cui hanno tratto profitto con medesima brutalità. I movimenti di decolonizzazione si fanno portatori e diffusori, come prima o seconda lingua, dell’Inglese. Possiamo considerare una lingua dominante come forma di colonizzazione contemporanea? Riguardo al processo di decolonizzazione, tuttora in atto e piena potenza, mi domando se tale evoluzione, tralasciando l’influenza che possiedono le parole sull’autorappresentazione, non si dimostri, in realtà, un processo incompleto. Cosa intendiamo esattamente quando pronunciamo il verbo decolonizzare?
Qualche tempo addietro trovai una lieta corrispondenza nella lettura di un capitolo scritto dalla studiosa anglofona Mckenzie Wark che parla di “devozione verso le parole”. Nello specifico, l’autrice si riferisce alla parola capitalismo, constatando come l’uso spasmodico del termine porti all’inflazione del discorso e a una perdita dell’impegno intellettuale verso il capitalismo stesso. Wark si chiede se aggrapparsi con insistenza alla medesima parola per riferirsi a una condizione complessa (a cui non viene in soccorso nemmeno un sinonimo) non significhi forse che la parola sia diventata un po’ troppo comoda. Questa comodità, che non si limita solo al linguaggio, ha la tendenza a generare automatismi che limitano la nostra facoltà immaginativa e il pieno sfruttamento del potenziale di un concetto. Penso che questa dipendenza dalle parole (l’inerte e, al contempo, compulsiva reiterazione di parole che diventano come dei gusci vuoti) porti alla creazione di una velata subalternità intellettuale, specialmente quando certi termini provengono da contesti anglofoni.
Claudio Marazzini, ex presidente dell’Accademia della Crusca, nel testo La lingua italiana e le lingue romanze di fronte agli anglicismi, afferma che cambiando le parole a volte si ha l’illusione di cambiare le cose. Pensiamo ai termini woke e cringe e all’uso che se ne fa (o se ne è fatto) in diversi ambiti sociali italofoni, da quello di Internet a quello delle lotte sociali, dalle nicchie alle masse. Che impatto esercita l’utilizzo di woke – che si sviluppa in un contesto storico e geografico peculiare e si riferisce a problematiche endemiche del luogo di nascita della parola – in un paese come l’Italia, in cui questa parola è regolarmente utilizzata nel dibattito pubblico? Come viene interpretata e adattata nella cultura di massa dato che il contesto sociale in cui la parola è stata trapiantata è diverso?
Spesso mi è capitato di pensare come l’uso di termini in alcuni casi intraducibili abbia saturato il lessico italiano, offuscando la produzione di un immaginario indipendente. Questo atteggiamento, a mio avviso, suggerisce erroneamente che solo l’ambiente intellettuale accademico e l’idioma online – entrambi a potente trazione anglofona – possano validare appieno la funzionalità e l’efficacia di un termine e di un pensiero, quand’anche questo atterri in un contesto socialmente e storicamente diverso. Ad esempio, budget è giunto in soccorso a chi, per una sorta di pudore nei confronti delle parole “soldi”, “compenso”, “fondi”, “bilancio”, ha sentito il bisogno di ricorrere a un termine più elegante e sicuramente meno diretto. Questi li chiamo “atti di cosmesi semantica”, di cui la lingua italiana, mi sembra, è un’insigne capofila. Quello che la lingua italiana è spesso riluttante a fare è parlare chiaro: a mio avviso, c’è chi trae vantaggio dalla non-definizione, specie in alcuni discorsi, per omertà o impreparazione.
Onomaturgia
Quando nel 1975 uscì Parole d’autore – Onomaturgia di Bruno Migliorini, Presidente dell’Accademia della Crusca per quasi 15 anni, i più consideravano il suo sforzo come un testo minore, quasi dal carattere accessorio rispetto al suo imponente testo Storia della lingua italiana. L’onomaturgia è la pratica o l’arte di coniare nuovi termini; i suoi frutti sono i neologismi che, al loro debutto, spesso suscitano ilarità e quel sorriso incuriosito che fa trapelare uno scoraggiante senso di tenerezza verso un’attività ritenuta dilettantistica, amatoriale. L’onomaturgia appare dunque come un vezzo decorativo, superfluo e al massimo flaneuristico; io, invece, ritengo non ci sia materia più seria di questa.
È attraverso la parola e il linguaggio verbale che deleghiamo la rappresentazione di noi stess3, dell’ambiente, di manifestazioni, di congetture, di astrazioni più grandi di noi, giacché la parola è una facoltà che permea l’immaginazione e l’identità che regola le relazioni con il mondo. L’onomaturgia, in questo senso, è uno strumento essenziale per affrontare con irriverenza le evoluzioni della percezione e della realtà verso quel colossale, mastodontico, prodigio tecnologico che è il dispositivo del linguaggio verbale. I neologismi sono sono utili quanto più tendono a rappresentare e descrivere una condizione, un’esperienza, individuale o sociale, a cui si desidera rendere partecipe il mondo perché questa parola possa aggiungere qualità e accuratezza al modo in cui interpretiamo, traduciamo e osserviamo la realtà. Nella sperimentazione onomaturgica è importante che le parole sappiano cogliere il momento cairologico di descrizione della realtà, ed è opportuno quindi che sappiano riflettere uno spirito del tempo, quello che originariamente in tedesco viene chiamato zeitgeist.
Spesso mi domando se l’inglese non si incarichi di evocare un atteggiamento più che prestare soccorso e porre riparo laddove si presentino lacune della lingua italiana. E, anche se fosse così, chi gli sta chiedendo questo favore? Non trovo preoccupante mainstream, shadowban e CEO, parole che si limitano, sotto il potere di sintesi dell’inglese, a camuffare un concetto semplice, perfettamente sostenibile, compatibile e comunicabile anche attraverso gli strumenti che la lingua italiana già fornisce – e a cui abbiamo piena libertà di accesso. Mi preoccupano invece l’esercizio e il potere di delega di termini complessi che, seppur tradotti, inizialmente disorientano e nel tempo si usurano, perdono significato, senza che alcun3 di noi gli presti più manutenzione.
Ciò che né il fascismo del ventennio né quello attuale hanno compreso è che gli anglicismi non sono una minaccia; lo è il mancato rinnovamento del linguaggio e l’incapacità di abbracciare altre lingue, considerate come una minoranza
L’uso insistente della lingua inglese non si manifesta solo in ingerenze esigue come summer school e scrolling, ma serve anche per descrivere enormi processi sociali ed esistenziali, come ad esempio si assumono la responsabilità di fare le parole tokenism, poc, bipoc, white-passing, cat-calling e gatekeeping. Questi termini sono diffusi soprattutto dal potere estensivo e globale delle piattaforme social e sono promossi dall’autonarrazione di membri delle diverse comunità. Mi rendo conto di come l’inglese — quale ambasciatore linguistico di un sistema di saturazione onnicomprensivo, imperante e imposto — abbia il potere di aumentare la nostra capacità di riconoscimento di una condizione specifica, arrogandosi anche la pretesa di svolgere una funzione di vigilanza semantica prendendo, oltretutto, molto controllo e spazio nel farlo.
L’Italia, in quanto paese europeo, è influenzata da molte lotte di rivendicazione sul calco di modelli statunitensi, poiché il contesto culturale degli Stati Uniti è spesso capace di prevedere molti scenari che faranno successivamente ingresso altrove. È il termine anglofono a creare una consapevolezza “a posteriori” nel contesto che lo ospita? È possibile che la parola sia in grado anche di creare nuovi bisogni o di influenzare abitudini, come se il suo scopo fosse quello di magnificare lo sguardo attraverso la sua lente semantica? Ne consegue, forse, che non siamo in grado di realizzare con i nostri occhi e con il nostro linguaggio la realtà che viviamo senza l’ausilio della lente statunitense? Oppure si tratta di un sintomo culturale che prima nasce e solo successivamente influenza il lessico?
Il piano Marshall nel suo passaggio in Europa e in Italia non ha scaricato solo basi NATO, ma un intero assetto culturale; ha portato un’esplosione di influenza statunitense al limite del mito che, ancora oggi in modo improprio, definiamo con enfasi e ammirazione “l’America”. La peggiore delle sineddochi. In particolare, nell’ambito italiano, questo processo è stato accelerato negli anni Ottanta e Novanta dal medium televisivo privato, che ha lasciato un’impronta così profonda da plasmare la percezione degli Stati Uniti come un modello di riferimento, di cui ancora fingiamo di non essere succubi. Com’è possibile, quindi, che tale imponente processo non abbia lasciato tracce, specie nel linguaggio?
Ad esempio, ci saremmo mai potuti accorgere che determinati gruppi compiono uno sforzo insincero e simbolico per dimostrarsi inclusivi nei confronti dei membri di altri gruppi considerati minoritari, se nel contesto sociale e linguistico italiano non fosse arrivata la parola tokenism per rilevare un subdolo atteggiamento che dilaga negli ambienti lavorativi e della produzione culturale? Come definiremmo, in lingua italiana, la derisoria pratica del body-shaming? La percezione di questo fenomeno è nata prima, o dopo, che l’inglese ci ha consegnato la parola che ci ha permesso di riconoscerne l’importanza politica? Forse, lo smarrimento dell’abitudine di narrare la contemporaneità in italiano suggerisce una possibile carenza di connessione con la lingua. Lasciare che una, unica, lingua dominante parli per noi, a mio avviso, è un atto di ventriloquismo. Si tratta di una rinuncia alla traduzione in favore di un graduale o totale vassallaggio concettuale verso un’altra lingua. Forse, l’anglicismo ci fa sentire parte di una famiglia più grande all’interno di un processo globale, e forse ci fa sentire meno “indietro” rispetto a un contesto culturale che ci appare più affermato e veloce.
Qualora davvero si trattasse di una tendenza globale, allora perché assegnare tanto della rappresentazione di noi stess3 e di processi sociali complessi a una lingua sola? La questione centrale, a mio avviso, risiede nello svilimento del plurilinguismo, ossia nella svalutazione di partenza nei confronti di lingue o vocaboli che non appartengono a modelli di successo o a che appartengono a contesti troppo specifici. Ad esempio, qualcuno potrebbe ritenere una forzatura introdurre in Italia nei discorsi di decolonizzazione la parola Sumud (صمود, traducibile in “risoluta e ferma perseveranza”, parola araba che coincide a un alto valore culturale nella società Palestinese in resistenza all’occupazione sionista). Forse è una parola ancora relegata a un contesto politico non eurocentrico, poco applicabile ad altri contesti culturali? Ma le rivolte nei paesi del Nord Africa e Mashreq iniziate nel 2011, conosciute in Europa come “primavere arabe” (la denominazione è, appunto, frutto dell’inventiva sensazionalistica di un giornalista britannico), cosa avevano di tanto lontano o poco comprensibile? L’estinzione della corruzione, il rispetto dei diritti umani e il ripristino delle libertà individuali? È noto come questi movimenti si siano propagati non tanto per effetto della loro organizzazione interna, quanto tramite la copertura mediatica in Europa, grazie a Twitter. Non ci si può appellare, quindi, alla scarsa ricezione.
Anche il termine bipoc, acronimo di “Black, Indigenous and People Of Color” che proviene nuovamente dal contesto socio-culturale statunitense, viene utilizzato da molti italofoni in cerca sinonimi più godibili e meno usurati di “persona di origine straniera”, “seconda generazione”, “persona razzializzata”. Per inciso, nel 2020 il termine bipoc era finito sotto il microscopio dei media per l’uso che se ne faceva nei contesti accademici e popolari: il suo significato, percepito come ambiguo, creava controversie. Negli anni Dieci, la parola veniva usata per dimostrare inclusività nei confronti di persone indigene e di colore negli Stati Uniti e in Canada e per dare visibilità alle istanze politiche che portavano avanti. Eppure, come sostiene la storica dell’arte canadese Charmaine Nelson in un articolo del New York Times, “sotto il colonialismo le popolazioni Africane e Indigene hanno avuto esperienze molto diverse”. E aggiunge, “confondere tutto in una sola cosa significa cancellare, che è la natura stessa della pratica del genocidio”. Nelson sostiene inoltre che il termine contiene una fallacia storica, poiché tutte le persone di colore (“people of color”) sono indigene e la loro disconnessione nasce da una violenta tecnica di rimozione della loro storia e da un annichilimento della loro identità individuale e comunitaria.
È necessario conoscere il contesto di origine di una parola per non trovarsi, durante il trapianto in un altro ambiente culturale, a dover gestire un potenziale tilt comunicativo e concettuale. Dunque come mai, nonostante imponenti fenomeni migratori globali, le lingue che vengono accompagnate dai processi diasporici in Italia non hanno avuto la stessa influenza dell’inglese? Lingue come arabo, wolof, bengali, spagnolo, farsi, albanese sono parlate da milioni di persone madrelingua, bilingue, plurilingue nate o cresciute in Italia, eppure l’attenzione verso di esse non è di pari rilevanza. Gli arabismi nella lingua Italiana sono copiosi, ma l’ibridazione tra le due lingue risale solo al VII secolo, durante l’epoca medievale di espansione Islamica. Questi arabismi sono dei prestiti o calchi, ossia nuovi termini che nascono da un procedimento che recupera le strutture della lingua di provenienza. Scarsi, se non nulli, sono gli esempi in cui altre lingue non dominanti in Europa sono riuscite a emergere con la stessa veemenza dell’Inglese, idioma commerciale per eccellenza, che ha assorbito ogni ambito dello scibile umano: informatico, digitale, finanziario, accademico, giornalistico, perfino giuridico e, non ultimo, relazionale.
Quante e quali sono le parole che definiscono la nostra esperienza di figli3 di migrazioni e diaspore?
Come ci poniamo quando una lingua non nativa si instaura all’interno di processi delicati come la descrizione della nostra interiorità più profonda? Innumerevoli sono anche gli esempi di casi in cui la neologia ha fallito sul lungo termine, come processo di intervento emergenziale o tappabuchi. Dinanzi a un nuovo fenomeno sociale di grandi proporzioni, i media si trovano spesso sprovvisti di termini adeguati per definirlo. Uno dei neologismi più rappresentativi, a mio avviso, è “seconde generazioni” (nuovamente, un termine preso in prestito dal contesto anglofono e poi mai rielaborato). Il termine indica in modo sempre meno soddisfacente tutte quelle persone che si riconoscono all’interno di un processo sociale e giuridico “recente e nuovo di 40 anni”. “Seconde generazioni” ha contenuto negli anni un complesso amalgama di pensieri, sentimenti, ambizioni, persino istanze, tra cui spicca la fervente richiesta di riformare la legge sulla cittadinanza, in particolare la legge 91 del 1992, affinché possa finalmente evolversi verso il principio dello ius soli.
Ciò nonostante, la parola “seconde generazioni” è stata per molte persone uno strumento utile per descrivere la propria storia e ritrovarne altre simili. Al contempo, è stato uno strumento al servizio di chi ha scritto le storie degli altri, da articoli divulgativi di testate giornalistiche affermate a tesi di dottorato di sociologia che hanno studiato da vicino come fossero fatte queste seconde generazioni. Quella parola serviva come termine tampone per contenere un processo in continua espansione; ora è utilizzata dai più mal volentieri, poiché pochi di noi vi si riconoscono e ancor meno sentono di averla scelta. Fatico io stessa a designare con precisione la datazione del trapianto di questa parola; non abbiamo una genealogia che ci permetta di conoscerne e tracciarne l’origine e, soprattutto, di risalire al motivo (politico, emotivo, percettivo della realtà) che ci ha portati a utilizzarla. Eppure, quella parola ha scavato profondamente in noi, ha creato limiti e potenzialità, ha detto chi potevamo essere e cosa non potevamo fare. Ha quindi perso quello zeitgeist.
L’ideologia megalomane della destra italiana contemporanea esalta in modo acefalo un senso di identità nazionale attraverso la lingua per accomodarsi nella diretta discendenza con l’epoca fascista. La destra sa che controllare la lingua significa sfruttare il primo dispositivo di potere, e vede nella repressione e nella normatività coatta un riscatto da un inconfessato senso di inferiorità che spera di risolvere con la deontologia, proibendo una lingua in favore esclusivo di un’altra, a patto che sia l’unica. In sostanza, bisogna guardare alla sproporzione del predominio di una lingua come diretta conseguenza della disuguaglianza sul pianeta.
Ciò che né il fascismo del ventennio né quello attuale hanno compreso è che gli anglicismi non sono una minaccia; lo è il mancato rinnovamento del linguaggio e l’incapacità di abbracciare altre lingue, considerate come una minoranza. Si tratta quindi di favorire un reale multilinguismo che attinga non da una o da due, ma da tutte le lingue che attivamente modellano il discorso politico di autorappresentazione nella cornice delle lotte sociali contemporanee. Come diceva Edouard Glissant, poeta e scrittore Martinicano, “Parlo e soprattutto scrivo in presenza di tutte le lingue del mondo”. Ma scrivere in presenza di tutte le lingue del mondo non coincide con il conoscere tutte le lingue del mondo. Significa che è giunta la fine del monolinguismo. Si legge in Poetica del Diverso: “Vuol dire che la mia lingua la dirotto e la sovverto non operando attraverso sintesi, ma attraverso aperture linguistiche che mi permettano di pensare i rapporti delle lingue fra loro, oggi, sulla terra – rapporti di dominazione, di connivenza, d’assorbimento, d’oppressione, d’erosione, di tangenza, ecc. – come il prodotto di un immenso dramma, di un’immensa tragedia cui la mia lingua non può sottrarsi”. Ed è allora che torna in soccorso l’onomaturgia.

Nuova Bozza
Nuova Bozza è un progetto laboratoriale ideato da me e facilitato assieme a Khadim Loum, co-ideatore del ciclo di incontri settimanali Nettali Hshouma (unione delle parole in darija e wolof “Raccontare – a bassa voce – la vergogna”) che riunisce a Milano ogni settimana una comunità di persone attorno a tematiche eterogenee di rilevanza sociale osservate attraverso una lente critica, analitica e creativa: il razzismo, il classismo, l’omo-transfobia, l’attivismo radicale, la scena artistica e musicale indipendente, approfondimenti storici. Gli incontri sono occasioni di scambio per affrontare questi temi in modo partecipato e condiviso, stimolando la crescita spontanea di nuove relazioni e facilitando la messa in rete di persone, collettivi e realtà urbane.
È proprio dall’interno di questa comunità che abbiamo attinto per riflettere su alcuni temi che ci toccano in prima persona, indagando l’utilizzo di parole come tokenism, razzializzazione, seconde generazioni, bipoc, integrazione. Quante e quali sono le parole che definiscono la nostra esperienza di figli3 di migrazioni e diaspore? Social media e giornalismo hanno coniato termini che hanno dominato dibattiti pubblici così come posizionamenti personali e sociali, ma abbiamo iniziato a chiederci con quali di essi ci sentivamo veramente a nostro agio per descrivere noi stess3: pochi. Abbiamo pensato quindi di riappropriarci di una tecnologia potente come il linguaggio per poterci restituire una traduzione più precisa dei nostri vissuti, percezioni, richieste, esperienze.

L’onomaturgia è stata il mezzo di trasmissione, uno strumento messo a disposizione di un gruppo di persone per porre le basi di una riflessione condivisa e di una prassi costruttiva sui termini a nostra disposizione per parlare in prima persona singolare e plurale. La nostra aspirazione non è solo coniare un nuovo termine per soddisfare una corrispondenza tra il sé e il mondo, ma vogliamo anche che questo neologismo sia frutto di un processo comunitario condiviso. Il compito di tradurre un piccolo frammento della realtà non viene più affidato solo al singolo individuo, ma a coloro che si sentono coinvolti in un processo interiore simultaneo, in cui si identificano e a cui sentono di appartenere attivamente. Trovandosi spesso a vivere in quella crepa lasciata vuota dal linguaggio, queste persone hanno l’opportunità di riempirla con un atto creativo, collaborativo e partecipato, che inevitabilmente richiede audacia, fatica e immaginazione.
Il risultato del laboratorio Nuova Bozza ha dato vita a una produzione cartacea omonima, realizzata grazie al supporto di Sprint Milano, a testimonianza di un processo sperimentale, ma anche per suffragare una filosofia dello scripta manent attraverso un piccolo prontuario lessicale stampato. La pubblicazione ha il preciso scopo di diffondere le parole, con la speranza che il suo potenziale memetico, di replicabilità, permetta di far attecchire nel lessico contemporaneo le parole coniate durante l’esperienza laboratoriale, dando loro una genealogia, una data e un contesto di provenienza.
Un termine che ha risposto a un’esigenza specifica è stato ad esempio il neologismo collettivo Pluaffinente, nato da un gruppo semi-anonimo. Il termine ha sviluppato più significati, e interviene sulla necessità di trovare un’alternativa attiva alla condizione di subalternità che denota l’aggettivo razzializzato. In una delle accezioni conferite dall3 autor3 si legge: “Pluaffinente è utilizzato per descrivere le persone che appartengono contemporaneamente a diverse culture e aree geografiche, risultando affini a più contesti. Questa parola si compone di plurale e affine”. La parola si riferisce alle persone la cui identità è multiforme e si relaziona in maniera armonica e profonda con più culture. Un altro esempio è stato creato dall’artista Ismael Condoy con il neologismo cobrunitario (nato dalla sincrasi tra lo spagnolo cobrar – riscuotere, incassare – e comunitario/extracomunitario). Cobrunitario è un aggettivo che denota un approccio orientato a promuovere l’unità e migliorare le condizioni sociali delle persone di origine straniera all’interno di un contesto dominante. Essere persone cobrunitarie significa aiutarsi a vicenda a guadagnare spazio e rispetto, come descrive l’autore : “per abbattere le gabbie del pregiudizio nazional-popolare e quel paradigma paternalistico della sinistra borghese che vuole il sud globale ancorato al mito del bon sauvage, come articolo da leggere su Internazionale o soltanto come meta turistica”.

Ci sono poi due sostantivi: radileanza di F.B.B., usato per riferirsi “all’impegno comune di persone razzializzate provenienti da origini diverse che si uniscono verso un futuro migliore. Il termine non vuole porre l’accento sulla diversità culturale, ma sottolineare soprattutto gli aspetti di alleanze e la solidarietà tra tali gruppi per un obiettivo comune di uguaglianza e cambiamento”. E infine abidonia di N.C.R., che indica “la profonda sensazione di allontanamento, estraneità e disconnessione dall’identità culturale o dal senso di appartenenza”. L’abidonia è caratterizzata da una “tristezza interiore dovuta al fatto di non sentirsi rappresentati o compresi da nessuna cultura o gruppo sociale, portando a una sensazione di vuoto e smarrimento nell’esperienza individuale”.
L’attitudine poietica dell’onomarurgia incoraggia ad assumere uno spirito di presenza più vigoroso nei confronti delle parole, distaccandoci da un’aderenza supina alla nostra stessa realtà. Credo fermamente che questa prassi corrisponda a un atto politico, specie quando sono le persone pluaffinenti a diventare dirette autrici di nuove parole. L’atto onomaturgico emerge come una risposta sofisticata al razzismo imperante, alla mediocrità e al mito di una generazione in perenne attesa di approvazione. Nella creazione di nuove parole, non solo sfidiamo l’etichetta di “stranieri” o “ospiti”, ma plasmiamo attivamente un dispositivo esistenziale di cultura. Imprimiamo un’incisione così profonda nel linguaggio da suggerire la possibilità di vedere le nostre sperimentazioni linguistiche affermarsi anche nel tessuto sociale più ostile, così come speriamo un giorno di vedere il loro ingresso anche nel dizionario di lingua italiana.
Ciò significa prendere decisioni per noi stess3, come anche non abbandonare alla destra ogni genere di speculazione, sorveglianza e disciplinazione sulla liceità del linguaggio, lasciando che ciò diventi una triviale esaltazione di amor patrio o di identità a senso unico. Significa prendere spazio, occupare un esteso campo di autorialità che rivendica l’autonomia e l’autodeterminazione di coloro che si desidera sempre tenere al margine in una, forzatamente compressa, versione ridotta di sé.