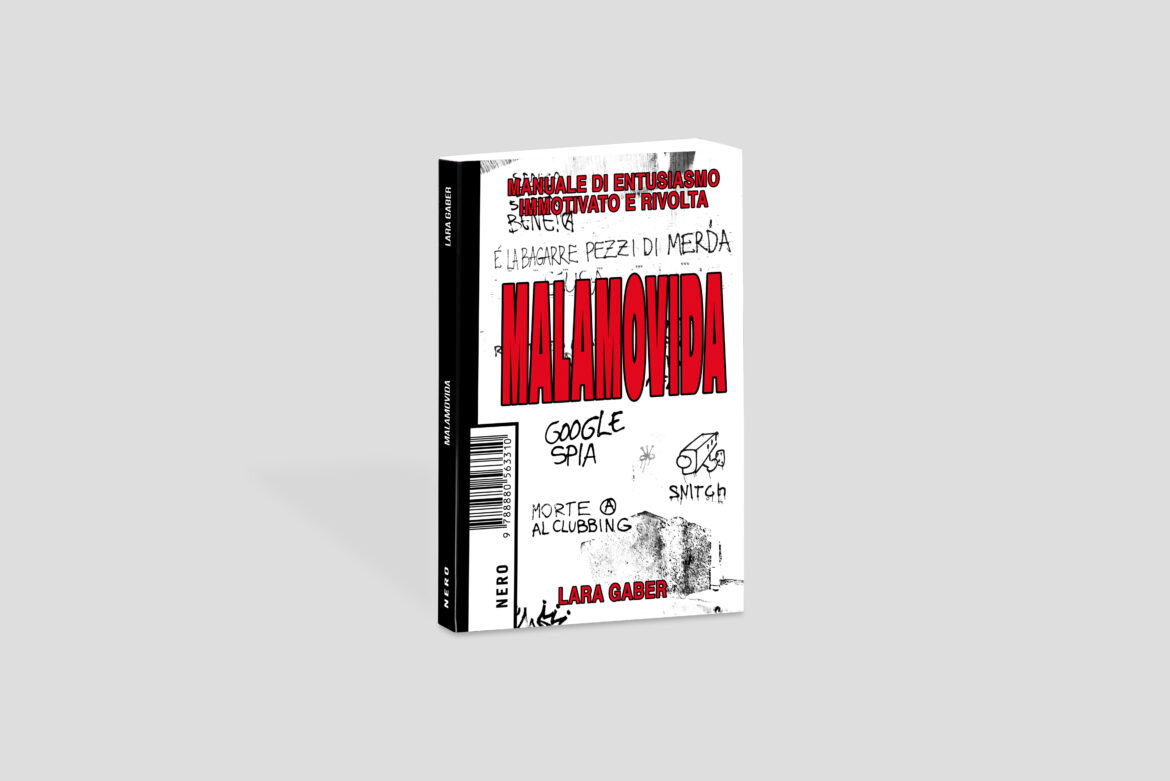Alcune giornate di mobilitazione dei tempi recenti, in diverse città d’Italia, aprono uno spazio di riflessione importante sull’utilizzo del conflitto simulato come pratica di lotta e sul significato della sua continua riproposizione. Per chi ha più memoria, non è niente di nuovo: il conflitto simulato è un logoro prodotto italiano che a più riprese, da quasi trent’anni, torna nelle piazze con grande carica estetica abbagliando le telecamere.
Spesso nel dibattito militante questo tema viene ripreso ma mai rivendicato seriamente da chi lo agisce, nascosto com’è tra confuse giustificazioni e vittimizzazioni o fantasmagoriche narrazioni di esplosive giornate di lotta sulle piattaforme di movimento.
Non serve un naso allenato per sentire, molto spesso, quella puzza, dato che la cagata è stata chiaramente proposta a favore di telecamera, se non apertamente rivendicata e sbrodolata sui giornali da uno dei «capoccia» di turno, con tanto di giustificazioni ai «poliziotti che fanno bene il loro lavoro» contrapposti a quelli che «si fanno prendere la mano» e andrebbero bacchettati (parole tanto infami non meritano di essere nemmeno commentate).
Guardando alle giornate di lotta europee, emerge subito un dato evidente: il conflitto a volte c’è, a volte non c’è, a volte è più intenso e a volte meno, ma di certo gli unici a tenerlo sotto controllo sono gli sbirri
Questo asservimento alla politica del compromesso e dello spettacolo, che vuole piazze disciplinate e orchestrate, non è solo una fastidiosa stortura con cui fare i conti, ma un’abitudine radicata che crea mostri, spezza le gambe e soffoca la rivolta; trascinarsi questo cadavere al seguito è una fatica che, se in tempi storici più lontani si diluiva in un conflitto sociale più alto e un apparato repressivo più debole, a oggi non possiamo più permetterci.
Queste righe non hanno lo scopo di indicare un modo giusto di fare la lotta, né di tracciare una strada da percorrere. Al contrario, sono un invito a valutare seriamente l’abolizione della nostra normalità e la rottura degli argini militanti, per tuffarsi finalmente nell’ignoto, lì dove può nascere l’impensabile.

CONFLITTO SIMULATO, PERCHÉ PROPRIO A NOI?
Guardando alle giornate di lotta europee, emerge subito un dato evidente: il conflitto a volte c’è, a volte non c’è, a volte è più intenso e a volte meno, ma di certo gli unici a tenerlo sotto controllo sono gli sbirri. Non ci sono, né tantomeno potrebbero esserci, avanguardie organizzate che sovrintendono e trattano tempi e modi del conflitto di piazza.
Ma allora perché proprio a noi? Porsi questa domanda è ambizioso e circoscrivere il discorso obbliga a sorvolare ragionamenti importanti, dal modo in cui l’autorità ha gestito l’ordine pubblico dagli anni Settanta a oggi, al protagonismo storico che la sinistra ufficiale ha avuto nella repressione del fermento insurrezionale di quegli anni. Ma soprattutto, per quel che qui ci interessa, la memoria va alla svolta «riformista» incarnata negli anni Novanta dai centri sociali del Nord-Est e dalle cosiddette Tute Bianche, che con i loro scudi di plexiglas battezzarono di fatto la modalità «spettacolare» dello scontro simulato, non a caso descritto ai tempi – dall’ex portavoce dei Verdi Luigi Manconi – come «un esercizio sportivo [che] presuppone un’idea della violenza di piazza come una sorta di flusso prevedibile, indirizzabile, controllabile», con tanto di incontri in prefettura tra militanti e polizia per stabilire luogo e ora della performance.
Intere comunità politiche fondano le loro battaglie sulla convinzione di poter utilizzare lo strumento mediatico a proprio vantaggio, venendo poi tragicamente recuperati e fagocitati dallo spettacolo stesso o quando il nemico contrattacca davvero
L’idea di uno scontro simulato e militarmente tutelato da una manciata di manifestanti organizzati crollerà pietosamente nelle giornate del luglio 2001 a Genova, quando migliaia di ribelli, disinteressati allo scontro diretto con la polizia, scelgono di disertare l’appuntamento mediatico. Sollevando al cielo l’asfalto e ciò che ci sta sopra, rovesciano interi quartieri e bucano il velo della finzione, costringendo la polizia a mostrare il suo vero volto.
Dopo le giornate di Genova, il progetto delle Tute Bianche prima si conclude e poi rinasce in quello della neonata «Disobbedienza», che durerà a sua volta fino al 2004 – oltre vent’anni fa. Eppure, una precisa area politica raccoglie tuttora le pratiche di quel progetto e le porta avanti immutate, rendendole la norma – o peggio: l’abitudine – nelle piazze di tutta Italia. Ecco perché occorre tornare così indietro nel tempo per rintracciare la genesi di una contrapposizione che, avvicinandoci più a noi nel tempo, continua a riprodursi quasi sempre in miniatura: quella tra «spettacolarizzazione del rifiuto» e «rifiuto della spettacolarizzazione».

LA SPETTACOLARIZZAZIONE DEL RIFIUTO
Il copione è più o meno sempre lo stesso: un «gruppo di contatto», inventandosi una zona proibita da raggiungere, si lancia a peso morto sulla polizia per essere manganellato a favore di telecamera finché un Capo Macho non si butta in mezzo insieme alla DIGOS e, tra urla scimmiesche e cenni di intesa, ognuno spinge indietro «i suoi»; una volta portata a casa la credibilità rivoluzionaria, si conclude la pantomima sui giornali, romanzando la giornata e lamentandosi delle sorprendenti violenze della polizia e della sospensione dello Stato di diritto. Il passo successivo – e tutto contemporaneo – è poi l’ossessiva esaltazione estetica delle immagini degli scontri, accompagnate da musiche di sottofondo e slogan ricondivise sui social, per il giubilo della polizia, proprio dalle stesse persone che vi hanno partecipato.
È tragicomico fermarsi un attimo a pensare che tutto questo, senza una telecamera a riprendere la scena, sarebbe completamente inutile (più di quanto già lo sia); ciò che succede in piazza, le persone presenti o l’obiettivo dichiarato, non hanno nessun valore reale; il fine ultimo è unicamente quello di raccontare sé stessi, firmare la giornata e apparire sui social, in una spirale di autocompiacimento senza fine.

Intere comunità politiche fondano le loro battaglie sulla convinzione di poter utilizzare lo strumento mediatico a proprio vantaggio, venendo poi tragicamente recuperati e fagocitati dallo spettacolo stesso o quando il nemico contrattacca davvero. Dietro questa convinzione ci sono da un lato consapevoli opportunismi elettorali, dall’altro il tentativo di qualche politicante di incasellare il gesto della rivolta come una piccola parte di un grande puzzle che ci porterà, un giorno, tramite compromessi e confronti democratici, a una poco chiara «presa del potere» e che finisce poi, nel migliore dei casi, per risolversi nell’accettazione di un capitalismo un po’ più democratico, un po’ più umano (che mai sarà).
Infine, fa riflettere quanto questi scontri alla giornata siano prerogativa unica di persone bianche e privilegiate; bisogna misurare questo dato con la realtà di fatto: una realtà dove, in tutt’altre situazioni, lo scontro con la controparte non è solo «un programma», ma la diretta conseguenza di una postura nel mondo, nella maggior parte dei casi nemmeno voluta ma obbligata dal fatto di appartenere a una minoranza minacciata e oppressa.
IL RIFIUTO DELLA SPETTACOLARIZZAZIONE
Basterebbe citare, tra i tumulti più recenti, quelli per Alfredo Cospito o per Ramy, le rivolte contro il lockdown, le eccedenze durante i cortei per la Palestina, le passeggiate rumorose dopo i femminicidi o le rivolte dentro le carceri e i CPR, dove – è importante notare – la polizia ha tutt’altro approccio all’ordine pubblico, molto più violento e senza compromessi.
Alcuni episodi, però, parlano più di mille giornate e vanno riportati.
Luglio 2017: due persone fanno sesso sul balcone mentre sotto di loro le strade di Amburgo vengono date alle fiamme dalle proteste contro il G20.
Ottobre 2019, Santiago del Cile: sono le giornate dell’Insurrezione Cilena, e intorno alla carcassa di un autobus incendiato alcune persone si radunano per ballare al ritmo dei colpi sul metallo; qualcuno finge di guidare l’autobus, qualcuno suona l’arpa.
Giugno 2020: una manifestante con la maglietta «Black Lives Matter» twerka verso la polizia durante le proteste dopo la morte di George Floyd.
Ciò che ci divide dalla possibilità di vivere un gesto rivoluzionario è la difficoltà di scorgerlo quando se ne presenta l’occasione, per il semplice fatto che l’atto rivoluzionario è per definizione qualcosa che nessuno conosce ma che va inventato da zero sul momento
Non serve del resto uscire dai nostri confini per rendere ancora più chiara l’idea: una ragazza sale sul cofano di una Tesla e ci piscia sopra durante una passeggiata rumorosa; c’è chi riscopre la sua chitarra o la gamba di un manichino come clava contro la polizia; chi gioca a «Un, due, tre, stella!» o improvvisa un karaoke davanti a un plotone dalla celere.
Il filo che lega tra loro queste vicende è l’interruzione della normalità a favore di un capovolgimento del significato degli oggetti e dei luoghi.
Il fine di una rivolta, che sia il calcio in bocca a un maschio violento o i tre giorni di un rave illegale, è la sospensione del tempo e l’apertura di squarci nel quotidiano dentro i quali sperimentare gioiosamente avventure di libertà reale e collettiva. Chiunque abbia provato almeno una volta la sensazione di sovversione del quotidiano conosce la bellezza di riappropriarsi di una parte di ciò che ti viene sottratto ogni giorno, ma soprattutto sa perfettamente che il gesto della rivolta non ha bisogno di nessuna legittimazione o argomentazione: è giusto perché è sempre un atto d’amore spontaneo verso sé e il resto.
Ciò che ci divide dalla possibilità di vivere un gesto rivoluzionario è la difficoltà di scorgerlo quando se ne presenta l’occasione, per il semplice fatto che l’atto rivoluzionario è per definizione qualcosa che nessuno conosce ma che va inventato da zero sul momento.
Agire, bucare questo Velo di Maya, questo muro invisibile che divide noi dall’azione, richiede di coltivare una tensione al pensiero rivoluzionario capace di generare un’intuizione, un’idea; che sia quella di infrangere una vetrina o di comunicare un pensiero profondo a una persona in un momento speciale, in entrambi i casi il peso enorme dei dubbi, delle paure e delle abitudini può facilmente oscurare il rapidissimo lampo dell’intuizione o appesantirlo fino a spegnerlo.

È desolante che proprio chi cammina al nostro fianco ed è più intimo a questi pensieri non dia spazio a tutto questo, ma anzi si adoperi attivamente per gettare acqua sul fuoco. Per chi ha appreso la militanza come un mestiere, annegando dentro le ideologie e le strutture verticali, quel momento di esprimere i desideri non è mai adesso ma sempre domani, nell’avvenire rivoluzionario che loro stanno costruendo per noi.
Si finisce dunque per avere piazze in cui, invece di trovare alleanze, trovi chi mette in scena i tuoi sentimenti al posto tuo, come nel mondo di tutti i giorni; tu rimani in disparte a guardare, a consumare il prodotto. E se mai ti venisse in mente di voler anche tu indossare quel casco, armare la tua ira, allora devi prima scalare la gerarchia militante o quantomeno chiedere il permesso.
Domandiamoci perché le nostre piazze, anche le più rabbiose a seguito di tragici eventi, si siano ridotte a veri e propri concerti itineranti per la città, nelle mani di qualche microfonato che ci traghetta nella miserabile esperienza di urlare la nostra rabbia a ritmo di musica e cori esplosivi, con ai margini un cordone di polizia che ci tutela dal mondo reale.
Alcuni collettivi, nati dal furore di rivendicazioni incandescenti, si sono ridotti a team di organizzatori di viaggi turistici delle ricorrenze di lotta, con le istanze politiche ridotte a badge di riconoscimento e finendo poi, a volte, ad abbassarsi al ruolo di guardie quando qualche persona altra ha l’ardore di arrabbiarsi davvero invece di godersi il ballo di gruppo.
Non c’è da stupirsi poi se, durante i momenti di sommossa questi «Grandi compagni» restino a braccia conserte mentre bruciano le camionette della Gendarmerie a Saint-Soline o sprofondino nel divano quando esplode la rabbia per un ragazzo ucciso dai carabinieri.
È proprio questo che dovrebbe spaventarci di più: la messa a nudo davanti alla realtà. La prova concreta di non saper affrontare quello che hai scimmiottato per anni e che ti porterà, inesorabilmente, a mancare il tuo appuntamento con l’Insurrezione, a non saperla riconoscere e soprattutto a non sapere come vivertela, perché hai dimenticato pure cosa desideravi.
La lotta anticapitalista non si esaurisce nella giornata di mobilitazione o nell’appuntamento col nemico, ma sta nella diffusione di comportamenti sovversivi, nella condivisione di spazi di libertà illegale collettivi dove mettersi alla prova davvero in prima persona, e dove, a volte, poter anche sbagliare ma con la dignità di aver compiuto qualcosa di tuo. Questo può accadere solo tenendo accesa la tensione verso un agire sovversivo: capire cosa significa per noi, riconoscerlo nei gesti altrui e sceglierlo tutti i giorni, dandogli spazio vitale.
Imparare a prendersi cura di sé e di chi ci sta vicino, decostruirsi, boicottare la linea, perché «Il conflitto non avanza linearmente, per linee di classe o soggetti affinitari, bensì si diffonde per risonanza, per cerchi di intensità, attraverso la polarizzazione dei vissuti comuni».
«Ai contestatori dell’Impero che insegnano alle persone a lottare per farsi concedere dei “diritti”, i nemici del totalitarismo capitalista ribattono che non ci sono diritti da elemosinare, ma la totalità della vita da conquistare. Ai primi che organizzano scontri e conflitti simbolici funzionali al mercato della rappresentazione politica, i secondi controbattono la necessità di rivolte autentiche e spontanee capaci di creare momenti di libertà immediati, effimere schegge spaziotemporali sottratte all’oppressione del dominio totalitario capitalista».

VIVERE NELLA VERITÀ
L’utilizzo del conflitto simulato, con tutte le sue aberrazioni al seguito, è figlio di un’epoca dove saper vendere la rappresentazione spettacolare dei vari sé è la chiave del successo. La porta d’emergenza per uscire da questo teatro è quella di riconquistare una forza estetica molto più attraente: quella della verità.
Mentire su ciò che succede in piazza, esagerare nei comunicati trionfalistici tutti uguali, decuplicare i numeri delle manifestazioni, ripetere come mantra slogan fiammeggianti in piazze finte e costruite… Chi pensate di prendere in giro?
A rimanere nella briglia di questa rete di bugie sono i poser, gli opportunisti, gli abuser, gli animatori di quelle relazioni sociali neutralizzanti che intossicano i già deboli spazi di movimento. A non cadere nella trappola sono invece le migliaia di possibili giovani ribelli che a ogni spazio non concesso, a ogni bugia, abbandonano schifati e delusi la lotta collettiva per chiudersi nell’individualismo e nell’egoismo capitalista.
Invece di sacrificare energie nelle autonarrazioni teatrali, è urgente tornare ad agire un’azione diretta, tornare a rendere le strade cornici di rivolte autentiche, capaci di attrarre almeno una parte di quella tensione che, costretta nel sottosuolo, trema sempre più forte e irrequieta. Sarà stupefacente riscoprire la potenza sovversiva del dilagare della rabbia di moltitudini furiose, per ora ancora sonnecchianti e represse.
Con un genocidio in corso e la guerra dei potenti alle porte, sotto il cielo più nero degli ultimi ottant’anni, è ora di riscoprire la nostra più feroce voglia di vivere e stare insieme, stringendoci a chi, all’ombra dello show, alleva il dubbio, si prende cura della verità e, in silenzio, affila il coltello.
Da qualche parte nel 2026.
Teppistx, incivili, guastafeste