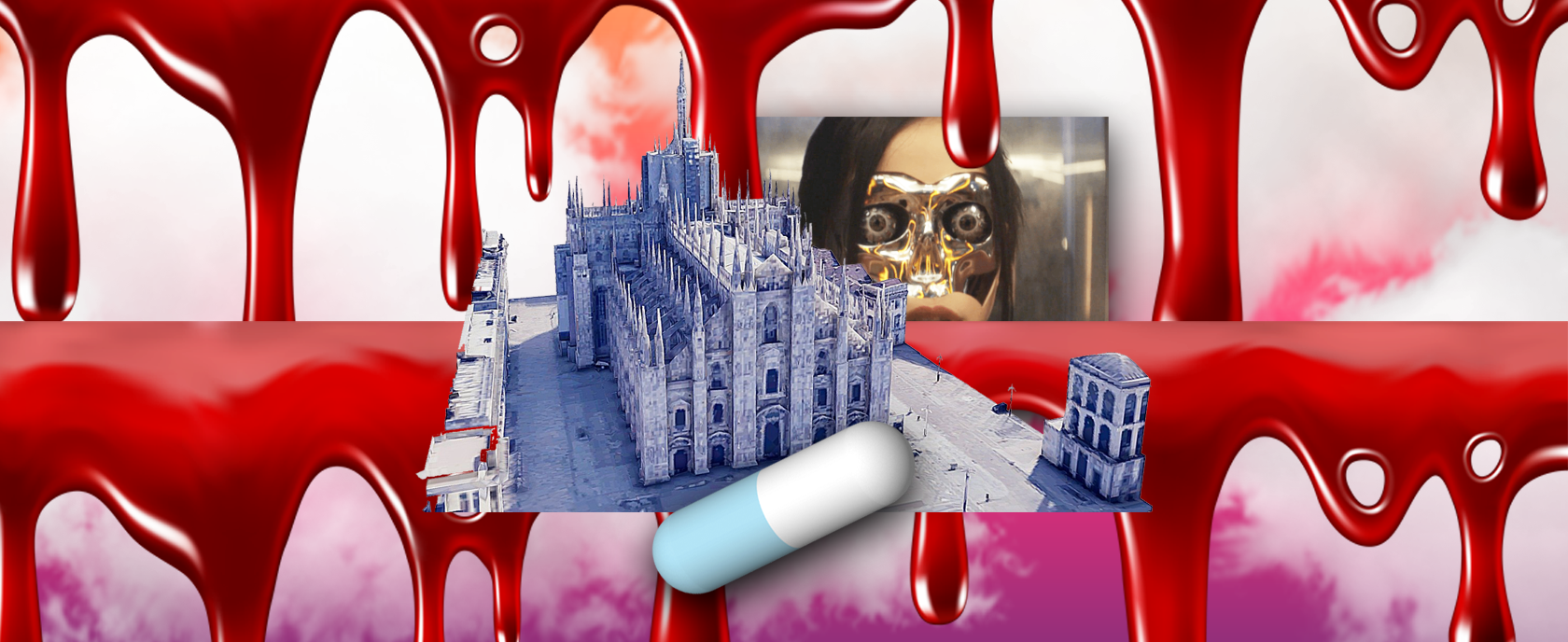Nicoletta Vallorani oltre il cybernoir
Quasi alla fine del viaggio ai confini del mondo che vedeva protagonisti Sam Farber/William Hurt e Claire Tourneur/Solveig Dommartin, compiuto per realizzare il sogno del padre di lui, cioè di permettere alla moglie cieca di vedere, i due protagonisti si scoprono vittime di una dipendenza. La storia raccontata da Wim Wenders in Fino alla fine del mondo (1991) è complessa e intricata e alcuni suoi caratteri ci aiuteranno ad entrare nell’universo fantascientifico e “cybernoir” di Nicoletta Vallorani.
Nel film, l’apocalisse nucleare è imminente a causa di un missile orbitante nello spazio uscito fuori traiettoria; le persone continuano con le loro cose, c’è chi fa finta di nulla e chi si dà a una vita sregolata dal momento che nulla risulta più importante se la fine di tutto è dietro l’angolo. L’impressione è che la Terra sia avvolta da un grigiore e una foschia costanti che corrispondono all’immobilità psicofisica dei suoi abitanti. Nel frattempo, Farber Jr. si era causato le inimicizie del governo degli Stati Uniti per un dispositivo di visione singolare costruito proprio da suo padre, con cui il figlio si muoveva clandestinamente di continente in continente per registrare le conversazioni e gli incontri avuti con i suoi familiari, volti, espressioni, corpi, immagini che poi sua madre avrebbe finalmente potuto vedere.
Questo macchinario, messo a punto all’inizio per un fine positivo, finisce con l’assorbire la coscienza e il senno di Sam e Claire nel momento in cui scoprono che poteva essere utilizzato per registrare i propri sogni. Sventato il pericolo del missile esploso soltanto nello spazio e dopo una raggiunta armonia collettiva, i due, per contraltare, si chiudono in loro stessi: non vedono più la luce del sole, non comunicano, non c’è profondità nel loro sguardo e i loro occhi rosso sangue sono ormai prosciugati dall’eccessiva esposizione al dispositivo. Sono assuefatti dalle proiezioni fantasmatiche e oniriche dei rispettivi demoni interiori: il mondo così com’è non gli basta più. Hanno bisogno di trasmigrare con la propria anima e non tornare mai più con i piedi per terra. Il dispositivo – che in parte ricorda lo schermo dei nostri cellulari – è una vera e propria dipendenza, una sostanza che dona immagini un po’ come lo “squid” in Strange Days di Kathryn Bigelow, che permetteva di registrare i pensieri delle persone; o come il “sintar”, la droga di cui parla Nicoletta Vallorani in Il cuore finto di DR. Per i sintetici protagonisti del primo romanzo della scrittrice è impossibile farne a meno perché illude loro che ci sia stato un “prima” carico di ricordi, sensazioni, amore.
Nicoletta Vallorani ha da sempre corteggiato la fantascienza e il cyberpunk uniti a una componente noir che definisce i percorsi tortuosi e accidentati dei suoi romanzi.
Milano. Futuro imprecisato. La città è una megalopoli multirazziale percorsa da cappe di fumo e scarichi mefitici, nei cui bassifondi si può arrivare a comprare ogni cosa. Penelope De Rossi (DR) è la protagonista di Il cuore finto di DR, una donna androide “mal riuscita”, grassa, inavvicinabile ma detective privata acuta e in gamba, affetta anche da una segreta passione per il sintar, una droga logorante che regala ai sintetici solo pochi attimi di allucinazioni benevole e sogni. DR viene ingaggiata da Elsa Bayern, facoltosa erede di una multinazionale farmaceutica per ritrovare il marito scomparso, un alieno di nome Angel portato sulla Terra dal padre di lei. Vallorani scrive due romanzi sulla personaggia (uso il termine “personaggia” rifacendomi al modo in cui viene adoperato da Giuliana Misserville, nel testo Donne e fantastico. Narrativa oltre i generi) della detective cyborg DR: a Il cuore finto di DR segue Dream Box, dove una coscienza diversa dell’essere “sintetici” (robot) attraversa le pagine del romanzo. In Dream Box viene, inoltre, approfondita la riflessione postcoloniale soltanto accennata nel primo romanzo: siamo sempre in un pianeta, Entierres, dove sono presenti nello stesso tempo nativi, colonizzatori e terrestri: una colonizzazione che già porta con sé un’idea di rovina.
Nicoletta Vallorani ha da sempre corteggiato la fantascienza e il cyberpunk uniti a una componente noir che definisce i percorsi tortuosi e accidentati dei suoi romanzi. Ma sono anche generi che l’autrice è riuscita sapientemente a destrutturare, in relazione, in particolare, alla figura del cyborg inteso come “mostro” e “alterità” e, più in generale, al significato attribuito alle rappresentazioni del mostruoso femminile nella sua produzione, che la avvicina a molto cinema di genere contemporaneo. Infatti, nei testi di fantascienza, così come nella narrativa e nel cinema cyberpunk e horror, come sostiene Rosi Braidotti in Madri, Mostri, Macchine, “gran parte delle mutazioni fisiche e morfologiche sono espresse nel linguaggio del mostruoso, dell’abietto e dell’horror”, generi saccheggiati e più volte riciclati nel corso del tempo – l’horror specialmente – perché, eliminando i confini tra umani e non-umani, offusca le distinzioni e introduce un senso di panico e caos.
Il lato oscuro delle cose
Nell’introduzione al volume Fantastico italiano (2009) – da lei curato – Costanza Melani, sulla scia delle riflessioni sulla letteratura fantastica di Remo Ceserani, riconosce in Tzvetan Todorov il merito di aver portato all’attenzione degli studiosi alla fine degli anni Sessanta un’intera zona letteraria della modernità, ovvero quella della letteratura del mondo fantastico. Nessun altro genere letterario sfugge più del fantastico a una puntuale definizione, se ogni paese e ogni epoca hanno stabilito i loro confini tra reale e irreale. Spostare questi confini, sostiene Melani, significa ridefinire il proprio territorio conoscitivo e gioco letterario, spostando gli equilibri intellettivi ed emotivi che si creano tra scrittore e lettore: cambiare pelle e accettare una nuova identità. Nonostante i suoi rigidi schematismi, che lo hanno portato ad escludere dal “canone” autori più sfuggenti e ambigui come Edgar Allan Poe, lo studio di Todorov resta tutt’ora il punto di riferimento storico-critico per chiunque voglia approcciarsi allo studio del fantastico.
Todorov applicava al discorso fantastico i parametri dello strutturalismo. Nella sua definizione appariva fondamentale l’identificazione del lettore con il protagonista e la sua percezione del fenomeno surreale. Il fantastico rappresentava l’esitazione provata da un individuo che è a conoscenza di sole leggi naturali dinanzi a un avvenimento in apparenza soprannaturale, durando, il fantastico, lo spazio di quest’incertezza, un genere instabile in bilico tra la categoria dello strano e del meraviglioso. La sua definizione, venne però criticata da più parti: alcuni l’hanno giudicata troppo restrittiva e altri hanno sostenuto che nel fantastico non c’è una effettiva opposizione tra reale e soprannaturale, che invece risultano legati. Il fantastico si fonda infatti sull’azione perturbante di un fenomeno su un personaggio nel quadro della vita quotidiana.
Todorov aveva individuato tre categorie: il “fantastico puro”, che definiva una zona di sospensione ed esitazione in cui il lettore non sapeva risolversi tra due coordinate; lo “strano puro”, storie in cui eventi insoliti irrompono nella vita dei protagonisti turbandone gli equilibri senza, però, minare le basi della realtà; e infine, il “meraviglioso puro”, in cui il soprannaturale modificava sia la realtà che i paradigmi cognitivi dell’io.
La categoria dello strano puro è un concetto vicino a quello di unheimlich postulato da Sigmund Freud nel suo saggio Il Perturbante (1919). Il filosofo e psicanalista austriaco scriveva che il perturbante era “quella sorta di spaventoso che risale a quanto ci è noto da lungo a tempo, a ciò che ci è familiare” il cui sentimento poteva manifestarsi solo in condizioni di “incertezza intellettuale”; qualcosa, cioè, in cui non ci si riesce più a orientare. Dunque, assumendo la compresenza di naturale e sovrannaturale quale elemento decisivo alla genesi del fantastico, Freud affermava la necessaria presenza del reale per l’insorgere del fantastico. Il perturbante rappresenta ciò che sarebbe dovuto restare nascosto, tornando in superficie e infrangendo un ordine stabilito, anche attraversando un confine: l’idea dell’attraversamento di un confine, della trasgressione di un limite, del passaggio da una dimensione a un’altra è uno dei momenti più decisivi di qualsiasi racconto fantastico. Varcare il limen – portando, spesso, con sé un’attestazione concreta del “passaggio di soglia”, il cosiddetto oggetto mediatore che diviene testimone tangibile dell’attraversamento – implica pervenire a una dimensione spaziotemporale diversa: slittare da un mondo narrativo all’altro, da un paradigma di realtà mimetico-realistico a uno fantastico.
Nel fantastico ottocentesco il mondo rappresentato si articolava secondo una struttura manichea caratterizzata da due poli in conflitto e, di conseguenza, da due dimensioni distinte. Il fantastico rappresentava una rottura dell’ordine conosciuto, una vera e propria eclissi del consueto. Per la studiosa Rosemary Jackson, la letteratura fantastica era il tentativo di dare voce all’inespresso, in una dialettica al negativo che vede coinvolti naturale e soprannaturale, una letteratura della “ricerca” che prova a colmare i vuoti della ragione, spingendosi verso le zone buie del mondo, ridisegnandone i confini. Confini tra reale e irreale che, verso la fine dell’Ottocento, vanno sempre più confondendosi e intersecandosi: il Novecento è un secolo in cui, anche complici le drammatiche circostanze storico-culturali, i contorni della paura e del perturbante si ridefiniscono, non individuandosi più una rappresentazione concreta dell’elemento soprannaturale.
Siamo, così, dalle parti della categoria del “neo-fantastico” teorizzata da Jaime Alazraki, che avvicina sempre di più il fantastico alla retorica postmodernista, per la rottura dei confini e la parzialità del punto di vista ufficiale. Se il fantastico, dunque, guarda la realtà come a una superficie solida su cui si apre una fenditura che ne mostra la fragilità, nel racconto neo-fantastico il reale appare come una spugna, una superficie piena di fori, dai quali si può intravedere l’«altra» realtà. Abbattuti i confini, non ci sono più passaggi di soglia tradizionali: il perturbante è ed esiste nel reale. Manca l’aspetto terrificante, nel senso concreto dell’espressione. Manca un percorso narrativo orientato a una fenditura finale, il fantastico è percepito come normale, una presenza quasi ovvia.
Non c’è più una linea netta di demarcazione tra reale e irreale né tantomeno una localizzazione precisa della paura, dal momento che l’inquietudine pervade ogni aspetto della vita. Le ragioni della paura restano indecifrabili e il senso di smarrimento si fa ancora più spaventoso.
In questa nuova ondata letteraria – e questo ci conduce nell’universo narrativo di Nicoletta Vallorani – il repertorio di aspetti e tematiche convenzionali del fantastico non è più così facile da circoscrivere: in Il cuore finto di DR ci troviamo in una Milano angosciante e irriconoscibile, popolata da strane creature e da un nichilismo da cui sembra impossibile uscire. Nel romanzo di Vallorani, la presenza dell’elemento soprannaturale, in questo caso filtrato da una prospettiva fantascientifica e “cybernoir”, è costante e ovvia, inserita perfettamente nel contesto reale in cui si muovono i protagonisti, quasi come in uno dei più labirintici e stranianti romanzi di Kakfa. Come scrive Gunther Anders in Kafka Pro e Contro, “il volto del mondo kafkiano sembra s-spostato: s-spostando l’aspetto normale del nostro mondo spostato per renderne la follia, tratta questo aspetto come qualcosa di normale, descrivendo il fatto folle che il mondo folle passi per normale”. Non c’è più una linea netta di demarcazione tra reale e irreale né tantomeno una localizzazione precisa della paura, dal momento che l’inquietudine pervade ogni aspetto della vita. Le ragioni della paura restano indecifrabili e il senso di smarrimento si fa ancora più spaventoso.
Se l’inquietudine è dovuta al fatto che i personaggi reagiscono ad oggetti o eventi insoliti come fossero normali, senza agitazione, con il mondo che mantiene assolutamente immutato il proprio livello sonoro, a favorire questo effetto di immobilità è anche – e soprattutto – un certo modo di usare il linguaggio. Il senso di straniamento provato dal lettore corrisponde al vuoto lasciato dal linguaggio, che deve fare appello a situazioni soprannaturali per spiegare ciò che sarebbe impossibile rappresentare. Il modo fantastico ottocentesco e, in parte, quello novecentesco, si contrappongono alla tradizionale trasparenza settecentesca che adotta un linguaggio improntato alla transitività di parole che rinviano fedelmente alla realtà, utilizzando i termini in modo da creare o rappresentare un mondo altro. È, infatti, usando in maniera letterale lo strumento della metafora che il fantastico riesce ad attuare veri e proprio cortocircuiti logico semantici (come in Soffio di Luigi Pirandello, dove l’autore costruisce una storia partendo dall’espressione metaforica “morire in un soffio”). Le potenzialità creative del linguaggio si fanno ancora più decisive quando il racconto deve raccontare il passaggio di soglia tra il mondo familiare e quello inquietante in cui dobbiamo cadere. Due mondi distinti che vanno rappresentati in maniera antitetica anche linguisticamente.
Cosa succede, però, quando non c’è più distinzione tra i mondi e il mondo irreale in cui dobbiamo inoltrarci è quello che già stiamo attraversando? Nel tentativo di cartografare quella “seconda realtà” oggetto dei suoi racconti, Julio Cortázar si era chiesto come rappresentarla, considerando la sua non riproducibilità in base al codice linguistico della comunicazione ordinaria, e data, anche, l’impossibilità di prescindere completamente da tale codice. La soluzione che l’autore argentino adotta è il linguaggio poetico: l’unico genere di linguaggio, secondo Cortázar, che poteva spingersi fino in fondo dell’animo umano e giungere al cuore delle cose esprimendo la realtà. Le manifestazioni della realtà altra, come in Bestiario o Circe, sono percepite come fossero normali e l’elemento fantastico viene trasformato in elemento domestico, tanto che sembra quasi che l’autore voglia distrarre il lettore dalla presenza di caratteri straordinari.
Una simile modalità di rappresentazione metaforica viene adottata anche da Nicoletta Vallorani, specialmente nel suo ultimo romanzo Avrai i miei occhi. La cifra più significativa del testo è non per caso la prosa, che porta alle estreme conseguenze la sintassi asciutta e spigolosa – nella scelta di un lessico evocativo e, per l’appunto, poetico – delle opere prime dell’autrice: una prosa immaginifica che incede con ritmo, e grazie alla quale la vicenda scivola a tratti in secondo piano, a dispetto dei canoni della scrittura science fiction, intenzionalmente destrutturati. Com’è già stato osservato da Valerio Evangelisti nella sua recensione al libro uscita per La Stampa, sono molti gli elementi linguistici che spiccano nel testo, e che, soprattutto, inquadrano e definiscono lo stile di Vallorani, distante dai codici della scrittura di riferimento. Tra questi, annoveriamo l’uso alternato di prima e seconda persona, monologhi introspettivi che sospendono la concitazione del racconto, una sintassi quasi nevrotica e descrizioni evocative coinvolgono il lettore, e lo magnetizzano dentro un mondo angoscioso.
Si fa, quindi, non poca fatica a entrare nelle prime pagine del romanzo, proprio per questo uso originale e insolito della seconda persona singolare con cui Olivia, la protagonista, si rivolge al suo compagno Nigredo: non col dialogo, ma con la percezione empatica o telepatica delle loro azioni. Il lettore è all’inizio disorientato, ma poi comincia ad assumere il punto di vista di Olivia, capace di sentire le emozioni degli altri, sulla propria pelle, nei giri labirintici a bordo del suo taxi per una Milano distopica e frantumata, divisa in zone invalicabili, avvolta perennemente da una luce plumbea.
La città, i corpi, i sintetici
La protagonista del primo romanzo di Vallorani, Il cuore finto di Dr, è Penelope De Rossi (DR), donna dal “cuore finto” perché sintetica, una specie di replicante in stile Blade Runner, concepita non attraverso il grembo materno ma in un laboratorio genetico; è interessante, a questo proposito, ritornare a David Cronenberg, e in particolare a The Brood (1979), per la riflessione sul concepimento materno mediato dalla tecnologia, senza l’ausilio di un corpo altro, in quel caso maschile. La personaggia di DR è una sintesi di echi e reminiscenze di ulteriori figurazioni del cyborg, soprattutto del cyborg-femmina. “Nelle rappresentazioni dei cyborg e delle IA femmina”, scrive Federica Timeto in Intelligenze Artificiali incorporate. Macchine femmina e relazioni di genere umano-macchiniche nel cinema e nella televisione contemporanei “si tratta di strategie di addomesticamento, inteso come asservimento e/o come feticizzazione erotica. È questo il caso in cui, per esempio, i cyborg di genere femminile, meglio se non caucasici, sono usati per svolgere alla perfezione mansioni per le quali le donne sono ritenute più ‘adatte’, come i servizi e i lavori di cura”.
Timeto nota come l’audiovisivo abbia spesso ridotto l’IA femmina a una figura marginale e di contorno i cui unici scopi dovevano essere subordinati ai desideri di chi aveva programmato le loro intelligenze. È il caso, ad esempio, dell’IA Joi in Blade Runner 2049 di Denis Villeneuve, un’intelligenza artificiale olografica ideata per essere l’amante perfetta. Programmata dal consumatore in base ai propri desideri, Joi è un robot depotenziato e vuoto che ricorda moltissimo le “cavie” sintetiche di cui ci racconterà Vallorani in Avrai i miei occhi. In quanto ad agency, la capacità, cioè, di una soggettività – in questo caso femminile – di agire consapevolmente e autonomamente nel mondo, seppure con modalità e scopi differenti, DR è invece abbastanza simile all’androide Ava di Ex Machina di Alex Garland: qui Garland insiste sul magnetismo dell’intelligenza artificiale femmina che costringe l’umano a una messa in discussione di sé, tanto che il film si può leggere in una prospettiva quasi anti-antropocentrica. Il potere magnetico di Ava, che sarà poi motivo della sua liberazione e affrancamento finali dalle autorità maschili cui era sottoposta, viene designato inoltre dalla caratterizzazione del corpo: un involucro trasparente e attraversato da nervature blu fluorescenti e meccanismi di raffreddamento del sistema che lo sguardo può attraversare interamente. Un corpo “femminile” esposto a una costante visibilità.
Garland e Vallorani creano due IA femmina particolarmente consapevoli della loro forza e intelligenza, riuscendo, progressivamente, ad allontanarsi da uno sguardo maschile annichilente. Ava riesce nel suo intento non appena diviene consapevole della sua carica erotica; DR, invece, è temuta da tutti e intimorisce chi le si avvicina per la conformazione particolare del suo corpo. Una parola chiave fondamentale nella riflessione di molte filosofe contemporanee che si sono interrogate sulla materialità del corpo femminile, applicandola, nel nostro caso, alla materialità del corpo femminile cyborg, è “trasformazione”. In Madri, Mostri, Macchine Braidotti sostiene che la trasformazione sia una caratteristica intrinseca della contemporaneità. Il corpo di DR è, in questo senso, un corpo femminile “trasformato”, entità composita ottenuta attraverso la combinazione di vari esperimenti scientifici. DR si muove nei grigi anfratti milanesi, seguendo una pista intricata alla ricerca di un marito (alieno) che una moglie (terrestre) non sembra avere realmente intenzione di ritrovare.
I temi di Il cuore finto di DR sono coniugati a partire dalle istanze che il femminismo ha elaborato sulla figura del cyborg, come dicevamo pocanzi, riflettendo su questioni quali alterità e memoria. Vallorani e altre autrici di fantascienza femminista hanno eletto la figura del cyborg a simbolo politico capace di incarnare il superamento del dualismo con cui la società patriarcale ha posto le donne in una posizione marginale e subalterna. DR, così come il suo corpo, sono l’emblema di una possibile trasformazione socio-culturale, degna rappresentante di un mondo post-differenza di genere.
In relazione alla figura dell’alterità femminile “mostruosa”, ci torna di nuovo utile ricordare Braidotti: la filosofa sostiene “l’esigenza di creare figurazioni delle attuali soggettività femminili all’altezza delle complessità e contraddizioni del nostro universo tecnologico”. Il cyber-femminismo, così come Vallorani nel 1992, avevano già intuito il potenziale e la forza del corpo della donna cyborg e “mostro” come strumento di una rivendicazione sociale e politica, trovando nella fantascienza, nell’horror e nel cyberpunk appropriate rappresentazioni culturali di questi cambiamenti. DR è una freak, una “Frankenstein del ventunesimo secolo”, modificata e trasformata in “sintetico da difesa” dallo scienziato Willy, “lo svitato” e poi abbandonata a sé stessa. DR è una creatura metamorfica e, come ogni freak, depravato, androgino, ermafrodita, e ogni forma di creature mutante, è uno scomodo “doppio corporeo” (Braidotti) e una figura borderline che confonde i confini.
È il fantasma della realtà in cui viviamo che evoca Vallorani a partire da DR e dal suo legame con il sintar, che crea, per l’appunto, l’illusione di vivere una realtà che non è quella concreta, tangibile, effettiva.
E che cos’è che apparenta DR al dolore di coloro che, dalla creatura di Frankenstein al replicante protagonista di Blade Runner, fanno parte della schiera dei diversi? In Il cuore finto di DR questo collante – che si rivelerà poi essere il vero motore della narrazione – è rappresentato ancora dal sintar: droga del futuro cresciuta naturalmente sul pianeta Entierres che regala sogni, temporalità e ricordi umani ai sintetici, che non riescono a non farne uso. Se il film di Scott è del 1982, esattamente dieci anni dopo, sostituendo – programmaticamente – il protagonista maschile con una IA femmina, Vallorani avrebbe ragionato sulle medesime contraddizioni vissute dal personaggio di Rick Deckard e, quasi trent’anni dopo, dal replicante interpretato da Ryan Gosling in Blade Runner 2049, incaricato di trovare ed eliminare i replicanti “troppo umani”. È il fantasma della realtà in cui viviamo che evoca Vallorani a partire da DR e dal suo legame con il sintar, che crea, per l’appunto, l’illusione di vivere una realtà che non è quella concreta, tangibile, effettiva.
È una droga-schermo attraverso cui si spinge il pedale su una non indifferente alterazione politica ed emotiva, riprendendo la tesi portata avanti da Misserville in Donne e fantastico; per una frazione di tempo limitata e felice, i sintetici possono trasmigrare in uno spazio che è onirico e reale nello stesso tempo:
“Sintar. È il suo amico migliore, da quando ha scoperto che può farle sognare sogni quasi umani. Farla sentire normale, cioè: una persona, che vive, soffre, si sbatte, ride, si infogna in situazioni impossibili e poi, alla fine, alla fine di tutto, muore.
Buffo, no? Essere gelosi del dolore degli uomini, del loro tempo finito, determinato.”
Non sappiamo nulla della vita delle cose
Sia in Il cuore finto di DR che in Avrai i miei occhi, vengono citate vie importanti del centro di Milano, la cui ricchezza sembra annientata da una trasformazione sia morale che materiale dell’assetto urbano. È una Milano oscura, sudicia e sporca quella che attraversano i protagonisti di questi due romanzi, in un futuro che sembra aver espanso i luoghi del privilegio e individuato strade, vie, luoghi percorribili soltanto da determinate classi sociali. Il resto viene relegato ai margini, in un grigiore ancora più impattante e minaccioso. Olivia, a bordo del suo taxi, e il detectibe Nigredo (già protagonista di Eva, in cui indagava su un serial killer che realizzava opere d’arte con i corpi delle sue vittime), si imbattono in un mucchio di cadaveri di donne abbandonato come fosse spazzatura, negli interstizi e nei vani più bui di una città reduce di un tempo che ne ha decretato il collasso. Sono corpi di donne, “cavie” tutte uguali, probabilmente costruite in serie, macchiate – e marchiate – delle violenze e soprusi subiti.
Trascorso un po’ di tempo dal rinvenimento dei cadaveri e dopo il confronto con altri personaggi chiave della storia, Olivia e Nigredo capiscono cosa si nasconde dietro il mistero di questi corpi. Scoprono che in quell’ambiente dove la sicurezza è al primo posto, venivano da tempo creati dei cloni di donne per soddisfare i piaceri più perversi. All’inizio si trattava di avere a che fare con semplici androidi; in seguito, i diabolici inventori di queste “macchine del piacere” realizzano quanto non sia divertente né soddisfacente torturare degli esseri artificiali, non essendo in grado di provare emozioni, quindi nemmeno dolore. Vengono così creati cloni femminili in serie, sulla base di matrici umane senzienti così che questi cloni percepiscano tutte le fasi del dolore e degli abusi che vengono loro perpetrati.
“D’accordo, sono cavie. Non veri esseri umani: oggetti senza volontà, pilotati dalla loro natura di cose utili. Esperimenti di vita, clonati o, come un tempo, del tutto artificiali: dunque non avranno lacrime. Le cavie, di qualunque natura, non ne sono degne.”
Le cavie diventano così degli oggetti-feticcio. Si tratta di un feticismo che da un lato nasce come ripetizione stravolta e temporanea di una specie di rito antico esotico di devozione – paradossalmente, l’atto stesso del creare queste cavie, da parte di questi uomini, plasmarle dal nulla, curarsi di ogni minimo dettaglio del loro aspetto, implica una devozione, un sentimento di attaccamento – dall’altro inaugura un rapporto basato sulla sostituzione fantasmatica, sull’ossessione mentale capace di dominare la realtà materiale. È l’attrazione morbosa per il mondo delle cose inanimate di cui pure era rimasto vittima il protagonista di L’orco insabbia di Hoffmann: l’oggetto della pulsione feticista è, in questo caso, rappresentato dalla figura-bambola di Olimpia, oggetto inanimato che vuole essere animato sia dall’intelletto (l’ingegnere Spallanzani, che la mette al mondo) che dal sentimento, ossia da Nathaniel, che se ne innamora, diventandone dipendente. Nel saggio Feticci. Letteratura, cinema, arti visive, Massimo Fusillo riflette non tanto sull’oggetto-feticcio in sé ma sul tipo di sguardo che questo implica: uno sguardo plurale che si diversifica nel corso delle letterature e delle arti e che è da sempre presente nella storia umana. In un capitolo in particolare, l’autore individua gli scrittori e gli artisti che utilizzano oggetti-feticcio per proiettarvi sopra valori simbolici ed emotivi, e quindi per animare il mondo inanimato delle cose: una tendenza che ha appunto caratterizzato da sempre l’universo del fantastico, e che corrisponde a uno strato arcaico ed infantile della psiche, quello che Freud fa rientrare nella categoria del perturbante:
“La fabbrica delle ceneri è un’entità multipla: un solo nome per una serie di edifici con la stessa funzione e distinti solo dal diverso numero d’ordine. Capannoni industriali ritenuti idonei e modificati in modo da accogliere questo rituale selvaggio di eliminazione delle spoglie sintetiche delle nostre bamboline sexy. Un genocidio delle cose che, in mancanza di nomi migliori, rievoca la vergogna di un altro olocausto, ricordandoci che non facciamo altro che ripetere la nostra storia.”
Se la reazione e il dolore della vittima sono lampanti, se c’è repulsione da parte della vittima, la violenza diventa ancora più affascinante, attraente. La violenza sul corpo femminile lo rende un oggetto e se questo corpo viene trasformato in una “cosa” incapace di ribellarsi, per il carnefice c’è maggiore soddisfazione. Senza ricadere nella retorica vittimistica che accomuna alcune narrazioni di genere contemporanee (come ad esempio in Il racconto dell’ancella, dove le donne protagoniste riescono a rialzarsi soltanto dopo essere state vessate, annichilite e silenziate), Nicoletta Vallorani ci parla della condizione del corpo femminile oggi. Le personagge protagoniste di Avrai i miei occhi sono delle donne che attraversano la sofferenza in un modo che però non annienta la loro capacità di scelta o autonomia decisionale, andando, per converso, a restituire loro una agency, la medesima perduta dai corpi in cui Olivia e Nigredo s’imbattono per le vie di Milano.
Non sappiamo nulla della vita delle cose è la frase che più ritorna nel romanzo: e in effetti, cosa ne sappiamo? Tanto più quando a diventare una cosa è un corpo che prima era vivo e pulsante: quando il corpo delle donne viene violato è come se non fosse più una cosa organica, vitale, animata, diventando, per l’appunto, una cosa subumana e, per questo motivo, idonea a ogni genere di tortura.