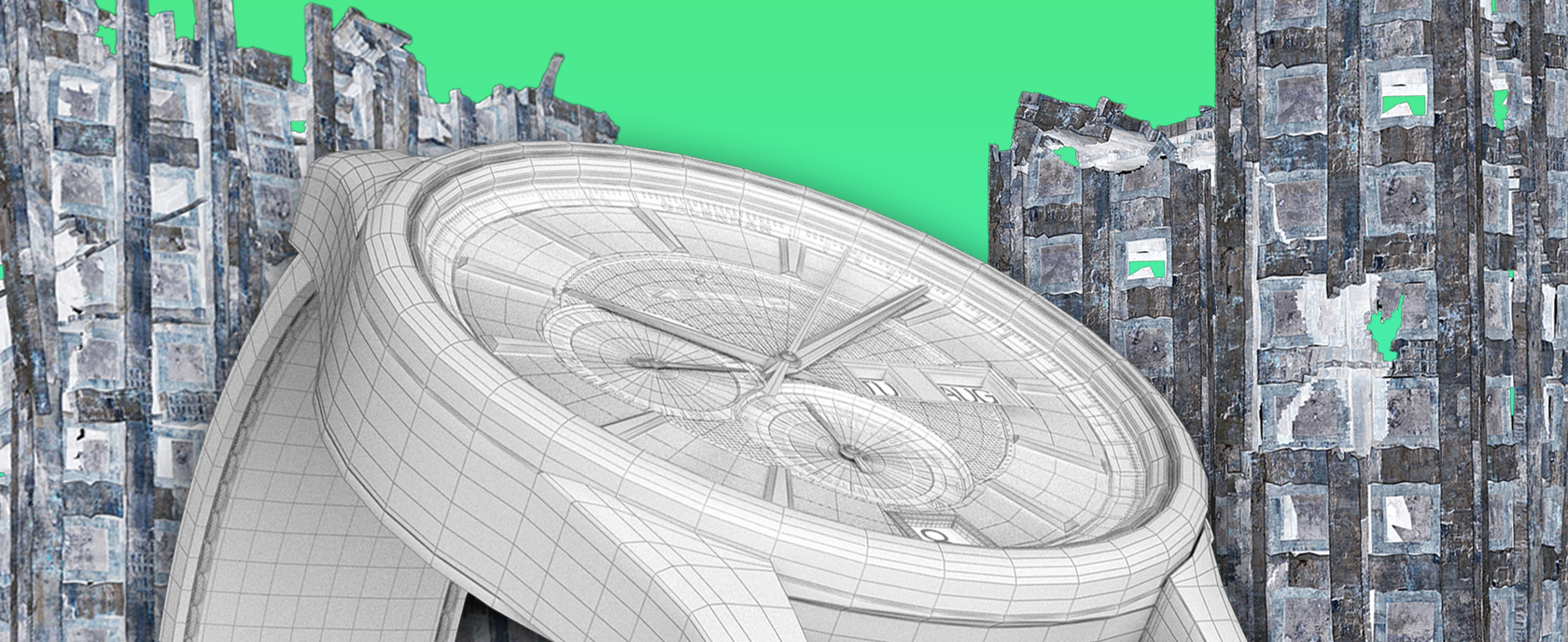Nascere nel futuro perduto
Di recente mia madre mi ha detto che se ripensa a vent’anni fa molto probabilmente non mi avrebbe permesso di nascere. La perdono, i tempi son fuor di sesto. Dice Amleto: “brutta sorte, che io debba essere nato a mettere ordine”. The time is out of Joint recitava il povero figliolo alle prese con lo spettro del padre. D’altronde to be or not to be: con l’essere e il non essere dobbiamo fare i conti e, inutile dirlo, il sottofondo è tragico. Heidegger diceva che l’essere si comprende solo nell’Esserci. Essere-lì, in un punto fissato nel tempo. Dasein. Cosa succede però quando the time is out of joint? Cosa succede quando il tempo svanisce, passato e futuro coesistono e il presente è una brutta sorte? Proprio allora, infatti, Amleto dice: essere o non essere?
Ma che sono, quindi, questi tempi fuor di sesto? Derrida, nel 1993, parla di un “adesso dissestato che rischia sempre di non mantenere nulla assieme, nella congiunzione assicurata di un contesto i cui bordi sarebbero pur sempre determinabili”. Pur sempre determinabili. Ma il tempo ha smesso di essere lineare e di conseguenza ha cessato di esistere. Il suo omicidio è la storia della mia identità negata. Del mio non-essere. Ma come è morto il tempo? Chi ha ucciso la storia?
È il 1993 quando Derrida scrive Spettri di Marx. Il muro di Berlino è da qualche anno crollato e con lui il comunismo storico. Sono anni in cui il tono apocalittico della filosofia domina il dibattito pubblico. Derrida trova tutto ciò stucchevole, un “noioso anacronismo”: un deja-vu. Per molti come lui, “una certa fine del comunismo marxista non ha dovuto aspettare il recente crollo dell’URSS e di tutto quel che ne dipende nel mondo”; la stessa questione era già risuonata. È proprio Amleto che apre l’opera di Derrida. Se i tempi sono fuor di sesto, come è possibile dichiarare una reale “fine del marxismo”, una reale “fine della storia”?
L’eredità marxista che, come ci ricorda Derrida, infesta le nostre coscienze, si riferisce agli spettri con cui lo stesso filosofo si confrontò per tutta la sua vita. Ovvero la percezione che in questi tempi fuor di sesto ci sia qualcosa di profondamente ingiusto: the time is out of joint sta a indicare qualcosa che nel presente non va, non va come dovrebbe andare.
Il tempo presente si presta a una psicopatologia ontologica, il suo essere viene articolato nella prospettiva di due assenze: ciò che non è piu e ciò che non è ancora. La hantologie derridiana, il concetto stesso dell’essere, si fonda proprio sul non-essere, sulla potenza virtuale, di quello che è stato e di quello che non è ancora, di definire le condizioni attuali. E tutto questo si presenta come qualcosa di profondamente ingiusto, faticoso.
Ricordo la prima volta che lessi Spettri della mia vita di Mark Fisher. Era marzo 2020, in piena pandemia, ed ero all’ultimo anno di liceo. Avevo appena finito di leggere Realismo Capitalista, la sensazione adolescenziale di ritrovarsi a vivere in tempi ingiusti combaciò perfettamente con lo sguardo visionario di un professore universitario che divenne un fedele compagno, una voce che mi accompagnò nello shock del presente che stavo vivendo. Spettri della mia vita fu un passaggio necessario. Dovevo sapere di piu riguardo i suoi pensieri, i suoi sguardi, la sua depressione. Dovevo capire il suo suicidio, i suoi spettri, le implicazioni emotive profonde che mi stavano legando a lui.
Lo shock del presente è la consapevolezza di vivere in tempi fuor di sesto, è la percezione della violenza amorfa e intrinseca che regola lo spazio esterno. La mia generazione, nata a cavallo del nuovo millennio, è la rappresentazione plastica di una distopia temporale: più che hauntologica, post-hauntologica. Non credo di appartenere alla lenta cancellazione del futuro, né di poter elaborare l’idea di un futuro perduto. Sono nato nel futuro perduto, azzarderei dire che ne sono anche un prodotto. Il sentimento post-hauntologico si riferisce al fatto che, come il deja-vu derridiano, non esiste nulla di nuovo. D’altronde, nel nuovo sono nato, non ho mai vissuto alcuna forma di allucinazione futuristica, di fantasia fantascientifica o tecnologica. È piu facile immaginare la fine del mondo che la fine del nuovo. E se il nuovo è di per sé sempre immaginabile, davvero lo possiamo chiamare tale?
Il sentimento post-hauntologico appartiene a una costante fuga dal reale. L’orizzonte delle possibilità non attrae, non sorprende e di conseguenza non delude mai.
La psicopatologia post-hauntologica è una forma distorta di apatia, in bilico fra una ricerca ossessiva di entusiasmo e la convinzione latente che nulla possa deludere davvero. Nulla possa deludere davvero. Il sentimento post-hauntologico appartiene a una costante fuga dal reale. L’orizzonte delle possibilità non attrae, non sorprende e di conseguenza non delude mai. È ciò che Simon Reynolds chiama la “delibidinizzazione del domani” l’aspetto più rilevante dell’indole depressiva dei miei tempi. D’altronde a essa corrisponde l’estrema libidinizzazione dell’oggi, del momento, in un’atmosfera porneggiante che sembra quasi iniettare dosi di piacere istantaneo, ma finito.
Un mio caro amico mi ha detto che spesso, quando esce la sera, bere è un modo per non pensare al domani. Prolungare l’oggi il più possibile per fare in modo di ritardare quanto più in là l’incontro col giorno dopo. Spesso mi sono reso conto anche io che, di fronte l’angoscia che mi provocano eventi passati o futuri il mio istinto è, semplicemente, di non pensarci. Se i tempi sono fuor di sesto, come posso pensare di rimetterli in ordine? Se l’orizzonte è la precarietà, la catastrofe ambientale, anni di studi per un lavoro sottopagato del cazzo, relazioni sentimentali potenzialmente infelici e fragili condizioni psichiche, davvero devo aspettare questo domani?
Da qualche settimana sto lavorando a Santa Maria del Soccorso, quartiere romano vicino il carcere di Rebibbia. Entrando nel quartiere c’è una scritta sul muro di un palazzo che mi capita di vedere ogni volta che ci vado. Fra le cancellature e i tag si riesce a leggere: “nella durezza di questi tempi non si deve perdere la tenerezza”. La vera politicizzazione della paura del domani è la capacità che abbiamo di tenerci l’uno all’altro. I nostri legami si solidificano nella condivisione del dolore, nella collettivizzazione della paura. L’esperienza comune dà la forza necessaria a incanalare la merda nel conflitto, l’unica arma in tempi fuor di sesto, unico orizzonte di un ampliamento del possibile. “Siamo già da sempre disseminati in tutto ciò a cui ci leghiamo” scrive il Comitato Invisibile. La disseminazione è il nostro punto debole, ma anche la nostra forza. Siamo legati dalle nostre stesse paure e dai nostri stessi desideri. La nostra è un’esperienza comune, non tipicamente hauntologica in senso nostalgico, ma post-hauntologica in senso ansiotico. La prima vera risposta che dobbiamo darci è deresponsabilizzarci. La condivisione del dolore è autentica nella misura in cui capiamo che l’unica vera responsabilità che dobbiamo prenderci è quella collettiva.
To drain. Drenaggio, esaurimento passivo ad opera di un prosciugamento coatto. Nel 2022 è uscito Spiderr, il nuovo album di Bladee del collettivo svedese Drain Gang. La tristezza generalizzata e professata dal gruppo si riferisce esattamente al sentimento post-hauntologico di cui parlo. Il sound stesso sembra svuotato dalle rime di Bladee, con ritmi semi-passivi, mai esplosivi, ma permanenti e pervasivi. Si ha la percezione di entrare letteralmente nella sua testa, accompagnati da una voce che a tratti assume le caratteristiche di un lamento incessante. Dice in “Disaster Prelude”:
I make a wish
I want to know it exists
That’s my only wish, uh
Believe in the myth
L’unico desiderio è credere in un mito, desiderare qualcosa e, se possibile, romanticizzarlo all’estremo. In “Drain Story” tutto si riferisce alla sensazione di non riuscire, di essere drenati, impotenti e inermi di fronte l’insuccesso del desiderio. Il videoclip è agonizzante, la camera ruota attorno a Bladee dall’inizio alla fine. Il sintomo dell’ansia, di perdere i sensi, del giramento di testa. La prassi del malessere, di questo malessere generazionale. Per poi crollare tutto.
Alla fine del video la camera sembra quasi accasciarsi, interrompe il movimento e si vede solo il cielo sbiancato, come in preda a uno stato confusionale. Se l’hauntology di Burial e dei Boards of Canada si riferiva alla nostalgia per un futuro mai avvenuto, per una melanconia retrò estetica e artistica, la post-hauntology della Drain Gang è la nebulosa fluida del presente, una gabbia spaziotemporale in cui il futuro e il passato non esistono perché coincidenti e tutto perde di sensualità. Un vuoto pieno di cose, abissale.
Poco prima delle elezioni, sono rimasto particolarmente colpito dalle parole di Tiziano Cancelli su Not, per una “Apologia dell’astensione”. Io e Tiziano non ci conosciamo, lo seguo su Facebook da diverso tempo e spesso ho condiviso le sue riflessioni. Il suo sfogo mi ha dato la voglia di continuare un discorso che parte dai suoi pensieri ma che necessita di essere perseguito, scavato a fondo. Scrive infatti Tiziano: “condividere risorse, saperi, emozioni. Trovarsi, incontrarsi, parlarsi non per fare teorica politica delle bolle intellettuali ma per risolvere, concretamente, i problemi che ci affliggono e ci impediscono di vivere come potremmo”. Siamo già da sempre disseminati in tutto ciò a cui ci leghiamo. E ciò a cui ci leghiamo sono i nostri stessi legami, la nostra stessa capacità di vivere cercando il contatto dell’altro, la nostra stessa ragione di vivere. Lì sono le basi per una reale volontà politica, la quale non consiste nel partecipare alla finzione del gioco elettorale e democratico, ma nella capacità di creare conflitto dall’esperienza comune: qualcosa non va come dovrebbe andare.
Tempo fa ebbi modo di rivolgere una domanda a Bifo a una presentazione qui a Roma: se la volontà non può nulla di fronte alla violenza che domina il nostro mondo, che forma deve assumere allora il conflitto?
La sua risposta fu caratterizzata da una dolcezza tipica di chi riconosce l’emotività dell’altro, con parole calme e rassicuranti che mi toccarono e per le quali non ebbi modo di ringraziarlo come dovuto. L’unico conflitto che esiste è collettivo, mi disse. Quello è lo spazio reale della volontà. Concluse riportando le parole degli occupanti Black Lives Matter di Portland: “Stay tight Stay together”.
Che vuol dire? Non serve nessun vuoto da creare, nessuna crisi da scongiurare. Il fallimento del domani è inscritto nell’oggi, la catastrofe è già nelle nostre case, ma non a suon di fulmini quanto in forma di ninne nanne inquietanti. E se nella tempesta, nel freddo, nella violenza della natura ci si stringe più vicino, ciò a cui ci leghiamo diverrà la nostra nuova casa.
Nel 1993, l’architetto radicale Lebbeus Woods passeggiava per una Sarajevo saccheggiata da una guerra violenta e distruttrice. Di lì a poco pubblicò un pamphlet di una straordinaria potenza poetica e conflittuale: Guerra e architettura. Il manifesto che apre il libricino lo reputo un capolavoro dei nostri tempi e lo riporto qui integralmente.
Architettura e guerra non sono incompatibili.
Architettura è guerra. Guerra è architettura.
Sono in guerra con il mio tempo, con la storia, con tutte le autorità che risiedono nella fissità delle forme.
Sono uno dei milioni di individui che non ci stanno, che non hanno casa, senza famiglia, senza fede, nessun luogo sicuro da poter considerare mio, non conosco l’inizio o la fine, nessun “sacro luogo primordiale”.
Dichiaro guerra a tutte le icone e a tutti i fini, dichiaro guerra a tutte le storie che mi incatenano alle mie stesse menzogne, alle mie pietose paure.
Conosco solo momenti, e vite che sono come momenti, e forme che sembrano avere una forza infinita, fino a quando “si fondono con l’aria”.
Sono un architetto, un costruttore di mondi, un sensuale adoratore della carne, la melodia, una figura che si staglia contro il cielo oscuro.
Non conosco il tuo nome. Né tu il mio.
Domani, inizieremo insieme la costruzione di una città.
Domani, inizieremo insieme la costruzione di una città. In guerra. Questa è forse la mitologia del futuro più prossimo. Non la guerra, presenza costante della follia contemporanea, ma in guerra. Poiché lì sentiremo il calore dei nostri corpi. Lì, l’estetizzazione e condivisione del dolore vorrà dire conflitto, vorrà dire felicità.