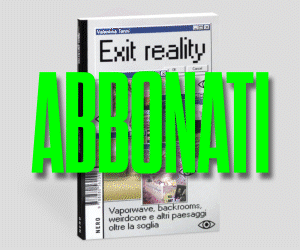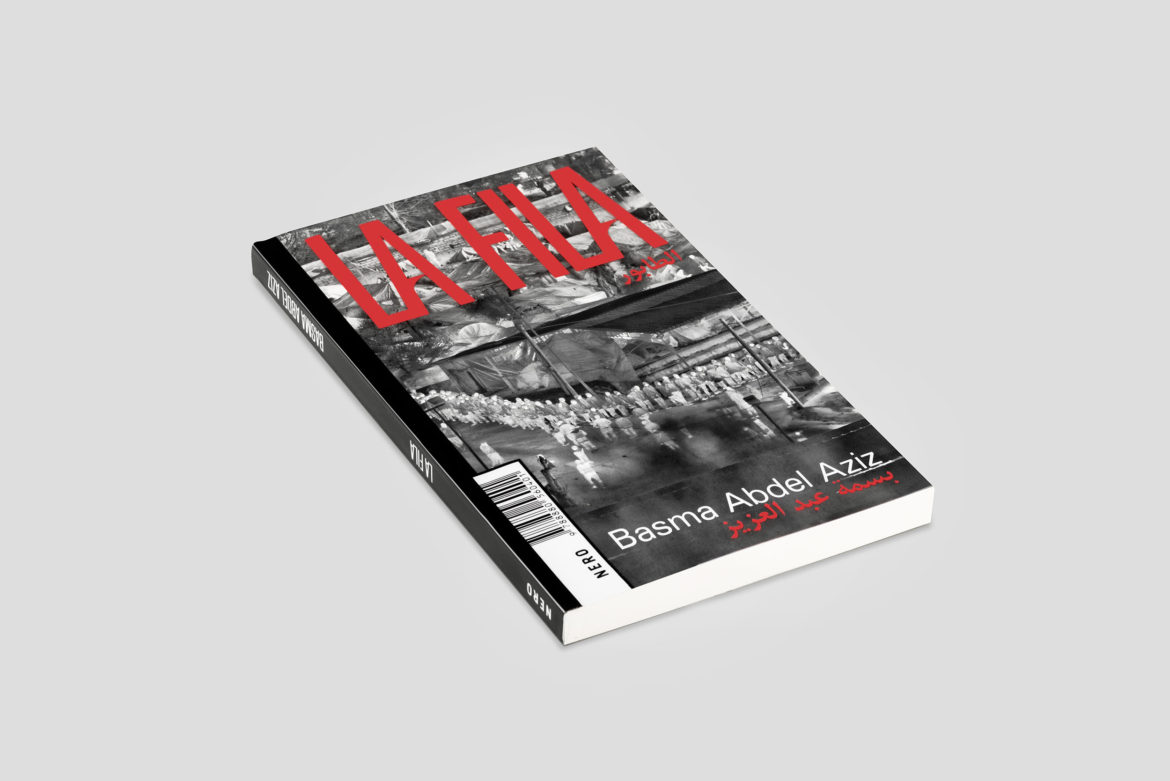Un bambino ricoperto di polvere, il corpo estratto dalle macerie, un occhio che gronda sangue, lo sguardo perso nel vuoto per lo shock. Nell’agosto 2016, la foto di Omran Daqneesh – ribattezzato dai social “the ambulance boy” – divenne l’icona della brutalità del regime siriano contro i civili: bombardamenti indiscriminati, sfollamenti forzati, assedio di città costrette alla fame. Una lotta tra il popolo siriano e la dittatura ultracinquantenaria della famiglia Assad, esplosa con le proteste della primavera 2011 e culminata, infine, nella cacciata del presidente nel dicembre 2024.

All’epoca, in una delle rare interviste video concesse alla stampa occidentale, Assad osservò impassibile la foto del piccolo Omran sotto shock, mentre il giornalista gli spiegava come fosse diventata il simbolo di una guerra insensata contro la popolazione civile siriana. “Sì, certo, la conosco”, aveva osservato l’ex presidente con un tono neutro. Ad ogni dettaglio sottolineato dal giornalista, Assad replicava con la stessa fredda indifferenza. “È coperto di sangue”. “Sì”. “È impaurito, traumatizzato”. Un cenno di assenso con la testa. Poi, dopo un video-silenzio che era sembrato durare in eterno, aveva dichiarato: “Questa foto è fabbricata, non è reale”.
Su Internet tutto può essere manipolato. E infatti, “è manipolata”, aveva decretato Assad con una sicurezza disarmante, lasciando il mondo a bocca aperta e, al tempo stesso, insinuando con successo il dubbio. E se avesse ragione? E se fosse davvero uno dei tanti falsi che popolano la rete? Come se quella foto dovesse essere l’unica prova inconfutabile della realtà siriana, come se non esistessero centinaia di migliaia, milioni, di bambini siriani sotto shock, affamati e bombardati come Omran. Il mondo archiviò il caso. Tutto cadde nel dimenticatoio: Omran, Assad, la Siria.
Sempre nel 2016, l’Oxford Dictionary incoronò “post-verità” come parola dell’anno. Il suo utilizzo era aumentato del 2000% rispetto all’anno precedente. I media occidentali la associavano alla Brexit o alla campagna elettorale di Trump, che proprio a fine 2016 sarebbe diventato presidente degli Stati Uniti. Ma per chi aveva seguito la Siria fin dall’inizio delle rivolte del 2011, la post-verità non era una novità. Era la condizione permanente in cui il potere aveva relegato ogni singola immagine-prova prodotta dagli attivisti siriani, riducendola a un’ombra, a un dubbio costante, a una sembianza illusoria.
Non fu solo l’astuzia di Assad, né il suo assoluto monopolio sulla comunicazione in Siria, a decretare il successo di una strategia basata sull’incertezza digitale, che rafforzava il sillogismo del regime: su Internet tutto può essere manipolato, dunque queste immagini sono manipolate.
Già nei primi mesi della primavera siriana del 2011, il caso del blog A Gay Girl in Damascus aveva fornito al regime un argomento perfetto. Dietro la presunta voce di una giovane attivista lesbica siriana, scomparsa nel mezzo della rivoluzione, era apparso all’improvviso un uomo bianco occidentale che dichiarava di aver usato quella piattaforma per sperimentare la sua scrittura. La rivelazione divenne una prova, nelle mani del governo, per screditare un intero movimento: gli attivisti mentono, la Siria sta bene, la rivolta è una messinscena orchestrata dalla cospirazione sionista e occidentale.
Si continuava a morire, ma le immagini fuori fuoco non trovavano più spazio nei media del mondo. Per farsi notare bisognava, come minimo, avere una bella morte, un’estetica del martirio.
Successivamente, gli stessi attivisti siriani finirono per strattonare la realtà. Divisi da decenni di dittatura, frammentati in un’opposizione incapace di compattarsi, pressati da media e ONG che chiedevano immagini chiare, intellegibili, prive di pixel sgranati e confusione visiva, iniziarono a mettere in scena gli eventi. La necessità di un’immagine leggibile e immediata – capace di colpire l’opinione pubblica – prese il sopravvento sull’immagine-prova. Il sacrificio della documentazione venne consumato sull’altare dell’immagine ‘bella’, la narrazione che prende il sopravvento sulla cruda realtà fuori dai formati estetici.
C’è un bel documentario siriano, Jellyfish di Khaled Abdelwahed, in cui un video-attivista ammette, con disarmante sincerità, come la messa in scena fosse diventata routine. Così come il traffico delle immagini, la loro monetizzazione, il loro consumo globale, bulimico ed indifferente. Ma questo non significava che la violenza non accadesse – soltanto, indicava come la preoccupazione estetica avesse preso il sopravvento sulle istanze etiche. Si continuava a morire, ma le immagini fuori fuoco non trovavano più spazio nei media del mondo. Per farsi notare bisognava, come minimo, avere una bella morte, un’estetica del martirio. Ma questa ossessione per la forma estetica aveva svuotato l’immagine-prova della sua forza vitale, riducendo la tragedia siriana a una delle tante storie risucchiate nella banalità della post-verità.
Ho amici che sono stati torturati, persino giustiziati, per aver prodotto immagini-prova. Il regime, mentre perseverava nella sua strategia di diffusione dell’incertezza digitale, alimentando confusione e dubbi in uno scenario di piena post-verità, nella realtà perseguitava e torturava chiunque documentasse la violenza e la archiviasse. La camera veniva considerata alla stregua di un’arma, e i video-attivisti sono stati trattati come militari, come combattenti armati: un esercito impegnato a confutare la propaganda, ad accumulare prove, ad archiviare immagini nella speranza che un giorno potessero servire nelle corti internazionali di giustizia. The Syrian Archive – forse il più grande progetto pubblico di archiviazione delle immagini-prova siriane – è stato pioniere nell’uso di prove audiovisive, prodotte per la maggior parte da attivisti anonimi, nei processi contro i carnefici del regime. Più di dieci anni fa, quando il progetto ha preso forma, l’obiettivo era di salvare queste immagini dalla sparizione a cui le avevano condannate il regime di Assad e l’indifferenza globale, ma anche il capitalismo delle piattaforme che le stava cancellando dalla rete con il pretesto di tutelare le proprie community da violenza ed hate speech.
Per oltre un decennio, lontano dai riflettori dei media, il lavoro di preservare il diritto all’esistenza delle immagini-prova è continuato in silenzio. In un mondo sempre più intrappolato nella logica della post-verità, organizzazioni come The Syrian Archive hanno insistito, ostinate, nel documentare e archiviare. Quando ho chiesto ai miei amici perché continuassero a rischiare la vita per produrre immagini che tutti sembravano ignorare, mi hanno risposto che lo facevano per se stessi, non per il mondo. L’immagine è la nostra memoria, dicevano. Se le città vengono distrutte, se i volti e le voci di chi abbiamo amato spariscono, almeno rimarranno fissati nella prova digitale.
Uno di loro mi ha detto: “Sono cresciuto dentro queste immagini. Dall’adolescenza all’età adulta, tutto quello che ho vissuto è passato attraverso immagini del mio paese in macerie, del mio popolo violato, della mia storia fatta a pezzi. Se nessun tribunale le userà mai per condannare i criminali, almeno saranno il mio album di famiglia, la traccia di una memoria vivente”.
Ripensando alle sue parole, non mi sono sorpresa quando ho visto altri amici, questa volta in Palestina, imbracciare la telecamera di fronte all’ennesimo attacco del governo israeliano contro la popolazione civile, e questa volta di magnitudine senza precedenti.

Dall’inizio dell’assedio genocidario del popolo palestinese dell’ottobre 2023, ho osservato il flusso delle immagini-prova da Gaza. È una grana completamente diversa da quella siriana del 2011. Qui le immagini sono nitide, chiare, molte hanno un’estetica selfie. I cellulari sono più avanzati, ma non è solo una questione tecnologica.
Laddove i pixel siriani erano sfocati, tremanti per la paura di chi filmava, lo sguardo sempre in soggettiva, puntato sulla collettività – manifestazioni, proteste, atti di disobbedienza civile – i palestinesi parlano in camera, direttamente. Si autofilmano, fissano l’obiettivo negli occhi e chiedono a loro volta di essere guardati. Un esempio lampante è Hamadashoo, mezzo milione di follower su Instagram. Ex food blogger, oggi cucina pasti per i bambini di Gaza, provando a regalare sollievo con piatti colorati e fantasiosi realizzati con quel poco che si trova. Come lui, molti altri content creator da Gaza guardano dritto in camera, incessantemente. Come a dire: io ci sono, tu mi vedi. E cosa fai? Chiamano in causa lo spettatore, senza mediazioni.
Se l’estetica influencer prende piede in queste narrazioni personali, in parallelo aumentano le riprese dall’alto, campi lunghi, inquadrature a 360° realizzate dai droni. La violenza, ora, è pienamente distinguibile, osservabile, misurabile – come se una telecamera di sorveglianza fosse puntata costantemente su Gaza. Stavolta non ci sono dubbi su chi bombarda, chi uccide, chi rade al suolo. Anche perché i carnefici stessi si filmano, fieri delle proprie azioni. Assad negava le immagini-prova; i giovani soldati dell’IDF, invece, le producono con meticolosa costanza, giorno dopo giorno, attacco dopo attacco. Le pubblicano, le taggano, le diffondono sui social con i loro veri nomi. Un battaglione ha persino inciso sulla terra di Gaza un’immensa stella di Davide, visibile su Google Maps. Il territorio – persino quello digitale – porta il marchio dell’occupazione militare israeliana e delle sue continue violazioni dei diritti della popolazione palestinese.
La violenza selfie non è l’unica forma di aggressione visiva che emerge dalle macerie di Gaza. Un’altra, forse ancora più inquietante perché sottile e implicita, prende corpo attraverso le immagini sintetiche generate dall’intelligenza artificiale. Sono realtà parallele, costruite da strumenti come DALL-E e Midjourney – scenari non reali ma realistici. Possibili, plausibili, non ancora concretizzati. Come quello suggerito da Gaza 2035, il progetto diffuso lo scorso maggio dall’ufficio del primo ministro Netanyahu. Le immagini IA mostrano una Gaza irriconoscibile rispetto alla situazione attuale: macerie scomparse, corsi d’acqua limpidi, spazi verdi e grattacieli ultramoderni. Una nuova Dubai, dove gli abitanti indossano gli abiti tradizionali del Golfo, i lunghi thobe bianchi. Non c’è traccia di vita palestinese. Tutto è stato ripulito, rimosso, sostituito.
L’immagine stessa diventa un progetto politico: una Gaza senza palestinesi. Un futuristico corridoio hi-tech tra Israele e Arabia Saudita, definito apertamente da Netanyahu alle Nazioni Unite, nel settembre 2024, come “una benedizione” – un sogno che, per realizzarsi, richiede la scomparsa o l’assimilazione forzata della popolazione locale.
La violenza di queste immagini è evidente proprio perché apparentemente pacifica. Nessuno spargimento di sangue, nessuna distruzione. Chi non sa nulla del conflitto israelo-palestinese potrebbe leggerle come un progetto di sviluppo, un’iniezione di investimenti e benessere. Ma sono immagini di guerra, una guerra degli immaginari, combattuta attraverso algoritmi che modellano il futuro. Queste rappresentazioni proliferano nel conflitto attuale. Create in pochi istanti dall’IA, sono visivamente accattivanti. Popolano una sorta di realismo sintetico, dove ciò che non è ancora accaduto non è meno reale, poiché già perfettamente immaginato e visualizzato. Dovremmo chiederci se questa nuova era, invece di segnare la fine delle immagini-prova, non stia piuttosto favorendone il ritorno in una forma diversa. Non più strumenti di testimonianza del reale, ma dispositivi che piegano la realtà empirica all’immaginario del tecno-potere egemonico.