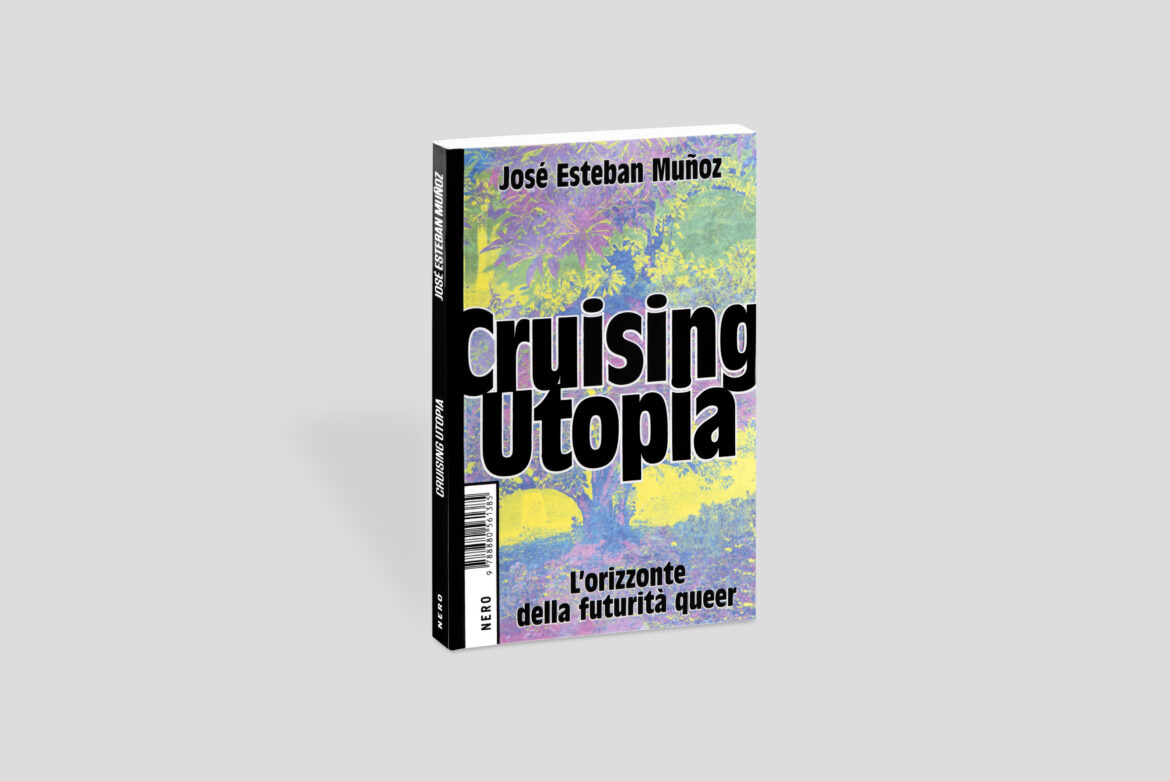Come da appuntamento aspetto Maria Galindo all’uscita della proiezione di Diva Futura. Mentre saliamo al bar del piano di sopra le chiedo come fosse il film. “Ho delle critiche”, taglia corto visibilmente assorta dalla vista su piazza Barberini, ma poi sente addosso il mio sguardo sospeso e mi dice: “È dalla prospettiva di lui”. “Te pareva”, commento io, ma non so se mi sente; ho tutte le parole in bocca, sono un po’ intimidita. Poi penso che potrei evitare di dire cose tipo “te pareva” ed essere un po’ più formale. Anche se non è Galindo a richiedermelo, ma una certa postura che mi impongo di avere nel ruolo di intervistatore sulla base di chissà quale riferimento culturale passivo e sbiadito. Lei aggiunge: “Sai, abbiamo passato del tempo insieme, con Cicciolina, quindi mi interessava vederlo. Poi sono a Roma! Cerco di fare tutto, tutto quello che vent’anni fa non ho potuto fare”. Mentre lo dice siamo già sedute a bere del vino che sicuramente non posso permettermi. Incastra lo sguardo oltre la sua spalla destra, dietro di lei Santa Maria della Concezione se ne sta tutta piena di teschi dei monaci cappuccini. I platani intorno alla chiesa le fanno quasi da corona. Sarà sicuramente anti-monarchica, ma la corona le sta bene. “Quando vivevo qui non sono mai entrata in un posto simile, capiscimi: stasera questa è la mia piccola venganza”.

L’avevo ascoltata al CSOA Forte Prenestino due giorni prima, insieme a centinaia e centinaia di persone, e a Lucha y Siesta il giorno dopo, in un’assemblea con le altre realtà transfemministe e queer romane. Registro la nostra chiacchierata anche se so che non sentirò praticamente niente: Maria ha perso la voce, urlando addosso a una persona lì a Lucha. “Non dobbiamo perderci nella politica identitaria, per esempio”, aveva detto la compagna, “nell’identità sessuale. Quando invece la lotta di classe ci unisce subito”. Traduzione degna dei primi tempi di Google translate. Galindo allora si raddrizza, tira fuori il petto come un avvoltoio dalle piume rosse scintillanti. E grida con tutta la voce che ha: “Noi in Bolivia siamo il proletariato del proletariato. Siamo stati schiacciati, esauriti, dal colonialismo”. Galindo giustamente odia che le sue parole siano tradotte e manipolate. Non è in effetti quello che ha scritto o detto. Però è esattamente il discorso con cui le istanze queer vengono de-legittimate dai vetero-compagni o quelle compagne che Galindo chiamerebbe macho-materne, macho-accondiscendenti o quant’altro (la lista è lunga). Seppur con responsabilità diverse, siamo tuttɜ parte di questo processo di delegittimazione, tocca scarnificarci. La critica all’identitarismo è una delle perle che Galindo ci porta in dono e che va custodita senza snaturarla. È stato uno dei piccoli regali (li ha chiamati così) che ci ha fatto alla serata al Forte: “Io ho tre piccole proposte per voi, ma sono proposte dolci che ho già testato”. Io arrivo al Forte con un leggero ritardo, cioè un’ora dopo, e Galindo aveva appena iniziato a parlare. Come sempre negli spazi sociali e nei cortei, si arriva e si diluisce lo sguardo in una serie di convenevoli e saluti che percorrono l’imbarazzo di non saper interagire e l’emozione di sentire di far forse parte di un branco.
Primo regalo
“Dobbiamo prima di tutto uscire dalla politica identitaria, cioè capire che nessunǝ è solo questo o quell’altro: l’identità è sempre un pezzo di altro. Allo stesso tempo, simultaneamente. Organizzarci solo in base alle identità è omogeneizzante: è una logica in cui tremila diventa una persona sola. Diventiamo la fotografia di Benetton”. La platea ride di gusto. “Significa interrogarci di nuovo sul soggetto della politica contemporanea con lo scopo di creare un soggetto multiplo eterogeneo e sempre incompleto. Affinché la porta rimanga aperta”. Non vedo il suo volto, ma sento la sua voce e la stanza del Forte si riempie di punti esclamativi sospesi e immaginati. La folla arriva fino a oltre il cinema nei corridoi della fortezza occupata più grande d’Europa. Almeno un centinaio di noi si ritrova circondato di teste, e con la voce, alta e limpida, di Galindo che riecheggia profetica mentre noi compagnɜ siamo costrettɜ a guardarci in faccia con una luce artificiale da interrogatorio. Neanche fosse fatto apposta. Galindo parla per circa un’ora, mi dice poi che “è come fare teatro”. Nel senso che parlare a tanta gente richiede un certo tono di voce, un linguaggio, delle climax. Ascoltarla in effetti è fenomenale: riesce ad entrare nelle cose in profondità senza perdersi, senza smettere di essere accessibile. Gliel’ho detto: “Sei universale e specifica”. Ad ogni climax e applausi e ululati ne approfitto per studiare le reazioni di chi mi circonda, analizzo i consensi, i sorrisi e gli accigliamenti. “Un soggetto complesso non può essere cooptato”, lo ripete lei o tuttɜ noi nelle nostra testa: non siamo solo lesbiche, autistiche, proletarie o quant’altro, siamo tanto altro, possiamo diventarlo. La porta deve rimanere aperta, non possiamo essere co-optate. Dobbiamo essere indigeste! “Dobbiamo creare alleanze insolite, vietate dal sistema e io ho una metafora per questo valida per la mia società: voi dovete trovare la vostra metafora. È la metafora di uno spazio che ci unisce, dove entrano tuttɜ, siamo state invece addomesticate ad avere delle alleanze utili al sistema. Dobbiamo domandarci: qual è la politica che vogliamo fare? Se non vogliamo fare quella dei diritti e identitaria?”
Secondo regalo.
“Se non vogliamo fare la politica dei partiti e anche quella dell’assemblea io propongo la politica concreta cioè massiva: è una politica chiara e tangibile e popolare. Per costruire cosa? Qualcosa che il patriarcato e il colonialismo non possono assorbire. Per costruire l’empatia sociale che è la nostra forza: che non può essere cooptata o sostituita da nessun potere”. Si prende spazio, respiro, e lo ripete un’altra volta: “È urgente creare un’empatia sociale massiva”. Ha urlato anche: “Le assemblee sono noiose”. L’applauso, quasi automatico ormai a ogni climax dialogica, ha scrosciato un po’ meno forte mentre in alcuni punti della sala si è acceso un ronzio colpevole. Della noia delle assemblee siamo tuttɜ co-responsabili, ne è forse però colpevole chi militarizza gli spazi socio-politici applicando sanzioni sociali (commenti, sguardi) a ciò che non riesce a decifrare o inglobare; applicando spesso anche un dress code o un gergo militante (dire cose tipo “agire il conflitto” o altre mille parole incomprensibili che nonostante l’editing ritrovate anche qui: sono anche io una sopravvissuta). Contro l’accademismo (di cui anche negli spazi ci siamo contaminate) Galindo propone un femminismo intuitivo pieno delle voci silenziate che non hanno mai avuto luogo d’espressione o microfono. E forse anche noi dovremmo tornare lì. Le sue domande ci rimangono addosso più del previsto: “Siamo capaci di fuggire dalla logica del leader? Del martire? Possiamo fuggire dal conflitto sociale come luogo di sacrificio e di sofferenza?”
Terzo regalo
Galindo parla di utopia, ma prima afferma: “Di fronte al potere non cerchi l’empowerment, ti ribelli”; in sala ci si chiede a vicenda: “Ha detto: ribelli o riveli?”. In tantɜ prendiamo appunti. “Riveli, riveli”, mi conferma la sconosciuta con cui stavo dividendo la birra. “Ribelli, ma anche riveli, vogliono dire la stessa cosa alla fine”, mi aveva detto poi Maria. “Abbiamo bisogno di utopia, cos’è? Un orizzonte de sentido”. Galindo tiene la pause sul filo delle gambe pelose di tante di noi, che, assorte, ce li arricciamo. “Cosa vi propongo io? Come utopia e orizzonte de sentido: un orizzonte che può essere dentro le nostre profonde discrepanze ed eterogeneità e pluralità femministe. Quello che vi propongo è la de-patriarcalizzazione”. Depatriarcare, scrive Galindo, è quello che facciamo noi femministe “con la famiglia, con la terra, con il cibo, con il lavoro, con l’arte, con la vita quotidiana, con lo spazio, con la salute, con il sesso”. La de-patriarcalizzazione è un orizzonte, “è una grande porta dove possono stare caoticamente tutte le nostre lotte”, è un movimento “assetato e insaziabile che non può venir divorato né negoziato da interessi o gruppi o governi”.
Per Galindo i diritti sono uno strumento secondario di controllo che divide la società in segmenti: “Sono un copione da ripetere anche se non ci appartiene. E stiamo a ripetere. Sono uno chantaje : oggi te li do domani te li tolgo. Parlando solo di diritti non parliamo di strutture di potere”.
Fiocchi e nastri bonus
Eccoci di nuovo sulla terrazza a Barberini divise da un tavolino caotico tra bicchieri sparsi, tapas mezze mangiate e fogli scritti e già stinti dalla bottiglia di vino gocciolante. Non era tra le domande che mi ero preparata, ma le chiedo come fosse andata male alla Biennale di Venezia. Dico “male” per sbaglio e lei sorride. “È stato come stare dentro ad un bicchiere”, prima di fare il primo sorso ci infila le dita dentro e sparge delle gocce di vino bianco in aria e verso terra, per gli antenati. “Tornare così, negli spazi politici, tra la gente, è realizzare un sogno. La Biennale questo non lo sa fare”. C’è una rete militante che ha portato, in dieci tappe, Galindo in giro per l’Italia. Lei la descrive con “una capacità organizzativa meglio della Biennale stessa”. Quando ci parliamo siamo solo all’inizio del tour che si concluderà dallɜ compagnɜ di Squeert al CSO Pedro a Padova. Incontro due di loro a Vienna, qualche giorno dopo, parliamo di Galindo e concordiamo su quanto abbiamo bisogno della sua voce, del suo grido. “Femminismo Bastardo”, edito da Mimesis edizioni, è un testo ibrido e compatto. Non è insensato pensarlo come un manuale di non-assimilabilità: dopo la devastazione del colonialismo, contro il risucchio del capitale. Speriamo che mentre provano a digerirci si strozzino con le paillettes e i moschettoni. L’abbiamo ribadito quando con la cucciolata queer di Priot abbiamo presentato il suo libro con Hanay del Gruppo Ippolita: “Non vogliamo essere frociɜ ad alta digeribilità”, e testi come quelli di Galindo non vogliono spianarci la strada, ma insegnarci a stare nel rigoglio e costruirci tane e fortini. Infatti, “Galindo pensa al corpo delle donne come una potenza sessuale espropriata, come piacere distrutto, come soggettività devastata”, scrive Paul B. Preciado nella prefazione al testo. E aggiunge che i transfemminismi possono essere solo bastardi perché sorgono da “un luogo socialmente conflittuale, dolorosamente irrisolto, ardentemente illegittimo e mille volte proibito”.
Le chiedo se avesse delle aspettative o un intuito su come avrebbe risuonato il suo pensiero in Italia. Femminismo Bastardo non è solo una guida, un dizionario specifico e potenzialmente universale, ma è uno spazio arioso dove tanti collettivi e individui possono andare a prendere una boccata d’aria; e vedere se qualcosa germoglia o brucia fino alla radice. “Sono convinta che con la scrittura e la radio stiamo inventando nuovi femminismi. Ma non voglio cadere nell’arroganza europea, non voglio essere, per farti capire, Bifo Berardi (in effetti io non ho mica capito come dobbiamo disertare e forse alcuni di noi per posizionamento, anche volendo, non potrebbero mai?). Quello che dico è interessante se poi nasce un dialogo e una pratica politica. In America Latina, in quella che io chiamo ‘il continente senza nome’, abbiamo crisi in comune e abbiamo anche delle crisi in comune con voi, anche se le vediamo da punti diversi”. Rifletto insieme a lei che sicuramente ciò che nei nostri spazi politici risuona di più è la critica alla politica identitaria. È vero: “La lotta per i diritti è satura, esausta”. Per Galindo i diritti sono uno strumento secondario di controllo che divide la società in segmenti: “Sono un copione da ripetere anche se non ci appartiene. E stiamo a ripetere. Sono uno chantaje: oggi te li do domani te li tolgo. Parlando solo di diritti non parliamo di strutture di potere”.
Le chiedo di tornare su alcuni punti che aveva detto la sera prima: cosa voleva dire con “la mia nazione è l’immaginazione”? Intanto, sorridendo mi dice che suona bene, annuisco pensando a quanto sia musicale la sua scrittura; merito anche della traduttrice Roberta Granelli. Galindo continua: “Quando non hai neanche le scarpe ti offrono la Nazione. Guarda Meloni, Meloni questo lo sa benissimo”. Annuisco. Aggiunge: “Lo spazio simbolico è lo spazio emozionale”. Le chiedo come stimola la sua immaginazione, se ha uno spazio ancora vuoto o se la sua immaginazione è satura. Mi risponde: “Io ho la capacità immaginativa di una bambina, lo dico in senso positivo, ma non fraintendermi: lo sforzo d’immaginazione che dobbiamo fare è collettivo”. Le chiedo come sia stato sentire una rete così, che dalla Bolivia l’ha portata in Italia in giro per gli spazi politici. Mi dice: “C’è un deseo profondo di ascoltarsi, di rispetto, di organizzarsi”. Concludiamo proprio su questo: su quanta potenza ci sia nell’autogestione, sulla passione, sulla cura che mettiamo. Ce lo scordiamo spesso, non abbiamo certo l’arroganza di tenere in piedi il mondo (spesso neanche noi stessɜ), ma riusciamo ancora a creare spazi di respiro e germinazione. Invidio Maria che domani sarà dallɜ compagnɜ della Vampa e poi sarà accolta da tutto ciò che in giro, senza chiedere il permesso, brulica di bastardismo e femminismo intuitivo. Tengo stretto in mano un diavoletto fatto dal collettivo che ha co-fondato: Mujeres Creando. I diavoletti, ci ha spiegato alla libreria Antigone, sono una traduzione anarchista-blasfema degli altari. Li teniamo stretti mentre cospiriamo sempre più all’unisono. Galindo è un gigantesco ombrello sotto il quale ci troviamo tuttɜ d’accordo e soprattutto faccia a faccia: in questo spazio ristretto possiamo iniziare a intessere trame, amache e ghirlande.
“La lotta sociale è un paradiso in cui restare, grazie mille!”