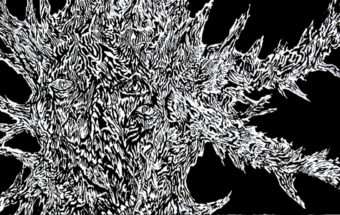La lingua di Lovecraft
C’era una volta un castello, nelle cui segrete «si apriva una serie intricata di volte, dove non era facile per una persona in preda all’ansia trovare la porta che conduceva al cunicolo. Un silenzio impressionante regnava in quelle regioni sotterranee, a eccezione di qualche corrente d’aria che di tanto in tanto scuoteva le porte […] facendole cigolare sui cardini arrugginiti e suscitando ogni sorta di echi nell’oscurità di quell’interminabile labirinto».
C’era una volta una camera da letto immersa nell’ombra: «Davanti a una vetrina piena di antiche immagini ardeva una lampada d’oro. Le poltrone di seta stinta e i divani dai cuscini di piuma, dalla doratura mezzo scancellata, stavano in melanconica simmetria lungo le pareti coperte di tappezzerie cinesi, dove pendevano due ritratti dipinti a Parigi da Mme Lebrun».
C’era una volta, infine, la camera di uno studente di Oxford. «Da ogni nicchia e da ogni mensola facevano capolino Horus, Iside e Osiride, mentre al soffitto era appeso con due nodi un autentico figlio del vecchio Nilo, un gran coccodrillo con la bocca spalancata. Nel centro di questo strano ambiente si trovava un ampio tavolo quadrato cosparso di carte, bottiglie e di foglie disseccate di una pianta elegante, simile alla palma. Questi svariati oggetti erano stati tutti ammucchiati per far posto alla cassa di una mummia».
Poi, improvvisa come un’epifania, c’è «una massa melmosa e infernale di mota nera, che si estendeva intorno a me, fin dove potevo vedere, in ondulazioni monotone. […] Quell’area era putrida delle carcasse di pesci in decomposizione, e di altre cose meno facilmente descrivibili che vedevo spuntare dal nauseante pantano di quella pianura senza fine». È il 1919 e sull’undicesimo numero di The Vagrant, rivista amatoriale pubblicata da W. Paul Cook, compare, a firma H.P. Lovecraft, il racconto Dagon, ormai largamente considerato come l’atto fondativo di quel corpus di scritti lascamente interconnessi che va sotto il nome di «Miti di Cthulhu» e la cui formulazione in sistema coerente non fu mai preoccupazione dell’autore, bensì chimera ostinatamente perseguita dai suoi epigoni, August Derleth in primis.
Non si può forse comprendere appieno la rivelazione letteraria e linguistica della palude di Dagon se non si percepisce la rottura rappresentata dalla filosofia antiumanista di Lovecraft.
Nelle parole di S.T. Joshi, senz’altro lo studioso che più energia ha dedicato allo studio della lingua, della letteratura e della visione del mondo di H.P. Lovecraft, i Miti di Cthulhu «sono una serie di invenzioni narrative utilizzate da Lovecraft per trasmettere i punti essenziali della sua filosofia cosmica», e non si può forse comprendere appieno la rivelazione letteraria e linguistica della palude di Dagon se non si percepisce la rottura rappresentata dalla filosofia antiumanista di Lovecraft. Laddove l’Umanesimo aveva immaginato – e dunque fondato, attraverso il recupero ideale della civiltà greco-romana – un sistema culturale e civile che aveva l’uomo al centro della propria orbita, l’Illuminismo prima e il Romanticismo poi si erano spinti ancora oltre, facendo dell’uomo il principio ordinatore del sistema tutto: l’Illuminismo affidando alla sola ragione umana il potere di dare nome alle cose e struttura al mondo; il Romanticismo facendo della sensibilità umana l’unico prisma attraverso il quale poter guardare l’universo. Nemmeno i venti d’ossario della fin de siècle, carichi dell’usta di fiori del male già frolli, avevano davvero eroso questo sistema, perché – anche a fronte della scomparsa del mondo, del rinserramento di ogni turris eburnea – pur sempre rimaneva, su un piedistallo dorato che è teatro non meno di catafalco, l’uomo, con la propria originalità ormai solo criterio veritativo nell’interpretazione del reale.
Finché dal nulla arriva un uomo da nulla, un impomatato gentleman del New England, spaventato dalla modernità, cultore di un Vecchio Mondo sognato ma mai conosciuto, se non fra i tomi della biblioteca di famiglia, amante di lunghe passeggiate mattutine per i campi e boschi del Rhode Island. Tormentato fin dall’infanzia da incubi terribili in cui qualsiasi superficiale lettura psicanalitica potrebbe leggere i segni rivelatori di una repressione disperata, H.P. Lovecraft ama i vecchi libri rilegati in pelle, i sentori pulverolenti di antichi masti, le antichità egizie, le buone cose di pessimo gusto che un’educazione piccolo-borghese e puritana gli hanno insegnato a riconoscere come di valore; ma H.P. Lovecraft ama anche le stelle, i funghi che crescono sulle cortecce degli alberi, gli strani fiori dei prati, gli animali raccolti sul letto del fiume. È un chimico e un astronomo dilettante: da adolescente, ha fondato e diretto due periodici poligrafati – The Scientific Gazette e The Rhode Island Journal of Astronomy – e al cielo stellato sopra di lui ha sempre guardato con attenzione; dapprima (nel periodo per così dire dunsaniano della sua produzione, quello della Nave bianca e della Rovina di Sarnath) con anelito avventuroso di fuga, poi con sempre più acuta e dolorosa consapevolezza che il ruolo dell’uomo all’interno del vasto cosmo è del tutto irrilevante, un semplice accidente che non disturba affatto il meccanismo insensibile e amorale delle leggi naturali.
Nasce da qui la «rivoluzione copernicana» cui Lovecraft dà vita, e c’è una sorta di tragica ironia nel fatto che questa rivoluzione nasca dalla postrema periferia del sistema letterario – i pulp magazines –, proprio come l’assalto al mondo e all’uomo è portato, nell’opera di Lovecraft, dalle estreme propaggini dell’universo, nelle cui abissali profondità dormono e aspettano divinità aliene che delle leggi naturali sono ben più che l’allegoria, la metafora o la personificazione: ne sono l’attuazione schiacciante, inevitabile e bruciante come una reazione chimica, come una decomposizione gassosa, come un’esplosione di supernova.
Questa rivoluzione – che mirava alla realizzazione di un orrore pensato non già come violazione del reale, ma come sua ipotetica estensione – aveva bisogno di una lingua. E quella lingua, Lovecraft – che pure della letteratura del fantastico, del meraviglioso e dello strano era conoscitore sopraffino, tanto da aver scritto quello che è ancora oggi considerato come uno dei più importanti contributi sul genere, L’orrore sovrannaturale in letteratura – non poteva trovarla in Horace Walpole e nel suo Castello, nella pur rigogliosa tradizione europea del romanzo gotico (da Ann Radcliffe agli scrittori francesi di raffinati incubi fantastici, come Théophile Gautier o Prosper Mérimée), né in quella americana – che pure, dopo le prime esperienze di Washington Irving e Charles Brockden Brown, aveva trovato i suoi risultati più compiuti in Edgar Allan Poe –, né nella produzione letteraria di quelli che egli stesso individuava come i quattro maestri dell’orrore: Algernon Blackwood l’ermeta; Lord Dunsany il sognatore; M.R. James l’antiquario; Arthur Machen il mistico.
La trovò, invece, nei manuali di scienza.

Racconta Lovecraft in «The Whisperer in Darkness» (1930, contenuto in The Call of Cthulhu and Other Weird Stories, traduzione mia): «C’era un modo sicuro di asportare il cervello, e un modo per mantenere vivo il residuo organico mentre il cervello non c’era. La nuda, compatta materia cerebrale era dunque immersa in un fluido, rabboccato all’occorrenza, all’interno di un cilindro a tenuta d’etere, fatto di un metallo estratto su Yuggoth e attraversato da alcuni elettrodi, che il cervello poteva connettere a piacere a elaborati marchingegni in grado di duplicare le tre facoltà vitali di vista, udito e parola».
Da questo punto di vista, l’esito più alto della ricerca espressiva lovecraftiana è senz’altro Le montagne della follia, dove l’ossessione nominativa assume i contorni di un vero e proprio delirio filogenetico, specie nella lunga scena dell’autopsia di una creatura aliena, trasmessa via radio dal biologo Lake al resto della spedizione nel continente antartico: «A circa metà torso, uno su sommità centrale di ciascuna delle cinque coste che fungono da doghe, ci sono cinque apparati di braccia o tentacoli elastici, grigio chiaro, trovati ripiegati strettamente verso torso ma estendibili fino a lunghezza massima di più di tre piedi. Come braccia di crinoide primitivo. Singolo peduncolo di tre pollici di diametro si divide dopo sei pollici in cinque sottopeduncoli; ciascuno di questi si divide dopo otto pollici in cinque piccoli tentacoli o cirri affusolati, per totale di ventinque tentacoli per ogni peduncolo».
Eppure, se il contributo di H.P. Lovecraft alla letteratura contemporanea si esaurisse in questa rivoluzione copernicana del linguaggio, la sua opera potrebbe essere rubricata facilmente all’interno del genere orrifico, genere da cui sembra invece voler continuamente traboccare, e non già per riversarsi in un altro contenitore, bensì per abitare uno spazio informe, un vuoto non dissimile dalle vaste profondità siderali che Lovecraft elesse a teatro dei propri incubi: è in questa ineffabilità che sta la contemporaneità sorprendente di Lovecraft, a cui le storie della letteratura dovrebbero ormai, e finalmente, riconoscere il posto che gli spetta nella cultura letteraria occidentale.
La vera originalità, la vera radice della grandezza di Lovecraft, andrà allora cercata altrove, nel rovescio della medaglia del suo amore per la parola precisa, notomistica: e cioè nel suo corteggiamento dell’afasia, del silenzio. Perché non c’è tassonomia che possa davvero squadrare fino in fondo il terrore paralizzante dell’esistenza; non c’è biologia, chimica, medicina, filosofia o stregoneria che possa trovare un senso in qualcosa che di senso è costituzionalmente privo. E per quanto gli aggettivi, gli avverbi, le accurate misurazioni, le descrizioni ossessive cerchino di scongiurare l’assurdità del mondo e della vita, infine la parola deve arrendersi, e così l’uomo.
Le divinità aliene create da Lovecraft – Cthulhu, Nyarlatothep, Yog-Sothoth, Shub-Niggurath – non possono essere né conosciute né comprese né sfidate o sconfitte.
Non è un caso, allora, che Le montagne della follia si chiuda con un verso privo di significato, Tekeli-li (ripreso dal Gordon Pym di Poe), e che i racconti e i romanzi di Lovecraft abbondino di suoni inarticolati, strozzati, impronunciabilità fonetiche correlativo oggettivo di questa insensatezza, di vuoti sospensivi che suggeriscono come l’intelletto umano, di fronte all’assenza di teleologia, non possa che arrestarsi:
«Nyarlathotep… il caos strisciante… io sono l’ultimo… parlerò al vuoto in ascolto…»
(da «Nyarlathotep»)
«La pazzia cavalca il vento stellare… zanne e artigli affilati su secoli di cadaveri… morte che sgocciola sopra un baccanale di pipistrelli dalle nere notturne rovine dei templi sepolti di Belial…»
(da «The Hound»)
«Eh-y-ya-ya-yahaah—e’yayayaaaa… ngh’aaaaa… ngh’aaa… h’yuh… h’yuh… AIUTO! AIUTO!… pp—pp—pp—PADRE! PADRE! YOG-SOTHOTH!»
(da «L’orrore di Dunwich»)
«OGTHROD AI’F
GEB’L—EE’H
YOG-SOTHOTH
‘NGAH’NG AI’Y
ZHRO!»
(da «Il caso di Charles Dexter Ward»)
«Ph’nglui mglw’nafh Cthulhu R’lyeh wgah’nagl fhtagn.»
(da «Il richiamo di Cthulhu»)
Presentificazioni di questa mancanza disperante di scopo, di questo meccanicismo che non concede all’uomo né limbo né eliso, le divinità aliene create da Lovecraft – Cthulhu, Nyarlatothep, Yog-Sothoth, Shub-Niggurath – non possono essere né conosciute né comprese né sfidate o sconfitte: non hanno nulla a che vedere con i pantheon di J.R.R. Tolkien o di C.S. Lewis, né con le mostruosità immaginate da Stephen King o Clive Barker. L’uomo non può vincere, contro Cthulhu, come non può vincere contro la gravità; e come la gravità lo schiaccia al suolo, così Cthulhu lo schiaccia nelle proprie grinfie senza finalismo. E quei pochi racconti che si chiudono senza la morte o il completo impazzimento dei loro protagonisti, non sciolgono l’orrore, non illuminano il buio: la fine è solo rimandata e, quando le parole scivolano nel bianco della pagina, l’uomo non è più al centro di nulla, se non di uno shakespeariano palcoscenico vuoto, nudo. Si legge nel Macbeth:
… La vita non è che un’ombra
Che cammina, un povero attore
Che si pavoneggia e si agita per la sua ora
Sulla scena e del quale poi
Non si ode più nulla: è una storia
Raccontata da un idiota, piena di rumore
E furia, che non significa nulla.
La platea è buia, nessuna luce illumina il proscenio, nessun lanternino può dare più conforto alcuno. Non c’è che oscurità, e un’incertezza così profonda che la voce si strozza, soffoca, muore in gola: la parola si fa balbettio, l’uomo un neonato che lalla; la vita e la morte si rassomigliano tanto da confondersi. L’esorcismo – del reale, della paura, della fine – fallisce. Il fallimento di H.P. Lovecraft è il nostro, eppure – come Lovecraft – continuiamo a cercarla, quella parola elusiva, forse inesistente, che può salvarci. Continuiamo a scrivere.

La nuova edizione di Le montagne della follia di Howard Phillips Lovecraft è uscita per il Saggiatore nella nuova traduzione di Andrea Morstabilini.