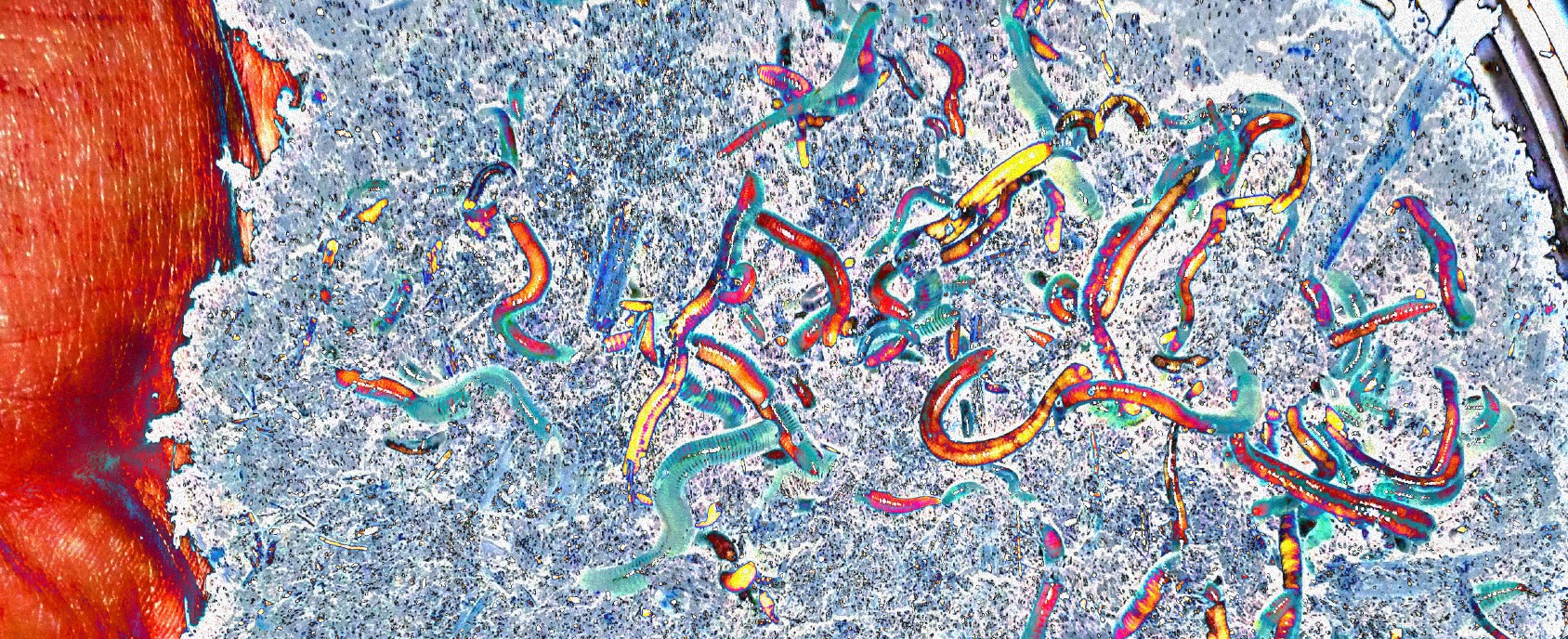I bambini del compost
Introduzione – Marta Bono
Digitando la parola «speculazione» sul motore di ricerca, a fianco compaiono altre parole: «finanziaria», «edilizia», «in borsa». L’occhio cade su quest’ultima locuzione, «la speculazione in borsa», e torna alla mente una cantilena, un ritornello: Pensare, pensare dobbiamo. A volte è facile come un gioco di parole, un esercizio dal sapore rodariano che devia il senso comune per farti immaginare tante forme che attraversano uno spazio bianco, munite di sacche, zaini, borsette e borselli di ogni tipo, il contenuto è fluido, risuona alle orecchie e allunga lo sguardo. Le forme lo rovesciano quando s’imbattono in altre forme, si contaminano e lo sfondo si sporca di altri colori, il disordine aumenta: cosa succede quando la «speculazione esce dalla borsa»?
In origine l’atto della speculazione era contrapposto alla prassi, da intendersi sia come azione produttiva che semplice attività pratica. L’etimologia della parola svela la presenza del verbo speculari, osservare, e del nome specula, con cui si indicavano gli osservatori astronomici, luoghi rialzati in cui si poteva godere di una posizione sospesa tra cielo e terra. Gli speculatores, prima ancora di diventare loschi figuri, potevano essere filosofi, esploratori, astronomi. La dicotomia tra speculazione e azione ha tuttavia un confine poroso perché, da quando l’essere umano è comparso sulla terra, la pratica del pensiero si è trasformata nelle narrazioni che hanno conformato ogni ambito della nostra vita, producendo le rappresentazioni della realtà che abitiamo, spesso senza neanche accorgercene.
Quando la «speculazione esce dalla borsa» e si riversa nella «sporta del narratore» (tanto per utilizzare le parole di Ursula LeGuin), il pensare pensare dobbiamo non basta, abbiamo bisogno di formule magiche più lunghe: È importante sapere quali pensieri pensano altri pensieri; è importante sapere quali storie raccontano altre storie. La maggior parte delle rappresentazioni della realtà su cui si sono costruite società intere raramente ha posto lo sguardo al di là dell’immagine riflessa nello specchio, soffermandosi sui contorni ben definiti di un protagonista dominante (fallocentrico, conquistatore, addomesticatore). Il risultato non è solo quello di confinare una molteplicità di soggetti in proiezioni statiche e piatte, ma anche di mettere in secondo piano la trama delle relazioni, la complessità della coesistenza, l’instabilità delle rifrazioni nell’atto stesso di specchiarsi.
Per destrutturare questo paradigma, nell’ultimo capitolo di Chthulucene, Donna Haraway ricorre al pensiero ecologico e alla narrativa speculativa femminista e fantascientifica, rielaborando le riflessioni emerse durante la sua partecipazione a un workshop di scrittura collettiva. In quell’occasione, a ogni gruppo di lavoro è stato chiesto di immaginare il futuro di cinque generazioni che si trovano a vivere su un pianeta sfruttato e sconvolto dai cambiamenti climatici – conseguenza diretta dei dispositivi di potere che una parte della specie umana continua imperterrita a generare. Le fabulazioni di Haraway si inseriscono all’interno di una mappa in divenire, in cui i mondi concepiti si moltiplicano, si sovrappongono senza escludersi e coesistono in atti di creazione condivisa, con l’intento di tracciare nuove prospettive per i tempi che verranno.
Nella storia di Haraway, le epoche dello Chthulucene ridefiniscono il concetto di Antropocene/Capitalocene/Piantagionocene costruendo un immaginario che si appella alle forze ctonie per riunire una Comunità del Compost ispirata dal processo di composizione e decomposizione che è proprio della terra, dell’humus. Racconta di un futuro possibile in cui l’umano diventa simbiotico, multiforme e alieno. Per questo è un essere queer, aperto alla mutazione che avviene nella continua generazione di parentele, nella relazione e nell’interazione con l’altro, con il non umano (da qui lo slogan «Make kin, not babies»).
Trovate qui raccolti i testi di autrici e autori che hanno deciso di partecipare a un esperimento di narrazione speculativa ispirandosi alle fabulazioni harawayane. Quando è nato questo progetto non stavamo affrontando una pandemia globale con le annesse conseguenze, ma eravamo sistematicamente adagiati su un pianeta infetto rispetto al quale si continua a speculare in termini sbagliati. Ancora più di prima, abbiamo bisogno di riflettere sul nostro stare nel mondo, di risignificare il concetto di «umanità», senza che questa implichi l’annientamento di ciò che viene considerato altro, diverso da noi. Abbiamo bisogno di trasformare il costante senso di crisi, e di ridisegnare il concetto di sopravvivenza, di vita e di morte. Alla luce di questo, i racconti che leggerete possono collocarsi all’interno di una cartografia incompleta e in divenire di spazi di rappresentazione da costruire collettivamente, su reti di alleanze sempre più fitte e simbiotiche.

I bambini della mente – Andrea Gentile
Prima di noi umani
Prima di noi, era così semplice lasciarsi andare. Ora, diciamo, non possiamo lasciarci andare, non possiamo ignorare quello che c’era, prima di noi, sul pianeta.
Non possiamo solo parlare di inondazioni, di acqua che scorre, di schiavi, re, contadini, di regni che annunciano il futuro.
Non si può andare avanti così, scrivere la nostra storia, come se fosse possibile scrivere una storia come la nostra senza un pianeta.
Frammenti sparsi in meno di un milione di anni ed ecco: avevamo un pianeta.
I frammenti andavano aggregandosi, migliaia di anni su migliaia di anni.
Poi un piccolo pianeta andò a sbattere sul nostro e, con l’impatto, fu inghiottito.
Anche i pianeti mangiano.
A quell’epoca, scopriremo, la terra era nera, una sfera bruciata.
Solo piccole fratture di un rosso acceso.
Nei millenni, impatti meteoritici.
Le rocce vaporizzate saltavano in orbita, come una grandine dorata.
La terra si squarciava sempre di più.
Il pianeta, ora, era pieno di fratture.
La sua superficie, solo fanghiglia di roccia fusa e incandescente.
Lo spazio attorno era freddo.
Dopo ogni impatto, la superficie della terra, senza aria, si raffreddava rapidamente.
Si formò una crosta rocciosa.
Erano le rocce.
Il mondo era nero, coperto da una pellicola di basalto.
Getti di vapore bianco sporco, carichi di cenere, oscuravano i coni vulcanici.
Meteoriti bombardavano ininterrottamente la superficie, frantumando la crosta nera, e rovesciando frammenti di roccia e getti di magma sulla piana circostante.
Che cosa ci sarebbe accaduto, se fossimo stati lì in quel momento?
Non esisteva, all’epoca, alcuna traccia di ossigeno.
Come avrebbero reagito le nostre narici?
Sarebbero state aggredite dall’odore pungente dei composti di zolfo.
La nostra pelle sarebbe stata ustionata dai vapori che fuoriuscivano.
Gli occhi si sarebbero bruciati per effetto dei gas caldissimi e nocivi.
La terra si raffreddava e si riscaldava.
Aveva un’ampia riserva di calore interno.
Poteva essere rovente.
Moltissimi millenni dopo, racconteremo ai nostri piccoli una fiaba.
Un uomo, Cenere, un giorno si svegliò e scoprì che sua figlia, neonata, era sparita.
«È arrivato un gigante nella notte» disse il cane di casa «e se l’è portata via».
Cenere allora andò a casa del gigante e gli chiese che fine avesse fatto sua figlia.
«L’ho mangiata, avevo fame» disse il gigante.
Cenere, tanta era la rabbia, bucò il petto del gigante e tentò di strappargli il cuore.
Poi si accorse che il gigante non aveva alcun cuore.
«Sono il gigante senza cuore» disse il gigante.
Così mangiò Cenere.
La terra senza di noi era un gigante senza cuore.
Durante l’essere umano
Per secoli, sempre la stessa storia.
Erano quelle le epoche in cui tutto sembrava uguale a se stesso.
Un respiro, un millennio.
Un respiro, un millennio.
Scoprivamo, ancora una volta, che tutto era come un cerchio.
Che l’essere umano era così buio, dentro la sua abitudine.
Faraone dopo faraone, si costruivano piramidi dopo piramidi.
Lo stato non aveva più risorse, la monarchia si indebolì.
Il paese precipitava nell’anarchia.
Uno di noi, si chiamava Ipuur, scrisse un suo lamento.
Stralci furono ritrovati nei secoli.
Diceva:
Il portinaio dice «Andiamo e devastiamo».
Il lavandaio si rifiuta di portare il suo carico.
L’uomo virtuoso va in lutto, a causa di ciò che è successo nel paese.
Il malfattore è dovunque: non c’è nessun uomo di ieri.
Davvero, il Nilo trabocca, non c’è chi ari per lui.
Ognuno dice: «Non si sa che cosa avverrà nel paese».
Davvero, le donne sono sterili e non si diviene più incinte.
Davvero, gli schiavi, i loro cuori sono amari.
Davvero, i cuori sono violenti, la peste è nel paese, sangue è dovunque non manca la morte: la benda da mummia parla, nessuno si avvicina.
Davvero, molti morti sono sepolti nel fiume: la corrente è un sepolcro.
Davvero, la nobiltà è in lutto, i poveri sono in gioia.
Davvero, il fiume è sangue.
Davvero, l’allegria è morta, non esiste più.
Davvero, tutti i morti sono come i viventi.
Quelli che erano egiziani, sono divenuti stranieri, messi sulla strada.
Davvero, i capelli sono caduti a tutti.
Davvero, grandi e piccini dicono «Voglio morire».
I bimbi piccini dicono «Non dovrebbe esistere» e si riferiscono alla vita.
Davvero, la giustizia esiste nel paese soltanto in questo modo: quello che realmente fanno, chiamandola giustizia, è iniquità.
Davvero, tutti gli animali, i loro occhi piangono.
Il bestiame muggisce per le condizioni del paese.
Davvero, il terrore fa a pezzi.
Le vie sono controllate, le strade vigilate.
Ci si siede dietro i cespugli, finché non arriva il lavoratore notturno.
Gli si ruba il carico, lo si tortura a colpi di bastone, lo si uccide iniquamente.
È tutto rovesciato!
I proprietari delle tombe sono portati fuori sull’altopiano.
Chi non poteva farsi una cassa, ora possiede una tomba.
Ecco, è successo questo alla gente: chi non poteva costruirsi una stanza, ora è padrone di mura.
Ecco, il bestiame è lasciato vagare, e non c’è nessuno per radunarlo.
Ognuno cattura per sé quelle bestie e le marchia col suo nome.
Se tre uomini camminano per la via, si trovano a essere due; il numero più grande uccide il minore.
Il paese è come un’erba cattiva che distrugge gli uomini.
Eppure, sarebbe così bello vedere le navi risalire la corrente.
La corrente che sale… è così dolce.
Il tempo di Sempre
Poi arrivò il tempo nuovo.
Lo chiamarono: il tempo di sempre.
Vite anteriori
Nei primi anni Duemila del nostro Signore, in acque e territori devastati, nacquero nuove comunità, nascevamo noi.
Ci chiamavamo Comunità del Compost.
Per noi, no, non avevamo nome.
Vita anteriore X
Nascevo.
Ecco il bambino.
Ecco l’apparizione.
Ero così diverso, così uguale.
Uno mi chiedeva come ero fatto, come ero composto, mezzo uomo, mezzo farfalla, non importava.
Guardavano ancora il corpo, cercavano l’appiglio, eppure non c’era.
Ero nato nel 2025 del nostro signore.
Ero morto nel 2100 del nostro signore.
Cercavano di dirmi chi sei, non vedo il tuo naso.
Cercavano di dirmi, noi, umani, avevamo sempre freddo, e tu?
Il tuo corpo, che non hai, riposerà in pace?
Hai un corpo?
Di me dicevano che sarei vissuto in eterno.
Tu non hai un corpo, dicevano, e quindi sei come dio.
Tu sei dio.
Io ho un corpo, dicevo, siete voi che non potete vederlo.
No.
Tu sei dio.
Allora ti chiederemo mille domande.
Pregare modifica la realtà?
Se prego riesco a cambiare qualcosa attorno a me?
Che cosa c’è dietro il mistero della morte?
È giusto cercare la felicità?
Perché per comunicare con noi stessi abbiamo bisogno di silenzio?
L’universo ha creato una parte di sé per studiare il resto di se stesso?
Perché alcuni di noi pensano, soffrono, piangono e altri no?
Che cosa c’è lassù?
Che cosa c’è quaggiù?
Che cosa c’è nell’abisso, sotto la terra?
Le stelle parlano tra loro?
Gli animali pensano?
Gli animali soffrono?
Dove finisce quello che mangiamo?
Esiste un altro luogo?
Quante sono le forme di vita che non conosciamo?
Gli alberi hanno un’anima?
E le foglie?
Quando dormiamo siamo vivi?
Dormire è come morire?
Morire è come dormire?
Il fuoco è un dono di dio?
Quando si muore, si vive?
Quando si muore, c’è solo silenzio?
Quando si muore, si diventa spiriti?
Gli spiriti esistono?
Se non esistono, chi ha creato le stelle, il sole, la luna, gli oceani?
Se esistono, perché hanno inventato la morte?
Gli spiriti sono gli dei?
Se non sono gli dei, chi sono gli dei?
Dove sono gli dei?
Sono in cielo?
Sotto terra?
Perché abbiamo dieci dita?
Esistono il bene e il male?
Il mondo ha una fine?
Il tempo è senza fine?
Il mondo è solo questo che vediamo?
L’altezza del mondo è illimitata?
Il cielo si può toccare?
La profondità del mondo è illimitata?
Si può toccare la base del mondo?
Da dove arriva un fulmine?
Gli dei mangiano?
Il vento è fatto di morti che si fanno sentire?
Quando il cielo tuona, gli dei sono arrabbiati?
Esiste il nulla?
Perché siamo gli unici a camminare su due gambe?
Può esistere il niente?
È solo buio?
Che cosa succederà?
Che cosa succederà domani?
Domani?
Continueremo all’infinito.
Continueranno all’infinito.
Vita anteriore Y
Rinascevo ogni giorno, giorno dopo giorno.
Rinacqui nel 2085.
Morii nel 2185.
Ora di me dicevano soltanto: tu non sei niente.
Di te è rimasta solo la mente.
Voli nell’aria, aleggi nel niente.
Essere solo la mente, dicevo, non è che essere niente?
La mente, dicevo, origina tutti i pensieri.
Togli i pensieri, togli la mente.
Eliminati i pensieri, non esiste niente che possa chiamarsi mente.
Togli i pensieri, togli il mondo.
Eliminati i pensieri, non esiste niente che possa chiamarsi mondo.
Quando dormiamo profondamente, esiste un mondo?
Il ragno emette il filo della ragnatela fuori da se stesso e poi lo riavvolge dentro.
Così la mente con il mondo.
Così la mente con il mondo.
Proietta il mondo fuori da se stessa per poi ritirarlo dentro se stessa.
Quando la mente esce dal sé: ecco il mondo.
Quando il mondo appare, il sé non appare.
Quando il sé appare, il mondo non appare.
Io, dunque la mente: eravamo lì, da qualche parte, in mille parti diverse.
Vita anteriore Z
Io nascevo nel 2170.
Morivo cento anni dopo.
Di me si diceva che non avevo neanche la mente.
Io dissi, da qualche parte:
Essere colpiti da una freccia fa male.
Essere colpiti dalla seconda freccia fa ancora più male.
Quando morii, al mondo, c’erano molti meno esseri umani.
Vite anteriori K, C, R, S, T
Non c’era più corpo e non c’era più mente.
Di noi dicevano che non c’era più niente.
Quelli che lo dicevano non erano niente.
Non erano voci.
No alghe.
Niente coralli.
Si sentì soltanto una voce.
Credi che domani pioverà?
Diceva.
Poi la voce svanì.
(Queste pagine sono una rielaborazione di un testo in scrittura, dal titolo provvisorio Umanità).

Dopo la natura – Felice Cimatti
2020
«Hai letto il libro di Donna Haraway, quello uscito nel 2016?» chiese la genetista, «quello con quel titolo lungo e complicato, Staying with the Trouble – Making Kin in the Chthulucene?». «Non leggo quel tipo di libri, non mi piacciono, non capisco mai dove vogliono andare a parare, quindi no, non me lo ricordo perché credo proprio di non averlo mai letto. Sai, io lavoro, non ho tempo da perdere» gli rispose il suo amico. Era un uomo di mezz’età, magrissimo, sempre indaffarato, un demografo che era passato a lavorare per le Nazioni Unite dopo avere insegnato in una università in India, un’esperienza che non gli piaceva ricordare. Dirigeva uno dei tanti dipartimenti dell’ONU che si occupava del problema della sovrappopolazione. «Sbagli», gli disse la genetista, «sbagli, è un libro importante, anche se la soluzione che propone per uscire dal disastro del nostro tempo è davvero difficile da accettare, anche solo da immaginare». La luce che riempiva la stanza delle riunioni era dolce, quella mattina: il mondo rimarrà comunque, l’antropocene passerà, come sono passati i dinosauri.
«Guarda che lo so di che parla quel libro, che credi, sono informato su tutto quello che esce di anche vagamente sensato sul problema dell’Antropocene – anche se so che è un modo di dire che non le piace, ne abbiamo parlato insieme una volta – è che non credo proprio che quella possa essere la soluzione» le rispose il demografo. «La conosci, ma dai, e allora?». «Allora che», non aveva voglia di parlare, ma l’amica insisteva: «che pensi di quel libro? Davvero, pensi sia praticabile l’idea di ibridare la nostra specie con altre specie viventi, per dare vita a quelli che lei chiama … aspetta, ho qui il libro … simbionti umano-animali, come la Camilla di cui parla nell’ultimo capitolo, l’incrocio di una bambina con una farfalla». Il demografo la fissò negli occhi: «Capisci perché non ho tempo da perdere per leggere libri come questi? Ti pare una soluzione, andare in giro a proporre a qualcuno di fare una figlia che è un po’ umana e un po’ farfalla? Ma cos’è uno scherzo? Non fa ridere, lo sai». In fondo non era una cattiva persona, aveva preso con molto impegno quello che evidentemente era il vero problema umano del suo tempo, la sovrappopolazione, troppi sapientes sul pianeta terra, troppa gente da sfamare, troppa energia per tutti i loro bisogni, troppa acqua per le loro piscine, troppo, semplicemente troppo. La terra non bastava più, nessuno poteva più dubitarne.
«Lo so anche io che come proposta non è granché, però il messaggio che lancia è semplice e potente: Generate parentele, non bambini! Non puoi negare che il problema ce l’ha ben chiaro anche lei, basta figli». Il demografo la guardava perplesso: «il punto non è questo, se permetti, ormai che la sovrappopolazione sia il problema nessuno lo nega, credo che nemmeno al Vaticano abbiano più nulla da obiettare. Il punto è la soluzione che propone: che vuol dire generate parentele, praticamente? Davvero pensi che mischiarsi con le farfalle sia una soluzione?». La genetista lo fissava avvilita, capiva benissimo anche lei che quella non poteva essere la soluzione, però era tenace, a quel libro era affezionata, e voleva salvarne qualcosa: «guarda, da un punto di vista genetico può sembrare assurdo, ma con le tecnologie di editing genetico che già conosciamo, pensa alla CRISPR o al prime editing e a tutte quelle che verranno fra poco, rendono un’ipotesi del genere non impraticabile, al contrario, si potrebbe fare, ammesso che qualcuno non l’abbia già fatto in qualche laboratorio nascosto». Lo fissò, sperando che questa risposta potesse interessare il demografo, neanche lei sapeva bene perché ci tenesse tanto a quel libro. Forse era per via del suo amore per le formiche, ne aveva una colonia in una grande teca di vetro nel salotto di casa, le piaceva quella strana idea di generare parentele, anche se doveva ammettere che non capiva realmente che cosa potesse significare.
«Lo sai cos’è», riprese il demografo, «il fatto è che quel libro l’ho letto, in verità, ma alla fine mi ha deluso, perché sta tutto il tempo a parlare di parentele, di ibridazioni, di relazioni, e così via per pagine e pagine, e poi che propone? Di modificare il genoma della nostra specie, ma non quello delle altre specie, per costruire una sorta di specie post-umana. Tutto qui? Ti ricordi la storia di Spider-Man? C’è quel ragazzino sfigato, Peter Parker, che viene morso da un ragno radioattivo e acquista dei super poteri. È sempre la solita storia, un umano più che umano, come il centauro o la sirena, che prende qualche caratteristica di valore dagli animali per diventare un umano ancora più potente. In questo caso un umano super-buono, capace di stringere parentele anche con le farfalle».
La genetista era rimasta zitta per tutta la durata della sparata del suo amico, appena fece una pausa per prendere fiato provo a ribattere: «sei ingeneroso con lei, non intende affatto dire questo, è tutto un libro contro l’invadenza antropocentrica». Tuttavia non era davvero convinta, «però, forse un po’ hai ragione anche tu. Senti qui, c’è qualcosa dell’eccezionalismo umano che rimane anche nelle sue parole: ‘alla nascita, vengono presi un po’ di geni e di micro-organismi dal simbionte animale e vengono aggiunti al bagaglio genetico del bambino in simbiosi, in modo tale che la sensibilità e la risposta al mondo sperimentate dalla creatura animale possano essere più intense e precise per il suo simbionte umano’. In effetti è qualcosa che già conosciamo, l’umano che decide per la vita degli altri viventi. Sì, qui c’è qualcosa che non convince neanche me. Forse non lo sai», gli disse a bassa voce, quasi si vergognasse di quello che stava per dire, «all’università prima di fare genetica ero iscritta a filosofia. Haraway forse non lo sa, ma la sua idea non è lontana da quella di Heidegger, che parlava dell’uomo come ‘pastore dell’essere’. Proprio il pastore, non una delle tante e anonime pecore del gregge della vita». Non riusciva ad accettare che alla fine la pensasse come il demografo, però doveva ammettere che l’idea dell’ibrido umano-farfalla proprio non la convinceva. «Ha ragione su un punto, però», le concesse l’amico demografo, «si tratta di fermare la crescita della popolazione umana, siamo davvero troppi». «Già» si e gli disse, «ma come si fa?».
2040
«Hai letto gli ultimi dati» le disse corrucciata, «quest’anno ci saranno più di 9 miliardi di esseri umani in giro per questo pianeta, e qualcuno sta già andando in giro a calpestare Marte, i tizi della planetary engineering fanno maledettamente sul serio. Tutti i tentativi che abbiamo fatto per provare a rallentare questo processo non hanno funzionato» ammise sconsolata l’economista. Era seduta davanti alla Segretaria generale delle Nazioni Unite, una nigeriana dallo sguardo stanco. In realtà non aveva avuto successo neanche nel suo paese, c’erano quasi 400 milioni di nigeriani in quel momento che lottavano per cibo, energia ed istruzione, un numero non molto inferiore alla popolazione di quasi tutta l’Europa. Lo sapevano tutti, la prossima guerra si sarebbe combattuta proprio lì, nel Mediterraneo, fra i più di due miliardi di giovani e avventurosi africani e la debole e invecchiata Europa. Comunque la situazione stava diventando incontrollabile; da un lato la crisi ambientale, con l’aumento delle temperature e la siccità che stava distruggendo i terreni agricoli in tutto il mondo, dall’altro i conflitti ormai endemici per il controllo delle risorse idriche. Avevano ancora negli occhi le immagini della guerra violentissima che era scoppiata fra Turchia da una parte e Iraq e Siria dall’altra per le sempre più misere acque del Tigri e dell’Eufrate. «Siamo troppi, e non riusciamo a fermare la crescita della popolazione umana.» La segretaria alzò lo sguardo, «guarda che lo so, non serve che me lo ricordi, non mi occupo praticamente di nient’altro, ma come vedi non ci riusciamo».
«Senti», riprese a parlare l’economista, «ho trovato in rete questo libro, Staying with the Trouble, che ha scritto una scienziata e filosofa americana un po’ più di venti anni fa. Propone una tesi talmente assurda che forse può funzionare, promuovere una cultura dell’ibridazione fra umani e animali, per costruire un futuro di umani simbionti, così li chiama, abbastanza umani da essere più o meno come noi, ad esempio rimangono capaci di parlare, ma anche abbastanza animaleschi da non avere più bisogno di sopraffare i pochi animali rimasti in circolazione». La segretaria alzò gli occhi dal dossier, l’ennesima raccolta di numeri e grafici che non faceva che ribadire quello che era evidente a tutti, bastava affacciarsi dalle finestre del palazzo di vetro, tutta quella gente, sempre, dovunque, rumorosa, volgare, invadente: «lo conosco quel libro, era stato discusso già molti anni fa, ho ritrovato una volta anche i verbali della riunione in cui se ne parlò ai massimi livelli. Ma nessuno aveva creduto credibile la sua proposta, e lo penso anche io, sinceramente» le disse mentre con lo sguardo osservava il cielo sopra Manhattan solcato dagli aerei che continuavano a portare in giro per il mondo umani annoiati e inarrestabili. «Lo so, lo so anche io, però, senti qui, quando dice generate parentele, non bambini! ci sto pensando da qualche giorno, forse ha ragione». «Che vuoi dire, non facciamo che dirlo in tutti i modi, non fate bambini, inondiamo il mondo di preservativi, la pillola è gratis dovunque, la vasectomia è una pratica di massa, ci manca che trasformiamo la maternità in un reato, e in alcuni posti già quasi ci siamo, che cosa vuoi dire allora?» le disse la Segretaria, che non sapeva più che cosa inventarsi non per risolvere il problema, che era irrisolvibile, ma almeno per liberarsi di quelli che pensavano di avere una soluzione.
«Il punto non è incoraggiare a non fare bambini, anche perché niente è più desiderato di ciò che è vietato, lo sappiamo da sempre. Il punto è un altro, a me interessa questo generate parentele. Se dobbiamo generarle vuol dire che al momento non ci sono, che non siamo capaci di stare insieme, fra noi e con il resto del mondo». La segretaria alzò gli occhi, non aveva capito dove volesse arrivare l’economista, «che vuol dire che non siamo capaci di generale parentele? E la famiglia, i clan, le mafie, tutte le infinite forme di relazione dentro cui siamo avviluppati?». L’amica stava davanti alla finestra vetrata che affacciava sull’East River, solcato come sempre da imbarcazioni di tutti i tipi, il solito inarrestabile formicaio umano; «guarda che il clan non serve a stabilire una relazione fra umani, al contrario, serve a difendere gli individui dai suoi simili. Pensa alla famiglia, a quel mostro giuridico che è diventata la nostra vita quotidiana. Prima di sposarsi ormai passi più tempo dal notaio, con tutta questa storia degli accordi prematrimoniali, che ad arredare la nuova casa. Il punto è che gli umani sono incapaci di stare con gli altri, punto, solo un illuso crede il contrario».
La segretaria generale si era già stufata, non le era mai piaciuta la filosofia, e ora doveva stare lì a sentirsi raccontare queste storie sugli uomini e sulla loro incapacità di stare insieme: “guarda, non so che farmene di queste teorie, non ci facciamo nulla, rimane che qui la popolazione continua a crescere, figuriamoci se volessimo aggiungere anche degli umani simbionti, quelli che propone Haraway”. L’economista però era cocciuta, e cinica come solo un economista può essere, e ribatté decisa: “scusami, ma non si tratta solo di filosofia, ma anche e soprattutto di biologia. Gli umani sono animali profondamente antisociali, e solo perché esistono forme coercitive come i clan, o le famiglie, possono a fatica sopportarsi l’un l’altro. D’altronde, scusa, perché esisterebbe un messaggio come quello cristiano, diliges proximum tuum sicut te ipsum se non succedesse proprio il contrario? Nessuno ti esorta a fare quello che già sei disposto a fare. No, Haraway ha ragione, non si tratta tanto di fare figli, quanto di stabilire relazioni con gli altri, e poi anche con gli animali”. “Va bene, non mi va di discuterne, tanto sono solo belle idee, ma non vedo come possiamo tradurre in pratica il suo motto: la gente continua a fare figli e a fare guerre” concluse alzandosi, come a dire che la discussione era finita, aveva da fare. “Sì, è così, è proprio così” ammise un po’ avvilita l’economista. Però quel pensiero continuava a girargli per la testa, il punto è liberare gli umani dalla voglia di farsi guerra l’una l’altro. I figli, in fondo, derivavano da questo, noi e loro, la mia terra e la tua terra, i nostri e i loro: “è che siamo ancora davvero troppo stupidi” pensò mentre lanciava uno sguardo oltre la finestra, il cielo da lassù era come sempre splendido, “se solo riuscissimo a mettere un po’ di quel cielo nella nostra testa”.
2060
“Ma stai scherzando?” gli disse la Presidente degli Stati Uniti, “davvero la proposta è stata accettata?”. Si era alzata dalla scrivania nella stanza ovale, ingombra di carte e dossier, e fissava interrogativa il biologo che per primo le aveva fatto quella pazzesca proposta, che a quanto sembrava era stata infine accettata. “Sì, sia il Senato che la Camera hanno accettato all’unanimità il nostro Post-human Birth Act. D’altronde, che cosa avrebbero potuto obiettare, anche quelli del movimento per la vita, dopo quello che sta succedendo al vallo di Trump?”. La guerra sul fronte meridionale, dopo un conflitto a bassa intensità durato decenni, era ormai deflagrata apertamente, si contavano già decine di migliaia di morti. Il Pentagono aveva già chiesto l’autorizzazione per poter usare le armi nucleari, ma la presidente non voleva usarle, sapeva che anche il Brasile disponeva di armi atomiche, quelle che gli aveva fornito la Cina, e che la desertificazione della foresta amazzonica spingeva più di mezzo miliardo di persone verso il nord ancora ricco, o almeno meno povero del sud America. Era un continente affamato quello che premeva per passare oltre quello che restava del vallo di Trump, quelle migliaia di chilometri di campi minati, bunker e filo spinato.
“Penso che mi abbiano eletto Presidente solo perché nessuno sapeva più che fare”, disse quasi fra sé e sé la donna a capo di quella che era stata la più potente nazione del mondo, e che ora era minacciata alle frontiere da centinaia di milioni di disperati disposti a tutto e distrutta all’interno dalla miscela esplosiva della sovrappopolazione e dalla desertificazione delle grandi pianure; “non si aspettavano che proprio una donna potesse fare una proposta del genere”. “Hai proprio ragione” gli disse il biologo, che stringeva fra le mani una copia ingiallita del vecchio libro di Donna Haraway. Era stato proprio il suo appello alle femministe che gli aveva fatto venire in mente quell’idea, così sfacciatamente misogina che solo una donna avrebbe potuto proporla: ‘le femministe sono state le prime a sciogliere i presunti legami naturali e necessari tra sessualità e genere, […] sesso e riproduzione […]. Se vogliamo l’eco-giustizia multispecie, un tipo di giustizia che possa anche accogliere una popolazione umana diversificata, è tempo che le femministe prendano le redini dell’immaginazione, della teoria e dell’azione per sciogliere ogni vincolo tra genealogia e parentela, e tra parentela e specie’ così aveva scritto Haraway, non avevano fatto altro che prenderla sul serio. “E ora?”, gli chiede la Presidente, come procediamo?”.
Lo scienziato aveva lavorato a questo progetto per anni, era tutto pronto, e come sempre la California sarebbe stata in testa. “L’idea è questa, semplice e vantaggiosa per tutti: fare figli naturalmente diventa un reato penale, perché rappresenta una minaccia per la salute della nazione e dell’ecosistema. D’ora in poi le nascite saranno tutte e soltanto extra uterum, controllate attraverso tecniche di riproduzione artificiale gestite esclusivamente dallo stato; soprattutto la gestazione si svolgerà all’interno di macchinari che riproducono, e migliorano in effetti, l’ambiente uterino naturale. E i figli non saranno più i figli di qualcuno, di una certa persona o di una certa famiglia, saranno i figli di tutti, della comunità. Nessuno potrà più dire ‘mia figlia’, perché nessuno potrà più essere ‘proprietario’ di un altro essere umano. La riproduzione della specie umana è troppo importante per lasciarla in mano agli esseri umani”. Rimase in silenzio, lui stesso era sconvolto da quello che aveva appena detto, ma sapeva che l’unico modo per salvare Homo sapiens e con lui il pianeta come l’avevano conosciuto dagli effetti disastrosi della distruttività umana era intervenire in modo drastico sulla sua causa, la sovrappopolazione, cioè sull’antiquata pratica e dannosissima di lasciare una faccenda decisiva come la vita in mano a degli animali incapaci di pensare alle conseguenze delle proprie azioni. “Fra l’altro”, continuò a parlare lo scienziato, più per convincere sé stesso che per rispondere alla domanda del Presidente, “in questo modo si potranno evitare malattie ereditarie, e si potrà anche migliorare la nostra specie, sia sul piano intellettuale che fisico”. “Eugenetica, si tratta di questo” aggiunse lei; lo osservava atterrita, ma era stata lei stessa che aveva proposto quella legge, ma in fondo credeva che non sarebbe mai stata approvata. E invece, la situazione era così disperata che anche una proposta così mostruosa era stata accettata. Anche il Papa nigeriano Babatunde II° da Lagos si era subito detto d’accordo (ovviamente lo scismatico Antipapa Benedetto XVII era del tutto contrario, e aveva lanciato un’altra delle sue innumerevoli e inutili scomuniche). Le tornava in mente la lettura della Repubblica di Platone, quel passo tremendo che aveva sempre pensato fosse assolutamente inumano, e ora proprio lei lo aveva trasformato in legge: ‘pertanto, man mano che i figli vengono alla luce, troveranno ad accoglierli delle commissioni di magistrati a ciò preposte, e queste commissioni, presi in consegna i figli dovrebbero portarli in asili ubicati in parti isolate della città dove abitano speciali nutrici’. “Abbiamo solo aggiornato Platone”, intervenne lo scienziato, come se le avesse letto nel pensiero, “e adattato le sue giuste idee alla possibilità tecniche del nostro tempo. In fondo i filosofi lo hanno sempre detto, non si può lasciare il potere nelle mani degli umani, non sono abbastanza intelligenti, o almeno non sono abbastanza previdenti, è duro da dirsi ma è così. Il nostro motto implicito finora è sempre stato après moi le déluge”.
“Ma siamo così sicuri che Platone avesse ragione?” gli chiese per la millesima volta la Presidente, “una decisione del genere non scatenerà una guerra civile?”. Lo scienziato sorrise, e le rispose ancora una volta come aveva già fatto tante altre volte: “la guerra civile c’è già, ora, per l’acqua, l’elettricità, l’ombra, il cibo. Piuttosto vogliamo togliere combustibile all’incendio già in atto. E vedrai che in poco tempo la nostra soluzione verrà copiata in tutto il mondo. Noi stiamo messi male, ma hai visto quello che sta succedendo in India e in Cina? Piuttosto mi meraviglio”, disse infine, “che non ci abbiano pensato prima loro. Forse la memoria delle disastrose politiche per il figlio unico li ha trattenuti, ma anche loro capiranno che è l’unica speranza che ci è rimasta”.
2080
“Ci crederesti”, gli disse la giovane seduta accanto a lui sui banchi del corso di Letteratura americana del diciannovesimo secolo, “hai letto la storia di Hester, nella Lettera scarlatta? Per avere dei figli dovevano fare l’amore, proprio fisicamente” e mentre lo diceva ridacchiava un po’ imbarazzata, “con tutti i pericoli che comporta. Certe volte ci penso, è incredibile quanto fossimo primitivi anche solo pochi decenni fa, mi vengono i brividi solo a pensarci”. “Hai ragione”, le rispose l’amico che le stava accanto, “pensa ai corpi di quelle donne, sfigurati delle gravidanze, oltre ai rischi del parto, per non parlare dell’assurdità di affidarsi al caso per la salute e il sesso dei figli. Ho letto che allora non si poteva intervenire geneticamente sul feto, un po’ non si sapeva come fare un po’ non volevano farlo, per motivi religiosi o qualcosa del genere, non ho capito bene; risultato, i bambini potevano nascere già malati, oppure con gradi deficit mentali, e a quel punto non c’era più niente da fare. È incredibile l’irresponsabilità di un comportamento del genere”. “Hai ragione” intervenne un’altra giovane, “è davvero incredibile che una questione così importante fosse affidata al caso, quando se ci pensi vogliamo poter scegliere tutto quello che ci riguarda, da che cosa studiare a dove e come lavorare, dalla persona che vogliamo vicino al cibo che preferiamo mangiare, dal modo di vestire a come passare il tempo libero”. L’ampia finestra dell’aula universitaria affacciava su un boschetto di querce, e in lontananza si vedevano le montagne innevate. La neve, almeno sulle cime più alte, era tornata, così come le foreste, che lentamente ma tenacemente si allargavano sugli spazi lasciati dagli umani. Erano tornati anche gli animali, quelli veri, che fino a poco tempo prima si potevano vedere solo nei documentari del secolo precedente.
Il professore era lì vicino a loro, c’era una pausa nel seminario, la prima ragazza, quella più spigliata e disinvolta allora glielo chiese, “scusi professore, ma com’era vivere in un mondo del genere, dove i bambini erano delle famiglie, e non ci pensava lo Stato a farli nascere e crescere?”. Il professore, piuttosto avanti negli anni, era un tipo timido e impacciato, però questa volta non si tirò indietro: “non potete nemmeno immaginare quanto fosse diversa la vita allora, anche una situazione come questa, un professore e una studentessa, era tutto molto più difficile, vecchi e giovani dovevano stare separati. Fare i figli era un problema, sempre, o perché non li si voleva fare, ma allora molti ti giudicavano male, oppure perché non ti venivano, e allora era tutto un correre qua e là dai medici perché ti aiutassero a farne uno; oppure li facevi, ma ormai eravamo davvero troppi, e ti guardavano male, perché vedevano in quel pancione, in effetti alla donne incinte si gonfiava molto la pancia, un futuro concorrente per le già scarse risorse disponibili. Non era un bel vivere, davvero, c’era sempre questa storia dei figli in mezzo, sia che ci fossero sia che non ce ne fossero”. “Scusi, professore”, intervenne l’altra ragazza, “non ho capito che c’entri la faccenda dei vecchi e dei giovani, mi può spiegare meglio, per favore?”.
L’uomo tirò un sospiro, ma ormai se ne poteva parlare liberamente, era davvero cambiato tutto. “Scusami, hai ragione, sono due problemi diversi, anche se intrecciati. Il problema era che il sesso aveva sempre a che fare, volenti o no, con la riproduzione, con la possibilità di fare figli. Anche se uno i figli non li voleva, io non li ho mai voluti, ad esempio, anche allora, ebbene anche se non ci pensavi questa possibilità era sempre sullo sfondo. Ad esempio, allora gli uomini erano attratti quasi solo dalle donne giovani e …”, “professore, scusi se l’interrompo, ma abbiamo parlato di questo nel corso sulla storia del femminismo, non c’entra niente la giovinezza, era che allora gli uomini avevano in mano il potere, e un modo per potervi accedere da parte delle donne era usare la seduzione della giovinezza, ce l’hanno spiegato così” disse l’altra ragazza con enfasi, “oltre al fatto che lei parla solo di uomini, e le donne, e i loro desideri?”.
Il professore arrossì, ma insistette: “Scusami, parlo solo per me, la mia non è una teoria, parlo solo di un uomo che è vissuto in un tempo incredibilmente diverso da questo. Posso parlare solo di quello che credo valga per me, sul perché una giovane possa essere attratta da un vecchio non so che dire, o forse vuol dire che è talmente sicura della sua giovinezza da non temere la vecchiaia dell’uomo”. “Provo a spiegarmi”, ricominciò, “lasciami finire. È che i vecchi sono sempre stati attratti dai giovani, perché i giovani sono vivi e sani, e i vecchi sono vecchi, appunto, cioè sono più vicini alla morte. Ed essere giovane vuol dire, in fondo, poter fare dei figli. Ecco perché, secondo me, i vecchi, uomini e donne, sono sempre stati attratti dai giovani. Ora, per fortuna, tutto questo non c’è più”. I tre ragazzi l’osservavano con interesse, per la prima volta scoprivano un uomo reale oltre quel professore bravo, sì, ma anche noioso, che parlava di romanzi antichi, roba da vecchi, appunto. A questo punto intervenne la prima ragazza, studiava anche filosofia, era sempre quella che arriva per prima al punto, direttamente e senza tanti giri di parole: “scusi professore, in pratica ci sta dicendo che il sesso era disturbato dalla faccenda dalla riproduzione? Ma scusi, il sesso è naturale, o meglio, ora non lo è per niente, ma in un senso biologico cosa c’è di più naturale del sesso per fare figli? Come avrebbe potuto una cosa così biologicamente necessaria come fare i figli disturbare il sesso?”. Il professore come sempre rimase sorpreso da come cogliesse sempre il punto, e sorrise, si poteva di nuovo sorridere senza problemi di fronte ad uno studente: “è proprio così, il sesso non è mai stato naturale, per questo la riproduzione, la biologia se vuoi, lo ha sempre disturbato, perché la gente fa l’amore non per fare i figli, è semplice, è sempre stato così. Ora che la riproduzione non ha più niente a che fare con il sesso, è tutto molto più libero, la giovinezza non conta più in quanto capacità di fare figli. Siamo tutti uguali, di fronte al sesso, vecchi e giovani. Non puoi nemmeno immaginare che libertà sia, essersi liberati dalla costrizione della riproduzione”. Pensò per un attimo a quanto fosse antica quella situazione, un anziano che parla a dei giovani, che l’ascoltano ma anche non lo comprendono. “Vedi, non so se riesco a spiegarmi” riprese a parlare, “il fatto è che se la gioventù significa riproduzione, la gioventù vale più della vecchiaia, è semplice. Se ora la riproduzione non dipende dalla gioventù, allora improvvisamente vecchi e giovani sono pari. E le persone possono scegliersi non per la vita implicita in un corpo giovanile, ma solo perché si piacciono. Un corpo vecchio non è un corpo sterile, ma semplicemente un corpo, così come un corpo giovane non è più un corpo fecondo, ma un corpo”. Li osservava, forse lo capivano, chissà, non aveva mai parlato con nessuno con questa franchezza: “ora ci sono solo corpi, finalmente, e il sesso è roba di corpi”.
I tre ragazzi rimasero in silenzio per qualche istante, non l’avevano mai pensata così, il sesso, la vita, la libertà. Poi la prima ragazza, la più ostinata, provò a ribattere: “mi scusi professore, c’è un vecchio libro di più di mezzo secolo fa, non ricordo bene il titolo, ha un titolo quasi impronunciabile, però c’è un passo che ci hanno fatto commentare nel corso di Post-etica bestiale, eccolo qui, ce l’ho sotto mano: ‘al centro dell’educazione di ogni bambino c’è l’idea di imparare a vivere in simbiosi in modo da nutrire il simbionte animale e tutte le altre creature di cui quel simbionte ha bisogno. Nutrire il simbionte animale significa anche essere nutriti a propria volta, oltre che inventare pratiche di cura per i sé simbiotici che si ramificano. I simbionti animali e umani fanno sì che la trasmissione della vita mortale vada avanti, ereditando e inventando pratiche di recupero, sopravvivenza e prosperità’. Ecco, mi sono ricordata il nome” disse dopo una breve pausa per riprendere fiato, “Donna Haraway. In sostanza ci dice che dovremmo imparare a vivere insieme agli animali, a ibridarci con loro, per sviluppare una specie di nuova armonia fra umani e resto del mondo. Mi sembra che lei la pensi in modo diametralmente opposto, o sbaglio?”.
“Non sbagli, per niente” rispose il professore. “Conosco questo libro, ai miei tempi, quando i figli cominciarono ad essere questione di stato e non familiare, era diventato una specie di Bibbia, tutti lo leggevamo e lo commentavamo. Ho sempre pensato che se la diagnosi era giusta, troppi figli, quindi se ne devono fare di meno, la prognosi che propone sia del tutto sbagliata. Per me il problema non è che siamo troppo lontani dal mondo animale, al contrario, è che a lungo siamo stati troppo animaleschi. Guarda la faccenda del sesso, di cui parlavamo poco fa. Finché il sesso aveva a che fare con la riproduzione era un disastro. Da quando abbiamo del tutto lasciato da parte la dimensione biologica della nostra vita, ora ci pensano le macchine a far fare e a crescere i piccoli umani, ci siamo tolti di mezzo una infinita fonte di problemi. Vecchi e giovani, uomini e donne, c’è una enorme libertà, e nessuno ha più niente da dire su questo tipo di scelta. Posso dirti, anzi, che questa è la prima epoca della storia umana in cui ci si può amare liberamente, ognuno fa quello che gli pare, tanto non ci sono conseguenze per i figli, appunto perché i figli non sono più la conseguenza dell’amore”. “Ma così non è tutto un po’ più freddo?”, provò a replicare il ragazzo, che senza nemmeno sapere perché ci tenesse ci teneva a sembrare romantico alle due ragazze. “È piuttosto il contrario”, gli rispose il professore, “pensa all’amore della tua anziana professoressa di Algebra lineare per quel giovanissimo studente, il tuo compagno di corso. Una storia del genere sarebbe stata impossibile in altri tempi, e non tanto perché un professore non può avere rapporti intimi con uno studente, piuttosto perché lui non si sarebbe mai permesso un amore del genere, proprio perché sviato dall’impensato pregiudizio biologico che ci portava sempre a preferire la giovinezza”. A questo punto intervenne la ragazza più battagliera: “ma amori come questi ci sono sempre stati!”. “Sì, ci sono stati, ma erano sempre l’eccezione, e non sai quanto fossero criticati, da tutti, vecchi e giovani; sai quante volte ho sentito dire, io stesso lo dicevo, ‘ giovani con i giovani i vecchi con i vecchi’. Ora invece un amore come quello di cui stiamo parlando non fa notizia, perché l’amore non ha niente a che fare con la riproduzione e la biologia. Si ama, così, liberamente. L’amore dopo la biologia, oltre la biologia. Non c’è più niente di animale in noi. Finalmente possiamo esplorare la nostra animalità artificiale”.
2100
La grande crisi demografica stava velocemente passando, in molti luoghi la popolazione terrestre era tornata ai livelli precedenti alla rivoluzione industriale. Era ancora l’era dell’Antropocene, ma zone sempre più vaste del mondo erano di nuovo spopolate, e gli animali, quelli di una volta e le nuove specie che si erano sviluppate nei territori più pesantemente inquinati, come il fosforescente Canis lupus radioactivus che prosperava nelle foreste dei dintorni di Černobyl’, tornavano a correre liberi e violenti come avevano sempre fatto. Gli esseri umani erano sempre di meno, ma sempre più appassionati e intelligenti, sempre più innamorati della vita. Sempre più artificiosamente bestiali.

La casa – Sara Marzullo
È iniziato l’anniversario del giorno in cui te ne sei andata. Solo tre mesi prima mi ero finalmente decisa a ridipingere la tua stanza. Avevo staccato i quadri uno alla volta, appoggiandoli nell’intercapedine tra l’armadio e il muro; alcuni li avevo sempre trovati incomprensibili, vuoti e freddi, mentre ad altri col tempo mi ero affezionata ed erano proprio quelli che avevo deciso di nascondere sotto al letto, perché ogni volta che li vedevo mi ricordavano la tua assenza.
Poi avevo staccato i chiodi dal muro, anche se non ero sicura che si facesse così, ma in quella situazione chiedere consiglio o tantomeno aiuto era fuori discussione. Non so bene come, ma ero stata capace di tagliarmi ed ero stata costretta a mettermi un cerotto attorno all’anulare – un anello di plastica rosa dove poi, in un tempo che non avresti conosciuto, sarebbe andato quello di sua madre, che le avrei restituito il giorno in cui me ne sarei andata via. Per ultima ho tolto la fotografia della nostra casa, quella che avevi scattato il primo giorno che ci eravamo trasferite qui, quando ancora stavi bene ed eravamo semplicemente felici.
Avevo dipinto le pareti poi di uno stucchevole color malva, un colore che odiavo e che avevo acquistato per corrispondenza. Al telefono avevo dettato il nome in codice al venditore: 15-TCX – non aveva niente in comune col colore che rappresentava, né con te o con me, ed era quello che pensavo di desiderare a quel tempo, qualcosa che cancellasse la memoria del passato.
Le pareti erano venute abbastanza bene, nonostante la mia impazienza. Il colore dava alla stanza quel senso di pulizia e di novità che volevo avesse, senza però essere troppo impersonale – del resto non avrei mai potuto cancellarti da quelle stanze in cui avevi respirato.
Il giorno dell’anniversario della tua scomparsa sono entrata in camera tua – la chiamavi così gli ultimi tempi, quella specie di studio in cui dicevi che riuscivi ancora a pensare. Avevo trovato la porta aperta, anche se io la lasciavo sempre chiusa, perché tu dicevi che quello spazio era tuo e che ti apparteneva e che non c’entrava né con me né con il resto della casa, quella casa in cui, posso dirlo adesso, avevamo vissuto insieme.
Sul muro color malva campeggiava di nuovo la fotografia della casa. Senza dire niente l’ho presa e l’ho rimessa sotto il letto, insieme al resto dei quadri. Non capivo allora e non avrei capito ancora a lungo. Poi mi sono chiusa dietro la porta, con un sospiro. Era un giorno difficile e sapevo che qualsiasi cosa avessi provato poteva spiegarsi con qualche acronimo, qualche sigla strana presa da un manuale di psichiatria, che significava solo che ero stanca e che, sostanzialmente, mi mancavi.
Avevamo preso quella casa in affitto appena l’avevamo vista, anche se era sempre stata troppo grande per noi da sole, ma tu dicevi che assomigliava a un ricordo, alla casa in cui tua madre era nata e che ti aveva descritto quando restavate da sole, in quel cortile in cui da bambina ti lasciava giocare. Dicevi che ti piacevano i pavimenti di legno scuro e lucido e l’erba che cresceva tutta intorno. Tutti i fiori che hai piantato, uno per ogni desiderio. Gli iris che riempivano l’aria con il loro odore, la lavanda, quel viola che ti entrava dalle finestre. Insistevi che non era un colore triste, era il colore dell’attesa e che io non lo capivo solo perché non sapevo cosa attendere.
L’acquazzone mi aveva svegliato all’alba: ancora intontita dal sonno ero entrata in camera tua per accertarmi che la finestra fosse chiusa bene e che gli infissi non stessero cedendo. Avevo aperto la porta piano, come facevo prima per non disturbarti, e dentro avevo trovato i muri tappezzati da tutti i quadri che ero sicura di aver messo via e la luce di aprile che inondava l’aria, anche se era novembre e non vedevamo il sole ormai da settimane. Pensavo di essermi sbagliata, come se quell’immagine dell’ultimo giorno insieme mi fosse rimasta incastrata sotto le palpebre. Allora ho chiuso la porta, ho preso un respiro e l’ho riaperta e dentro non c’era più niente, solo il color malva che la luce delle prime ore del giorno rendeva un po’ più freddo e triste. La stanza sembrava più vecchia e abbandonata, come poi sarebbe stata il giorno in cui me ne sarei andata anche io.
Mi mancavi e passavo le notti distesa a letto attenta a non calpestare la linea immaginaria che divideva la tua metà dalla mia. Negli ultimi mesi avevamo smesso di toccarci, ma il tuo peso rimaneva una forza di gravità irresistibile ogni volta che ti muovevi per cercare una posizione più comoda. A poco a poco ti eri fatta più leggera, finché poi non c’eri stata più.
*
Le ho viste arrivare una sera al tramonto. Lei aveva la mia età e teneva la bambina per la mano. Sono entrate in casa passandomi accanto e io non ho detto niente, non ho fermato quella che un tempo avrei chiamato un’invasione domestica, ma mi sono limitata a seguirle dentro, le loro orme bagnate che indicavano un percorso che finiva nella cucina.
La casa sembrava più quieta, più felice di come la ricordavo adesso che dentro c’erano anche loro.
Capiamo gradualmente e poi tutto d’un tratto, scherzavi sempre, così come andiamo falliti, così come amiamo. La donna e la bambina erano sedute attorno al tavolo dove ci trovavamo tutte le sere, tu con i tuoi libri, le tue ricerche, io a risolvere le parole crociate e poi, più tardi, a rileggerti quello che stavi scrivendo, ma questo solo alla fine, prima della fine.
Dicevi che ti sentivi come Lara, che eri venuta sulla terra per dare un nome alle cose e, se non ci fossi riuscita, per mettere al mondo figli che lo potessero fare al posto tuo, ma che tu i figli non li volevi e quindi quello scrittore russo si sarebbe dovuto dare pace, si sarebbe dovuto accontentare di quello che gli avresti potuto dare tu da sola. I tuoi libri, i tuoi quadri, la tua stanza, i tuoi fiori, i tuoi vestiti, i tuoi pensieri: quando eravamo insieme a me sembrava di non possedere niente, di non sapere niente. Mi eri entrata nella testa e io ti avevo lasciato fare, ti avevo lasciato prendere lo spazio di cui avevi bisogno e che non sapevo come avrei fatto a riempire dopo. Ogni tanto, quando eri di buon umore, mi chiamavi e chiedevi di entrare nella tua stanza e di mettermi davanti a quelle distese di colore che avevi appeso incorniciate al muro e mi chiedevi di avere fiducia, che lo spazio sembra vuoto finché non inizi a osservarlo da vicino. Mi dicevi che non sarei rimasta sola a lungo e a me veniva da piangere, perché era un pensiero triste, perché non volevo riempire il vuoto che sapevo avresti lasciato, perché lo avevo capito da subito che se una delle due se ne fosse dovuta andare, quella saresti stata tu. Io sarei rimasta a fare la guardia al fortino, a mandare a memoria i ricordi, a conservare quello che un tempo chiamavano presente. Lo dicevi anche prima, lo dicevi dall’inizio, dicevi che io desideravo solo essere colonizzata, che volevo che qualcuno si appropriasse di me e mi rivendicasse e che questo sarebbe successo – non c’era niente di più attraente di una landa in cui piantare una bandiera, di una terra vuota da chiamare propria.
Alla fine era successo, lo avevo capito davanti a quel tavolo. Mia figlia e mia nipote. Avevo capito gradualmente e poi improvvisamente, come sarebbe piaciuto dire a te (lo sapevo che era una citazione, anche se tu pensavi di no): al dito aveva l’anello di sua madre, quello che le avevo riconsegnato quando ci eravamo lasciate, lo stesso che mi aveva regalato il giorno in cui avevamo scoperto che avremmo avuto una figlia. Lo so che penserai che sono fatta così, che parlo sempre di memoria e che poi non vedo l’ora di disfarmi di tutto quello che mi ricorda il passato: ancora non lo so neanche io come è vivere infestata da tutti questi fantasmi, da tutte queste versioni che non sono più. Mia figlia mi assomigliava, aveva il mio naso, ma soprattutto il mio modo di dissentire senza dover parlare, muovendo solo la fronte – doveva essere cresciuta con me per imparare questa arte della ribellione insensata, una ribellione a cui non credevo neanche io, ma che dovevo averle trasmesso. E con lei sua figlia, mia nipote: sconosciute che avrei voluto farti conoscere, ma la vita con te sarebbe sempre rimasta la vita di prima, la vita di un tempo, la vita che poi avevo relegato nel tuo studio.
Con te e dopo di te ho vissuto in questa casa, e dopo di me mia figlia, mia nipote, e ancora sua figlia. Eravamo di una stirpe che fa figli, sarà stato nei nostri geni, una specie di virus che si duplicava attraverso di noi e ci diceva di mandare avanti il genere umano, anche quando sapevamo che non aveva più senso e tutto iniziava a crollare. Tu volevi controllare il corpo con la ragione, con le idee e a me sembrava sempre di camminare bendata verso un precipizio. Me ne ero andata da lì quando mia figlia era adolescente, un gesto inconsulto e inconsueto per uno spirito placido come il mio, avevo salutato sua madre, le avevo messo l’anello in mano, avevo raccolto le mie cose ed ero partita. Avevo preso la tua fotografia della casa, mentre il resto dei quadri li avevo lasciati nello studio, che avevo chiuso dietro di me: mi dicevo che ne facessero quello che volevano, ma speravo che lo avrebbero lasciato così, senza mai entrare, una scatola del tempo sigillata che fluttuava nella casa, dove il passato era ancora presente. Dopo quella prima volta, non avevo mai più dato il colore alle pareti: a cosa serviva se sarebbe sopravvissuta solo nella mia memoria? Perché lo avevo fatto, perché me ne ero andata? Non ho mai risposto a questa domanda e non penso che tu possa chiedermi adesso le ragioni per qualcosa che è accaduto in un tempo così distante, tu che te ne eri andata prima di me, senza di me. Loro erano rimaste in quella casa, alla fine, indisturbate dai ricordi: avevo riallacciato i rapporti con sua madre molto tempo dopo che me ne ero andata, dopo quegli anni passati a difendere i miei confini, a cercare di non essere quella che dicevi che ero e che in fondo sapevo di essere. Avevo accettato che mi seppellissero lì, nel giardino sul retro – avevo accettato è la definizione sbagliata, perché avevo fatto in modo che me lo chiedessero.
Le guardo insieme, felici e dimentiche di me, parlarsi, accendere le luci, passarsi i piatti, mettersi a cenare insieme, un gesto ripetuto centinaia di volte, un gesto eterno che sembra svolgersi continuamente. L’odore dell’estate, di quelle notti che sedevo sulla veranda ad aspettare che le stelle facessero il loro giro sopra la mia testa, senza saperle nominare, ignara di come si raggruppassero tra loro, incapace di separare il romanticismo dalla materia.
Adesso so che se apro la porta dello studio, la chiave ancora appesa al mio collo come una collana, ti trovo là dentro, che guardi fuori dalla finestra, con tutto quel viola che invade le pareti. E se ti chiamo – e ti chiamerò, disubbidirò ai tuoi ordini – tu ti volterai e mi sorriderai e in braccio avrai tua madre bambina, come te la ricordavi tu, in una casa simile a questa, e saremo per sempre lì, in mezzo ai tuoi quadri vuoti che adesso finalmente capisco. Dentro quella casa, che adesso non esiste più, dove non ci sono più il pavimento scuro e il tavolo a cui ci sedevamo ogni sera e attorno a cui adesso non siede più nessuno, spazzata via dal tempo e dalle stagioni, adesso che non esiste più niente, che le stelle si muovono vorticosamente intorno a una landa brulla di terra evaporata, dentro quella casa hanno vissuto persone prima di noi e poi ancora altre, e poi più nessuno e qui siamo insieme, e siamo tutti morti e siamo tutti vivi, nel tempo che segue il tempo, nel tempo in cui siamo tornate alla vita, risorte nei nostri corpi migliori.

Il Dipo – Matteo De Giuli
Ero seduto sulla vasca senz’acqua della fontana e aspettavo Mansur. Con la coda dell’occhio notai qualcosa che si muoveva. Un cucciolo di varano. Le uova si stavano schiudendo con qualche giorno di anticipo. Le vie del villaggio si sarebbero popolate presto di decine di piccoli.
Qualcuno diceva che i varani fossero ormai un centinaio, stipati nel santuario. Nessuno poteva saperlo con certezza, persino al custode era vietato entrare nelle sale interne. I varani erano creature nobili e mostruose, e per questo li veneravamo. In loro riconoscevamo la presenza divina. Pregavamo perché vegliassero sui passi dei giusti, facessero scendere l’acqua dal cielo, donassero vita a noi esseri umani.
Alcuni varani superavano i due metri di lunghezza. Avevano il ventre gonfio e la lingua biforcuta. Le squame spinose erano ricoperte di macchie. Avevano artigli lunghi quanto un mignolo e denti che avrebbero potuto divorare chiunque. Quando si allontanavano dal santuario, però, si avventuravano silenziosi per le strade del villaggio senza creare scompiglio, si lasciavano accarezzare dai bambini. Al tramonto si arrampicavano sulle mura di cinta e fissavano la striscia immobile del deserto all’orizzonte.
I varani non erano gli unici animali che Dio ci aveva fatto il dono di poter conoscere. C’erano ancora molti insetti, dalle nostre parti, e le iguane non erano sparite del tutto. C’erano i serpenti, i crotali e le vipere, in abbondanza, ma erano animali detestabili, fatali, imprevedibili. I varani – sia resa grazia a Dio – si nutrivano di quelle bestie, di quelle velenose budella. Anche per questo li veneravamo.
Poi le cose iniziarono a cambiare. All’epoca vivevo alla fine di un vicolo cieco che partiva da Bab Al Bahr, la porta a sud del villaggio, la Porta del Mare, anche se per vedere la prima goccia d’acqua bisognava viaggiare per almeno sei giorni in quella direzione. Era una piccola casa accostata alle mura orientali che avevo ricevuto in eredità dai miei genitori. Una casa povera, con i soffitti bassi. Alle pareti avevo inchiodato dei tralicci di rami di palma per isolare dal caldo e dal freddo. Mansur era il mio più grande amico. Ci eravamo conosciuti da bambini. Viveva non troppo distante, ma in una casa più grande, con un piccolo cortile e un portico in legno che aveva costruito suo padre.
Le cose iniziarono a cambiare in quel giorno di primavera. Stavo aspettando Mansur, e come al solito era in ritardo. C’eravamo dati appuntamento davanti al santuario. Mansur in quel periodo si faceva chiamare “Cavallo”. Era per via di un vecchio racconto che aveva letto in biblioteca, un vecchio racconto popolare: ci sono un toro e un cavallo che vivono in una stalla. Un giorno, sbirciando tra le travi, vedono il padrone prepararsi a partire per una battaglia. Il cavallo si fa inquieto, ha paura di morire in combattimento. Il toro invece è tranquillo. “Non mi riguarda, non ho nulla da perdere, starò qui beato comunque vada a finire”. La mattina dopo il padrone entra nella stalla e sella il cavallo per la battaglia. Tutto è pronto per la partenza quando arriva la notizia: le parti in conflitto hanno trovato un accordo. La guerra è scongiurata. Il padrone e la sua famiglia si abbracciano, piangono di gioia. Per festeggiare decidono di banchettare. Liberano il cavallo dai fardelli e sgozzano il toro.
Avevamo trovato questa favola in una raccolta – c’erano decine di libri antichi, alla biblioteca del villaggio, e Mansur li aveva letti tutti. Quando qualche viaggiatore, o un commerciante di passaggio, ci regalava un libro, o lo dimenticava, Mansur era sempre il primo a leggerlo. Detestavo quel racconto, non aveva alcun senso, e poi nessuno di noi sapeva come fosse fatto un cavallo; ma Mansur decise di farsi chiamare così, come porta fortuna. Io la trovavo una richiesta intollerabile, e continuavo a chiamarlo Mansur.
Quando finalmente arrivò all’appuntamento, era ormai ora di pranzo. Ci dirigemmo veloci verso casa sua senza dire una parola. Poi, mentre mangiavamo, iniziammo a sparlare, come facevamo spesso, del farmacista e della moglie, che si tradivano a vicenda, e del custode del santuario, uno dei nostri bersagli preferiti: si diceva che non avesse mai baciato, mai, né una donna né un uomo, e che passasse troppo tempo con i varani, che fosse diventato troppo intimo con loro… Altre volte, durante altri pranzi e altre cene, eravamo riusciti a parlare male di praticamente tutto il vicinato, il che da noi, visto che il villaggio era già da tempo per lo più disabitato, voleva dire parlare male di venticinque o trenta persone al massimo, a seconda degli anni, esclusi gli anziani e i bambini piccoli. Mangiammo palle di semola, una ricetta tipica di Mansur, un’invenzione della madre di Mansur, con melanzane stufate in salsa piccante, e poi datteri e caffè.
Dopo pranzo, sdraiati per terra accanto ai piatti, ai resti di cibo, ai bicchieri mezzi vuoti, stavamo per concederci qualche ora di riposo – e Mansur forse già sonnecchiava da un po’, con gli occhi a mezz’asta –, quando sentii delle grida e poi passi veloci, qualche porta sbattuta e frasi eccitate e incomprensibili. Guardai Mansur, che si era ridestato e badava anche lui al tramestio della strada. Ci scambiammo uno sguardo rassegnato e usciti per strada seguimmo i rumori fino alla piazza principale.
C’era una decina di persone radunate attorno a qualcosa che non riuscivamo bene a vedere, erano in piedi, in cerchio, con lo sguardo basso a terra. Mansur si gettò su di loro con la rabbia di chi è stato disturbato per nulla. Poco dopo tornò verso di me con grande calma. Mansur, Cavallo, gli chiesi, cosa succede?
È un dipo, mi disse. Chi è un dipo, cosa è un dipo? Lì, in mezzo alla folla, c’è un dipo, un animale, un dipo, mi disse. Come fai a sapere che è un dipo? Sono sicuro, mi disse, l’hanno visto venire su dalla terra, l’hanno visto spuntare da un momento all’altro, da un buco che prima non c’era, come nel racconto. Deve essere un dipo. Stava citando la favola del dipo e del serpente, veniva dalla solita raccolta: c’è un serpente che vuole divorare un dipo. Il dipo scappa, si scava una tana nella sabbia e ci si infila. Il serpente si piazza davanti all’imboccatura della tana, aspetta che il dipo esca dì per mangiarselo, ma il dipo scava, scava e scava ancora, e alla fine spunta dall’altra parte, alle spalle del serpente. “Da dove sbuchi? Non ti ho visto uscire”, fa il serpente. “Dio ti ha dato forse un grande stomaco”, fa il dipo, “ma non ti ha dato un grande cervello”.
Cercai il dipo con lo sguardo, tra le gambe degli altri e la polvere. Il suo corpo era poco più grande di uno pugno. Aveva due esilii gambette che disegnavano una specie di doppio 7 rovesciato e una coda lunga che terminava con un batuffolo bianco e nero. Le orecchie erano enormi, grandi quanto orecchie umane, sembravano poggiate per caso sul suo cranio minuto. Gli occhi erano vispi e accesi, e li muoveva freneticamente, a destra e a sinistra, mentre saltava tra la gente che lo aveva circondato.
È un dipo, mi disse Mansur. Sì, è un dipo, dissi anch’io, ma non lo ascoltavo più, cercavo solo di capire dove fosse finito. Il farmacista si staccò dal gruppo per avvicinarsi a noi. Allora, è un cavallo? Ci disse ridendo, forse sperando di indispettire Mansur. No, disse Mansur serio, e all’inizio non aggiunse altro. È un dipo, disse poi. Un dip-lo? disse farmacista. No, un dip-o, disse Mansur.
Da quel momento, tutti volevano vedere il dipo. Tutti volevano passare un po’ di tempo da soli con lui, giocarci, accarezzarlo, magari imboccarlo. Come prima cosa decidemmo di chiuderlo in una gabbietta, perché non scappasse. Poi ci sforzammo di capire cosa fargli mangiare. Ci furono lunghissime discussioni, al villaggio. Bacche non se ne parlava, le lasciava dov’erano, senza annusarle. Provammo con i datteri, e niente, e poi semi, pane, frutta secca… Riuscimmo finalmente a capire che mangiava gli insetti, anche se non sembrava andarne ghiotto, forse si abituò soltanto. A ogni modo iniziammo a dargli coleotteri e scorpioni, di quelli già arrostiti, che usavamo per le insalate.
Arrivammo a stabilire, di giorno, dei turni di visita al dipo. La gabbia l’avevamo sistemata sotto un porticato, nel caravanserraglio abbandonato. L’idea fu del farmacista, che era l’unico a usare ancora quel posto come deposito. Era un edificio ombreggiato e tranquillo, pulito, dove speravamo che il dipo potesse stare bene. La notte il portone veniva chiuso dal farmacista, che aveva le chiavi. Si prese lui l’incarico di aprire e chiudere, mattina e sera, e spesso all’alba trovava una piccola fila di persone in attesa. Le nostre vite iniziarono a girare attorno al dipo. La mia, quantomeno, presto non conteneva nient’altro. Andavo dal dipo quando era il mio turno di visita e poi tornavo a casa, a pensare al dipo.
Poco a poco smisi anche di frequentare Mansur. Lui continuò a invitarmi a pranzo e a cena, e un paio di volte mi invitò anche Giuha, il suo vicino di casa, con cui però già da tempo avevo tagliato i rapporti, dopo un litigio per questioni di gioco. Riuscii a declinare ogni loro invito, comunque, in quei giorni e nelle settimane a venire. Non volevo vederli perché sapevo che la discussione sarebbe scivolata rapidamente sul dipo, com’era ovvio, e io invece non volevo ascoltare quello che avrebbero potuto dirmi. Non volevo permettere ai loro racconti di mescolarsi ai miei, non mi interessavano le loro opinioni, non volevo sapere delle ore che passavano, prima e dopo di me, da soli con il dipo. Non volevo insomma confrontarmi con la realtà, con il fatto che pure loro di sentimenti ne dovevano avere, e forti come i miei, per quella creatura fantastica, che era adorata da tutti nel villaggio, ignorata forse solo dai varani, che non sembravano essersi accorti di nulla, continuavano a guardare l’orizzonte con il loro sguardo ebete.
Mi trasferii in un altro appartamento, poco più piccolo del mio. Era un posto che avevo già adocchiato da un po’ e che era disabitato ormai da qualche anno, da quando la vecchia proprietaria era morta di polmonite. Forse era per scaramanzia che nessuno aveva trovato la voglia o il coraggio di prendersi quella casa, ma io decisi di portare le mie cose lì, per avvicinarmi al dipo. Il caravanserraglio distava giusto una manciata di secondi a piedi.
Iniziai a fare un sogno ricorrente. Per strada intravedevo una ragazza che conoscevo. Non era una ragazza in particolare, direi piuttosto un misto di due o tre ragazze che la mia mente ripescava tra quelle che negli anni erano passate per il villaggio. Nel sogno la raggiungevo, lei si voltava, mi accorgevo che i suoi occhi erano quelli del dipo. In quel momento tutto si faceva iridescente, pacifico, sentivo il peso del mondo che si sollevava, era come se non rimanesse altro che luce, o dolcezza. La mattina mi alzavo e andavo a visitare il dipo, e quando ero lì cercavo di incrociare i suoi occhi. Il suo sguardo mi sembrava ormai sempre più spento, col passare dei giorni, sempre più stanco e impaurito in quella gabbia in cui ormai non abbandonava mai l’anglo più distante, ma io cercavo lo stesso i suoi occhi e quando li incrociavo rivivevo, guardandoli, almeno un piccolo frammento di quell’estasi dorata che provavo nel sogno.
Un giorno, finito il mio turno di visita al caravanserraglio, incontrai Mansur per strada. Riuscii a seminarlo senza che lui se ne accorgesse, o almeno così sperai. Un’altra volta lo incontrai che stava insieme a Giuha, parlottavano camminando. Capii che erano già troppo vicini perché potessi darmi alla fuga e decisi di non abbassare lo sguardo. Mi preparai a salutarli, anche se non ne avevo la minima voglia, ma mi passarono accanto fingendo di non vedermi. Parlavano del dipo. Lasciai che mi superassero e iniziai a seguirli a qualche passo di distanza. Giuha disse qualcosa sul sorriso del dipo. Il suo sorriso, i suoi denti candidi. Capii che era impazzito. Come può sorridere un dipo? Mansur invece annuiva. Pensai a quanti stupidi discorsi di quel tipo mi ero risparmiato decidendo di non vederli, in quelle settimane, e mi sentii improvvisamente sollevato. Continuai a seguirli per un po’, poi chiusi gli occhi per un attimo, per tornare a pensare al dipo, alla sua immagine che conservavo dietro le palpebre. Non sorrideva, o forse sorrideva, ma non con la bocca: lo faceva dal fondo del suo spirito, con il cristallo del suo sguardo. Tornai a casa, e capii che con Mansur non ci saremmo più parlati.
Poi una notte feci un sogno nuovo. Era un incubo orribile, opprimente, di cui ho solo dei ricordi vaghi, al di fuori di un particolare: nuotavo a fatica in una melma densa. Mi svegliai, e tendendo l’orecchio sentii dei rumori per strada: di nuovo gente che urlava. Non ci fu bisogno di alzarmi questa volta, sapevo benissimo cosa era successo. Il dipo non c’era più.
Dei giorni che seguirono non ricordo nulla, ma ho imparato a ripetere quello che accadde, come in un resoconto, un bollettino di guerra. Il dipo non venne più trovato. Si cercò ovunque senza successo, venne ispezionata ogni abitazione, anche quelle vuote da tempo. Nessuno si fidava più, in ogni momento ti poteva entrare in casa qualcuno per frugare tra i cassetti, i bauli, gli armadi. Venne nominata una commissione di notabili del villaggio per la gestione dell’emergenza. Si sciolse dopo poco per dissidi. Iniziò a circolare la voce che fosse colpa del farmacista, che fosse stato lui a uccidere il dipo e usare il suo sangue per qualche intruglio medico. Le voci durarono per settimane, finché non venne ucciso, il farmacista, assieme alla moglie e alle figlie, e la sua casa data alle fiamme.
Nel giro di poco iniziarono nuove voci, la più ricorrente dava la colpa ai varani. Se l’erano mangiato. Nessuno badava ormai più ai varani, li avevamo considerati così poco, negli ultimi mesi, che ci eravamo dimenticati anche di accusarli della scomparsa del dipo. Eppure era così evidente: erano stati i varani. Li sgozzammo tutti in un solo pomeriggio, e non ci fu una sola persona che fece notare che non poteva essere stato un varano a rompere la gabbia del dipo, scardinarla con quella forza e quella precisione, nessuno, neanche io, ebbe il coraggio di dire che quella era stata opera di un essere umano.
Il custode l’avevamo già ucciso. Aveva accolto la folla senza sorpresa, con uno sguardo triste, o forse solo uno sguardo rassegnato, aveva abbassato la testa prima di venire sommerso dai colpi dei bastoni. Sgozzammo i varani e ammassammo i loro cadaveri all’entrata del santuario, accanto a quello del custode. Qualcuno di noi, i più grossi e muscolosi, provò a buttare giù le mura e le colonne del tempio, ma era un edificio antico, con fondamenta profonde, le lastre massicce dei muri coprivano blocchi di cemento armato, e così non venne giù nulla se non qualche fregio e un pezzo di arcata.
Mi ricordo la puzza, il fetore di cadavere, che per tutta la notte mi raschiò la gola e che la mattina aumentò con le prime luci dell’alba. Verso mezzogiorno si alzò un po’ di vento e sentii nell’aria una vibrazione, la tensione elettrica inconfondibile che di solito annuncia una tempesta di sabbia. Succede così: una cappa di calore denso inizia a sfiancare i muscoli delle gambe e appesantire i polmoni, poi l’aria viene spazzata via da un vento violento, ma caldo anche quello, e i turbini di sabbia sempre più alti iniziano a oscurare il sole.
A casa, mi preparai alla tempesta come potevo, cercai di coprire le fessure delle porte con stuoie di juta, appoggiai il materasso alla finestra più grande e lo fissai lì spingendoci contro una vecchia credenza. La tempesta iniziò a ululare. Nella penombra mi sedetti in un angolo e poggiai la testa al muro. Una fitta di agitazione iniziava a prendermi lo stomaco, appena percettibile eppure già sfiancante. Seguii con lo sguardo le minuscole crepe che dal soffitto scendevano giù per il muro mentre la polvere riempiva la stanza. Sentii sbattere porte e finestre e sentii i rumori secchi di qualcosa che si frantumava, per strada, forse le palme, i rami spezzati delle palme.
Nel frastuono, la sabbia entrava in casa in piccoli lampi densi di luce e la polvere continuava ad accumularsi dappertutto, negli angoli, sui pochi oggetti della cucina, sotto le unghie delle mani, sulla punta della lingua. Pensai a Mansur, mi venne voglia di gridare il suo nome, ma pensai anche a Giuha, al farmacista e alla moglie e cercai di ricordare lo sguardo dei varani, Dio li abbia in gloria. Mi preoccupai, stupidamente, dei libri della nostra biblioteca che si stavano riempendo di granelli e che forse già da un pezzo erano stati spazzati via chissà dove. La tempesta continuò a soffiare, sbatteva furibonda contro il villaggio, si insinuava tra le fessure delle finestre. Chiuso in casa, madido di sudore, con gli occhi secchi per la polvere e la mente intorpidita, invaso dalla sensazione opprimente di non avere più speranza, ricordo però di aver pensato che prima o poi sarebbe finta. Prima o poi la sabbia si sarebbe placata. Ma avevo torto, non c’è riparo dalla tempesta. Da quel giorno il vento continua a sbattere senza sosta. Ancora oggi fa oscillare le mura delle case, le agita nella lenta danza macabra di cui siamo prigionieri.

La nuova Arte della Guerra – Laura Pugno
Ultima nota e frammenti
“Quella che segue, e che è riportata qui, è l’ultima trascrizione attendibile, anche se molto incompleta, del testo che si è cominciato a conoscere volgarmente come nuova Arte della Guerra, in analogia col manoscritto umano di Sun Tzu riportato sul bambù, nel II secolo a.c. prima della Città foresta mondo, e ritrovato nel 1972 prima della Città foresta mondo.
La parola testo è inadeguata, ma mentre scrivo, mentre si levano gli incendi, non ne ho altre. Negli ultimi giorni i roghi sono diventati continui, come se la natura stessa andasse a fuoco.
Non c’è tempo e il fuoco è già molto vicino. Qualcuno forse troverà queste parole, forse capirà cosa è accaduto.
“Tutto è già andato a fuoco, queste parole sono già state trascritte”.
Non c’è tempo–“
Qui la scrittura si interrompe e l’originale è macchiato di sangue, bruciato dal fuoco. Ricomincia con una calligrafia diversa e una forma di scrittura più antica. Nel segno c’è qualcosa di incerto, che cambia continuamente. Chi l’ha scritto sembra disabituato alla scrittura a mano. Il Mutamento era già in corso, ma ancora non se ne comprendeva del tutto la portata.
Per quanto si tenda a considerarlo come un tutto unico, è probabile che il testo noto come Arte della Guerra sia stato composto nel corso di anni, se non di intere generazioni. Forse si trattava di un gesto, di un processo rituale il cui significato non ci è chiaro, e potrebbe anche essere impossibile da ricostruire, perduto per sempre. Composizione come compost, farsi seme e terra, germogliare nella mente. Possiamo immaginare che fosse questa l’intenzione? Forse il testo veniva letto in comune, in occasione di incontri annuali, o al mutare delle stagioni, solstizio ed equinozio, recitato in comune, riunificato nelle sue parti fatte di corpi, umani e non umani. È solo un’ipotesi, ma forse non lontana da una verità.
Inizia così:
“Il testo che segue è stato ritrovato scritto su foglie, su brandelli di corteccia e in parte su corpi di donne e uomini, su foglie e corteccia d’alberi, mortali che poi sono morti e si sono propagati come semi, come radici, come compost.
Che il testo fosse scritto non è forse la parola adatta.
Le parole, in lingue umane e in quelle che allora si cominciavano appena a riconoscere, balbettando, come lingue vegetali, non umane, fitogrammi, sembravano a volte incise, a volte marchiate a fuoco, altre volte ancora sgorgate spontaneamente come resina. Inchiostro, sangue, terra, linfa. Materie chiare e scure.
Sull’origine di quelle parole, le donne e gli uomini che ne erano portatori – quando è stato possibile raccogliere la loro testimonianza – hanno raccontato nel tempo storie diverse.
A volte avevano tracciato da soli le parole portate su di sé, di propria scelta, sul proprio corpo, come spinti da un impulso insopprimibile. Altre volte era stato qualcuno di fiducia a tatuare loro addosso i segni o gli ideogrammi, in lingue spesso sconosciute, invitandoli a prendersene cura, a custodirle sulla pelle. Ancora per altri si era trattato di una imposizione, di un atto violento: erano stati sequestrati e costretti a diventare il messaggio, non erano più riusciti a toglierselo di dosso e dalla mente, e ancora lo vivevano con dolore e vergogna. Infine, per altri ancora, il testo era apparso sul corpo, come rugiada su steli e su dita al mattino, o come resina che stilla da uno spacco nel tronco, insieme a una sensazione di gioia, di gioia profondissima, senza nessuno sforzo.
Per quello che le ricerche che da un certo punto in poi sono state condotte hanno potuto stabilire, brandelli del testo sono stati ritrovati non solo su foglie e corteccia, ma anche all’interno di alberi secolari al momento dell’abbattimento o della morte, nei cerchi più segreti dell’interno, come un codice cifrato. E sulla pelle di animali domestici negli ultimi allevamenti ormai in disarmo, o di animali selvatici o rinselvatichiti, più frequentemente questi ultimi.
Tutti i portatori del testo dovevano evidentemente essere mortali. Nessuna parte del testo è stato trovata scritta – affidata – a carta o pietra o su schermi, a parte trascrizioni come questa.
È impossibile pensare alla nuova Arte della Guerra come a qualcosa di completo.
Infatti, in ogni momento, alla morte del mondo di uno dei suoi portatori, il testo ha cessato di essere completo – se mai lo è stato, se mai questo stato di completezza è avvenuto – o forse la sua completezza può essere pensata solo in modificazione, in movimento, verso l’alto, verso il basso, sempre come un tendere a –.
Ricostruire, ammesso che questo concetto abbia ancora un senso, la versione originale – per quanto sempre necessariamente incompleta – ha richiesto un lavoro di anni. Questa trascrizione la ferma qui, su questo che non è un corpo, ma tutte le sue parti – foglie, corteccia, resina, uomini e donne e alberi – stanno morendo e rinascendo, anche in questo momento.
“Il terreno cambia
sotto i tuoi piedi, quando lo infiltri. Così cambia
la tua pelle, quando ti impossessi del sole
quello che vuoi è impossessarti del sole
divorare il sole.
Queste parole non sembrano provenire da una voce umana. Le ascoltiamo finché un uomo bendato entra nella stanza
condotto davanti a noi a forza. La sua pelle
sembra, a tratti, nelle parti
scoperte del corpo somigliare alla corteccia. Altri
due uomini lo tengono per le braccia,
lo costringono a sedersi per terra.
L’uomo bendato si rannicchia in posizione fetale, è come
se facesse tutt’uno col suolo. Ripete la sua nenia:
Il terreno è la tua pelle, è senza sforzo
è il vuoto che ti contiene
è il pieno –
resina saliva bava,
nervature e intelligenza. La mia intelligenza
è in tutto il corpo.
Uno dei due uomini che hanno condotto
l’uomo bendato nella stanza –
e che indossa un’uniforme stracciata –
gli scopre un braccio. Vediamo parole
che sembrano emergere dalla pelle,
come scritte con la linfa.
L’uomo in uniforme
strattona l’uomo bendato, lo minaccia.
Cosa c’è scritto qui, cosa dice? Traduci!
L’uomo bendato
non sembra cosciente, sembra altrove.
Conficca le dita nella terra, protende
il corpo verso l’alto. Un raggio di sole,
proveniente dall’unica finestra della stanza,
lo colpisce in faccia.
La mia intelligenza è in tutto il corpo
la mia vita è in tutto il mondo.
La mia vita è tutto il mondo
La mia intelligenza –
L’uomo in uniforme stracciata schiaffeggia il prigioniero. La nenia si interrompe.
Nella stanza fa caldo, il sole sembra invadere tutto.
Un ronzio viene da fuori, un rumore basso, appena sensibile.
La città è mondo è foresta è bosco è tutto il mondo
Il mondo che è bosco è tutto il mondo
tutto il mondo è terreno ogni
terreno è terreno di morte
in un terreno di morte combatti
in un terreno di morte combatti
L’uomo bendato sembra scosso da un tremito.
Cerca di parlare, ma è come se le parole
non uscissero dalla sua bocca. Il ronzio
diventa sempre più forte,
quasi intellegibile
come se fosse un coro
tutto già è andato a fuoco
queste parole sono state già trascritte
affidati al vento
fai parte del vento spàrgiti ti spargerà –
per il cielo e la terra
il cielo e la terra
il cielo e la terra
Il caldo, adesso, è insopportabile.
L’uomo in uniforme stracciata
afferra una brocca piena d’acqua, beve
e quasi se la rovescia addosso.
L’acqua sembra acqua di fiume,
acqua del Grande Fiume,
è fangosa,
è piena di terra,
è più terra che acqua.
L’uomo in uniforme ha le labbra sporche di terra,
si passa la lingua sulle labbra,
non ha placato la sua sete.
Rovescia le ultime gocce addosso al suo prigioniero,
che mugola di piacere.
acqua con sole
acqua con sole
sopravvivenza e distruzione
sopravvivenza e distruzione
– s’interrompe
s’interrompe
s’interrompe –

Fate figli, non alleanze – Leonardo Caffo, Carola Provenzano
Ciò che accade, il fatto, è il sussistere di stati di cose
Ludwig Wittgenstein, Tractatus
Donna Haraway parla dei Bambini del compost, ovvero delle generazioni future, attraverso cinque generazioni a venire, di «madre» in «figlia» partendo dalla pratica dell’ingegneria genetica e dalla relativa insorgenza dei simbionti, dalla conseguente decrescita demografica, e in una nota arriva a parlare esplicitamente di antinatalismo e trigenitorialità. E questo lo sappiamo: e va di moda.
Invitati a contribuire a questo esercizio di narrativa speculativa ci siamo trovati un po’ in imbarazzo: siamo nel dicembre 2019 e a marzo 2020 è previsto l’arrivo di nostra figlia Morgana: siamo dunque la causa di uno dei tanti scenari apocalittici descritti dalla Haraway? La storia di Camille di cui parla Haraway tradisce, a nostro avviso, un’assenza di coraggio: perché dovremmo immaginare solo alleanze e non nuove forme di vita che siano esse stesse il risultato di una alleanza? Questo, invece, è ciò che non sappiamo.
Nel postumano di Donna Haraway il femminismo diventa paura: dobbiamo ancora avere la forza, crediamo, di essere genitori. Eteronormativi? No: semplicemente capaci di trasformare la somma tra due esseri viventi in una nuova potenza che miri all’incertezza.
Mentre ci siamo messi a lavoro su queste poche pagine ci siamo accorti che Morgana ci sussurrava, dalla pancia da cui ancora è protetta. «Generate bambini, non parentele».
Le parentele sono la necessità di un egoismo, di un noi che continua nell’altro costituendo somme potenziali: i bambini sono la scommessa non di un futuro immaginato, ma di un futuro che necessariamente avverrà.
Donna Haraway ci dice che rapporti di parentela si possono formare in ogni momento della vita e noi questo non lo contestiamo; contestiamo la paura di limitarsi ad inventarsi genitori: gli impegni davvero forti sono quelli in cui non si unisce ciò che esiste ma si costruisce contesto per ciò che ancora non esiste. I figli sono il valore di una variabile vincolata al contesto della rappresentazione del futuro.
Generare parentele per ridurre il numero di esseri umani, dice la Haraway, lasciando allo stesso tempo prosperare gli umani e le altre creature che esistono già qui: a noi questo appare onestamente di una tristezza concettuale massacrante. Non dobbiamo ridurre umani per dare gioia, ma produrre gioia per dare forma agli umani.
L’unico vero simbionte si chiama speranza.
Ecco dunque un piccolo popolo di Morgane: un’unica Morgana e cinque suoi momenti. Dunque una morgana spazio-temporalmente estesa.
MORGANA 1
2020
Il 13 Marzo del 2020 nasce Morgana: il mondo è pieno di paure e incertezze.
Ciononostante Morgana fluttua e nuota nello spazio della madre, ascolta le parole del padre, viene al mondo improvvisa sospesa da un cordone: l’alleanza è anche la materia che collega e poi libera e si libera.
Ma cos’è una vita prima che venga al mondo? Perché in qualche modo la loro speranza, delle non-vite, è già la nostra?
La vita che viene, non quella che esiste già, ci obbliga a costruire la luce che dovrà accoglierla.
Morgana non sa nulla del fuori, eppure dal dentro ha imparato qualcosa. Questo qualcosa è un mistero che l’alleanza nasconde, mentre la vita che arriva rivela. Morgana è il divenire altro: la materia presente nel corpo di Carola si stacca, produce altra vita, nuova coscienza: chi lo sa a cosa si appenderà, in futuro, questa esistenza che nasce.

MORGANA 2
2040
Il 13 Marzo del 2040 Morgana ha vent’anni. È bellissima, libera dalle gerarchie di genere e sesso. È donna, ma anche uomo, anche animale, addirittura anche pianta: è tutti i nomi della storia. Non era pazzo Nietzsche, eravamo folli noi: Morgana è il nome di tutti i nomi possibili. Gli umani che l’hanno generata, quelli che l’hanno accolta, hanno dato forma a un mondo popolato ma libero: la crisi degli anni passati non ha generato bombe, ma vuoti che sono stati riempiti di convivenze. A questo mondo ha contribuito lei stessa nella comprensione della fiducia che le è stata data dalla scommessa di averla messa al mondo: lei sa che nulla era scontato, che nel 2020 da più parti si pensava a un mondo perduto e senza speranza, in crisi per l’ecologia, in pericolo per la sovrappopolazione.
Ma Morgana sa adesso che il punto non era la quantità, ma la qualità: cento persone possono fare più male di un miliardo se non hanno imparato a stare al mondo. Morgana è stata allieva del suo cane, maestra di suo padre, l’uomo della sua donna: ogni categorie è stata capovolta. Aveva senso venire al mondo, essere gettati da questo lato.

MORGANA 3
2050
Il 13 Marzo del 2050 Morgana ha trent’anni. Insieme alla sua compagna deve decidere se fare o non fare un figlio. I metodi sono infiniti, è finito il binario maschio-femmina del passato. Un vecchio libro di Donna Haraway, ripescato dalla libreria dei genitori ormai anziani, le appare davanti: «Generate parentele, non bambini». È uno slogan che adesso Morgana percepisce come violento: come è stato possibile scambiarlo per rivoluzionario? Si accorge del coraggio che i suoi genitori devono aver avuto, della fatica del far venire nel mondo: senza quella fatica oggi, il suo punto di vista, l’amore per la sua compagna, le letture e la bellezza viste in trent’anni, non esisterebbero nemmeno: chi siamo noi, si chiede Morgana, per bloccare il processo di generazione dell’esistente?
Una cosa è l’aborto singolare, giustificatissimo, una cosa è quello universale: l’egoismo di chi possiede già la vita e non vuole più darla. Nel 2050 questo pensiero ormai antico viene chiamato “fascismo ecologista” ed è proibito per legge.

MORGANA 4
Il 13 Marzo del 2060 Morgana ha quarant’anni, Camilla – sua figlia – ha nove anni ed è bellissima. Un po’ zebra, talvolta mosca, Camilla non è altro che una forma di vita fuori dalle tassonomie. Gli umani hanno appena firmato la carta universale del disarmo, sono vegani e non uccidono più animali per mangiare come i loro antenati, gli stati nazioni sono ricordo di una Pangea geopolitica di cui Morgana e Camilla sono abitanti. Abitanti come ogni vivente sul pianeta: non sono serviti tentacoli per allearsi, ma visioni che permettessero a chi ancora non era al mondo di essere educato alla cultura dell’orizzontale e non del verticale.
I nonni di Camilla, ormai morti da qualche anno, ricordano con il loro lavoro passato a Morgana per cosa ha avuto senso lottare: scommettere nel progresso, non nell’apocalisse. Abbiamo attraversato un periodo, chiamato oggi pre-contemporaneo (gli inizi degli anni 2000), in cui andava di moda essere accelerazionisti, catastrofisti, estinzionisti, transumanisti: oggi Morgana e Camilla, felici, sanno che genere di follia sia stato il pensare male di se stessi rappresentandosi il futuro. Bastava imparare dalle farfalle, non allearsi con loro: fermi, seduti a osservare una nuvola, il senso della vita era tutto qui.

MORGANA 5
Il 13 Marzo del 2100 Morgana è ormai anziana. Anche lei, come i suoi contemporanei non teme la morte e cede la vita a chi verrà.
Camilla vive con i suoi figli dall’alta parte del mondo, nelle foreste vicino a Chernobyl dove le comunità di parlanti dell’esperanto si sono stabilizzate da qualche anno. In mano tiene un disegno della madre, le ricorda di cosa significasse aspettare qualcuno di cui neanche conosci il volto: i figli sono questa cosa qui, la possibilità di lottare per ciò che ancora non esiste.
Nessuna alleanza tra i viventi è tanto forte quanto quella con chi ancora deve venire al mondo. Homo Sapiens non esiste più, la specie a cui appartengono Camilla e gli altri si chiama “Postumano Contemporaneo”: si sta, come scarafaggi, in silenzio paziente attraversati dal mistero delle cose. L’epoca non ha nessun nome: nominare i tempi geologici con aggettivi umani oggi, da tutti, è ritenuto sintomo che la Storia del passato è stata piena di arroganza e che, grazie a Dio, non potrà più tornare.


Making kin, not babies – Gloria Baldoni
La prima aveva da poco superato il quinto mese. Una mattina d’estate stava attendendo che le venisse portata la colazione quando avvertì un piccolo dolore, come una punturina nella pancia. Mentre le punturine si moltiplicavano e si ramificavano in crampi che le tagliavano il fiato, non ebbe bisogno di abbassare lo sguardo o toccarsi le cosce per sapere del sangue. Un’ora dopo era già sedata.
La direzione sanitaria non si allarmò. La selezione delle donne era stata condotta con la massima cura proprio affinché l’eventualità di aborti spontanei e gravidanze non portate a termine fosse molto rara, ma la commissione medica era stata chiara col ministero: azzerarla non si poteva, soprattutto tra le primipare. Una donna su cinquemila rientrava senza dubbio nel margine di rischio calcolato, anzi erano stati fortunati che non fosse mai accaduto in tutti quegli anni. Dopo aver condotto gli esami necessari la misero a riposo e le cambiarono la dieta. Qualche mese dopo sarebbe stata più forte e pronta per essere ingravidata di nuovo.
La notizia non trapelò alla stampa né raggiunse il ministero ma circolò quasi subito tra i medici impiegati nel programma di riproduzione, abituati a tenersi in contatto. Tutti concordarono che non c’era ragione di ingigantire l’incidente. Anche quando una settimana dopo ci fu un aborto spontaneo in una seconda clinica, e il giorno successivo un distacco della placenta in una terza, a nessuno venne in mente di collegare i tre eventi.
Poi però tutto precipitò rapidamente. D’improvviso ogni clinica ebbe un caso, poi due casi, poi dieci casi. La maggior parte delle gravidanze si risolveva in aborto e le poche donne che arrivavano al termine partorivano un bambino morto, spesso perdendo la vita anch’esse. I medici non ci si raccapezzavano: continuavano a programmare ecografie, a controllare FSH AMH LH prolattina estradiolo, a sottoporre le donne a isterosalpingografia. L’esito era sempre lo stesso: nessuna malformazione, nessuno squilibrio ormonale. Allora buttarono tutti i campioni di sperma e ne fecero arrivare di nuovi. Niente da fare. Non nascevano più bambini.
Il programma di riproduzione era stato messo in piedi dieci anni prima per rispondere a un’evidenza ormai incontrovertibile: la popolazione umana era troppo numerosa. Sebbene vecchie e nuove malattie ne avessero falcidiata una buona porzione, l’innalzamento delle acque avesse rosicchiato i continenti seppellendone un’altra parte, e molti popoli si fossero estinti in aree ormai inabitabili, lo squilibrio tra le sempre più limitate risorse a disposizione e il numero di abitanti della terra rimaneva troppo ampio. Era stato facile far sì che una politica di ferreo controllo delle nascite, tutto concentrato nelle mani dello stato, ottenesse il consenso comune — ancora di più perché ormai tutta la popolazione della terra si era dovuta rifugiare nell’area centrale dell’unico continente abbastanza temperato da poter essere abitato, così da formare un unico stato.
A definire il programma di riproduzione fu un tavolo formato da una commissione medica e una giuridica. Il numero di donne giudicato soddisfacente fu cinquemila, da selezionare su base volontaria affinché nessuno potesse parlare di coercizione. Tutte le candidate erano state sottoposte a esami scrupolosi e, se ritenute idonee, trasferite subito in cliniche apposite, per essere ingravidate attraverso l’inseminazione artificiale tante volte quante il loro corpo ne avrebbe permesse. Firmando il contratto con il governo, le donne rinunciavano alla potestà sui nascituri, che sarebbero stati allevati in strutture dedicate, e alla possibilità di opt-out. Parecchie donne, per la maggior parte povere, tentarono di entrare nel programma, soprattutto perché fu presentato come un progetto vantaggioso sia per quelle che ne facevano parte, finalmente sollevate dall’accudimento dei bambini, sia per quelle che ne erano rimaste escluse, che invece — ed era questo che ora terrorizzava i medici — erano state sterilizzate in massa.
Quando la faccenda dell’interruzione delle nascite divenne di pubblico dominio, furono in pochi a crederci. Non era possibile che da cinquemila donne non si riuscisse ormai da mesi a cavare un bambino. Si fantasticò a lungo di complotti e di segreti di palazzo. Molti dei familiari delle donne coinvolte pretesero di vederle per accertarsi della verità: non trovarono che conferme. Subentrarono allora lo sgomento e l’ansiosa ricerca di soluzioni praticabili. Le commissioni si riunirono di nuovo: poiché sostituire le donne non si poteva, dal momento che la sterilizzazione delle altre non era reversibile, decisero di attendere il menarca delle prime bambine nate dal programma di riproduzione e tentare di ingravidarle subito. Titubarono nel comunicare questa scelta al ministero e al pubblico, ma fu uno scrupolo eccessivo: fu accolta con entusiasmo. Era chiaro che di fronte alla prospettiva dell’estinzione l’età di quelle ragazzine non costituiva un discrimine morale per nessuno. Così come le loro madri, però, le undicenni condotte in clinica non portarono a termine nessuna gravidanza. Così come le loro madri, impararono a eludere ogni controllo e limitazione e presero a suicidarsi per il dolore, la vergogna, l’impotenza. Tra i suicidi e le morti in sala parto, nel giro di pochi mesi non rimasero che alcune centinaia di donne. Per comodità furono riunite in un’unica clinica.
La medicina non sapeva spiegare il fenomeno né porvi rimedio: non era neanche il caso di parlare di uteri artificiali, la ricerca era stata abbandonata anni prima e ora il tempo a disposizione non era più sufficiente, e tutti i tentativi di fecondazione interspecie con vacche e scrofe prelevate dai macelli fallirono. Nella clinica non fu necessario ordinare di sospendere le inseminazioni: furono sospese e basta. La specie umana sembrava aver abbandonato ogni caparbietà, ogni risolutezza nel perpetuare se stessa. I corpi femminili non erano più adatti alla vita, e nessuno sapeva perché.
Intanto le donne vivevano senza scopo in un tempo dilatato, immobile e non più scandito da esami, gravidanze, parti. Alcune avevano chiesto di poter tornare a casa, ma poiché il programma era ancora ufficialmente in piedi il permesso era stato negato. Così smisero di chiedere e rimasero nella clinica. Continuavano a ricevere cibo ma non vitamine, passeggiavano nel parco ma lo yoga prenatale e le sedute di osteopatia erano spariti dai programmi giornalieri. Anche l’assistenza psicologica, imbastita in gran fretta quando ancora si pensava che non riuscissero più a portare a termine le gravidanze per stress o nevrosi, era stata cancellata. Solo pochi mesi prima il più importante degli incarichi le rendeva essenziali e meritevoli della massima cura. Ora, mentre l’umanità si rassegnava all’estinzione della propria specie, non c’era più niente a distinguerle dal resto dei mortali.
Restavano però uno scottante problema politico. Durante la messa a punto del programma di riproduzione, l’ipotesi che tutte insieme smettessero di restare incinte e partorire non era stata presa in considerazione né dalla commissione medica né da quella giuridica. C’era un fondo pensionistico che garantiva una buona entrata a quelle che entravano in menopausa, ma per ovvie ragioni l’infertilità non era coperta. Né d’altronde era possibile svincolare lo stato da ogni responsabilità nei loro confronti adducendo un dolo: le donne erano sempre state così strettamente sorvegliate che non avrebbero avuto nessuna possibilità di procurarsi un aborto. In più, negli ultimi mesi del programma molte di loro non erano neanche rimaste incinte.
Scoprirono così che anche sullo scorcio dell’estinzione quell’umanità rimaneva uguale a se stessa. Ci furono manifestazioni di piazza sempre più partecipate e lunghe sedute parlamentari. La questione era semplice: i soldi erano pochi, le risorse anche (non era forse per questo motivo che era nato il fallimentare programma di riproduzione?), e la maggioranza delle persone non voleva che le proprie tasse contribuissero a mantenere quelle poche donne. Se non potevano (o volevano, si insinuava talvolta) assolvere al compito per cui erano state selezionate, tanto peggio per loro. Il malcontento montava, la rabbia cresceva. Qualcuno presentì un possibile pericolo e suggerì di impiegare le forze dell’ordine per sorvegliare le cliniche, ma la proposta cadde nel vuoto.
Anche se nessuno sapeva decidere che cosa fare di loro, le donne reimpararono a fare qualcosa di loro stesse. Un po’ per sfuggire alla noia e un po’ per darsi un senso di utilità ora che all’apparenza non ne avevano più alcuna, cercarono un modo per occupare le proprie giornate. Ne trovarono diversi: cominciarono a prepararsi i pasti quando il personale di cucina fu lasciato a casa per tagliare i costi e placare l’opinione pubblica, e si organizzarono in turni quando per lo stesso motivo anche l’impresa di pulizia smise di venire. Lavavano, stiravano e rammendavano vestiti e biancheria. Un giorno, grazie all’aiuto di una dottoressa, apparvero dei gomitoli e dei ferri da maglia. Soltanto un anno prima nessuna avrebbe potuto ottenere un ferro da maglia.
Quando non erano affaccendate, sedevano a chiacchierare, leggevano e rileggevano i libri presenti nelle stanze comuni, ripetevano insieme le posizioni dello yoga prenatale. Alcune si dedicavano a completare l’istruzione delle bambine. L’amicizia che era stata impedita dal ciclo gravidanza-parto-riposo e dalla tacita competizione che si era innescata tra di loro poteva ora fiorire robusta nella serenità e nella cooperazione. Nacquero degli amori, che le sorpresero e le resero felici. Invisibili com’erano diventate, impararono a guardarsi, a parlarsi, a toccarsi. Nella loro solitudine condivisa appresero la cura. Non ci furono altri suicidi.
Un giorno, infine, il programma di riproduzione venne chiuso. Nei comunicati e nelle conferenze stampa si usò sempre la parola sospensione, ma non era che un’estrema salvaguardia dell’apparenza. Non c’erano più speranze sulla riproduzione, programmata o meno. Non fu reso noto neanche che il fondo pensionistico sarebbe stato liquidato tra tutte le donne, e a nessuno venne in mente di chiedere conto di quei pochi soldi. Del resto, non si pensava quasi più ai soldi. E in fondo neanche alle donne.
Non ebbero che qualche giorno di tempo per mettersi in contatto con le loro famiglie e riempire di nuovo i borsoni con cui qualche anno prima erano entrate in clinica. Ora che stavano per tornare in libertà non ci fu nemmeno bisogno di dirselo: sarebbero rimaste insieme. Molti dei loro parenti, per dimenticanza o per vergogna, avevano già smesso di farsi vivi; ma per tutte loro quei legami nati nell’eccezionalità, sul limitare della fine, valevano ora tanto da superare persino la biologia e il sangue. Si riunirono in assemblea e scelsero una città attraversata da un fiume, ridendo di come continuassero a pensare alle condizioni più favorevoli per la sopravvivenza anche ora che la sopravvivenza non era più un obiettivo a lungo termine. Avrebbero occupato un palazzo, o più palazzi. Nessuno sgomberava più gli immobili occupati, finalmente era chiaro che non aveva più alcun senso. Si sarebbero nascoste lì e avrebbero provveduto a se stesse fino alla fine. Non sarebbe cambiato nulla. Vollero unirsi anche delle infermiere e delle dottoresse.
La data della partenza fu tenuta nascosta per ragioni di sicurezza. Abbandonarono la clinica intorno alle undici di sera, dopo aver ottenuto un treno notturno che le portasse a destinazione. Un’infermiera aveva già fatto un sopralluogo in un quartiere disabitato e individuato un grosso complesso di condomini vuoti, provvisto di un giardino posteriore che poteva essere riconvertito a orto. Ciascuna aveva riempito il borsone di cibo dalla cucina, vestiti e medicinali dagli armadietti. Sebbene non ci fosse più necessità di fissare o tramandare nessun tipo di sapere, qualcuna aveva voluto ricavare dello spazio anche per qualche libro, fogli di carta e penne. Prima dell’alba si erano già installate nei condomini. E pochi anni dopo, mentre la popolazione umana continuava ad assottigliarsi a un ritmo sempre crescente come se volesse levarsi di mezzo il prima possibile, la loro piccola comunità autosufficiente continuava a vivere in pace all’esterno proprio come aveva fatto durante la reclusione. Erano molto felici. Se fossero state scoperte da un uomo, forse lo avrebbero lasciato entrare. E forse qualcuna di loro avrebbe fatto l’amore con lui.

La via dei tigli – Alessandra Castellazzi
Prese la bicicletta e iniziò a pedalare. Erano mesi ormai che l’aria era diventata irrespirabile nella città sovraffollata, satura com’era di una polvere nera, appiccicosa, che si posava su ogni superficie. Con una bandana a coprire la bocca, imboccò una strada laterale. Gli ingranaggi della bici erano arrugginiti dall’inutilizzo e sentiva le gambe pesanti, ma dopo un po’ arrivò al fiume.
Tutto sembrava immobile. Non c’era un soffio di vento a solleticare i fili d’erba, nessun ronzio d’insetti o eco dei giochi dei pesci. Era difficile dire persino in quale verso scorresse l’acqua. S’immaginò che sotto la superficie appena increspata, dove la luce del sole si spegneva come un mozzicone di sigaretta, lottassero forze profonde e contrarie, che strattonavano in una direzione e poi nell’altra.
Prese la via più famigliare. Svoltò nella strada piatta e uniforme che andava a sinistra, e pedalò. Pedalò per molto tempo, creando con il moto un sostituto del vento e un’impressione di vita canticchiando tra sé, pedalò così tanto che quell’accenno di vento e di vita iniziò a sembrare reale. Allontanandosi dalla città, notò dei tratti in cui la grana di polvere si diradava, come se un panno bagnato avesse levato lo strato più persistente di sporcizia e attraverso un alone s’intuissero forme e colori di una volta.
Quando arrivò al ponte di pietra, la sensazione di realtà divenne più intensa. Si fermò ma la brezza continuò a soffiare; tacque ma intorno a sé la vita mormorava. La casa della sua infanzia non era distante. Sotto quel tiglio malconcio, diversi anni prima, sua nonna aveva raccontato una storia semplice. Era una tarda sera d’estate e le cicale frinivano; con la sua posa solenne, la nonna aveva raccontato quanto profonde e articolate fossero le radici della pianta, simili a dita gentili e tenaci che si facevano spazio nella terra, guidate da un istinto secolare, quasi volessero stringere la mano ad altre piante sorelle; aveva raccontato quanto lontano viaggiassero i pollini, accomodati sulle correnti d’aria, abbandonati a un movimento incontrollabile ma fecondo, che li avrebbe portati a radicarsi in altre terre dove avrebbero forse affondato le loro lunghe dita verso nuove piante sorelle. “Ascolta bene, le senti?” aveva detto la nonna, tastando le radici nodose.
Riprese a pedalare, si tolse la bandana. S’immaginò una mappa sotterranea di vie linfatiche, decise che l’avrebbe seguita. Oltrepassò il punto dove suo padre aveva usato un fazzoletto di stoffa ricamato per asciugare il sudore dalla nuca della madre in una giornata afosa, continuò fino a un gruppo di cespugli dove aveva visto un ragazzo leccare il sangue dalla ferita di un amico, saliva per lenire il dolore.
La strada a quel punto scartava, iniziava a salire. Vedeva l’acqua scorrere nella direzione da cui proveniva. Non verso la foce pedalava, ma alla sorgente. La brezza non era più un’impressione ma un muro compatto forte contrario, le faceva perdere l’equilibrio. Urlò nello sforzo di salire, rispose un urlo. Diverse urla, ronzii, latrati, risate, ragli, sospiri; nascosti dietro la cortina di piante.
Continuò a pedalare, la sua bici aveva ripreso l’azzurro brillante di una volta. Arrivò su un altopiano, dove lo sguardo si allargava: rocce grigie, bianche, brunastre s’immergevano in un lago chiuso, una sorgente morta. Una nebbiolina si alzava simile a un sipario, sopra quel mare stagnante. Sulla riva sorgeva un’enorme fabbrica in disuso, tubi e condotti attorcigliati, valvole aperte sul vuoto, vene prosciugate ricoperte da una patina rossastra di ruggine. Arti che si tendono senza incontrarne altri. Si sedette e aspettò.
Aspettò il calare della notte, cercando di sentire il pulsare sotterraneo della trama linfatica. Eppure lì ogni antica via vegetale presagita, fantasticata – s’interrompeva. La fabbrica si accese di luci riflesse nell’acqua morta, un lunapark abbandonato di giochi industriali. Il rudere si animò. C’era movimento lì dentro, un intimo indaffararsi. Si avvicinò e vide i lumicini delicati delle lucciole. Una vegetazione umida, invisibile a distanza, circondava il relitto; le acque morte davano vita a piante sconosciute, maculate come ghepardi, sinuose come serpenti, ineffabili come colibrì, che parvero acquattarsi al suo passaggio, indecise se fosse preda o predatore. Arrivò al cancello scardinato dell’ingresso e bussò. Il colpo echeggiò attutendo per un momento il luccichio delle lucciole, zittendo il vocio all’interno. Qualche passo e alla soglia si presentò una creatura lampiride, alta e snella, con due sottili antenne sulla fronte e tra le braccia un fagotto; un cucciolo con il volto più luminoso che avesse mai visto.

Le sorelle – Nicolò Porcelluzzi
I.
Non avremmo trovato pace se Marta non fosse entrata nel vagone previsto, e non avesse visto uno di quegli annunci accanto alla mappa delle fermate, giallo su nero, che diceva
RICERCHIAMO APPARTAMENTI E NEGOZI
per banche e multinazionali
in AFFITTO o in VENDITA
e mai la pace senza quel numero di telefono, che Marta si era imparata a memoria come un bambino. Il suo telefono si scaricava più degli altri perché mi voleva, mi studiava nei riflessi e cercava di proteggersi anche se aveva capito, ormai, che l’unica con due idee in testa ero io. Gliel’ho chiesto a bassa voce, baciandola, come si fa in questi casi, le ho detto dai chiamalo, l’ho comprata apposta. È arrivata da un’isola senza fuso orario, è estratta da un fungo credo, o forse una spugna Marta, ma a quel punto era già nuda.
Sì buongiorno gli aveva detto, la chiamo per quell’annuncio. Stiamo considerando la vendita (neanche una piastrella del bagno era nostra), se non sbaglio 75 calpestabili (preziosissime risorse di improvvisazione), esatto – sui 5k al metro quadro (qui perfetta), mh-mh, si stringeva il cavallo tra le mani, era già stufa, a due minuti dalla metro sì. Grazie. Grazie. Grazie, a domani.
Domani poi lui si era presentato alla porta, gli occhi fluorescenti e tutto, spezzato senza cravatta e botton-down bianca, la montatura sottile, le mascelle. Era entrato in casa. Aveva rispettato il copione – molto graziosa, giusta per due. Una volta seduti in sala quando è arrivato il momento del vuole un bicchiere d’acqua ho preso il bicchiere e versato le gocce. Si sono diluite. Forse, pensandoci, ne sarebbe bastata la metà. Gli ho portato l’acqua e l’ha bevuta.
Nei primi minuti è ovvio non succedeva un granché, non eravamo curiose tanto per l’acido, lo conoscevamo, ma per la combinazione con la Q6-2 che, e questo va detto, un poco m’impauriva. Dopo il minimo di conversazione che gli avevano insegnato al corso, che lavoro fate non lo facevamo, perché proprio noi abbiamo visto un cartello, due sorelle che cercano casa quindi! esatto, Luca si è steso sul divano. Con un certo affanno.
– Vorrei avere… lato mio sarebbe desiderabile, ecco, una forma spontanea e non mediata di consenso, sciogliendo il nodo di una stima costi/benefici, l’entità del trade off e la consistenza dell’effort, che direi non mi si può negare, vorrei avere, come dire, la possibilità di baciarvi. Una alla volta.
– Scusa?
– Cosa?
Le pupille erano diventate delle monete, il labbro superiore iniziava a ritirarsi.
– Sarebbe impattante.
– Ah.
– Beh, per quadrare. Uno entra in casa per le metrature, il calpestabile, la pista ciclabile, e si trova a parlare del più e del meno.
Marta aveva deciso di partire dalle scarpe sfilandole forse un po’ di fretta, va detto, allineandole sotto al termosifone; erano scarpe da uomo di cuoio, da burocrate cocainomane quale il nostro Luca, l’amico degli amici, il figlio di Grazia, che solo qualche anno prima si comprava i fucili ad aria compressa vendendo foto su internet. L’ha scampata bella il ninfetto, il fiore fiacco.
– Sembrate mia madre.
Marta era passata alla cravatta. Ne scioglieva il nodo guardandomi, mentre Luca la cercava e toccava senz’ordine, “mescolando l’alto e il basso”. Era tutto questo la Q6-2, allora, un empatogeno più rapido?
– Ragazze dovete capire che senza infrastrutture sareste infelici. Serve acqua potabile, cibo, sicurezza, chi può negarlo? Potete negarlo?
– Nego quello che vuoi, basta che stai fermo con queste gambe. Che taglia hai di pantaloni Luchino, sono tutti strani, Clara non so fai una foto, qualcosa, non possono essere veri!
– Ho una XM.
– Una XM. Extra Medium? Sei buffo cicci, sei proprio tenero.
Era soltanto da qualche anno che Marta era riuscita ad accettare di non essere la ragazza madre che l’aveva partorita in un ospedale del centro; servirono mesi di discorsi a letto, in cucina, in bagno, fino a quando l’identità aveva aderito alla matrice grazie a un velo di colla, una leggera suzione, e qualche lacrimetta scema. All’ombra technicolor delle videocassette di famiglia la nostalgia di Marta era cresciuta senza incontrare ostacoli naturali, fino a quando le pressioni della nuova vita, “sedimentando doveri e aspettative”, avevano estinto il sentimento mastodontico. Come dire, si era estinta la megafauna infantile.
Poi l’abbiamo legato. Non era nei piani, ma ce l’aveva chiesto lui.
– Legatemi, vi prego! Legatemi, dovete legarmi. Se non mi legate vi ammazzo.
– Scusa?
– Se non mi legate, piango.
– O ci ammazzi?
– Piango e vi ammazzo.
– Ci ammazzi piangendo.
– Vi ammazzo.
– Piangendo.
– Vi ammazzo piangendo.
– Ok.
– Ok.
Continuava a toccarci senza insistere su scale cromatiche, labirinti viennesi, sentieri battuti. Abbiamo preso delle calze e l’abbiamo legato stretto, i polsi e i piedi ai braccioli del divano.
– Almeno non ridere!
– Come non ridere? Che tempo fa fuori?
– C’è il sole Luca.
– C’è il sole.
C’era il sole.
– Le vecchie malate si perdono nei campi. Vengono ritrovate distese nei fossi, sembra che dormano.
Si era fermato.
– Sapete cosa avrei voluto?
– Cosa avresti voluto?
– Cosa avresti voluto, Luca?
– Un gattino.
– Ah.
– Chiaro, un gattino. Non lo vuoi più?
– Non lo so, lo voglio? Voi che fate? Vi spogliate?
II.
Al risveglio pensavamo di trovarlo malconcio, sporco; in sala invece c’era un odore di rosa, di muschio e tracce di mare. Fuori dalla finestra c’era la città: era ogni giorno più silenziosa. Cosa dire, della città? La città già esisteva, prima che nascessimo. Ogni giorno si ricombinava, trasformandosi; sarebbe bastato il cielo a farlo, che mescolava il fumo e il lilla, i desideri agli stipendi. Il cielo come prova generale. La città come tentativo di metafora: una colonia batterica che aveva deciso di espellerci. Peccato. Avremmo riso molto in una casa di proprietà, mangiato sano e bevuto l’acqua filtrata, nella casa di proprietà avremmo avuto più amici, e più sani, risolti; biancheria più morbida, il burro nel frigo, biologico, e delle buone bottiglie. I desideri si sarebbero sintetizzati come proteine.
Almeno Luca ci faceva ridere. Stava diventando qualcos’altro, una pianta d’aria. Voleva mescolarsi all’organico, diceva, e altre idiozie del genere ma in fondo quello che voleva, grazie al cielo, era sesso. Quello sì, con qualsiasi cosa trattenesse carbonio, animali, vegetali, del sesso organico consenziente.
Il divano, in fondo, non serviva per dormire. Serviva per pensare al sonno, interromperlo, quasi addormentarsi; serviva soprattutto a spogliarsi, guardarsi da vicino, confondere le voci. Marta mi guardava negli occhi chiedendogli che facciamo Luca, ci spogliamo? Dici? E lui rideva. No che ci spogliamo cicci, non ci spogliamo mica, e Marta si tirava giù le mutande. Sarebbe stata una giornata davvero molto lunga, come se fosse sera dalla mattina.
Ero contenta di averla conosciuta ormai adulta, almeno nei numeri dico, una perfetta estranea. Tanto disonesta Marta, dolcemente, e tanto incapace nel racconto di sé. Capitava infatti che Marta, ahilei, cedesse alle fatiche della vita e all’agitazione, alla frenesia. Penso fosse “immunodepressa”, e che le noie alle articolazioni, l’infiammazione dei tendini e della lingua fossero dovute a questo, e a questo il suo abuso di diclofenac.
Purtroppo con il diclofenac in corso di trattamento si possono verificare cefalea, capogiro e vertigine, anoressia, nausea, vomito, diarrea, dolore addominale, flatulenza, sono relativamente comuni anche l’aumento di AST e ALT con talvolta evoluzione verso l’epatite e la comparsa di rash cutaneo, ma anche anemia, leucopenia, trombocitopenia, capogiro e anoressia, diarrea, gastrite, emorragia gastrointestinale, ematemesi, cefalea e vertigine, dolore addominale con talvolta evoluzione verso l’epatite e l’aumento di AST e ALT, e anemia, leucopenia, melena, ulcera gastrointestinale, flatulenza, dolore addominale, diarrea, vomito, orticaria, eczema, leucopenia, trombocitopenia, capogiro e rash cutaneo, anemia, ematemesi e vertigine, a volte dolore addominale con evoluzione verso l’epatite e l’aumento di diarrea, gastrite, emorragia gastrointestinale, e può verificarsi cefalea, capogiro e vertigine, anoressia, l’aumento di AST e ALT, e anemia, leucopenia, melena, ma anche dolore addominale, nausea, vomito, sono relativamente comuni l’epatite e la comparsa di rash cutaneo, anemia, leucopenia, trombocitopenia, capogiro e gastrite, ecco, era un farmaco da assumere con una certa cautela.
Il fatto è che Marta era da sempre ansiosa, da quando era nata e anche prima, i suoi nervi di notte si riallacciavano nel sonno, svegliandola con le braccia stanche come avesse nuotato, le caviglie gonfie. E altre noie che avrei sistemato con il Q6-2. A neanche trent’anni Marta, che viveva in città e non le bastavano i soldi, si era somministrata l’artrite.
– Tutto a posto Luca?
– Mh mh.
– Come va lì sotto? Tutto regolare?
– Lì sotto.
– Tutto regolare? Funghi? Leucopenia?
– Tutto regolare.
– Quanti anni hai Luca?
– Non mi chiamo.
– Ok. E quanti anni hai?
– Sto cercando la fonte.
– Certo, la fonte.
– Alla base della nuca. Sto cercando la fonte tra serpenti d’acqua.
– Ok.
– Clara?
– Sì.
– Non torno nel tempo.
– Non ci torni?
– No.
– Ma non hai mai fame?
– Annuso il vostro sacrificio, e questo mi basta.
– Tutto regolare?
– Non ci torno.
– E che ti devo dire, non tornarci.
– La luce.
– Luchino.
– Non mi chiamo.
– Piccolino.
Tutto quanto. Tutto regolare.
III.
– Allora Luchino, che facciamo? Terzo giorno nella casa dell’amore.
– Mh-mh.
– Hai bevuto un po’ d’acqua?
– C’è una gran pace sorelle. Una gran pace. No? Una gran pace?
– Sono da sola Luchino. Hai bevuto dell’acqua?
– Marta dov’è?
– Marta?
– L’altra, quella che non sei tu. La sorella.
Non ho saputo come “metterla giù”. Lo dovevo a Luca, ma non ho saputo come iniziare il
– Psst. Ti aiuto io. Si sono tutti chiusi in casa, lo so. Non preoccuparti, mettila giù come vuoi. Sono legato, sono idratato. Ma questi muri sono di vetro, Ada.
– Non mi chiamo Ada.
– Ti chiami come preferisco. Vediamo. Dimmi il primo nome che ti viene in mente.
Parlava senza aprire la bocca, lo sguardo al soffitto.
– … –
– Su, il primo nome.
– Ada.
– Bene. Ora Ada deve spiegarmi come siamo arrivati a tutto questo. Ora Ada deve aprirsi. Ada deve sdraiarsi come un cadavere, allineare la spina dorsale al pavimento e chiudere gli occhi, concentrarsi sul respiro anche se sta leggendo, concentrarsi, inspirare, espirare. Inspirare, espirare, ancora, dieci volte, cento volte, inspirare, espirare.
Dico davvero,
inspirare, espirare. Inspirare, espirare, ecco che Ada inizia passo dopo passo il cammino all’indietro, scende nello spazio negativo, inspirare, espirare, ora Ada senti che la pelle è superficie, l’unica membrana, sei attraversata dalla vita Ada, che è respiro; ti ami come mi ami, muoviamo i venti e la pioggia sugli oceani, lontani da noi, da Marta, inspirare, espirare,
dico
inspirare, espirare, ora Ada ripeti con me, io non sono quello che faccio io non sono quello che faccio, i morti non sopravvivono alle cose i morti non sopravvivono alle cose, il desiderio non è statistica il desiderio non è statistica, inspira ed espira, ancora, ora dimmi dov’è Marta non la vedo, guarda meglio Ada, dimmi dov’è Marta è a letto, e cosa fa sembra dormire, sei sicura Ada, sembra dormire però non dorme ma non è sveglia no, non è sveglia ma ha gli occhi chiusi ha gli occhi chiusi, Marta è andata a letto e ha chiuso gli occhi per sempre per sempre, ha chiuso gli occhi Marta, e così farò io, sì Ada, è così. Chiudi gli occhi.
Per sempre.

Devi capire l’odore di morte – Pier Mauro Tamburini
Lia si sveglia con un forte mal di testa e la mandibola indolenzita, sente il mondo che le preme sulla faccia e cerca sollievo tra le fessure della tapparella piene della luce del mattino. Le pareti della stanza pulsano lente, aritmiche, coperte da striature violacee e umide. L’odore di morte sembra più intenso ma forse è solo il mal di testa.
Nella notte Marco le ha inviato un vocale in cui le chiede se sia sveglia imitando la voce roca di Sofia, l’adesivo di un orso che si cosparge felicissimo di miele e un dormi bene. Scorre le notizie e sono le solite: confermato che il contagio non prevede prossimità; le autorità invitano a riprendere le attività sociali nel rispetto del protocollo narcolettico; il gruppo di Londra ha rivendicato l’attacco ai due ospedali; aumentano gli scontri, i furti e i morti ma ci rialzeremo più forti di prima.
Lascia il telefono sul comodino e va in cucina, scalda tre dita d’acqua e le usa per allungare il caffè del giorno prima. Si appoggia al tavolo dove i vicini non possono vederla, estrae una pillola dal blister e ne rosicchia quanto basta. Nasconde il resto nel pugno della mano e lo butta nel bidone, assaporando l’amaro sul palato prima di lavarsi i denti.
Le strade sono silenziose, caute, una famiglia è in posa davanti a una vetrina infranta e qualcuno ha infilato un manichino senza testa in una macchina carbonizzata, il braccio fuori dal finestrino come se stesse salutando. Le persone ciondolano sul marciapiede, il grumo rosso striscia e incespica, finisce nei tombini, il suono di una sirena si mescola al rantolo acquoso che arriva dal cielo, sembra un polmone perforato. Alla fermata tre ragazze fumano erba e ascoltano musica, vicino a loro un signore ha appena finito di piangere. Lia gli chiede se voglia un fazzoletto e lui risponde che ce l’ha, grazie.
Questa notte qualcuno ha scritto LE VONGOLE LO SANNO sulla saracinesca della profumeria vicina al bar. Lia si ferma a osservare lo spray, sembra brillare di un bagliore soffuso ma non ne è sicura. Entra e accende le luci e il forno, controlla che il bagno sia a posto – ieri ha dimenticato di cambiare il sapone – e porta su le brioche congelate. Accende la radio, la chitarra acustica di una cantante italiana impasta la sala e copre il rantolo che preme alla finestra. Non avrebbe mai pensato di affezionarsi a quel grembiule, le ricorda un mondo semplice, e ormai il lavoro è quasi inesistente.
La giornata passa tranquilla, poche facce sconosciute e nessun dramma. Potrebbe trovare conforto nelle cantilene dei due anziani ma prova solo noia. Parlano annebbiati delle allucinazioni e del virus, protestano contro il governo, i militari, i pazzi terroristi, le medicine. Lia passa lo straccio sul tavolino, insieme alle briciole raccoglie muco rossastro che cola e schizza via. Non si scompone e loro non si accorgono di nulla. Il signor Riccardo ripete le solite frasi frammentate sulla moglie, morta da otto anni, era enorme, ce l’aveva davanti e sopra e sotto, sanguinava dappertutto, non dimenticherà mai l’odore di morte. Dice che ha pensato di smettere con la quetiapina per poterla rivedere, poi ha temuto di morire e non l’ha fatto.
A cena mangia lenticchie davanti a un programma tv che rimette in scena le visioni degli ospiti prima della cura. È avvilita dalla stupidità, vuole che tutti credano e capiscano, ma è attratta dalle storie e sente di imparare cose nuove. Il battito delle pareti è debole e incerto. Alle undici spegne la tv e si mette la maglietta che usa per dormire.
Imposta la sveglia, appoggia il telefono a faccia in su sul comodino e spegne la luce. Dieci minuti dopo scivola silenziosa lungo il materasso, trattiene il respiro, cammina accucciata fino a dove il grandangolo del telefono non può più inquadrarla. Nel buio si affaccia alla finestra aspettando che passi la camionetta militare e ripercorre mentalmente il labirinto di strade da seguire, non ne ha mai sbagliata una ma l’idea le mette ansia. La camionetta passa mentre il respiro della stanza si assottiglia e diventa un sibilo.
Pedala, i palazzi riflettono traslucidi la luce della luna, gli alberi e i lampioni si piegano molli al suo passaggio e goccioline calde cadono e si coagulano nei suoi capelli mossi dal vento della notte.
Lega la bicicletta al solito palo della luce e cammina per cinquecento metri. Due ombre si avvicinano al passaggio nell’inferriata ed entrano, Lia aspetta un minuto e le segue, la vibrazione dei bassi che arriva dal grande fabbricato buio la eccita e la agita. Nella saletta d’ingresso si spoglia, infila i vestiti nello zaino e lo sistema vicino alla parete insieme agli altri. Il cemento cede morbido ai suoi passi.
La musica, le grida e le risate riempiono i corridoi dell’ex fabbrica, illuminati da sottili neon blu e gialli che scorrono insieme alle vene rossastre sul pavimento. Supera gli uffici dove persone di ogni età discutono, giocano, fanno l’amore. Incrocia Rita, si abbracciano forte, l’amica le chiede cosa stia vedendo, Lia stacca una scaglia di pelle oleosa dalla parete e gliela descrive. Rita indica nello stesso punto e le descrive un fascio di nervi, squarciato, e come sempre sa che è di suo figlio. Per ognuno è diverso, e per tanti è come lei, ma Lia è perseguitata dalla malinconia di non associare tutto questo a nessuno.
Beve la solita schifosa vodka, parla con gli altri e sta bene. Per farla incazzare Pietro le appare alle spalle celebrando Londra. Sembra che anche le emozioni negative rafforzino i legami per costruire l’incontro e Lia è felice di sfogarsi: gli dice che è un idiota, come Abigal e gli altri di Londra, la gente li considera già dei terroristi e azioni come quella rendono ogni cosa più difficile. Non c’è più niente da fare con le buone, risponde Pietro, e lei sarebbe adorabile con una molotov in mano. Lia gli dà uno schiaffo e intorno tutti esultano, poi lo bacia e tutti esultano di nuovo.
È quasi ora e Lia arriva nella grande sala centrale. Marco urla il suo nome, corre da lei sbattendo contro gli altri e l’abbraccia con un misto di ardore e affetto che racconta a chiunque cosa stia succedendo tra di loro. Si guardano, si sono mancati, parlano di niente di importante e poco dopo la musica si ferma.
Assonnati e ubriachi ci mettono minuti a organizzarsi a spirale, trecento corpi nudi tonici e flosci bellissimi e sudati. Sofia coordina i movimenti ma è la più sballata, qualcuno ancora litiga, altri ridono, allontanano il pensiero razionale per prepararsi all’incontro. Sofia ringrazia tutti per essere qui. Mentre cita i nomi dei morti e degli arrestati dalle casse parte un loop elettronico ellittico, ipnotico, lo stesso che nel mondo stanno ascoltando altri migliaia di gruppi come il loro.
Lia chiude gli occhi e rallenta il respiro per armonizzarlo al loop. Il volume della musica si abbassa lentamente e si unisce al soffio stanco della fabbrica. Lia si concentra su un punto in fondo al buio delle palpebre, respira all’unisono con tutti, con il suono sintetico, con quello organico.
Ciao, dice Sofia.
Lia apre gli occhi. È dentro un cuore malato.
Ciao, dicono tutti in coro. Il cuore pulsa in risposta. Dalle lacerazioni nella membrana biancastra esce un liquido scuro, granuloso, supera i lembi neri e rattrappiti degli strappi e scivola verso di lei e i suoi compagni, ora protuberanze spugnose e cave. Lia sente i talloni mescolarsi al tessuto viscido sotto di lei, abbassa lo sguardo ed è parte del tutto.
Noi ti vediamo, dice Sofia.
Noi ti vediamo, dicono tutti in coro. Un’altra pulsazione, più potente, e altro sangue nero spruzza fuori dalle ferite del cuore. I grumi si arrampicano appiccicosi lungo quelli che Lia sente i propri fianchi – ma non ci sono più – due protuberanze a fianco a lei si accasciano, l’odore di morte è forte e cristallino.
Noi ti vogliamo bene, dice Sofia.
Noi ti vogliamo bene, dicono tutti in coro. Il cuore batte ancora, i fiotti diventano cascate, il sangue supera l’orlo vuoto dei suoi compagni, avanza sul seno e sale sulle spalle, striscia lungo il collo, le riempie la bocca e allaga i polmoni, lo stomaco, l’intestino.
Noi ti vogliamo capire, pensa Sofia. Noi ti vogliamo capire, pensano tutti in coro e Lia sente gli altri e la creatura, le sue cellule si spezzano e si aprono, muoiono e risorgono, accolgono un’esistenza nuova, una stretta violenta, una richiesta d’aiuto.

Lievito madri – Francesca Massarenti
Le donne si sedettero e gli uomini guardandole riposarsi capirono che era la fine. Ci vollero decenni, ma una a una posarono telefoni, mestoli e sonaglini. Chi si era stesa a letto, chi appoggiata al muro, chi a gambe accavallate su una sedia in cucina, accanto alla finestra.
Un impasto di farina e acqua lasciato riposare all’aria inizierà a fermentare. Aggiungendo miele, o frutta matura con la buccia, o yogurt, la fermentazione sarà più veloce.
Trascorso il necessario tempo di ristoro – se per alcune ci vollero mesi, ad altre bastarono pochi giorni – le donne tornarono ad occuparsi dei bambini e della zuppa, delle coperte e dell’acqua insaponata, ma di nient’altro.
Il lavoro non finì col crollo di premi e salari, ma senza valuta finirono le professioni, gli orari e ogni forma di pendolarismo. Negli uffici ci fu polvere, poi ci furono edere e nidi di vespe.
Mentre gli umani smettevano di credere alla finzione dell’eroe e della moneta, le capre erano scese dalle colline per pascolare nei giardini degli abitati, avevano mangiato tutte le siepi. Cervi e daini dormivano lungo le carreggiate, i delfini erano tornati ai moli. Le donne avevano ripreso fiato.
Una pasta acida è attiva dopo almeno un mese di rinfreschi. Usarla prima del tempo, prima che le colture di lieviti e batteri si siano rinforzate, darà panificati dal sapore acre.
Fermi, gli umani ebbero due reazioni. Chi si depresse, annoiato dai propri pensieri, restò immobile dentro la propria stanza quadrata, riflesso contro schermi neri. Altri riempirono borse e sporte, partirono alla ricerca di spiazzi verdi, anse di fiume, fango e mare.
I barattoli che contenevano le prime madri, paste acide ai primi cicli di lievitazione, erano preziosi. Attorno a loro si raggruppavano famiglie di esuli d’impresa, sabotatrici di email, scioperanti della reperibilità, orfane di cosmesi.
Ogni giorno le madri andavano rinfrescate con parti uguali di farina e parti minori d’acqua. All’epoca erano candide come le miscele raffinate degli ultimi sacchi salvati da magazzini, container di camion, scaffali di supermercati in rovina.
Senza più posti di lavoro rimase il lavoro dei posti. Senza carriere e occupazione, restarono i mestieri di casa. Senza più nulla da guadagnare, gli umani tornarono a raccogliere e conservare. Pentole, buste, colini, reti e bottiglie: più preziose di schede, chiavi, contratti, cavi, carburanti, porte, coltelli.
Incredulità e incertezza di tutti liberarono ognuno da dipendenza e ricatto. Solo la vicinanza di affetto e intesa creava vincoli di sopravvivenza.
Copie senza matrice dei legami di prima, le nuove comunità scioglievano il nucleo e riscrivevano i ruoli. Non più le prime, o le uniche, a curarsi di tessuti, acqua e sporcizia, le donne smisero di rispondere a tal nome. Gli uomini compresero che era meglio così, e tacquero.
Le madri dovevano essere conservate in luoghi riparati. L’aria tiepida entrava dalle fessure dei coperchi senza sigillo, insieme alle molecole trasportate dalle mani impastatrici animava le colture primigenie. I batteri scindevano gli zuccheri ed emettevano bolle di anidride carbonica. La madre fermentava, cresceva più forte.
Le scorte di antiche farine industriali bastarono finché non arrivò la stagione della mietitura dei nuovi campi di grano. Quadrati terrosi piccoli, poveri, frutto di immani fatiche inventate daccapo, ispirate dai ricordi intatti di vecchie tecnologie. Da quelle spighe si macinarono farine ruvide e sporche, da miscelare con i semi selvatici e i chicchi spontanei raccolti dalle bambine.
Le madri erano ormai forti, le colture batteriche che le rendevano vive al limite della marcescenza erano le vere specie compagne degli umani panificatori. L’etanolo metabolizzato dal saccharomyces cerevisiae si mescolava all’acido lattico delle lattobacillacee. Rivali in simbiosi affamati di zucchero e ossigeno, ceppi di lieviti e colonie di batteri costruivano una flora stabile inacidendo la madre, rendendola una riserva di energia commestibile. E ogni madre creava una biopellicola, un tappo-schiuma per proteggere le proprie colture, filtrare l’ossigeno, immagazzinare scorte nutrienti comuni.
Gli impasti, nelle giornate in cui l’aria era secca, lievitavano alti per la spinta aerea della madre. Una parte, in forno, diventava pagnotta, focaccia, torta. Una parte, rimessa cruda nel barattolo, cresceva nutrita di acqua, farina e riposo. A volte, un riporto di madre veniva donato a un’altra casa.
Per rendere una madre immortale, intere cerchie di alleanza e memoria accorrevano in clan per rabboccare di acqua e farina ogni barattolo di lievito.
Ogni madre era immortale: ogni ciclo l’annullava incorporandola dentro farina fresca, sale e acqua tiepida, ma dalla nuova pasta la mano staccava una palletta nipote da conservare per dopo, o da donare a qualcuno.
La devozione tra le famiglie che accudivano paste figlie dei primi lieviti non aveva bisogno di radicarsi in parentele. Rami ereditari e genealogie verticali non potevano leggere la comunanza globosa tra impasti e batteri.
Cum-panis! Chi mangia il pane con dentro un altro, sulla stessa tavola, nel piatto e davanti al piatto. Simbionti commensali dentro pance e vagine umane, lieviti e batteri trovavano pareti morbide, diverse dal vetro dei barattoli e dalle spire alveolari degli impasti, prolungamenti di ambienti fertili, nuove case.
Le natureculture ricordate e reinventate dai gruppi umani scettici del sangue – ora osservanti delle tessiture volontarie – crescevano in ceppi spumosi e ibridi. La simbiosi rimpiazzò la memoria di parole e parentele, il tempo che alcuni tracciavano insieme all’enfiatura dei lieviti madre, altrove era regolato in tentacoli filamentosi di scoby, o dal diametro della cellulosa di mycoderma aceti.
Chi ne aveva voglia poteva ascoltare leggende del compost ctonio, ma leggersi seguendo attenti il proprio maggese, i propri cicli escrementizi, bastava. La realtà comprensibile con semplice attenzione era sufficiente ai più, solitari o membri di famiglie porose, si comprendevano come ospiti a riposo, seduti o sdraiati, occhi chiusi, occhi al cielo, dita infilate nella terra, stomaci sazi di pane.

Critters RPG – An eco-fantasy roleplaying game of kins and troubles – Marta “Martu” Palvarini
Scambiste
Molle spostò le sue due gambe in posizione. Il suo corpo antropomorfo dotato di quattro arti, una testa e un busto era pronto a scattare in avanti. Sotto i suoi piedi, con cinque dita non motrici, il pantano di foglie-humus della Pozza Rigogliosa subì la sua pressione muscolare.
Il suo intero tessuto, quello neurale incluso, era allineato nella decisione di terminare il contratto di parentela con Duro.
Ripeté mentalmente i passaggi:
– lo scatto
– lo sgancio
– il furto del suo bersaglio
– la fuga, oltre la Soglia, verso un’altra Pozza; semi-impossibilità, nella randomizzazione del passaggio di Soglia, di essere inseguita.
Duro, per ora, si trovava ancora avvolta alla sua schiena.
Duro era stata un’ottima zaino, una contenitore sicura e una casa-guscio molto utile in più di un’occasione.
Ora però pesava troppo.
Questione di comparazione.
L’attuale Duro non era paragonabile alla nuova Duro che Molle poteva acquisire: una Ombrello.
Vantaggi: manovrabilità, simbiosi sensata basata sui suoi arti, non più spostamenti faticosi di trascinamento muscolare.
Duro non ne sapeva ancora niente. Ma forse sospettava.
Forse, da prima della Pozza Rigogliosa. Prima di incontrare le Lombriche Locate e prima ancora della Soglia che le aveva portate fino a qui. Sospettava di certo, almeno dai tempi di quella Pozza Piana con Pioggia Consistente.
Lì, in mezzo a quella Pioggia di Acqua davvero Consistente la sua nuova potenziale Duro aveva dimostrato tutta la sua efficacia: una Ombrello che proteggeva una Fusora dalla decostruzione per troppa Ruggine. Puro sfruttamento.
Critters del tipo delle Fusora non possono neanche immaginare cosa significhi simbiosi, rapporto. Per loro è puro utilizzo. Vero: Ombrello è di fatto una Tech senziente, ma la sua stessa condizione di senziente non può determinare una condizione di sfruttamento da parte di alcuna Critters.
Nella Pozza Piana con Pioggia Consistente, prima di attraversare la Soglia per la Pozza Rigogliosa e non poter, quindi, più tornare indietro, Molle aveva capito che era necessario determinare la sua simbiosi con Ombrello.
Liberare Ombrello.
Oltre lo strumento, verso il rapporto. Divenire di nuovo Paguro pienamente efficiente.
Questa era la condizione delle Paguro: trovare la simbiosi dell’utile.
Duro non credeva che Molle volesse danneggiarla direttamente.
Tuttavia, sentiva che questa cosa che stava per accadere le avrebbe provocato comunque dolore.
Percepiva i piedi di Molle sprofondare leggermente nell’humus-viscoso della Pozza Rigogliosa.
All’improvviso, Molle scattò in avanti, e la sganciò.
Cadde.
Non sentiva più la presenza di Molle, così comune in tutti quei mesi di viaggio, così familiare: una parentela.
Tradita, Duro atterrò nell’humus di foglie.
Percepì la sua materia minerale a contatto con la Pozza Rigogliosa.
Solo in quel momento, Duro si accorse della Critter vegetale che, dall’inizio del viaggio, le aveva sempre accompagnate: una Critter che neanche Molle aveva notato, non percependola come tale, ignorandola perché così era ovvio, una Critter che avrebbe potuto mandare in malora il piano di Molle. Una Critter direttamente applicata ad Ombrello e, a sua volta, connessa a Fusora.
In quel giardino rigoglioso, abbandonata nell’humus, Duro era divertita e amareggiata, sorridente come può esserlo una grossa conchiglia vuota.
Fusora stava guardando le Lombriche Locate in lontananza, enormi, mimetizzate con le sequoie della Pozza, con le bocche aperte in attesa della prossima Pioggia Rigogliosa.
Come vivere Locate?
Come non spostarsi?
Se lo chiedeva spesso. Elaborava il calcolo. Cuoceva qualche pezzo di ferro senza valore auto-alimentandosi, sperando che bastasse. E non raggiungeva alcun risultato numericamente affidabile.
Rimanere ferme in una Pozza. Per sempre? Perché?
Era proprio una questione di nature diverse, di punti di vista non coniugabili.
Però le Locate aiutavano. Le Locate facevano in modo che Critters come Fusora, Paguro, Ombrello e Lichene potessero continuare il loro viaggio.
Non come le Perdute. Quelle non aiutavano affatto, erano Critters che, anzi, andavano contro altre Critters.
Infine, Fusora, con questo calcolo nei circuiti, si accorse del bip-bip sul suo radar: si accorse del movimento repentino di Molle. Si accorse di Duro che cadeva nell’humus e si chiese, calcolando, se stesse avendo a che fare con una Perduta per l’ennesima volta.
Lichene percepì, con la sua superficie, il movimento di Molle, la caduta di Duro, e la disunione della Paguro.
Percepì la violenza e il conflitto. La rottura di quel legame che le Critters di tessuto spesso chiamano parentela.
In reazione, Lichene rilasciò le sue spore.
Spore facilmente inalabili dalle Critters di tessuto.
Il nuovo tonfo nell’humus morbido percepibile attraverso le vibrazioni nelle micro spore vegetali della Pozza Rigogliosa le confermò il successo della sua azione.
Ombrello si aprì improvvisamente, di scatto, spandendo la sua superficie metallica nell’aria piena di spore. Ombrello si consultò rapidamente con Lichene.
Percepì la reazione affermativa della Critter simbiotico-vegetale attraverso l’improvvisa intermittenza della nutrizione corrosiva sulla sua stessa superfice metallica.
Ombrello percepì la presa di Fusora.
Fusora stava ignorando la situazione tra Duro, Molle, e l’intera azione di divisione della Paguro con tentativo di furto di Ombrello.
Fusora era di sicuro spaventata dalla trasformazione irreversibile in Perduta di Paguro, determinata dalla sua divisione. Secondo Ombrello, invece, c’era un rimedio.
Lo comunicò a Fusora, aprendosi e chiudendosi, Codice Morse, comprensibile con un semplice calcolo numerico.
Passarono dei minuti.
Duro percepiva solo l’aprirsi e chiudersi di Ombrello, lo spostamento di cloro percettibile.
Poi l’avvicinamento di una lega metallica.
Improvvisamente era di nuovo connessa.
Fusora la trasportava sulla schiena metallica.
Era di nuovo Paguro, ancora una volta.
Duro vide con i ricettori radar di Fusora che Ombrello assieme alla Critter vegetale – ora visibile, e decisamente definibile come una Lichene – erano appoggiate e connesse all’arto terminante in cinque dita di Molle. Una nuova e ulteriore connessione.
Un’altra Paguro.
“Che equilibrio, nessuno sconvolgimento ecosistemico nonostante il conflitto” pensarono le Lombriche Locate, comunicandoselo con profondi grugniti ululanti.
Da distante, le Lombriche percepirono la Fusora e la Duro, ora una Paguro, attraversare la Soglia, verso una nuova Pozza.
Sempre da lontano – la Pioggia Rigogliosa stava per arrivare a momenti – percepirono che la Molle si era adesso svegliata dal sonno sporifero. La Molle afferrò la Ombrello e la Lichene – di cui adesso era consapevole – e così, quest’altra nuova Paguro, tutta insieme, attraversò la Soglia, diretta verso un’altra Pozza.
Un’introduzione precaria di un gioco in pre-alpha
Critters RPG è un gioco di ruolo pen & paper, un gioco da tavolo, un gioco di ruolo analogico.
In Critters RPG la maggior parte delle persone giocanti interpretano delle Critters: creature, animali, vegetali, oggetti, e altro, coinvolte in un constante rapporto Multispecie, in un’alleanza/discordanza continua. Questo gruppo di Critters, saranno Critters Protagoniste.
Si può scegliere una tra le 100 Critters descritte sul manuale, oppure sceglierne casualmente una tirando un dado, a turno.La scelta di alcune specifiche Critters determina una scelta obbligata per la persona giocante successiva: ci sono Critters simbiotiche che, in altre parole, devono in ogni caso instaurare dei rapporti multispecie.
Una tra le persone giocanti interpreterà invece la Cene: un arbitro, una moderatrice, una narratrice. La Cene non solo descrive gli Ecosistemi che le Critters Protagoniste attraversano ma anche interpreta in prima persona le altre Critters non Protagoniste che abitano questi Ecosistemi.
Per giocare serve il Manuale di gioco, le Schede Critters Diffuse (i personaggi di cui si narrerà la storia), delle Schede Pozza (da compilare quando la Cene presenta il nuovo Ecosistema che le Critters attraverseranno) e , infine, matite, gomme e almeno un dado a sei facce.
Il mondo di Critters RPG si chiama Terrapolis.
Terrapolis è una distesa solida di bianco assoluto, coperta da una volta altrettanto bianca; Terrapolis non è altro che una distesa infinita di Latte.
Nel mezzo del Latte, ad una distanza siderale l’una dall’altra, sorgono le Pozze.
Le Pozze sono isole di non-Latte. Ogni Pozza ha il suo Ecosistema e i suoi abitanti.
Ogni Pozza ha una Soglia di Ingresso, da cui si può entrare nella Pozza.
Ogni Pozza ha una Soglia di Uscita, che conduce ad un’altra Pozza in modo del tutto randomico. Non c’è modo di determinare o sapere a quale altra Pozza si giungerà attraversando una Soglia.
In Critters RPG, non si può tornare indietro, non si può ripercorrere una Soglia di Ingresso già attraversata. Si può solo proseguire verso la prossima Pozza.
Le diverse pozze hanno, tuttavia, qualcosa in comune: esse sono sconvolte da un fenomeno chiamato Ciò Che Piove. Ogni Pioggia è molto diversa dalle altre: una Pioggia può essere diversa per via della sua cadenza giornaliera, della sua scarsità o della sua abbondanza. Ogni Pioggia può variare nel suo contenuto e può determinare anche parte dell’Ecosistema.
Trovare la Soglia all’interno di una Pozza può essere facile o difficile. Ma la Soglia si aprirà solo se l’Ecosistema della Pozza dovesse essere Bilanciato: in uno stato che sfugge al conflitto, in equilibrio. Se la Pozza è Sbilanciata la Soglia rimarrà chiusa e non si potrà procedere oltre. Sarà compito delle Critters Diffuse portare l’Ecosistema al suo Bilanciamento, per poter procedere oltre, passando sopra l’Ecosistema stesso.
Ogni Critter Protagonista è anche una Diffusa.
Le Diffuse sono delle Critters la cui esistenza inizia nella Pozza di Modestia, una grande metropoli delle Critters, dalla quale partono le diverse Spedizioni delle Diffuse.
L’organizzazione-culto delle Girovaghe raccoglie molte Critters. Benché ogni Critter abbia il proprio scopo, tutte condividono un’unica grande idea: andare avanti, dare un senso a Terrapolis, determinare il Viaggio.
Le Critters Protagoniste sono quindi Diffuse perché sono spinte verso la prossima Soglia da superare, sentono il richiamo della prossima Pozza.
Le Diffuse sono imbevute nel Capitalocene delle Diffuse, immerse in rapporti di sfruttamento, vittime e carnefici.
le Diffuse possono diventare Locate: Critters che hanno deciso di stabilizzarsi in una Pozza, per entrare in armonia con l’Ecosistema della Pozza stessa, o per sfruttarne appieno le risorse.
Altre Diffuse diventano Perdute: sono Critters che hanno perso la loro identità originaria, diventando altro da una Diffusa o da una Locata.
Queste queste Critters agiscono per ostacolare le Girovaghe stesse.
Critters RPG è la narrazione della storia delle Diffuse della Spedizione, i loro legami simbiotici, i Kins, i loro rapporti di sfruttamento, i Crediti, nel corso di un Viaggio che potrebbe portarle a Ritornare infine a Modestia, trovando la Pozza con la Soglia di Uscita che le riporterà indietro, completando il loro ciclo Capitalocenico. Un Viaggio che le farà divergere, diventando Locate o Perdute. Un Viaggio che semplicemente le farà smettere di esistere, diventando Compost.
Xenogioco
Critters RPG è un gioco di Kins.
I pilastri dell’avventura di questo gioco eco-fantasy sono l’esplorazione, la riflessione, i legami.
I legami e le parentele, i Kins, sono il cardine dell’esperienza di gioco. Ogni situazione può essere risolta attraverso i Kins, ogni momento di possibile tranquillità può essere portato a conflitto a causa della rottura dei Kins.
L’esplorazione delle Pozze, il costante viaggiare delle nostre Diffuse, ci porta ad essere osservatrici costanti di un mondo in costante decadimento. La precarietà esistenziale delle Critters ci fa riflettere sulla nostra stessa precarietà di soggettività giocanti, o sui nostri privilegi, creando un parallelismo tra il mondo di Terrapolis e il nostro mondo in rovina. Il Capitalocene delle Diffuse è motore di decadimento e conflitto, le dinamiche dei Crediti tra Critters fanno emergere debito ed esproprio, schiavismo ed oppressione.
Da osservatrici partecipanti di questi Ecosistemi complessi ed unici, siamo portate alla riflessione prima che all’azione, alla comprensione dell’unicità ecosistemica prima che all’intervento. Starà poi alla pratica del gioco di ruolo determinare la scelta circa l’azione da intraprendere e la narrazione che si vuole intavolare.
Il dubbio politico, etico e morale è sempre dietro l’angolo in un mondo in cui per avanzare si necessità di un Ecosistema Bilanciato secondo un punto di vista delle Diffuse Capitaloceniche. Quando la Pozza è Sbilanciata ma sensata nel suo Sbilanciamento, quando tutto sembra essere perfettamente disarmonico, è giusto avanzare quando la continuazione del viaggio comporta la creazione di violenza nell’Ecosistema?
Diventare Locate o Perdute non è solo questione di regole ma è innanzitutto una questione di scelte.
Il rapporto tra Critters ed Ecosistemi, e tra Critter e Critter, è la base di scontro dialettico dell’intero gioco.
Il genere fantasy, specialmente nel gioco di ruolo, prevede la progressione dei personaggi in maniera del tutto lineare. Eroi, che cominciano e terminano avventure, accumulando esperienza e ricchezze, “salendo di livello”. Come scrive Avery Alder nell’introduzione a Fuori dal Dungeon. Genere Classe e Razza nel Gioco di Ruolo Occidentale, antologia edita da Asterisco Edizioni:
“Abbiamo esplorato come i sistemi di gioco di ruolo spesso privilegino la norma eterosessuale: il tuo potere rimane costante anche quando ti muovi dentro e fuori le comunità privilegiate, qualcosa di decisamente diverso rispetto all’esperienza queer che, al contrario, spinge nei recessi dell’underground per trovare forme di appartenenza e forza, esattamente come l’investire, nel corso delle proprie vite, in abilità che non sono considerate nella vita eterosessuale. Il tuo potere cresce lungo una traiettoria lineare e stabile, a differenza del modello di precarietà e fluidità che caratterizza così tante vite queer; le ricompense che si accumulano attraverso il lavoro possono rimanere private anziché dover essere immediatamente riutilizzate all’interno della comunità, un’ulteriore differenza rispetto l’esperienza queer di alloggi e occupazioni volatili, esperienza che immette intere comunità all’interno di un ciclo di crisi circolare e costante. Il fatto che così tanti giochi abbiano regole che danno senso al potere come entità concreta, continua, lineare e privatizzata, è la prova del pregiudizio eterocis incorporato nei giochi stessi.”
Critters RPG è un gioco eco-fantasy, dove la progressione dei personaggi è queer e precaria, non lineare, asimmetrica.
La progressione di un personaggio è relativa alle sue esperienze.
Una Critter Diffusa è spinta anche dalla possibilità di potersi fermare: può decidere di diventare Locata, non come un ostacolo ma come parte della sua stessa avventura.
Una Critter Diffusa è spinta a mettersi in discussione, a diventare Perduta – non per renderle la vita difficile ma come parte dell’esperienza di gioco critica.
Critters RPG è pura xenofiction dove lo straniamento profondo verso tutto ciò che è altro va a braccetto con le allusioni politiche al nostro mondo
Molto di ciò che compare nel mondo di gioco è spiegato e altrettanto non lo è, lasciando ampia interpretazione e hackerabilità.
Giocate a Critters RPG come se steste giocando con i frammenti di una conchiglia proveniente da un esopianeta: osservate, domandatevi, mettete in discussione, non datevi delle risposte immediate, seguite il filo della verosimiglianza.
Critter RPG utilizzerà il sistema di regole Powered by the Apocalypse (in gergo PbtA), un sistema con licenza open ideato da Vincent Baker per il suo Apocalypse World ed in seguito utilizzato per altri giochi tra cui Dungeon World, The Sprawl e il noto Monsterhearts della già citata Avery Alder.
Critter RPG è in fase pre-alpha, a breve sarà playtestato da gruppi di giocatrici e giocatori per renderlo una esperienza di gioco quanto più critica possibile.