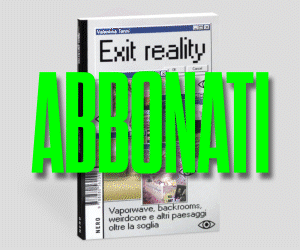Venerdì 12 settembre dalle 18:00 alle 02:00, a La Pelanda, Roma, Short Theatre presenta in co-curatela con NERO lo spettacolo they shoot horses di Phil Collins. Pubblichiamo questo articolo in collaborazione con Short Theater che, a oltre vent’anni dalla sua realizzazione, presenterà la videoinstallazione dedicata a una maratona disco di otto ore tenutasi a Ramallah nel 2004, durante la Seconda Intifada. L’ingresso è a offerta libera e l’incasso sarà devoluto a progetti a sostegno della popolazione palestinese attraverso Gazzella Onlus
Nel marzo del 2004, durante la Seconda Intifada, l’artista britannico Phil Collins organizzò delle audizioni a Ramallah con l’intento di trovare persone disposte a prendere parte ad un suo progetto artistico. Tra coloro che risposero, vennero selezionati due gruppi di giovani palestinesi, il primo composto da tre uomini e una donna, il secondo da tre donne e due uomini. A loro fu chiesto di ballare ininterrottamente per un’intera giornata su una sequenza di canzoni pop. Le performance vennero filmate e il girato diede vita a they shoot horses: un lavoro video in due canali della durata di sette ore che mostra i due gruppi di performer impegnati a danzare tra entusiasmo e stanchezza, interruzioni elettriche e segni indiretti dell’occupazione.

Realizzato mediante riprese frontali a videocamera fissa, privo di qualsiasi effetto scenico e sviluppo narrativo, con una eccessiva estensione temporale, they shoot horses sembra contravvenire ad ogni regola di produzione cinematografica. Eppure, proprio questi aspetti costringono lo spettatore a confrontarsi con la perseveranza dellx giovani palestinesi rendendo così evidente la complessità delle loro vite, le dinamiche interpersonali e il peso della fatica che aumenta con il procedere della loro performance. Il fatto che tutto ciò avvenga durante la seconda Intifada, senza che venga mai dichiarato, rende ancora più evidente il valore politico del lavoro di Phil Collins. La resistenza viene infatti messa in scena come un processo incarnato, che si fa visibile proprio nell’insistenza del gesto corporeo. Il movimento continuo e ostinato dei corpi, nonostante l’incedere della fatica e degli imprevisti esterni, diventa un deciso atto di autoaffermazione all’interno di un contesto di occupazione e violenza coloniale.
A vent’anni dalla sua realizzazione, quest’opera è stata recuperata e restaurata, e questo mentre la colonizzazione sionista della Palestina sembra avvicinarsi al suo stadio finale, con il genocidio a Gaza e la dichiarazione di annessione della Cisgiordania all’entità sionista. Se nel 2004 il lavoro di Phil Collins registrava indirettamente la condizione di oppressione mostrando corpi costretti a vivere sotto l’occupazione sionista, oggi quelle stesse immagini si confrontano con un panorama in cui la violenza coloniale si è intensificata fino a raggiungere una scala genocidaria. In questa prospettiva storica, questo lavoro aumenta la propria potenza critica, ritrovando una nuova dimensione di attualità che mostra come colonialismo sionista e resistenza palestinese sono evoluti nel corso degli ultimi due decenni.
Nell’infosfera contemporanea satura di immagini provenienti dai social media, un filmato che rappresenta un gruppo di giovani che danzano davanti ad una videocamera rievoca inevitabilmente le coreografie di content creators che circolano su Tik Tok. Tuttavia, nonostante l’evidente tratto comune, i dance videos di giovani tiktoker e they shoot horses sono animati da logiche fondamentalmente differenti. I primi, infatti, presentano solitamente coreografie condensate in gesti semplici, immediatamente riconoscibili e replicabili, pensate per catturare l’attenzione nello spazio di uno scroll. Mentre, al contrario, la durata di they shoot horses estesa senza alcun timore oltre ogni possibile soglia di attenzione, costringe lx spettatorx ad un confronto prolungato con le immagini.
L’invito è a fermarsi, conoscere, investigare i movimenti, le interazioni, i tratti fisici e caratteriali dellx protagonistx del video che, proprio grazie alla semplicità del compito affidatogli, e all’assenza di interazioni verbali, affermano le proprie soggettività in tutta la loro specificità. Come ha osservato la critica Liz Kolz nel suo saggio Phil Collins: the world won’t listen: «Non abbiamo mai conosciuto questi giovani, ma dopo un po’ ci sembra di saperne molto di loro: la ragazza un po’ cheerleader con i grandi orecchini e i vestiti sportivi, la ragazza stanca, il ragazzo bello e distaccato. Man mano che la fatica prende il sopravvento, i loro sforzi appaiono alternativamente tragici e comici, eroici e strazianti».
la barbarie ha assunto un aspetto diverso e più inquietante perché all’orrore del genocidio si aggiunge la partecipazione ludica, quasi infantile, dei suoi esecutori
they shoot horses può essere quindi letto come un ritratto collettivo, che registra i mutamenti emotivi degli individui coinvolti in questo lavoro, nell’arco di una giornata estenuante, in un contesto in cui la realtà della colonizzazione sionista, oggi ancor più che allora, si manifesta anche con la colonizzazione dei corpi e delle vite palestinesi. they shoot horses si oppone a queste logiche coloniali di deumanizzazione in maniera del tutto semplice ed immediata, attraverso un lento ma costante processo di familiarizzazione con la presenza dei due gruppi di performer. Nonostante, quindi, they shoot horses anticipi per certi aspetti la diffusione massiva dei dance videos di Tik Tok, che quindici anni dopo la realizzazione del film avrebbero invaso i nostri smartphone, le differenze formali e temporali rendono i due fenomeni sostanzialmente inconciliabili.
Se infatti Phil Collins utilizza la durata e la ripetizione come strategie di rivelazione, l’estetica tik tok sembra funzionare secondo dinamiche che si consumano nell’arco di pochi secondi tra uno scroll e l’altro. Una distinzione che assume dei connotati perturbanti se si confronta they shoot horses con i TikTok pubblicati dalle forze di occupazione israeliane a Gaza dall’ottobre 2023, che mostrano soldati e soldatesse delle IOF che scherzano divertiti mentre compiono massacri e devastazioni. Mettere a confronto questi due regimi di immagini significa leggere la distanza tra un’opera che afferma la presenza e il diritto all’esistenza del popolo palestinese, e un dispositivo mediatico che contribuisce alla sua cancellazione.
Non siamo più di fronte a quella che Hannah Arendt aveva definito “banalità del male”, ovvero la barbarie intesa come il risultato dell’alienazione burocratica di funzionari privi di pensiero critico e incapaci delle più basilari considerazioni etiche. Dopo il 7 ottobre la barbarie ha assunto un aspetto diverso e più inquietante perché all’orrore del genocidio si aggiunge la partecipazione ludica, quasi infantile, dei suoi esecutori. La violenza è così privata dei tabù che le civiltà umane hanno solitamente prodotto col fine di contenerla all’interno di determinati confini, per essere al contrario esibita come forma di intrattenimento. Si tratta di una ferocia che eccede i parametri con cui la cultura contemporanea del secondo dopoguerra ha cercato di concettualizzare il male che la civiltà occidentale è stata capace di generare nel corso del secolo scorso in Europa, e nel resto del mondo nei quattro secoli precedenti. In questo modo, perciò, viene segnato l’avvento di un regime estetico in cui l’orrore stesso diventa consumo e spettacolo, fino a raggiungere il paradosso in cui la violenza del carnefice sulle proprie vittime assume le caratteristiche della “cuteness”, come evidenziato da Noura Tafeche nel suo articolo L’epoca della violenza cute.
Il confronto di they shoot horses con questa modalità di produzione di immagini rivela quindi un conflitto fondamentale, utile a comprendere l’evoluzione delle logiche del colonialismo sionista e a sovvertirne le implicazioni estetico-politiche: da un lato un dispositivo che insiste sull’imprevedibilità e sulla complessità dei corpi, dall’altro una macchina di produzione di immagini che riduce i corpi a segni di potere e elementi di un orrido spettacolo di distruzione. Come suggerisce Fred Moten nella sua teorizzazione di una estetica black attraverso la nozione di fugitivity, la forza politica della rappresentazione sta proprio nell’opacità e nell’eccedenza dei corpi, nella loro irriducibilità a prevedibili funzioni narrative o propagandistiche. Nei corpi stanchi ed eccitati, esitanti, ostinati e resistenti dei giovani palestinesi di they shoot horses si apre così uno spazio critico che si oppone a qualsiasi processo di deumanizzazione. Ciò che appare, in questo senso, è l’immagine di un’alterità irriducibile, che nel suo eccedere i dispositivi di controllo, scardina la logica coloniale. È proprio nell’eccedenza si produce una forma di insubordinazione estetica, un rifiuto implicito di essere lette come mere vittime passive o corpi disponibili allo sguardo coloniale. they shoot horses restituisce quindi non solo la presenza di soggettività complesse ma anche la possibilità di pensare l’immagine come luogo di resistenza, capace di sovvertire un regime visivo dominato dalla violenza spettacolarizzata e dalla cancellazione delle vite palestinesi.