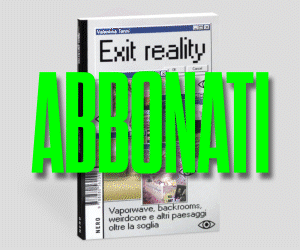Ogni neuroarchitettura trasforma lo spazio in un dispositivo psichico capace di indurre in chi lo attraversa un preciso stato di coscienza. Il panottico di Jeremy Bentham ne è il più celebre esempio: una struttura ottimizzata per l’accentramento e la circolazione dello sguardo. Oltre a queste neuroarchitetture premeditate, accade spesso che strutture costruite per tutt’altro scopo si trasformino in dispositivi psicologici, o forse dovremmo dire psicoattivi, malgrado l’intento dei loro creatori.
Costruito nel 1933, l’ex macello di Shanghai è una vasta e labirintica struttura di cemento percorsa da un sistema escheriano di scale a chiocciola, cunicoli indecifrabili e piani interconnessi. L’intento originario dei suoi costruttori era ottimizzare la circolazione del sangue, trasformando l’intero edificio in una sorta di colossale organismo animato dal sacrificio di centinaia di migliaia di corpi: una struttura porosa e vascolare in cui ogni superficie scivola inesorabilmente verso il basso. Oggi, attraversare lo scheletro del macello svuotato del sangue delle sue vittime produce nei visitatori uno spaesamento quasi allucinatorio. Le neuroarchitetture non premeditate come questa esprimono la capacità inumana di edifici e città di instaurare un’interfaccia psichica con i loro abitanti.

Dai primi insediamenti umani al paradigma della smart city, la città è sempre stata un’entità di difficile catalogazione. Oggetto e iperoggetto, spirito e materia, divinità e strumento dell’uomo, spazio di lotta e veicolo del potere. Una realtà che eccede la materia e che riflette le metafisiche, le cosmologie e la vita psichica degli individui. Il Formulaire pour un urbanisme nouveau del situazionista Gilles Ivaine e la teoria delle rovine di Albert Speer – pur nella loro distanza siderale per motivazioni e immaginari – sono accomunati dalla premessa di questo potere occulto. Lo spazio urbano assomiglia a un aggregato di metafore, simboli e allegorie veicolate dalla materialità, e che a sua volta la plasma. Questa relazione doppia – che è l’oggetto di indagine di questo numero – attraversa in filigrana l’intera storia dell’umanità: dalla struttura delle necropoli alla psicogeografia fino alle architetture digitali contemporanee.
Non riteniamo che l’evoluzione tecnologica – attraverso la proliferazione di dispositivi, schermi e sensori – abbia trasformato la città da matrice euclidea abitabile in uno scenario distopico, distante da una presunta essenza originaria. La computazione applicata oggi all’architettura ha semplicemente reso visibile il suo carattere essenzialmente “contagioso”. Come osserva Luciana Parisi, gli algoritmi, piuttosto che eseguire soltanto comandi impartiti dall’essere umano, producono nuove forme di pensiero, in quanto processi che selezionano, filtrano, decidono e anticipano. “L’architettura contagiosa”, scrive Parisi, “sta costruendo un nuovo spazio digitale, all’interno del quale le forme architettoniche e le infrastrutture urbane programmate rivelano non solo nuovi modi di abitare, ma anche nuovi modi di pensare”. Se la città digitale è programmata da algoritmi, allora non è solo organizzata da infrastrutture, ma è attraversata da vere e proprie forme di pensiero non-umane; e quello umano si rivela così solo una delle forme possibili del pensiero.
Se nel mito biblico Caino fonda la città per sottrarsi al dominio di Dio, oggi la città computazionale sembra sottrarsi al dominio dell’uomo
Questa agency opaca e diffusa riattiva un immaginario arcaico: quello della città-Dio, di un potere immanente che eccede i singoli individui. Nel descrivere la relazione tra divinità e architettura, Joseph Campbell ripercorre il poema cosmogonico babilonese Enūma Eliš, dove l’entità primordiale Tiamat è uccisa dal dio Marduk, il quale costruisce l’intero universo dai resti del suo corpo smembrato. Questo mito evidenzia una transizione significativa: con l’avvento della cultura indo-europea, il cosmo smette di essere compreso come un organismo e inizia a essere pensato come un edificio. Ma, per quanto questa architettura cosmica incarni l’idea di ordine, essa rimane impregnata del sangue di una violenza originaria. Nella Genesi, Caino fonda la prima città come gesto di emancipazione dal Dio unico; un atto attraverso cui l’uomo istituisce una forma di pensiero autonoma rispetto alla trascendenza. La civiltà inizia con la città e con ciò che essa incarna: radici, territorio, potere e, soprattutto, idolatria. Nella visione pagana, ogni città cerca la propria divinità protettrice, ed è per questo maledetta da Yahweh. Se nel mito biblico Caino fonda la città per sottrarsi al dominio di Dio, oggi la città computazionale sembra sottrarsi al dominio dell’uomo. E in questo modo la città realizza ciò che il mito temeva.
Si può ipotizzare, allora, che la città, come ogni sistema fisico-cognitivo, può essere affetta da un morbo. Se la città non è più un semplice oggetto ma una forma di soggettività, allora sulla sua stabilità, esattamente come le menti e i corpi umani, incombono stati patologici: ossessioni spaziali, metastasi architettoniche, derive schizofreniche della forma, degenerazioni organiche. Il misterioso gruppo di ricerca M.A.G.U.S., partendo in questo numero dal caso di Roma, si propone di analizzare la città non più solo come tecnologia o come sistema magico-occulto, ma come vera e propria patologia, per «capire in che modo la manifestazione materiale di edifici, quartieri e strade, il loro aspetto tangibile e concreto, la loro mera presenza, riescano a produrre uno stato morboso il cui quadro clinico è il diretto esito di un agente eziologico inscritto nel semplice “essere città”».
E se la città può delirare, qualcuno deve pur raccoglierne i sintomi. Cosa succede quando la mente stessa degli architetti che la disegnano si fa vettore del linguaggio tossico-mutageno della città? In questo numero abbiamo riportato in vita la rubrica cult che l’immaginifico Oscar Sentimento tenne tra il 2019 e il 2022. Solo per architetti tossicodipendenti è un archivio iconografico di allucinazioni urbane, psicosi edilizie e visioni SERTologiche. Protagonisti e destinatari esclusivi sono appunto «questi fantomatici architetti tossicodipendenti – in realtà nulla più di una versione svaporata dell’idea stessa di architetto – che, di deriva in deriva, di dose in dose, spinti pure da un delirio pseudo professionale mutaforme, vengono puntualmente fagocitati dallo stupefacente che si staglia dinnanzi ai loro occhi». Sovrascrivendo le intenzioni e i programmi degli architetti, ai margini abbandonati della città, gli edifici si fanno portatori di segni e linguaggi occulti, testimoni di presenze spettrali sotto forma di pratiche artistiche clandestine. Vittorio Parisi definisce questo fenomeno muralismo occulto, raccontando come le opere di artisti quali Dissenso Cognitivo, Void o Sauzer costruiscono una semiotica rizomatica e infestante.
L’articolo di Priscilla De Pace, invece, legge, The Sims come laboratorio di neuro–urbanistica virtuale. Il celebre videogame viene analizzato come simulazione del sogno suburbano americano e al tempo stesso come suo glitch: un ambiente costruito per disciplinare la vita quotidiana che, grazie alle comunità di modder, si trasforma in terreno di contestazione, riappropriazione e sabotaggio. Mentre Stefano Dealessandri ci porta al centro della Smart Control Room di Venezia, dove la digitalizzazione dello spazio urbano sfocia nella paranoia, e spinge l’autore – attraverso l’opera di artisti come Adam Harvey e Zach Blas – a cercare delle vie di fuga.
Come racconta il filosofo Achille Mbembe, la scala immane della distruzione innescata dalle tecnologie belliche oggi, in un tempo che potremmo definire di “fine della fine della storia”, ci mette di fronte alla dimensione politica dell’abitare uno spazio dove la materia stessa è innervata di memoria e cosmologie. L’articolo di Tommaso Gori analizza come l’architettura e la pianificazione urbana siano diventate uno strumento di dominio nei territori palestinesi occupati, manipolando forma e linguaggio della città, anche attraverso l’uso delle tecnologie di sorveglianza. La costruzione degli insediamenti è inseparabile dalla distruzione materiale e morale delle abitazioni palestinesi: un vero e proprio “spaziocidio”, cioè l’annientamento deliberato anche delle relazioni che costituiscono lo spazio vitale di un popolo.