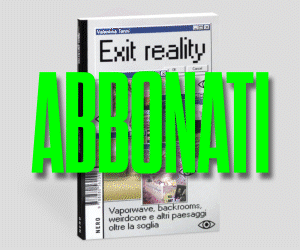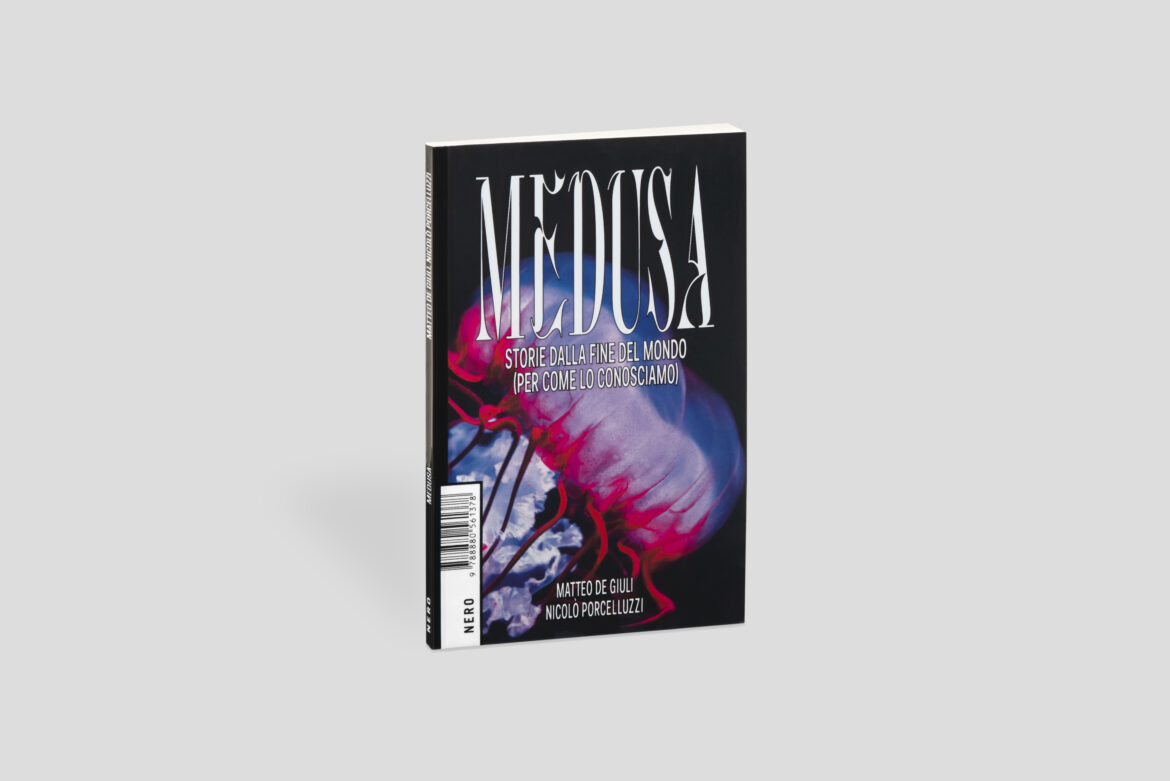Oltre ad accendere il fuoco, cacciare animali o cucinare il cibo, costruire un riparo deve essere stata una delle prime attività consapevoli intraprese dagli esseri umani dal momento in cui sono riusciti a stare in piedi. La nascita dell’architettura deve essere stata concomitante con la conquista della verticalità: cioè il momento in cui, grazie allo sviluppo dell’apparato cerebrale, gli esseri umani hanno acquisito la capacità di camminare eretti. Da quel momento in poi, la mano smise di essere un semplice strumento. Strettamente connessa al cervello, divenne una “forza motrice” capace di mettere in relazione strumenti e linguaggio, immagine e significato.

La rivoluzione urbana descritta da Gordon Childe fu preceduta dalla domesticazione delle piante e delle specie animali. Frutto, in parte, della combinazione di commercio, conquista e migrazione, essa portò alla trasformazione delle istituzioni sociali e aprì la strada a nuove modalità di costruzione di case, templi e monumenti pubblici. La gestione degli insediamenti per i poveri delle città e la costruzione di abitazioni a una velocità e a una scala senza precedenti sono stati tratti distintivi della modernità. In parte ingegneria (energia e trasporti), in parte medicina (acqua, igiene, sanificazione), in parte agricoltura (sicurezza alimentare) e in parte informazione e comunicazione, l’architettura è oggi intrecciata all’intera trama della vita materiale e immateriale. È una dimensione essenziale di quella che André Leroi-Gourhan chiamava “tecnologia sistematica”.
Come la scrittura o la stampa, la costruzione di un riparo fu una pietra miliare nella mutazione attraversata dalla specie umana. Forma di cognizione incarnata, essa contribuì al potenziamento di capacità vitali come il controllo e lo smaltimento dei rifiuti, l’approvvigionamento di cibo e acqua, le pratiche di cura reciproca, di difesa e protezione, persino la sessualità e altre forme di individuazione.
Poiché l’arte di costruire un riparo era, al tempo stesso, una scienza del restare in vita, nelle metafisiche africane precoloniali l’architettura era definita come uno dei molteplici utensili della vita. Una testimonianza vivida di questo progetto di sopravvivenza è l’architettura in pietra, fango e terra dei Dogon (Mali). Le case dogon erano costruite in pietra a secco e ricoperte di terra, spesso edificate sul fianco delle falesie. Poco lontano si trovavano i piccoli granai rettangolari, modellati a mano con uno strato sottile di terra che permetteva alla struttura di “respirare”. I tetti erano ricoperti di paglia per proteggerli dalla pioggia. L’interno, intonacato di terra per sigillare le fessure, era suddiviso in vari scomparti per conservare i diversi cereali.
In un ambiente modellato da altipiani di arenaria, ripide scarpate, falesie e pianure, si era radicata una lunga tradizione di costruzione in mattoni di fango e granai di argilla impastata a mano. La forma e la struttura di queste case erano plasmate dalla geologia e dal clima, e testimoniavano gli effetti continui dell’erosione. Questo stile di architettura in terra era inseparabile dalle cosmogonie dogon, dalla loro organizzazione sociale e dalla vita rituale. La terra era la madre della vita e il cielo il padre che, attraverso la pioggia, fecondava la terra, rendendo possibile la vita. Nicchie e porte erano spesso decorate con motivi scolpiti che riflettevano la metafisica dogon della vita e della morte, del giorno e della notte, del genere e della riproduzione, degli scambi tra esseri umani e animali.
non esisteva architettura senza la presenza del linguaggio nella materia. L’architettura era il processo attraverso cui la materia si trasformava in immagine e concetto. Era una sorta di trascrizione simbolica di forze vitali
In altre regioni dell’Africa, l’essere umano è sempre stato più che umano. Grazie agli strumenti, poteva potenziare sé stesso. Per questo costruire una casa non era solo un atto di ingegneria, uno sforzo manuale, fisico, muscolare. Fin dall’origine implicava l’emergere e la decifrazione di immagini e concetti. Fondeva estetiche concettuali, sensoriali e immersive (luce e ombra, volume, texture, odore, suono) con esigenze pratiche. Un riparo non era soltanto un contenitore. Era, per definizione, uno spazio dialogico di chiusura e apertura. Esprimeva il modo in cui l’essere umano abita la terra e costituiva il mezzo attraverso cui prende forma, esistendo in compagnia di ogni altro vivente.
Per questo non esisteva architettura senza la presenza, anche solo in filigrana, del linguaggio nella materia. L’architettura era il processo attraverso cui la materia si trasformava in immagine e concetto. Era una sorta di trascrizione simbolica di forze vitali, l’infusione di sostanze di vita e il rilascio di energia nella materia e nei materiali. Faceva parte integrante delle infrastrutture vitali e degli artefatti materiali e simbolici necessari al lungo processo di diventare pienamente persone umane.
Se il significato poteva essere progettato attraverso i materiali, i materiali a loro volta potevano servire da riparo e da canale per la diffusione di immagini, concetti, linguaggio. Linguaggio, immagini, simboli, concetti e significati erano destinati a trovare dimora nell’elementale, inducendolo a liberare energie vitali necessarie alla formazione della persona. Ecco perché la distruzione di un riparo umano – la massima forma di terrore – era considerata un atto radicalmente inumano.
Una caratteristica centrale della nostra epoca – l’età del brutalismo – è la capacità del potere di “ripulire” territori e produrre destituzione. Dis-abitare [Unhoming] dovrebbe essere il nome di questa catastrofe. Dis-abitare significa prendere deliberatamente di mira le case, distruggere i ripari e abbreviare l’esistenza di intere classi di esseri umani ritenuti superflui. È un processo di espulsione il cui scopo finale è trasformare un’umanità indesiderata in scarto. Nel processo di dis-abitazione, le capacità di sopravvivenza delle persone vengono gravemente compromesse, e le loro possibilità riproduttive mutilate per diverse generazioni. Il Dis-abitare non è un atto casuale. È un programma di sradicamento attivo e di privazione delle risorse essenziali necessarie per vivere come esseri umani in società, a partire dal cibo e dall’alloggio. Non è solo un fattore scatenante della destituzione (come nel caso sudafricano, con i programmi di sfratto forzato). Nell’epoca brutalista che abbiamo appena inaugurato, il Dis-abitare è il nuovo strumento di selezione sociale e politica.
Ma che cos’è il Dis-abitare, se non un modo di condurre una guerra contro nemici i cui ambienti di vita e le cui condizioni di sopravvivenza sono già stati distrutti in anticipo – con l’uso di munizioni all’uranio perforanti e di armi proibite come il fosforo bianco; con bombardamenti ad alta quota che annientano le infrastrutture di base; con cocktail di sostanze cancerogene e radioattive depositate nel suolo e diffuse nell’aria; con la polvere tossica delle città rase al suolo e l’inquinamento causato dagli incendi di idrocarburi.
E che cosa sarebbe il Dis-abitare senza le bombe – blind bombs convenzionali convertite mediante l’installazione, nella coda, di sistemi di navigazione inerziale; missili da crociera con testate a ricerca infrarossa; bombe a microonde progettate per paralizzare i centri nevralgici elettronici del nemico; bombe che esplodono nelle città emettendo lampi d’energia simili ai fulmini; altre bombe a microonde che non uccidono, ma bruciano i corpi e aumentano la temperatura della pelle; bombe termobariche che generano muri di fuoco, assorbendo l’ossigeno degli spazi più o meno chiusi, uccidendo per onda d’urto e asfissiando quasi tutto ciò che respira; bombe a frammentazione, devastanti per le popolazioni civili, perché si aprono in aria e si disperdono senza precisione su vaste aree; munizioni progettate per esplodere a contatto con il bersaglio; una gamma infinita di bombe, dimostrazione ad absurdum di una potenza di distruzione inaudita.
Questa forma di guerra che produce stordimento – calcolata, programmata, condotta con mezzi inediti – è una guerra contro l’idea stessa dell’abitare. Le bombe non mirano a corpi singoli, ma a masse umane, i cui organi devono essere oggetto di una incapacità mirata, trasmissibile di generazione in generazione: gli occhi, il naso, la bocca, le orecchie, la lingua, la pelle, le ossa, i polmoni, l’intestino, il sangue, le mani, le gambe. Tutti quegli individui mutilati, paralizzati, sopravvissuti; tutte quelle malattie polmonari come la pneumoconiosi; tutte quelle tracce di uranio nei capelli, le migliaia di tumori, aborti, malformazioni infantili, deformazioni congenite, toraci compromessi, disfunzioni del sistema nervoso – la frattura irreparabile.
L’epoca del brutalismo è l’età delle macerie e della polvere. Siamo circondati da innumerevoli città ridotte a polvere e rovine: Grozny, Homs, Aleppo, Gaza. La memoria oggi trova riparo nel fango, nelle macerie e nella polvere.
Nell’epoca del brutalismo, tornare a casa non può più essere dato per scontato. Pochi, del resto, hanno ancora una casa a cui tornare. In questi tempi allucinati, l’architettura riguarda la ricostruzione delle vite. Riguarda il ripristino dei mezzi di sussistenza e la fornitura di un rifugio a coloro che, avendo perso tutto e ritrovandosi senza casa, “possono sentirsi a casa solo nei loro corpi”.
Si tratta di ripristinare il riparo e costruire cittadelle di sopravvivenza. Ricostruire un riparo inizia con l’identificazione e la rimozione dei rifiuti pericolosi, compresi gli ordigni inesplosi (UXO), i rifiuti medici, e con la bonifica e il riciclo di milioni di tonnellate di macerie. L’architettura diventa allora un progetto di sgombero delle rovine, affinché i destituiti possano avere un riparo più sicuro nel momento in cui cominciano a ricostruire la propria esistenza.
Questo intervento è stato originariamente pubblicato in Insurgent Geologies, a cura di Nick Axel, Nikolaus Hirsch, Owen Hopkins, Kabage Karanja, Stella Mutegi, e Kathryn Yusoff (e-flux Architecture, 2025), che ringraziamo per la gentile concessione.