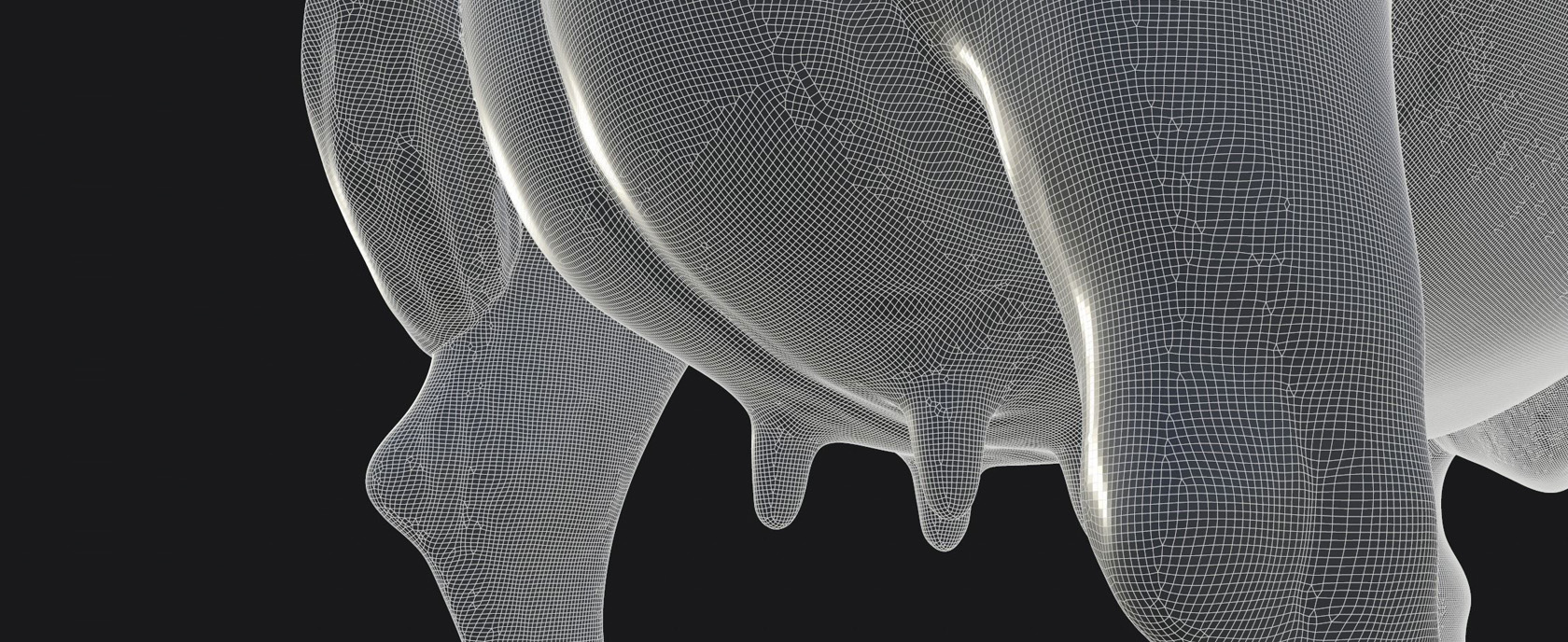Quando brucia il tetto di una cattedrale
Le fiamme
No, se pensate che questa sia l’ennesima riflessione tardiva sull’incendio di Notre-Dame, siete decisamente fuori strada. La cattedrale cui fa il riferimento il titolo di questo testo è infatti quella di cui parla Max Horkheimer in un passo di Crepuscolo. Appunti Presi in Germania 1926-1931 (Einaudi, 1977), nel quale il filosofo e sociologo tedesco descrive la società come un grattacielo in sezioni, il cui tetto svettante verso il cielo, simile a quello di una cattedrale, assicura una bella vista a chi abita i piani alti, ma i cui sotterranei nascondono un vero e proprio inferno, l’«indescrivibile e inimmaginabile» inferno animale. Capita, però, che anche i tetti delle cattedrali più sacre prendano fuoco, e che le fiamme di quest’inferno giungano fino in alto, aprendosi un varco laddove non ci sarebbe spazio che per l’ingresso della luce. Quando si vede bruciare il materiale su cui poggia e si eleva questo imponente edificio, la chiarezza si offusca e si rende necessario aggiungere nuovi sostegni, oppure, forse, demolire le vecchie strutture ormai pericolanti (e non è questo per fortuna il caso della cattedrale parigina).
Fuor di metafora, quando gli animali, i discorsi (sugli) animali, ma anche e soprattutto i loro corpi, irrompono nello spazio di sicurezza che l’uomo ha progettato per il predominio della propria specie, puntellandolo saldamente di dispositivi, tecniche, regole ed esercizi, possono accadere due cose: o la questione animale si «accende» e diventa politica, oppure, visto il rischio che ciò comporterebbe per il sistema, vengono messi a punto interventi di emergenza finalizzati a domare nuovamente le fiamme e riportarle nei sotterranei della cattedrale.
Le gabbie
Di antispecismo soprattutto come prassi politica, e della sua urgenza di fronte a un crescente «annacquamento» della questione animale, parlano i testi raccolti nel volume a cura di Marco Reggio e Niccolò Bertuzzi Smontare la gabbia. Anticapitalismo e movimento di liberazione animale. A collegare questi saggi, organizzati in tre sezioni che analizzano i movimenti, i temi-chiave e le pratiche antispeciste –sezioni che per la verità si richiamano felicemente l’una con l’altra proprio in virtù della non facile separabilità fra teoria e prassi nella politica antispecista –, è un invito alla mobilitazione, intesa sia come azione diretta sia come riconoscimento e incontro dei corpi in movimento, antidoto ai sistemi di ingabbiamento materiale in cui sono detenuti i corpi nelle batterie degli allevamenti intensivi, degli zoo, degli stabulari, degli hotspot, dei CPR, ma anche simbolico (dagli effetti altrettanto materiali) in base al quale gli animali non umani e gli umani animalizzati sono inseriti in tassonomie le cui definizioni insistono le une sulle altre ampliando l’esercizio e l’efficacia dell’oppressione.
Come appare chiaro fin dal sottotitolo, e come ribadito nella postfazione di Massimo Filippi, per smontare queste gabbie non basta immaginare un diverso approccio morale a partire dal quale riconoscere ed estendere ai non umani gli interessi e i diritti degli umani, perché una visione di questo tipo resta confinata nella sfera individuale ed è dunque viziata in partenza, dato che non mette in discussione il privilegio che il Soggetto Homo sapiens ha costruito e mantenuto nella sua antitesi con l’Animale. Le operazioni di speciazione, che sono sempre fatti storico-sociali e non leggi naturali, al pari di quelle di razzializzazione o sessualizzazione, invisibilizzano la propria produttività una volta condensate nelle categorie corrispondenti (specie, razza, sesso etc.), operando secondo una logica disgiuntiva e gerarchica funzionale a regolare i meccanismi di inclusione ed esclusione sociale. È dunque nel comune attraversamento, nel movimento che lascia arrivare i corpi animali, piuttosto che nell’inclusione o nell’estensione unidirezionale che va dall’Umano all’Animale, là dove cessa di esistere una netta separazione tra il Dentro e il Fuori assoluti, che si può pensare di abbattere le gabbie che racchiudono l’Animale, e con questa categoria tutto ciò che di volta in volta non si conforma al privilegio dell’Umano, per affrontare alla radice le molteplici forme di sfruttamento della vita, in vista di una riorganizzazione anticapitalistica e interspecie delle relazioni.
Animali e capitale
Gli animali hanno avuto un ruolo fondamentale nello sviluppo del capitalismo,[1] non solo perché sono stati strumenti e merci per l’accumulo della proprietà, ma anche perché, come ha sostenuto in particolare Jason Hribal rivedendo la posizione marxiana per la quale la forza lavoro può essere soltanto quella umana, gli animali sono forza lavoro: quand’anche non possiedano una coscienza di classe (sebbene ciò di cui l’animale è mancante è sempre tale in relazione all’uomo che ne pensa la mancanza in rapporto a sé), gli animali in quanto soggetti agenti non sono né un substrato passivo per l’esercizio dell’azione umana, come credeva Marx, né delle macchine, nonostante a queste siano state strumentalmente ri(con)dotti, dalla tradizione del pensiero meccanicistico di derivazione cartesiana fino alle pratiche di de-individualizzazione del complesso animal-industriale perfezionate dalla contemporanea zootecnia (tra gli esempi più recenti la mungitura robotica) e dall’ingegneria genetica.
Diventati vere e proprie tecnologie viventi (sarebbe meglio dire, tenute in vita), gli animali oggi sono lavoratori sfruttati sia per il loro lavoro produttivo (di prodotti derivati, ma anche di se stessi in quanto prodotti) che per quello riproduttivo (di nuovi corpi animali con cui alimentare il circuito senza fine della produzione-riproduzione). Al lavoro degli animali non umani è legato anche il concetto di plusvalore, se lo si rintraccia nel lavoro riproduttivo delle femmine animali e nell’impiego commerciale del loro latte eccedente ricavato dal ciclo naturale gestazione-lattazione. D’altra parte, nelle attuali condizioni del capitalismo diffuso, del lavoro nell’epoca del «Bio-Tutto», non vale più neppure ciò che avrebbe potuto, forse, distinguere ancora lavoratori umani e non umani, ovvero la possibilità di tenere separati il tempo libero dal tempo del lavoro, la casa dalla fabbrica, una continuità che per gli animali si trasforma in una sottrazione dell’intero processo vitale, dal concepimento (sempre più spesso artificiale) al termine dell’esistenza (cadenzato sulla base di precisi parametri).
Considerare gli animali come lavoratori non implica solo l’adozione di un diverso linguaggio, ma anche di una diversa prospettiva, non più quella dall’alto verso il basso, la prospettiva del capitale che fa degli animali oggetti, ma all’inverso quella dal basso, che considera gli animali come soggetti a pieno titolo, dotati di agentività e capaci di resistere e ribellarsi e non soltanto subire o reagire. Nonostante siano selezionati eugeneticamente e modificati fisicamente per essere il più possibile docili e «funzionali», certi animali (non tutti, certo, non gli animali in astratto, ma alcuni soggetti animali) non collaborano, ostacolano, scalciano, scappano, si lasciano persino morire pur di opporre resistenza al loro sfruttamento, come testimonia l’osservatorio permanente del Collettivo Resistenza Animale, che firma uno dei saggi del volume.

Annacquare, ripulire
Alla sussunzione e conseguente invisibilizzazione degli animali come soggetti agenti nel capitalismo contemporaneo corrisponde, oggi, una proliferazione mediale dei simulacri animali. I concetti di benessere animale e carne felice su cui si sofferma il saggio del Collettivo BioViolenza sono aspetti evidenti di questa normalizzazione dei rapporti di sopraffazione da parte del capitalismo, della grande industria come delle filiere più corte: attorno al benessere animale ruota per esempio la recente campagna delle uova cruelty free COOP, tali perché prodotte senza uccidere i pulcini maschi alla nascita (altrimenti triturati o gassati perché inservibili) nel contesto di una più ampia azione di vero e proprio animal-washing, cioè un animalismo di «ripulitura» usato come strategia di marketing, chiamata «Alleviamo la salute», mirante in primis a ridurre l’uso di antibiotici negli allevamenti, in cui da tempo è impegnata l’azienda – già premiata dall’associazione Compassion World Farming con il premio Good Egg (che abbiano ricevuto il premio Good Chicken multinazionali come McDonald o aziende italiane come Amadori dovrebbe quantomeno far riflettere). Poco importa che questo propagandato benessere non segua i futuri polli fino all’età «adulta» (per modo di dire, visto che vengono uccisi in media entro il mese e mezzo di età, cioè quando raggiungono il «giusto peso»), quando saranno regolarmente macellati per essere impacchettati a pezzi e venduti sugli scaffali dei supermercati.
Discutere di una maniera etica di uccidere gli animali in un contesto economico come l’attuale che dipende dall’istituzione del loro massacro è solo un modo per lenire la coscienza del consumatore edulcorando il mattatoio attraverso una serie di valori aggiunti (unicità, qualità e gusto) di cui l’animale umano è l’unico destinatario. Spesso le cosiddette «aziende etiche» propongono un modello di natura estremamente artificializzato (e fin qui potrebbe anche andar bene, visto che qualsiasi modello di natura lo è) non solo spacciandolo per un (impossibile) ritorno a uno stadio precedente l’allevamento intensivo, ma anche confezionando della fattoria tradizionale un modello pittoresco, da cartolina – di cui un’illustrazione molto efficace e pacificante è la «fattoria didattica» – che decisamente nulla ha a che vedere con la «vecchia fattoria», dove i rapporti fra animali umani e non umani erano improntati a un’estrema violenza e le condizioni di vita erano difficili per tutti (per farsene un’idea basta leggere il romanzo Regno Animale di Jean-Baptiste Del Amo, che racconta senza abbellimenti la trasformazione di una fattoria in allevamento intensivo seguendo la storia dei proprietari nell’arco di tutto il Novecento).
Adottando una retorica antropocentrica, ambientalismo, locavorismo e benessere animale finiscono spesso per far parte di un unico calderone che comprende anche l’assimilazione commerciale del veganesimo – altrimenti demonizzato e indigesto – nella sua unica forma accettabile, rinconducibile alla dieta (meglio se temporanea) e al lifestyle, l’ultima redditizia fetta di mercato (ne parla il saggio di Nicola Righetti). In questo modo al vegano, già abituato a essere categorizzato e stereotipato come ascetico, puritano, irrazionale, freak, fanatico o disturbato, si appiccica un’altra etichetta, quella del prezzo, per vendere (e spendere) il veganesimo riportandolo al livello dei consumi e delle scelte personali, e in questo modo sabotando indirettamente, per «svuotamento», la critica politica del veganesimo al privilegio specista (le fondamenta del sistema).
Dall’animalismo trasversale all’antispecismo intersezionale
All’arginamento del portato politico dell’antispecismo corrisponde una maggiore attenzione per la questione animale più genericamente intesa in un numero sempre crescente di contesti. Francesca De Matteis e Niccolò Bertuzzi nel loro testo si soffermano per esempio sulle campagne di informazione e sensibilizzazione online a tema, i cui effetti tanto rapidi quanto a breve termine finiscono per schiacciare l’intervento politico tra i due estremi di una partecipazione tendenzialmente emozionale, calibrata sulla velocità di un click, e dell’iper-razionalità dei dati forniti a riprova dell’efficacia delle azioni proposte, intercettando così due opposte tipologie di animalisti e utenti della rete rispetto ai quali fare leva sulle dinamiche di visibilità, partecipazione e appartenenza tipiche della costruzione delle identità digitali. Pur se animato da buone intenzioni, l’approccio di queste campagne trova in genere espressione in un riformismo conciliante che non di rado finisce per prestare il fianco agli interessi dell’interlocutore, mai veramente messo in discussione da un dialogo che si prefigge di essere sempre «costruttivo».
Anche la panoramica dei rapporti fra l’animalismo e la politica in Italia fatta da Bertuzzi e Reggio, che gli autori riconducono alle sue radici storiche per raccontarne l’attuale deriva, è tutt’altro che confortante. L’interesse che soprattutto i partiti di destra mostrano per la questione animale (senza contare i vari gruppi della destra estrema con le loro usuali strategie di infiltrazione) è un chiaro segno della sua normalizzazione ai fini di una strumentalizzazione propagandistica, condensata nella fotografia di Berlusconi che abbraccia l’agnellino salvato dalla mattanza pasquale nella sua villa di Arcore – versione zuccherosa e alquanto inquietante della classica icona dell’attivista incappucciato dell’Animal Liberation Front. Nel contesto di un restyling del berlusconismo è nato infatti il Movimento Animalista fondato da Michela Vittoria Brambilla, che pur avendo avuto un impatto elettorale ridotto ha funzionato da magnete mediatico con le sue azioni, come la campagna Fermare Green Hill, i blitz negli allevamenti e le visite ai rifugi, che hanno reso difficili le critiche da parte dell’ambiente animalista e ha limitato la visibilità, da molti considerata «inopportuna», di quelle che invece sono state avanzate, che rilevavano in particolare l’amalgama di slogan radicali e istanze moderate, azioni di denuncia e moralismo pietistico, e in definitiva una visione proprietaria e neoliberista dell’animale come pet da salotto cui garantire la sacra trinità di diritti famiglia-pappa-divano. Dal canto suo, la Lega ha fatto ricorso a un presunto animalismo d’occasione per rafforzare le proprie posizioni apertamente xenofobe, per esempio denunciando le pratiche della macellazione islamica, o non perdendo occasione per etichettare come barbare azioni connesse all’abuso di animali, ma solo nel caso in cui coinvolgessero stranieri (la Lega vanta fra i suoi membri numerosi difensori della caccia), mentre nel frattempo Salvini ha continuato tranquillamente a esibire i suoi pasti a base di ragù, bacon e salsicce.
Al qualunquismo di questo animalismo spugnoso, trasversale, da occasione, utile al mercato, alla propaganda e alla coscienza, l’antispecismo risponde proponendo una politica che coniuga l’approccio situato e l’analisi intersezionale delle oppressioni (articolato da feminoska nel suo saggio), ovvero il riconoscimento dell’esperienza e della specificità del posizionamento incarnato di ciascun vivente come correttivo del ricorso a verità assolute, e insieme la consapevolezza che le oppressioni interagiscono in modi diversi ma fra loro interagenti come correttivo alla fuga in un relativismo irresponsabile. Per avere un’idea del modo in cui le oppressioni incidono sui corpi animalizzati in modi specifici e sistemici basta guardare la composizione dell’attuale manodopera nell’industria della carne, dalla macellazione al confezionamento al rendering, in larga maggioranza formata da immigrati (molti dei quali donne) perlopiù irregolari, immessi nel settore come «materiali umani di scarto» (ne parla anche Francesca Gelli nel suo saggio), soggetti a un elevato numero di infortuni sul lavoro (sono frequenti, come a duplicare l’animale smembrato, amputazioni dovute alla velocità dei processi di lavorazione), senza tutele sindacali e sottoposti a un elevatissimo turnover: è un destino usa-e-getta, il loro, non molto diverso da quello degli «animali da reddito».

La spaccatura
Riconoscere le oppressioni che ci attraversano e ci connettono ci permette da un lato di comprendere che i confini aprono le identità, piuttosto che delinearle stabilmente, dall’altro di adottare una prospettiva parziale, della «spaccatura» invece che dell’essere, come la definisce Donna Haraway in Manifesto cyborg, che facendo a meno dell’identitarismo e dalla proprietà costituisca una base diversa per incontrarsi fra corpi animali. Se la domanda sul soffrire animale ha modificato quella sul loro pensare, inaugurando certamente una diversa attenzione per il vivente non umano ma non arrivando mai davvero a scalfire il privilegio dell’Homo sapiens che elargisce tale considerazione, la domanda sull’agire animale consente di utilizzare un’altra logica del limite, che ispessisce e ripiega la differenza moltiplicandola, e mostrando come al di là dell’unico bordo pattugliato dalle macchine antropogeniche non esista un’Alterità animale fissa, ma una molteplicità di soggettività parziali in movimento, non uniformi e in/appropriate.
Abbiamo racchiuso gli animali in gabbie letterali e metaforiche per classificarli e subordinarli – consideriamo per esempio la macro-distinzione fra pet, animali cosiddetti da reddito e animali randagi (a questo proposito Davide Majocchi si sofferma sulla costruzione storico-sociale della «canità» e l’attuale impensabilità del cane senza padrone). Ma quando i corpi animali si muovono e attraversano le sbarre, resistendo nei modi in cui è loro possibile farlo, i loro attraversamenti ci interrogano sui privilegi di chi detiene il potere di creare e chiudere queste gabbie, e in ultima istanza sul Luogo del Soggetto. Gli animali che evadono dagli allevamenti intensivi, per esempio, sono fuori luogo perché, già selezionati per avere alcune caratteristiche genetiche adatte alle esigenze del mercato, non sono più in grado di sopravvivere autonomamente, né possono tornare a una società animale di cui non fanno parte. In tal senso i cosiddetti santuari (di cui parla Maria Cristina Polzonetti con Agripunk a partire dall’esperienza di Agripunk) sono modelli alternativi di convivenza – che si spera portino alla loro stessa abolizione – che non si basano su definizioni o legami pre-costituiti fra umani e animali, ma dove gli animali, equiparabili a veri e propri rifugiati (poiché come questi non ha un altro luogo dove stare o tornare), semplicemente vivono, senza essere sottoposti ad attività o interazioni non volute.
Lasciare arrivare i corpi animali non vuol dire accoglierli e includerli nella società degli uomini, perché questo non incrina affatto la logica disgiuntiva della separazione originaria, ma incontrarli nell’esperienza di una comune limitrofia, come la chiama Jacques Derrida ne L’animale che dunque sono, dove i corpi esistono e si muovono in relazioni, non per opposizioni. In quest’ottica, la politica antispecista converge con tutti quei movimenti che, come il transfemminismo, il pensiero queer o i movimenti in difesa dei rifugiati, «rimettono i corpi in transizione» (Filippi), o per meglio dire creano le condizioni di possibilità per affermare le transizioni come costitutive di ogni soggettività, non solo di quelle appartentemente «diverse da» e «non conformi», e per contrastare sinergicamente le intersezioni delle oppressioni. In questo riconoscimento della differenza in comune, nel comune, nel passaggio dal piano individuale al collettivo, dall’identità alla relazionalità, la politica antispecista si afferma come una «politica delle alleanze» simbiontica, ricombinante e non chimerica (cioè soltanto additiva di identità pre-esistenti), come scrive feminoska a partire da Haraway.
Fondata sulla contaminazione e sulla ibridazione[2] piuttosto che sulla purezza, questa politica del comune potenzia l’alienazione al massimo grado, come auspicato anche dallo xenofemminismo (del Manifesto Xenofemminista, tra l’altro, feminoska è stata la traduttrice italiana con il Collettivo Les Bitches). Il punto, in definitiva, non è trovare nuove rappresentazioni degli animali, ma mettere in atto nuove pratiche (e gli esempi riportati nel libro sono numerosi) attraverso cui riconnettere umani e non umani in un diverso modo di fare mondo insieme. «Forse è giunto il tempo di guardarsi allo specchio, e smettere di riconoscersi», scrive ancora feminoska, farla finita, insomma, con la ricerca della Somiglianza e anche con la definizione della Differenza. Forse questo specchio possiamo anche coprirlo, e darci da fare invece che stare ad aspettare una nuova rivelazione o l’ennesima illusione del nostro sguardo.
[1] Già etimologicamente, la proprietà come accumulo di capitale e gli animali sono strettamente collegati, come mostra la comune radice di termini provenienti dal latino caput, quali cattle, chattel, catel, riferiti ai capi di bestiame e alla proprietà mobile, e così pure la derivazione del latino pecunia (denaro) da pecus (pecora ma anche bestiame, scambiabile come denaro).
[2] Che sarebbe opportuno richiamare ogniqualvolta si attaccano i vegani come puristi e fanatici.