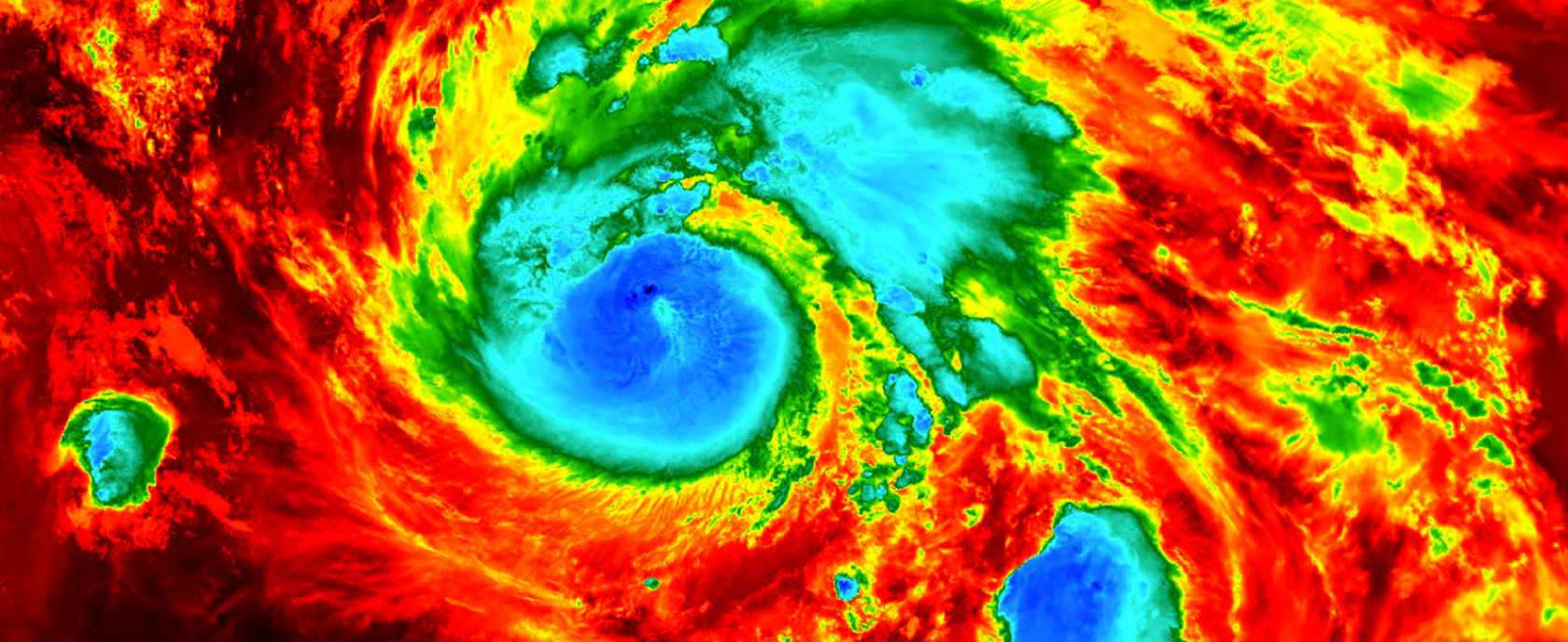Rimandare la catastrofe
MEDUSA è una newsletter bisettimanale che parla di Antropocene, dell’impronta dell’essere umano sulla Terra, di cambiamenti climatici e culturali. A chi si iscrive, ogni due mercoledì arriveranno un articolo inedito, delle brevi news e un po’ di dati per ragionare su questi temi. Una volta al mese un contenuto di MEDUSA viene ospitato anche su Not: può essere un estratto di un articolo già pubblicato sulla newsletter, una sua variazione, o un contenuto appositamente pensato per la rivista. Insomma, se ti interessa MEDUSA, la cosa migliore è iscriversi alla newsletter.

There is no alternative era uno degli slogan di Margaret Thatcher: il benessere, i servizi, la crescita economica, sono obiettivi raggiungibili esclusivamente percorrendo la via del libero mercato. Quarant’anni più tardi, oggi, nel mondo costruito su quelle promesse elettorali, There is no alternative suona più che altro come una cupa constatazione, un motto che traccia i limiti dell’immaginazione collettiva: non c’è alternativa al sistema in cui viviamo. Anche quando veniamo toccati dalla crisi, anche dove arrivano disagio, sfruttamento e sperequazione, rimaniamo tutto sommato inermi davanti allo stato di cose. Non c’è via di fuga – o non la vediamo: lo spazio del possibile è ormai circoscritto. «Che cos’è successo al futuro? Che fine ha fatto?»
Inventare il futuro di Nick Srnicek e Alex Williams uscirà la prossima settimana per la collana Not di NERO, con la traduzione di Fabio Gironi. È un’analisi della sconfitta della sinistra mondiale –sopraffatta, obsoleta, tagliata fuori – ed è un tentativo di tracciare una nuova mappa degli orizzonti di quell’area politica. Secondo Srnicek e Williams per sfidare il neoliberismo non bastano più i tentativi di alternativa localista, le proteste, la democrazia diretta, gli esperimenti Belli Ma Infruttuosi alla Occupy Wall Street: bisogna ambire a una società post-capitalista basata su un’ideologia egemone e ultra-moderna, dove il lavoro venga il più possibile automatizzato e il decoro delle vite di tutti sia salvaguardato dal reddito universale di base.
Non sono sufficientemente qualificato per poter scrivere una critica significativa del libro, ma se nonostante tutto state leggendo queste righe è perché Inventare il futuro fornisce più di un paio di argomenti che possono tornare utili per le nostre riflessioni sull’Antropocene. Prima di tutto è un libro con una tesi seducente, consapevolmente utopica, che fa espliciti riferimenti ai cosmisti russi di fine Ottocento, quelli che volevano conquistare lo spazio e sconfiggere la morte, profeti del controllo dell’Uomo sulla Natura. È un saggio accattivante non solo per lo slancio futurista, ma anche per il dettaglio con cui racconta invece il pantano, l’eterno presente in cui siamo irretiti (e su questo riprende diverse intuizioni di Mark Fisher e del suo Realismo Capitalista).
«Il futuro è stato cancellato: siamo più inclini a credere che la catastrofe ecologica sia imminente, la militarizzazione della società inevitabile e l’aumento delle disuguaglianze inarrestabile» che a lanciarci in qualche progetto, per quanto faticoso, di costruzione del domani. Viviamo come una resa incondizionata le criticità della società moderna. Accettiamo con fatalismo simile una cosa enorme come i cambiamenti climatici.

Inventare il futuro a Ebbing, Missouri
Perché non riusciamo a interessarci sul serio al riscaldamento globale? Perché è uno di quei sistemi complessi che, secondo la definizione di Srnicek e Williams, «operano per di più su scale temporali e spaziali che vanno ben al di là delle nude capacità percettive di un singolo individuo» e i cui effetti «sono così estesi che un’esatta collocazione della nostra esperienza nel loro contesto risulta impossibile». Insomma il problema climatico è anche conseguenza di un problema cognitivo. Siamo persi nei corridoi di un edificio articolato e vasto, dove a una nostra azione non corrisponde una reazione diretta e immediata, e non abbiamo nessuna chiara bussola etica che ci aiuti a orientarci.
C’è questo, e – volendo insistere con le speculazioni psicologiche – c’è anche il fatto, innegabile, che tendiamo a rinviare la risoluzione di problemi non imminenti. Per esempio: sapevo di dover scrivere quest’articolo da almeno due settimane. Ho iniziato a buttare giù una bozza solo giovedì scorso, quando la pagina bianca ha iniziato a essere un problema. Venerdì ho scritto a Nicolò che entro sabato sera gli avrei mandato tutto. Sabato sono uscito. Domenica sono andato al mare, c’era il sole. Sto scrivendo queste righe martedì mattina.
Proprio per approfondire questi temi, dopo Inventare il futuro ho deciso di iniziare What We Think About When We Try Not to Think About Global Warming (da qui in poi WWTAWWTNTAGW), saggio dello psicologo ed economista norvegese Per Espen Stoknes, un libro di cui ho a lungo rinviato la lettura per una serie di motivi che si sono rivelati solo in parte validi. Prima di tutto c’era il mio pregiudizio vagamente scientista: nonostante l’interesse per l’argomento, la quarta di copertina di WWTAWWTNTAGW suona più come la bandella di un libro di self-help che come quella di un serio volume di divulgazione. Eccola: «Stoknes mostra come ri-raccontare la storia del cambiamento climatico e, allo stesso tempo, creare azioni positive, significative, che possano essere sostenute anche dai negazionisti». Poi c’era il titolo, WWTAWWTNTAGW, che parafrasa in maniera goffa il titolo di per sé già più ferocemente parafrasato della storia dei titoli della letteratura mondiale. Infine – rimanendo sulla superficie – c’era lo spettro dell’altro saggio pubblicato da Per Espen Stoknes nel 2009, di cui la sola copertina continua a crearmi un disagio insormontabile: Money & Soul: A New Balance Between Finance and Feelings.
Messa via almeno momentaneamente la spocchia che mi teneva lontano da WWTAWWTNTAGW, ho scoperto un libro leggero che contiene diversi spunti interessanti e almeno un capitolo che vale davvero la pena di leggere, e che tra l’altro è strettamente collegato alle questioni sollevate da Inventare il futuro (se siete pigri, è il capitolo 7). In breve: perché ci interessa così poco del cambiamento climatico, del nostro futuro? Perché lo avvertiamo come un problema così astratto e lontano? Quali sono le barriere cognitive che ci sedano, ci tranquillizzano e ci separano dall’avere un briciolo di viva preoccupazione per le sorti del pianeta? Stoknes ne individua cinque qui riassunte in un disegnino che prendiamo in prestito dal saggio:

Riassunte e condensate, le cinque barriere di WWTAWWTNTAGW suonano più o meno così:
La distanza. Il problema climatico è ancora remoto per molti di noi, sotto diversi punti di vista. Inondazioni, siccità, incendi, sono sempre più frequenti ma colpiscono ancora una parte piccola del pianeta. Gli impatti più pesanti sono ancora lontani nel tempo, un secolo o più.
La condanna. Il cambiamento climatico è raccontato come un disastro invincibile che causerà perdite, costi e sacrifici: l’istinto umano è di evitare l’argomento. Siamo prevedibilmente avversi al lutto. La mancata offerta di soluzione pratiche rafforza l’impotenza e i messaggi catastrofici ci si ritorcono contro. Abbiamo sentito che «la fine è vicina» talmente tante volte che non ci fa più effetto.
La dissonanza. Quando quello che sappiamo (utilizzare energia fossile contribuisce al riscaldamento globale) va in conflitto con con quello che siamo costretti a fare o che finiamo comunque per fare (guidare, volare, mangiare carne di manzo) si instaura in noi una dissonanza cognitiva. Per uscirne siamo spinti a mettere in dubbio o sottovalutare le cose di cui siamo certi (i fatti) per poter vivere con più agio la nostra vita quotidiana.
La negazione. Quando neghiamo, ignoriamo o evitiamo di riconoscere alcuni fatti inquietanti che sappiamo essere «veri», riguardo al cambiamento climatico, troviamo rifugio dalla paura e dal senso di colpa che generano, dall’attacco al nostro stile di vita. Il diniego è un meccanismo di autodifesa, e non si basa sull’ignoranza, la stupidità o la mancanza di informazioni di una persona.
L’identità. Filtriamo le notizie attraverso la nostra identità personale e culturale. Cerchiamo informazioni che confermino valori e presupposizioni già esistenti nella nostra testa. L’appartenenza culturale sovrascrive i fatti. Se nuove informazioni ci richiedono di cambiare noi stessi, allora è probabile che non le accoglieremo. Siamo resistenti alle richieste di cambiamento della nostra identità personale.
Naturalmente ci sono centinaia di altri motivi che ci tengono ancora lontani da una strategia per la mitigazione dei cambiamenti climatici: gli interessi economici, la lentezza delle diplomazie, gli scontri tra modelli di sviluppo, gli Stati Uniti, l’India, il puro egoismo, la grande cecità e tutte quelle cose che abbiamo imparato a conoscere così bene negli anni. Ma questo disegnino di Per Espen Stoknes, per quanto ingenuo possa sembrare, suggerisce empiricamente una via da percorrere. Catastrofismo e allarmismo non funzionano. Bisogna trovare un tono diverso per uscire dall’apatia di questo nostro eterno presente.