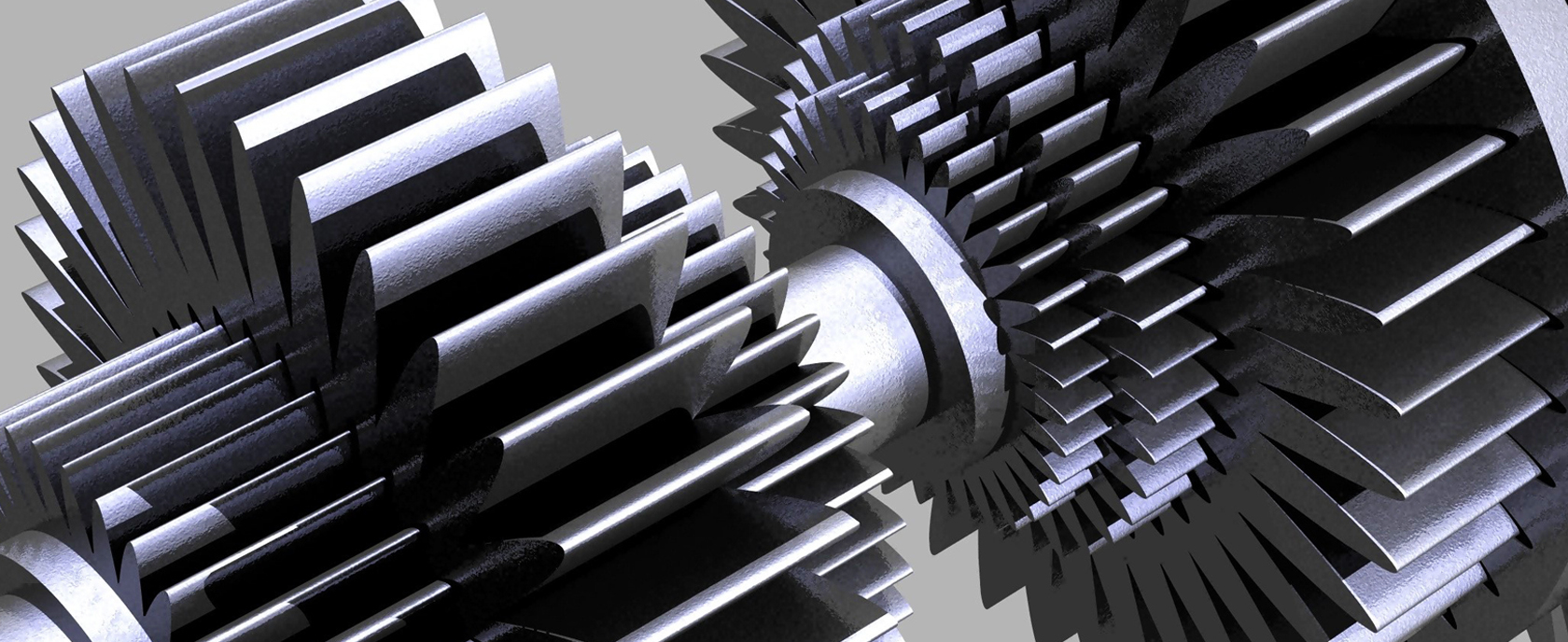Il reddito di cittadinanza è una merda, liberiamoci dal lavoro
C’è stato un tempo nella preistoria della politica italiana – non più di dieci anni fa – in cui il dibattito sul reddito era relegato a una polverosa discussione tra intellettuali o a qualche sporadica e visionaria assemblea di movimento. Tuttavia, con l’ascesa del Movimento 5 Stelle nel panorama politico italiano, questo tema ha iniziato a imporsi prepotentemente nel dibattito pubblico fino ad affermarsi definitivamente nel lessico quotidiano della politica. Ma – perché c’è sempre un «ma» – lo ha fatto in una sua mutazione genetica piuttosto inedita: ovvero quella del reddito di cittadinanza, che, già a partire definizione stessa, dimostra come l’impostazione pentastellata stravolga i termini del dibattito e il senso originale con cui questo strumento era stato progettato.
In effetti, messer Philippe Van Parijs, filosofo, economista e giurista belga, quando nel 1992 ha introdotto per la prima volta la nozione di reddito di base universale per come lo conosciamo, aveva da subito chiarito che, seguendo il suo disegno originale, avrebbe dovuto trattarsi di «trasferimento monetario erogato periodicamente dallo Stato o da altri Enti pubblici agli individui, indipendentemente dalle loro condizioni economiche ed indipendentemente dalla loro disponibilità a offrire in cambio un qualche tipo di contributo lavorativo». Tuttavia, l’idea che c’è dietro sembra essere più vecchia di Van Parijs di ben cinquecento anni. In effetti, senza stare a scomodare la misura redistributiva dell’annona nell’antica Roma, dall’immaginaria isola di Utopia disegnata da Thomas Moore (1516) a La giustizia agraria di Thomas Paine (1597), dalla Speenhamland Law (1597–1834) dell’Inghilterra della prima metà dell’Ottocento alle varie sperimentazioni che hanno attraversato diverse fasi della storia del Novecento, sono stati parecchi i tentativi di immaginare, tanto nell’elaborazione teorica quanto nella prassi politica, una forma di distribuzione delle ricchezze fondata sul «diritto di vivere».
Nonostante questa storia plurisecolare, la definizione di Van Parijs è ormai largamente riconosciuta, dentro e fuori dal dibattito accademico, come la formalizzazione più chiara e completa del concetto di basic income, tanto da essere pressoché sovrapponibile in toto a quella adottata dal BIEN (Basic Income Earth Network); e, a pensarci bene, lo è per una ragione piuttosto precisa: come ben evidenzia Peppe Allegri nel suo nuovo libro Il reddito di base nell’era digitale, una misura immaginata su questi presupposti – che prevedono un’erogazione monetaria periodica e individuale sufficiente a mettere le persone in condizione di autodeterminare le proprie scelte di vita – si pone nella direzione di un reddito di esistenza che sia quanto più universale e incondizionato possibile, superando in questo senso altre proposte più parziali e limitate – come quella del «reddito di cittadinanza».
Una volta calata la riflessione sul reddito di base in questo contesto, non è difficile osservare come il modello di società che si disegna attorno ad esso affondi le radici del suo impianto teorico in una profonda critica ai meccanismi su cui si impernia la variante neoliberale del sistema capitalista. Le posizioni di Van Parijs infatti si inseriscono in quella tradizione del pensiero economico che galleggia tra una lettura dell’esistente libertaria di sinistra e una neo–marxista, senza porle in contraddizione, ma alimentando piuttosto l’una con l’altra. Al contrario, il reddito di cittadinanza del ddl n. 1148 si pone in piena continuità con una lettura neoliberale dei processi socioeconomici, ed è facile comprenderlo osservando anche solo distrattamente quali siano le sue principali caratteristiche. La formulazione che propone Van Parijs poneva al cuore della propria visione del mondo una serie di temi che identificano in modo chiaro la prospettiva politica in cui il reddito di base andrebbe letto (e costruito): ma questi temi, nella variante a cinque stelle, vengono disgraziatamente disattesi e stravolti in ogni loro aspetto.

Una delle idee più affascinanti nella provocazione che lanciano i fautori dell’accelerazionismo come Nick Srnicek e Alex Williams (a cui Van Parijs strizza l’occhio con simpatia) è quella di una post–work society, in cui il lavoro umano viene progressivamente sostituito dall’innovazione tecnologica e dall’automazione dei processi produttivi. Del resto a che serve il lavoro, se non come dispositivo di controllo sociale, laddove le stesse mansioni possono essere svolte da una macchina in modo più efficiente e con un cospicuo abbattimento dei costi? In particolare, il fatto che le prime attività ad essere sostituite sarebbero proprio quelle meno stimolanti e più alienanti, basate su processi routinari che una macchina potrebbe svolgere più facilmente (e probabilmente meglio) di un individuo, impone di conseguenza anche una riflessione sulla qualità dell’occupazione su cui un sistema economico si basa.
Tuttavia, a questa prospettiva, il reddito di cittadinanza del M5S contrappone un modello sociale lavorista, imbevuto della retorica fastidiosamente moralista del «lavoro ad ogni costo», quasi ci fosse una dignità nel passare il proprio tempo a fare qualcosa di avvilente per se stessi e inutile alla collettività. Per come si configura questo specifico aspetto, il reddito di cittadinanza si presenta come una regalia alle imprese che, da una parte, non hanno nessun incentivo a investire sulla propria innovazione per intervenire sulla qualità dell’occupazione e, dall’altra, possono permettersi di porre sotto ricatto i lavoratori che pur di non rifiutare un impiego, pena la decadenza del diritto, saranno costretti ad accettare ogni condizione, salariale, materiale e in termini di tutele. Ecco, in questo senso si potrebbe dire che la distanza che intercorre tra queste due idee di reddito intercorre è la stessa che si frappone tra la fascinazione per la liberazione (dell’individuo) dal lavoro e quella per la liberazione (dell’impresa) dai lavoratori.
Allo stesso modo, uno dei temi più cari ai redditisti nella loro originale concezione di basic income è la tutela della libertà di scelta dell’individuo: in questo senso, il reddito di base diventa strumento per emanciparsi dal ricatto della povertà, da una parte fornendo una fonte di sostentamento che garantisce a ciascuno la possibilità di scegliere quello che desidera, e consentendo dall’altra di uscire dalla logica coercitiva del «lavoro a prescindere» a cui si è costretti in mancanza di quella fonte di sostentamento. Al contrario invece, il disegno di legge dei parlamentari a cinque stelle, se da un lato non si pone il tema della libertà di scelta individuale avanzando la proposta di un sussidio su base familiare (che rimane in questo modo subordinato ad un modello di welfare anacronisticamente familista che non tiene conto di tutta una serie di situazioni particolari che andrebbero invece tutelate), dall’altro riesce a fare pure di peggio con l’assurdo istituto dei cosiddetti «acquisti immorali», secondo una logica paternalista per la quale dovrebbe essere lo Stato a decidere per te cosa puoi o non puoi consumare (ma, ovviamente, solo se sei povero).
Insomma, a un impianto teorico che pone al centro della sua proposta temi come la liberazione dal lavoro, la tutela della libertà di scelta e l’emancipazione individuale, la proposta grillina risponde con un modello lavorista, classista e paternalista, in cui se sei povero devi accettare qualsiasi lavoro di merda e non hai nessun diritto di scegliere in autonomia come spendere i tuoi soldi, lasciando sullo sfondo la sgradevole impressione secondo cui tutto quello che viene dato alle fasce più deboli della popolazione altro non sia che una gentile concessione da parte del potere costituito.
Il reddito di cittadinanza a cinque stelle, con le sue «norme anti-divano» e i suoi «acquisti immorali», si inserisce nel solco della tradizione neoliberale con una precisione disarmante.
In un bellissimo articolo pubblicato sul Guardian l’anno scorso, Stephen Metcalf chiariva come «il neoliberalismo non sia semplicemente un nome che sta a indicare le politiche a favore del mercato, o i compromessi con il capitalismo finanziario fatti dai partiti socialdemocratici falliti. È la denominazione di una premessa che, silenziosamente, è arrivata a regolare tutta la nostra pratica e le nostre credenze: che la concorrenza è l’unico legittimo principio di organizzazione dell’attività umana»: il reddito di cittadinanza a cinque stelle, con le sue «norme anti-divano» e i suoi «acquisti immorali», si inserisce nel solco di questa tradizione con una precisione disarmante.
Da questo punto di vista ha senso interrogarsi sulla contraddizione tutta politica della formazione grillina, che dopo aver fondato tutta la sua identità su posizioni strutturalmente anti-sistemiche ha plasmato, già al primo banco di prova, la più forte delle sue proposte proprio nel solco dei riferimenti culturali e valoriali del pensiero dominante neoliberale. Rispetto a questo fenomeno, i Wu Ming, già in tempi non sospetti, avevano fornito una spiegazione articolata e convincente, sostenendo che la composizione ideologica (troppo) eterogenea della base sociale del M5S avrebbe finito per fare da «tappo» al suo potenziale esplosivo nel panorama politico.
Tuttavia, se il tema è quello dell’egemonia culturale e dei modelli teorici di riferimento per immaginare un quanto mai ipotetico «migliore dei mondi possibili», credo emerga in modo piuttosto prepotente la totale inadeguatezza sul piano teorico del reddito di cittadinanza del «governo del cambiamento», che neanche tenta di mettere in discussione la logica e la prassi del pensiero economico imperante, approvando un testo di legge che si pone tremendamente al ribasso persino rispetto alle istanze che lo stesso Movimento Cinque Stelle aveva rivendicato in campagna elettorale, sancendo il penoso ma non sorprendente fallimento del modello culturale su cui la compagine grillina ha fondato la sua proposta. In questo senso, credo che un (possibile) punto di svolta all’interno di questo ragionamento si concretizzi in una riflessione sugli strumenti di analisi ed elaborazione che la teoria economica offre per studiare quali misure di welfare si possano mettere in campo per rispondere alle sfide del presente.
In effetti, gli studiosi mainstream dell’economia (pur essendo difficile far coincidere al concetto di «mainstream» una definizione univoca ed omnicomprensiva) fanno ricorso ampiamente e in modo pressoché esclusivo a un’analisi di stampo econometrico, che si basa sul confronto tra modelli economici ed evidenze empiriche ottenute mediante la rilevazione di dati non sperimentali (ovvero dati raccolti non attraverso esperimenti costruiti ad hoc, ma tramite l’osservazione di ciò che accade nella realtà). Questa scelta metodologica porta con sé un cospicuo bias cognitivo generato dal fatto che risulta complicato allontanarsi dal contesto di riferimento in cui i dati sono raccolti e che comporta, come estrema conseguenza, che chi si occupa di elaborare nuovi modelli all’interno della teoria economica finisca per fare fatica a prendere le distanze dagli schemi prestabiliti che vengono adottati in quel contesto di riferimento. Chiaramente, in queste condizioni, diventa più difficile per chi fa analisi e ricerca in ambito economico allontanarsi dai presupposti teorici che compongono la cornice di quel contesto di riferimento (che in questo caso è quella di matrice ideologica neoliberale) ed elaborare soluzioni più originali che si porrebbero in rottura con lo stato delle cose.
Il fatto che sia difficile immaginarsi uno strumento di analisi controfattuale rende più facile per gli economisti produrre teorie economiche basate sull’esperienza già osservata in passato, invece che immaginarsi uno scenario totalmente diverso.
Ora, per contestualizzare meglio questo ragionamento sulla metodologia dell’analisi e della ricerca economica, credo sia necessario riportare alcuni elementi della riflessione sulla filosofia della scienza introdotti da Thomas Kuhn nella seconda metà del Novecento. Kuhn sostiene che il progresso scientifico si fondi sull’alternanza tra fasi di scienza normale – in cui gli studiosi di una tradizione di ricerca affermata accumulano dati che validano quella teoria dominante – e fasi di scienza rivoluzionaria – in cui gli studiosi cercano dati in grado di mettere alla prova le assunzioni di base del quadro teorico di riferimento.
In altre parole, contestualizzando questo ragionamento nel dibattito sulla teoria economica, il fatto che sia difficile immaginarsi uno strumento di analisi controfattuale – che consenta di ragionare secondo un ipotetico what if? – rende più facile per gli economisti produrre teorie economiche basate sull’esperienza già osservata in passato invece che immaginarsi uno scenario totalmente diverso, che si dimostri in grado di segnare una rottura con la teoria economica dominante. In effetti, questo quadro ci chiarisce meglio le ragioni per cui persino uno strumento ambizioso come il reddito di base, che mira a ripensare l’intera struttura del sistema di welfare aggiornandolo alle sfide e alla complessità del presente, rischi di essere «normalizzato», rimanendo ingabbiato nelle maglie della logica neoliberale – come l’esperimento grillino ci ha dimostrato.
Chiaramente, questo non significa che, partendo da una solida base teorico-politica rispetto agli obiettivi che ci si pone quando si tenta di progettare uno strumento nuovo, sia categoricamente necessario abbandonare gli strumenti analitici tradizionali. Tuttavia, per produrre quello che Kuhn definiva un cambiamento di paradigma (ovvero il passaggio da una fase di scienza normale ad una di scienza rivoluzionaria), credo possa essere utile ribaltare totalmente i presupposti metodologici della ricerca economica e ricorrere a scelte di tipo differente, che consentano di concedersi di immaginare soluzioni più originali secondo i termini di quell’ipotetico what if? di cui dicevo prima. In questo senso, gli strumenti a disposizione per condurre un’analisi che si collochi nell’eterodossia del pensiero economico, sebbene poco diffusi, sono molteplici, e credo sia un tantino dogmatico decidere a priori che ne possa esistere uno migliore degli altri in termini assoluti.
Personalmente, la chiave analitico-interpretativa che ho scelto di adottare per studiare dal mio punto di vista un modello economico fondato su un sistema di basic income sono state le simulazioni fondate sul cosiddetto agent-based modelling (ABM). I modelli ad agenti, infatti, sono una tecnica analitica nata negli anni Settanta ma diffusasi quasi su scala larga a partire dagli anni Novanta, che si ispira alla teoria dei sistemi complessi e vengono sempre più spesso utilizzati per studiare fenomeni di diverse discipline, dalla fisica alla biologia, alle scienze sociali. L’idea consiste, appunto, nel simulare un ambiente al cui interno degli agenti eterogenei, ovvero che presentano caratteristiche differenti, (inter)agiscono sulla base delle loro caratteristiche generando un comportamento emergente a livello di sistema che, proprio sulla base delle interazioni tra gli agenti, non potrebbe essere ridotto alla sommatoria dei comportamenti individuali.

Nella simulazione ABM che ho progettato utilizzando il software NetLogo, quello che ho cercato di fare è stato immaginare lo scenario di un’economia che, affrontando le sfide della crescente innovazione tecnologica impiegata in sostituzione del lavoro umano, adotta un modello di reddito di base universale appropinquandosi finalmente all’idea di fine del lavoro, perlomeno nella sua componente più alienante.
Il modello, sostanzialmente, consta di due fasi: nella prima vengono creati gli agenti e stabilite le loro caratteristiche di base, mentre nella seconda, che si ripete per ogni ciclo della simulazione (dove ogni ciclo corrisponde un anno), avvengono le interazioni tra gli agenti. Essendo questa simulazione, come del resto ogni modello, non una mappa uno a uno ma una stilizzazione della realtà che ci torna utile per studiare alcuni fenomeni, ho cercato di rendere il più semplice possibile lo schema-base di riferimento, seguendo il principio cardine dei modelli ad agenti KISS («Keep It Simple, Stupid!»). Per questo, la simulazione prevede due sole classi di agenti, ovvero due tipologie di attori nel sistema economico: gli individui (non necessariamente lavoratori) e le imprese, che interagiscono tra loro senza l’intermediazione di un soggetto pubblico esplicitamente formalizzato che, come vedremo in seguito, «c’è ma non si vede», come nei migliori trucchi di magia.
A questo punto, ciascuna classe di agenti presenta una serie di caratteristiche specifiche e peculiari che la identifica. In particolare, gli individui sono suddivisi in tre categorie a seconda del loro livello di qualificazione: esistono dunque, in termini molto generici, individui altamente, mediamente o bassamente qualificati per lo svolgimento di ciascuna occupazione che le imprese possano domandare sul mercato del lavoro. Facendo un importante sforzo creativo, immaginiamo ora che le imprese assumano i lavoratori in base al loro livello di qualificazione e che i salari siano uguali per tutti all’interno di ciascuna delle tre categorie.
Per quanto riguarda invece le imprese, queste sono suddivise in quattro quadranti all’interno di una mappa semiotica che traccia le loro caratteristiche principali, rappresentando sull’asse orizzontale la produttività del fattore capitale e su quello verticale quella del fattore lavoro. Quello che si vuole misurare così facendo è l’efficienza produttiva di ciascuno dei due fattori di ogni impresa in termini relativi rispetto alle altre, differentemente dalle definizioni adottate nella microeconomia neoclassica, dove produttività di capitale e lavoro sono intesi come complementi stretti. Pertanto, per ciascuna impresa, entrambe le variabili possono assumere valori inclusi tra zero e uno, sulla cui base è determinata la collocazione spaziale delle imprese nella nostra mappa a quadranti. In altre parole, questo significa che se un’impresa è rappresentata nel quadrante in alto a destra della mappa semiotica questa presenterà una forte componente di produttività del capitale e di produttività del lavoro (con entrambi i valori vicino a uno), mentre, simmetricamente, se appare nel quadrante in basso a sinistra si tratterà di un’impresa a bassa intensità di capitale e di lavoro e così via con le diverse combinazioni per ciascun quadrante della mappa semiotica.
Altre caratteristiche rilevanti per la classe di agenti delle imprese sono la dotazione di capitale iniziale e la dimensione dell’impresa (piccola, media o grande): a queste due variabili è subordinato il numero massimo di dipendenti in regime di piena occupazione, mentre la combinazione tra produttività dei due fattori determina la qualità dell’occupazione, ovvero quale tipologia di lavoratori un’impresa preferisce assumere. A questo punto, avviene la prima interazione che avviene tra individui e imprese all’interno del modello: nell’«anno zero» del modello le imprese assumono i lavoratori in base a una serie di parametri che incrociano le caratteristiche della domanda e dell’offerta sul mercato del lavoro per come le abbiamo definite.

Ora che «l’universo è stato creato», possiamo fare un passo in più analizzando la dinamica del modello. L’evolversi degli scenari che emergono dal modello infatti si basa fondamentalmente su due avvenimenti che si ripetono a ogni ciclo della simulazione: le interazioni sul mercato dei beni e quelle sul mercato del lavoro.
Per semplificare, immaginiamo che sul mercato dei beni si scambi una sola tipologia di bene e che le imprese vendano agli individui tutto ciò che producono. La funzione di produzione delle imprese dipende fondamentalmente dalla dimensione dell’impresa (assumendo dunque che più un’impresa è grande e più produca), ma lascia comunque ampio spazio a una componente stocastica (ovvero selezionata casualmente all’interno di un determinato range), garantendo in questo modo che le imprese rappresentate siano eterogenee. Allo stesso modo, la funzione di consumo che definisce le scelte di ciascun individuo sul mercato dei beni dipende in maniera diretta dal reddito che questo percepisce ogni anno (che può essere un salario commensurato al proprio livello di qualificazione nel caso in cui l’individuo abbia un’occupazione, o un sussidio di disoccupazione nel caso in cui non la abbia): a questo valore viene sottratto una quota generata casualmente dal software entro un determinato range, assumendo che in proporzione il consumo aumenti all’aumentare del reddito percepito.
In questo modo, sul mercato dei beni la somma delle funzioni di produzione individuali delle imprese genera la curva di offerta e, specularmente, la somma delle funzioni di consumo degli individui quella di domanda: il rapporto complessivo tra domanda e offerta, come nel più (neo)classico dei manuali di microeconomia, determinerà in questo modo il prezzo dei beni. Chiaramente, seguendo pedissequamente quest’impostazione, ogni ciclo del modello si riprodurrebbe praticamente identico a quello precedente (differenziandosi l’uno dall’altro solo per i valori degli elementi stocastici inseriti nelle funzioni di produzione e di consumo degli agenti). Per questo, ipotizzando che l’evoluzione del sistema economico segua comportamenti adattivi, le funzioni di produzione e di consumo dei singoli agenti sono soggette a un leggero aggiustamento per ciascun periodo: infatti ciascun individuo osserva i prezzi del periodo immediatamente precedente e di quello ancora prima e, se, vede che i prezzi sono in calo, decide di consumare una quantità maggiore di beni, mentre se ne osserva un aumento, riduce il proprio consumo; allo stesso modo, le imprese produrranno di più se il prezzo sale e di meno se scende.
Alla fine di ciascun periodo, le imprese osservano i loro risultati sul mercato dei beni, calcolando i propri profitti come differenza tra il totale della loro produzione (aggiornata in base al prezzo corrente) e il totale dei loro costi, ovvero i costi fissi (che sono funzione diretta della produttività del capitale), i salari che pagano ai loro impiegati, e un importo che viene loro prelevato per finanziare un sussidio di disoccupazione a chi non ha un impiego. Com’è ovvio che sia, ogni volta che un’impresa consegue un profitto, questo va a sommarsi al capitale iniziale, mentre ogni volta che chiude in perdita, quest’ultima erode il capitale inziale: se il capitale iniziale si erode fino ad annullarsi, l’impresa chiude e sparisce dal mercato. Inoltre, seguendo una dinamica più o meno analoga a quella osservata per quanto riguarda l’aggiustamento di domanda e offerta in base al prezzo, a seconda dei risultati riscontrati sul mercato dei beni, le imprese valutano se (e in quale direzione) intervenire sul mercato del lavoro, assumendo o licenziando parte del personale.
Adesso che il modello è settato e abbiamo finito con le cose da economisti noiosi, possiamo iniziare con le cose divertenti e accelerare un po’. Per questo, ipotizziamo che si inserisca in questo scenario un elemento di shock tecnologico «esogeno», ovvero un improvviso aumento della tecnologia impiegata dalle imprese nei loro processi produttivi che, per semplificazione, assumiamo sia generato da cause esterne. Questo, nel modello, si traduce in un incremento della produttività del capitale, che, tuttavia, non colpisce tutte le imprese in maniera uniforme, ma in modo proporzionato alla loro recettività rispetto alle innovazioni tecnologiche (ovvero, chi ha una struttura più capital-intensive assorbirà più velocemente lo shock tecnologico).
A questo punto, le imprese possono reagire allo shock in due modi. Se aumenta la produttività del capitale, produrre diventa relativamente più economico: dunque, le imprese potranno scegliere se impiegare le stesse risorse che impiegavano prima dello shock e produrre una maggiore quantità di beni o se produrre la quantità che producevano prima abbattendo i costi di produzione sostituendo – almeno in parte – il lavoro umano mediante l’automazione. Ora, osserviamo il primo di questi due scenari alternativi ponendo il caso che le imprese decidano di rispondere a questo mutamento del sistema aumentando a dismisura la propria produzione senza licenziare lavoratori. Dal momento che, nel più profondo rispetto della tradizione microeconomia neoclassica, abbiamo definito il meccanismo di formazione dei prezzi attraverso il rapporto tra domanda e offerta, se la domanda rimane costante e l’offerta tende – diciamo un’esagerazione – ad infinito, il prezzo dei beni tenderà improvvisamente a zero. Praticamente, la sovrapproduzione rende i beni così abbondanti da renderli disponibili sul mercato gratuitamente: in altre parole, abbiamo abolito il concetto di scarsità e abbiamo distribuito i beni prodotti dalle gratuitamente a tutti gli individui nel sistema – ma la cosa divertente è che l’abbiamo fatto utilizzando la cassetta degli attrezzi del mainstream della teoria economica!
A chi ripete ossessivamente «there is no alternative», come se il neoliberismo e tutte le diseguaglianze che ne discendono fossero una condizione naturale come l’alternanza tra il giorno e la notte, questa simulazione risponde ponendo il tema della volontà politica.
Ora, supponendo che le imprese non impazziscano all’idea di azzerare i propri profitti come succederebbe seguendo il ragionamento alla base della precedente ipotesi, poniamo il (più probabile) caso che decidano di reagire allo shock tecnologico licenziando la maggior parte dei propri lavoratori, le cui mansioni vengono sostituite dall’innovazione tecnologica: insomma, se non è la piena automazione poco ci manca. Tuttavia, come ben sappiamo, la piena automazione non serve a nulla – anzi rischia di fare danni! – se non ne vengono distribuiti i frutti alle persone. Osserviamo allora cosa succede in questo scenario.
Irrompe l’automazione dei processi produttivi e le imprese, non avendo più bisogno dei lavoratori, se ne disfano: siamo in uno scenario di disoccupazione tecnologica. A questo punto ci aspettiamo che, avendo abbattuto i costi di produzione eliminando i salari come voce di bilancio, i profitti delle imprese aumentino a dismisura. Eppure, questo non si verifica: al contrario, ne osserviamo un leggero calo a seguito dello shock. Cosa è successo? Nel momento in cui gli individui hanno perso in massa la loro occupazione – e, ovviamente, il loro salario – non sono stati più in grado di sostenere la domanda con le loro entrate e per questa ragione i consumi subiscono un crollo: ovvero, disgraziatamente, le imprese non riescono più a vendere sul mercato i beni che producono perché nessuno ha i soldi per comprarli.
A questo punto, decidiamo magnanimamente di intervenire per evitare che l’economia di mercato collassi su se stessa, introducendo quella che gli economisti keynesiani definirebbero una «politica di sostegno alla domanda dei consumi». Ora, osservando che nella simulazione i profitti, pur essendosi ridotti, sono rimasti complessivamente positivi perché gli individui hanno mantenuto una componente minima di consumo necessaria a sostentarsi, ci possiamo facilmente rendere conto che questi sono l’unico serbatoio di liquidità da cui è possibile attingere per attuare una policy di questo tipo.
Dal momento che, come anticipato, non abbiamo formalizzato l’esistenza di un agente–Stato, supponiamo che questo operi imponendo semplicemente un obbligo: la tassazione dei profitti delle imprese e la loro distribuzione, sotto forma di basic income, a tutti gli individui. A questo punto, questi potranno tornare a investire il loro reddito per acquistare i beni che le imprese producono, godendo appieno i frutti della piena automazione. Ooops: abbiamo abolito il lavoro e messo in pratica il reddito di base!
Chiaramente, l’obiettivo di questa simulazione non è né quello di riprodurre fedelmente la realtà né quello di esprimere una previsione rispetto a uno scenario realistico in un futuro prossimo, quanto evidentemente quello di lanciare una provocazione. A chi ripete ossessivamente «there is no alternative», come se il neoliberismo e tutte le diseguaglianze che ne discendono fossero una condizione naturale come l’alternanza tra il giorno e la notte, questa simulazione risponde ponendo il tema della volontà politica di esplorare scenari alternativi per arrivare a praticare un cambiamento di paradigma. Volontà politica che necessita di essere sperimentata nella teoria economica anche attraverso strumenti di analisi e di ricerca differenti, come possono essere, tra gli altri, gli agent-based models, perché «hackerare la teoria neoliberista» è possibile, e talvolta bastano le poche righe di codice di una simulazione per ricordarcelo.