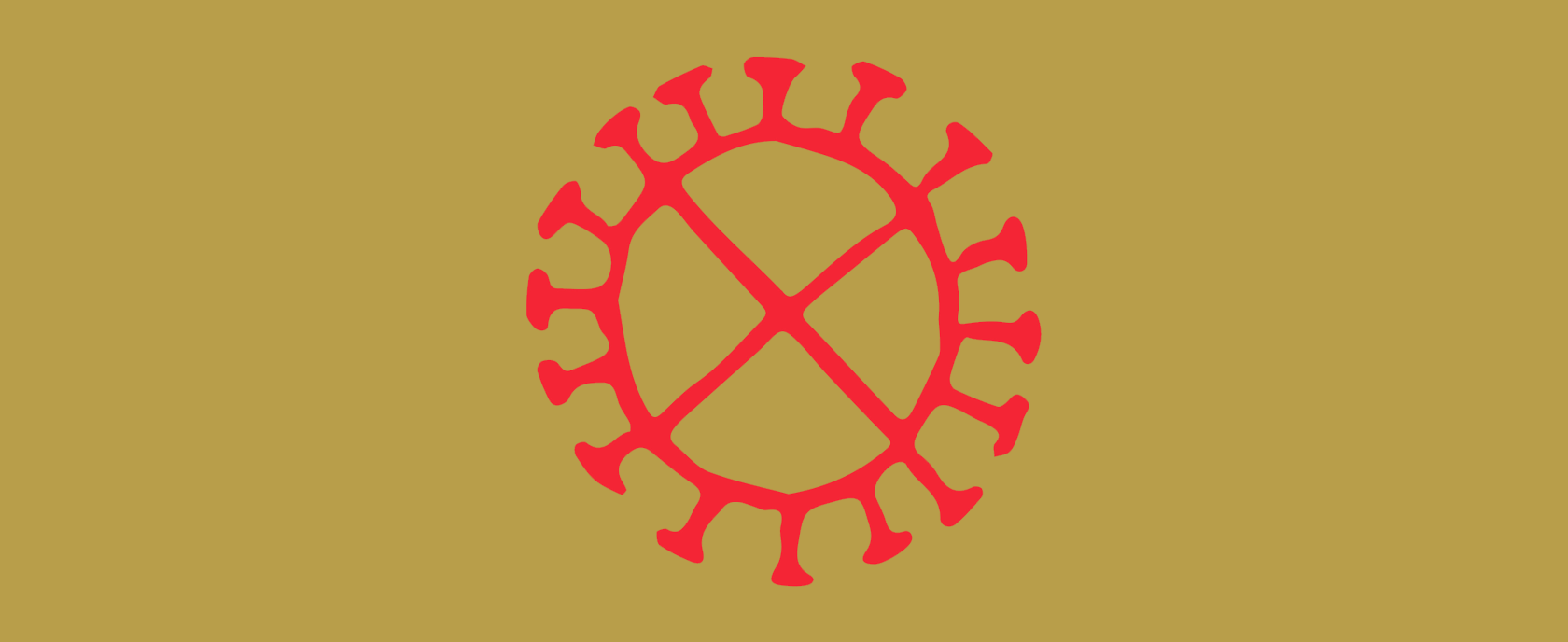Magia nera
Pubblichiamo la prefazione di Djarah Kan a Omenana. Racconti fantastici dal continente africano, il nuovo titolo della collana Not in uscita in questi giorni, assieme a una riflessione della traduttrice Giulia Lenti. Trovate Omenana in libreria, sulle consuete piattaforme, o direttamente sul nostro sito.
Storie segrete
di Djarah Kan
La fantasia, intesa come capacità di immaginare l’impossibile e l’imprevedibile oltre ogni ragionevole irragionevolezza, è forse l’unica caratteristica che posso affermare oltre ogni dubbio di apprezzare nella specie umana. Sul resto, che lascio appositamente senza nome, non mi pronuncerò. Non in questa sede almeno. Ma ciò che mi ha sempre affascinato di questo concetto divino e terreno chiamato «fantasia» è la sua – apparente – caotica mancanza di limiti, sia temporali che spaziali, razziali, di genere o di classe.
L’immaginazione è gratis e a disposizione del pubblico non pagante. Tutti possono agirla quanto e nei termini che più preferiscono. L’immaginazione è la condizione necessaria che l’essere umano pone alla base della costituzione del sé come animale che si mette in relazione con il divino.
Non è un caso che il termine Omenana, che dà un titolo e una specifica dimensione a questa antologia di racconti, è una parola igbo che sta a indicare sia quel che resta di questa specifica cultura tradizionale scampata all’ecatombe culturale perpetrata dalla penetrazione Cristiana nel Continente Africano, sia la divinità, o meglio il divino e le sue emanazioni magiche, soprannaturali e sacre – incarnate in divinità spesso dispettose e fin troppo interessate agli affari degli umani. Divinità che a dispetto del Dio delle tre grandi religioni monoteistiche, camminano in mezzo al popolo Igbo, dando loro «le storie».
Storie segrete, storie che si nascondono sotto altre storie pur di sopravvivere all’erosione del Cristianesimo e dei nuovi dèi – tra santi e madonne – portati dai bianchi. Storie di autrici e autori che sulle piattaforme digitali trovano l’agency e la libertà di espressione che spesso le case editrici offrono con non pochi compromessi a chi fa della sua scrittura la sua verità e la sua eresia. Credere significa vivere. Vivere significa immaginare. Non si può avere la fede senza l’immaginazione. Né si può concepire il bello senza l’immaginazione. O si può inventare l’amore, senza un ventaglio di storie che lo raccontino e lo ispirino in chi ne fa esperienza indiretta. E indovinate attraverso quale mezzo, se non l’immaginazione?
Gli africani raccontano tante storie. Storie che da sole testimoniano la capacità straordinaria degli africani di attingere alla tradizione per creare contemporaneità magica in costante movimento tra passato, presente e futuro.
In quanto figlia della diaspora, cresciuta come corpo estraneo in una società bianca, italiana e meridionale, quelle storie non avevano la forza necessaria a sopravvivere come possibilità in un’immaginazione totalmente occupata dalla bianchezza.
Quando ero piccola, mia madre, una donna ghanese appartenente alla tribù Fanti facente parte del grande gruppo delle genti Akan, giurava di aver sentito da un’altra donna del villaggio che era stata testimone oculare della bizzarra vicenda di una donna-serpente – spirito dell’acqua tipico di molti culti diffusi del Continente – che, innamoratasi di un uomo che l’aveva tradita con un’altra, una notte si era vendicata inghiottendolo, senza però riuscire a digerirlo prima dell’alba. Al mattino gli abitanti del villaggio, scoperto l’inganno, le avevano tagliato la testa e infine aperto il ventre con lo scopo, a mio avviso non così indispensabile, di liberare l’amante fedifrago che le aveva spezzato il cuore.
Nella storia da lei raccontata erano gli anni Sessanta e il fatto avveniva nel suo villaggio, mentre, nell’unica radio funzionante della zona, i Beatles suonavano una musica che più tardi avrebbe fatto crescere nei giovani come lei la voglia di dare un’occhiata a quella famigerata Europa.
Mia madre mi raccontava anche degli orrori che si potevano trovare nella foresta, tra tagliatori di gole che violentavano le ragazze di ritorno dal lavoro in campagna e nani che ti promettevano conoscenze e ricchezze straordinarie in cambio di un patto di riservatezza che, nelle sue storie, veniva puntualmente infranto e punito con pestaggi eseguiti da mani e piedi invisibili ai più.
L’esoterismo che penetrava la quotidianità, gli incontri fortuiti con dee capricciose e spiriti con il vizio del fumo e dell’alcol, e poi ancora i riti, le maledizioni e le cerimonie segrete per ottenere amore, soldi e successo con conseguenze quasi sempre tragiche erano lì, sono sempre state lì, di fronte ai miei occhi. Ma in quanto figlia della diaspora, cresciuta come corpo estraneo in una società bianca, italiana e meridionale, quelle storie non avevano la forza necessaria a sopravvivere come possibilità in un’immaginazione totalmente occupata dalla bianchezza. Un’immaginazione che tradiva il suo stesso primo enunciato, ovvero l’assenza di limiti. Mentre crescevo dimenticando tutte quelle storie che sporadicamente mia madre raccontava a una bambina poco interessata ad ascoltare l’Africa, che la società intorno a lei ripudiava sistematicamente, diventavo sempre più incapace di immaginare la letteratura fantastica, alla quale mi ero aggrappata disperatamente lungo tutta l’infanzia e l’adolescenza come uno spazio che potesse comprendere le storie di nani africani che abitavano sotto le radici di alberi sacri o di donne metà serpente e metà pesce che si sposavano con uomini bugiardi solo per il gusto di vederli fallire e infine divorarli.

Fantaghirò – l’eroina che veste panni maschili e un discutibile taglio di capelli per salvare il suo futuro sposo, sempre in bilico tra la vita e la morte, è una giovane donna bianca. Nella saga di Harry Potter che mi ha accompagnato lungo tutto l’arco della mia infanzia e adolescenza i personaggi fondamentali per lo sviluppo della storia sono tutti bianchi. E bianchi sono tutti i protagonisti della meravigliosa saga del Signore degli Anelli, da cui molti autori del genere fantasy hanno tratto ispirazione per l’ambientazione e la costruzione dei personaggi. Il fantasy è un genere fortemente influenzato dall’idea che tutti questi mondi inesistenti alla fine siano vicini, se non speculari, all’idea che nel Mondo della realtà abbiamo della razza, e del razzismo. Che cos’è Il signore degli anelli se non la raffinata e straordinaria metafora dello scontro tra razze intrinsecamente buone e intrinsecamente cattive?
Eppure, nonostante ognuno faccia ciò che più gli aggrada della propria immaginazione, l’attenzione del pubblico che consuma la narrativa speculativa continua a immaginare con una certa fatica protagonisti neri che possano fare qualcosa di più del soffrire e basta.
I neri – noi che scriviamo, recitiamo e raccontiamo storie – nell’immaginario collettivo europeo e italiano in cui sono cresciuta eravamo e siamo ancora oggi raccontati come soggetti in cui non scorre la Magia. Crescendo e osservando come l’industria della letteratura e dei media dipingeva le persone nere, ho capito che il potere, la meraviglia, e il diritto di abitare Mondi Nuovi erano un privilegio che spettava solo ai bianchi. Mentre se si voleva parlare di spazi che si conciliavano di più a corpi e storie nere, la letteratura dura e realista era l’unico spazio che eravamo legittimati a occupare.
Razzismo, colonialismo, schiavitù. Duri e crudi, senza interventi magici o divini. L’intera personalità dei protagonisti neri si basa per lo più sul trauma di essere neri in una società che razzializza anche la carta da parati. Il nero o la nera sono vittime. E le vittime non possono compiere magie o essere figli di una realtà in cui essere africani non sia il Dramma per eccellenza. I neri devono soffrire. O essere tristi per il trattamento che ricevono da terzi solitamente bianchi. Un nero che può rendersi invisibile o che può viaggiare tra passato e futuro per il mercato globale, che spesso è un eufemismo per descrivere il mercato occidentale… queste storie non funzionano. Perché il pubblico e la sua immaginazione colonizzata dalla bianchezza, non sono pronti. Anzi, come hanno dimostrato le recenti polemiche in merito a serie tv che rappresentavano persone non bianche in vesti e ruoli che non concernevano sofferenza razziale o emigrazione forzata, in questi casi una certa parte di pubblico denuncia una certa mancanza di autenticità e sensatezza.
Mi sono chiesta in che posizione si ponesse Omenana. Specie in un paese come l’Italia, che fatica già di suo anche solo a immaginarsi una letteratura italiana scritta da cittadini italiani non bianchi come me.
Nel 2020, molte sono state le polemiche e altrettante le proteste in occasione del lancio della serie tv Bridgerton. Ambientata nel periodo della Reggenza Inglese, la serie si ispira al genere ucronico, in cui si immagina che eventi del passato realmente accaduti abbiano invece avuto risvolti storici alternativi. Come afferma Ebony Elizabeth Thomas nel suo lavoro principale, The Dark Fantastic: Race and the Imagination from Harry Potter to the Hunger Games, «La storia del fantasy è razzializzata. A dispetto di quello che pensiamo di questo straordinario genere, che appassiona milioni di bambini e adulti in tutto il mondo, il fantasy sembra avere valori speculari al conservatorismo espressi dalla riaffermazione dei confini della razza che non possono essere oltrepassati».
La stessa Ebony Elizabeth Thomas, in un’intervista rilasciata all’Università della Pennsylvania dice: «Sono sempre stata attratta dalla fiction e dalle narrazioni speculative, ma non avevo nessuno con cui parlare delle mie ossessioni, o di quanto amassi queste storie e di quanto avrei preferito vivere nel mondo magico o essere una cittadina della Federazione dei Pianeti Uniti invece di essere una giovane donna di colore a Detroit. Sì, dunque volevo l’avventura. Volevo la magia. Volevo un passato migliore e un futuro glorioso, ed è per questo che penso di essere stata attratta da quelle storie».
Storie di libertà, storie in cui la conquista della Luna non è proprietà esclusiva di russi e americani, ma appartiene ad astronauti ed esploratori del Continente, che fin dall’alba dei tempi hanno tracciato il cammino dei popoli delle stelle, solcando il deserto in groppa ai dromedari, e che a un certo punto della Storia, quelle stelle luminose e considerate sacre, decidono di raggiungerle sparandosi in una navicella spaziale in direzione della prima nebulosa visibile a occhio nudo. Le nebulose degli antenati. Le nebulose delle storie dei nostri anziani.
A un certo punto, nel bel mezzo di un racconto, mi sono chiesta in che posizione si ponesse Omenana. Specie in un paese come l’Italia, che fatica già di suo anche solo a immaginarsi una letteratura italiana scritta da cittadini italiani non bianchi come me. Che posizione spetta prendere a un’antologia di scrittrici e scrittori africani che provano e riescono brillantemente nel tentativo di prendere le redini della propria autenticità decolonizzata? Ma soprattutto, quanti lettori saranno disposti a precipitarsi di loro spontanea volontà nello squarcio interdimensionale che Omenana – parola di potere, cultura e richiamo stesso alla divinità che si accompagna disinvolta agli esseri umani – apre su ogni singola storia scritta e raccontata da queste autrici e questi autori, la cui ironia oscilla leggera tra stelle, creature mutanti e generazioni che, affrancate dal trauma generazionale della schiavitù, guardano in alto, dove gli dèi tramano ogni nuova storia?
L’Africa come epicentro di un terremoto culturale che non abbraccia il suprematismo come risposta alla bianchezza del fantasy occidentale, era la posizione che, come nell’universo, non concepisce né il sopra né il sotto, ma soltanto la pienezza di una cultura che ci offre storie in cui esistiamo oltre la pena del razzismo. Storie che per molto tempo non siamo stati disposti ad ascoltare poiché troppo impegnati a riflettere internamente il divieto di essere, o che non siamo stati in grado di recuperare poiché troppo presi dall’idea di rendere la nostra immaginazione uno spazio bianco. Storie che trasmigrano collettivamente in un singolo punto, e che rappresentano un movimento che lascia scie concrete e ben visibili su cui potersi ritrovare e in cui poter scrivere ancora il divino e il futuro.

Tradurre Omenana
di Giulia Lenti
Sarò sincera. Quando ho ricevuto la proposta di tradurre Omenana, oltre a fare i salti di gioia ho sudato freddo: un’antologia di sedici racconti di narrativa speculativa, scritti da sedici autori e autrici provenienti perlopiù dalla Nigeria ma anche da Kenya, Zimbabwe, Senegal, Gabon e Sudafrica. La redazione di NERO mi raccontava di aver provato a coinvolgere traduttori o traduttrici afrodiscendenti che avessero familiarità, oltre che con la speculative fiction, con le culture rappresentate, visto che si trattava di diverse aree geografiche del continente. La ricerca però non era andata a buon fine, e sorge spontaneo chiedersi perché. Come ha detto Tlotlo Tsamaase: «We probably know the answer to this»: per com’è fatta l’industria culturale, è molto difficile che persone con un background migratorio o provenienti dalle classi lavoratrici abbiano la possibilità di dedicarsi a tempo pieno alla scrittura e alla traduzione. Questo non significa che le traduttrici e i traduttori letterari afrodiscendenti non ci siano: spero che diventi possibile e improrogabile rintracciare queste persone e offrire loro le risorse necessarie.
L’entusiasmo con cui ho accettato l’incarico, comunque, non mi aiutava a scacciare la fifa che mi si era appiccicata addosso insieme al suo amico affezionato, il complesso dell’impostore. L’inglese dei racconti è intessuto di yoruba, hausa, igbo, afrikaans, swahili, kikuyu, wolof e pidgin nigeriano. Oltre alla varietà di lingue, i testi raccolgono una fantasmagoria di tradizioni, religioni, miti, rimandi a culture pop, pietanze, vestiti, mezzi di trasporto, attrezzi… Al di là del livello di difficoltà, avevo il diritto di tradurre quei racconti pur essendo aliena a quelle zone e alle loro culture? Ho deciso di rimandare il dilemma, farmi coraggio e mettermi al lavoro.
E poi un giorno ecco il mio deus ex machina plurale e geograficamente lontanissimo: «sorry for the mass email,» scrivevano da Lagos, dalla redazione della rivista da cui la raccolta è nata, facendomi dono dei sedici indirizzi e avvisando le autrici e gli autori che di lì a poco avrei cominciato a tempestarli di domande. Così ho avuto la fortuna di parlare con loro, e tutti sono stati disponibili a contribuire al mio impegno di conoscere ed evitare di scadere nell’appiattimento traduttivo. Questi scambi mi hanno permesso di scoprire un sacco di dettagli nascosti nei testi: antiche leggende, canzoni di resistenza travestite da ninnenanne o filastrocche, abitudini di svago, mode, impatti e ingerenze di gruppi religiosi, punti di vista africani sull’Occidente, persino eventi di vita personale che hanno influenzato la scrittura. Sono profondamente grata a tutti loro per avermi permesso di comprendere meglio i loro mondi.
I personaggi di questi racconti escogitano o scoprono strumenti di lotta e vendetta: invocano spiriti che massacrano bande armate, si innamorano di divinità che divorano uomini ricchi e ingiusti, fanno amicizia con la morte o diventano invisibili per aggirare leggi prepotenti.
Omenana raccoglie racconti di narrativa speculativa permeata di tradizione, di una vastità di tradizioni tanto varie quanto accomunate dall’essere superstiti del dominio bianco coi suoi sproloqui civilizzatori e le pretese di universalità e le mutilazioni di corpi e culture e le razzie di risorse e speranze. La rivista in sé nasce per dare spazio ad autori e autrici provenienti dall’Africa e dalla diaspora africana che vogliono esplorare l’eredità culturale del continente abbracciando la scrittura fantascientifica e fantastica.
Omenana invita a decostruire e riplasmare – prendo in prestito le parole della prefazione di Djarah Kan – «un’immaginazione totalmente occupata dalla bianchezza», a rivendicare un territorio che, senza assolutamente dimenticare lo schifo che l’Occidente ha perpetrato e perpetra in Africa, sia libero da pietismi ipocriti e dalla costrizione occidentale dell’identità e della storia africana nell’unico e solo ruolo di vittima.
La narrativa fantastica ci permette di sviscerare la realtà immaginando futuri verosimili e inverosimili e presenti alternativi o amplificati. Le autrici e gli autori dei racconti speculativi di Omenana affrontano diverse e interconnesse sfaccettature individuali e collettive legate al presente e al passato. Ma pur essendo non di rado oppressi e abitando mondi logorati dal colonialismo e dal capitalismo e dal patriarcato, i personaggi di questi racconti escogitano o scoprono strumenti di lotta e vendetta: invocano spiriti che massacrano bande armate, si innamorano di divinità che divorano uomini ricchi e ingiusti, fanno amicizia con la morte o diventano invisibili per aggirare leggi prepotenti e farsi giustizia, si coalizzano con altre alterità mutanti o magari si scrollano semplicemente la tragicità di dosso. Ricorre una magia antica, ridacchiante e dispettosa, spesso vendicativa e gratificante, una magia che reclama spazio in un’immaginazione finora colonizzata dall’Occidente.

Come ci poniamo noi bianchi (perdonatemi la bieca semplificazione) di fronte a questo spazio? Credo sia una domanda che dobbiamo farci. Penso solo all’oggi: dove siamo? Osserviamo il bianco mentre minaccia la guerra nucleare, chiude l’accesso ai porti e nega il soccorso in mare a decine di migliaia di neri, finge che non ci sia il fascismo e intanto lo coltiva sotto gli occhi di tutti, si impegna a distruggere la possibilità di immaginare qualcosa di diverso, insomma, osserviamo il bianco che – come dice Bifo – «non accetta la prospettiva dell’esaurimento e preferisce la distruzione totale, il suicidio, alla lenta estinzione del suo dominio».
A parte quando vorrei dare fuoco a tutto, non pretendo di avere risposte, ma forse posso farmi una domanda meno difficile: come mi pongo io, bianca, col mio bagaglio culturale occidentale e la mia estrazione piccoloborghese, di fronte a questo spazio, di fronte all’antologia di Omenana quando mi viene chiesto di tradurla?
Condividendo il suo amore sconfinato per questo lavoro che abbiamo la fortuna di fare, attingo alle parole di Norman Gobetti: «Tradurre bene per me significa soprattutto trattenermi dallo strafare, riuscire a mettermi in ascolto, a disposizione, al servizio del testo che ho di fronte, prendendomi il tempo necessario per arrivare a conoscerlo bene prima di tentare di farmene tramite in un’altra lingua, lasciando che sia il testo a parlare, senza soffocarlo con le mie parole, ma ascoltandolo, contemplandolo a lungo in silenzio.» Ecco, non saprei dirlo meglio: ciò che posso fare di fronte a questa antologia, e così anche di fronte a questo territorio emergente, è ascoltare con attenzione, ammettere di non sapere e chiedere aiuto a chi sa per comprendere e imparare. E dopo, solo dopo, farmi tramite come meglio posso, senza sovrappormi e tentando di essere il più fedele possibile e il meno invasiva possibile, mettermi al servizio del testo così che queste storie possano essere lette anche in italiano e contribuiscano alla costruzione di un’immaginazione decolonizzata. Fare largo, dare spazio, mollare le redini. Dalla pagina alla realtà, Omenana verso l’infinito!