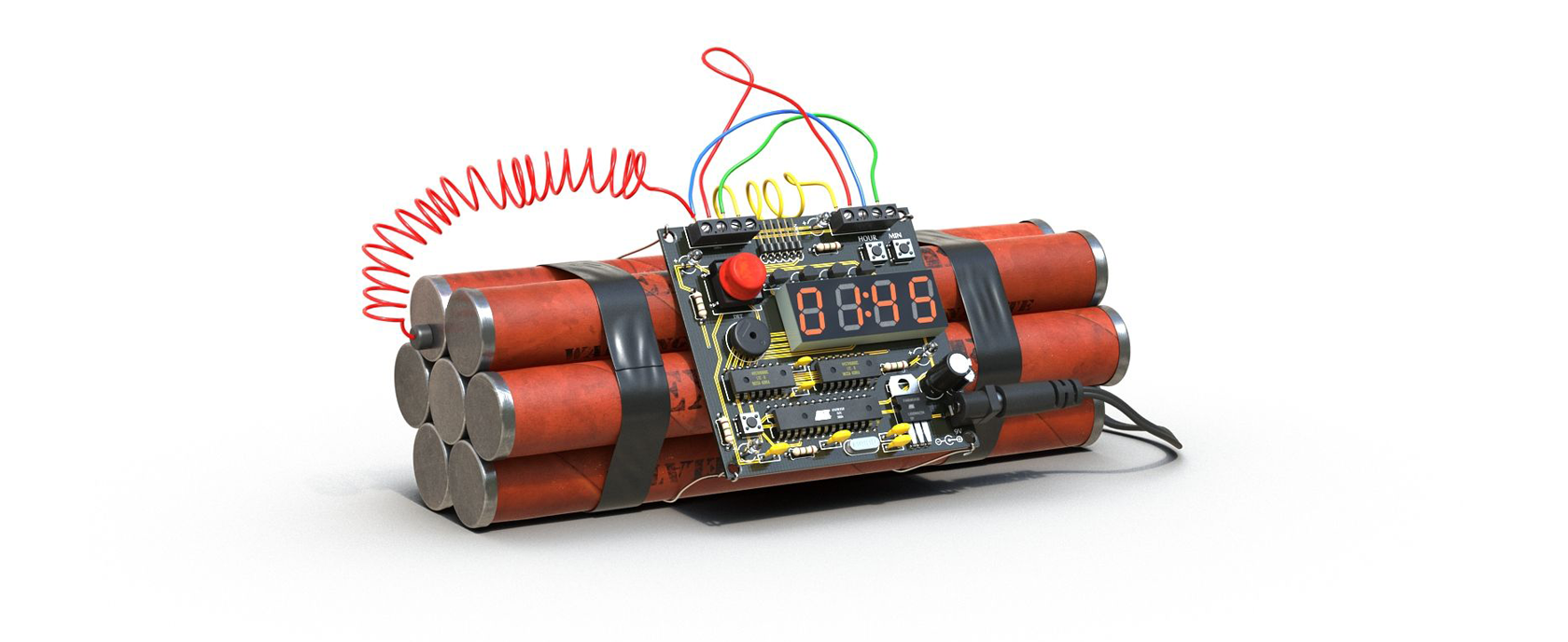Lo spettacolo del terrore
Marsiglia, 9 aprile 2023: la città si risveglia al suono di un’esplosione assordante. Un palazzo crolla alle prime ore del mattino in Rue de Tivoli, a pochi passi dal centro della città. I vigili del fuoco intervengono per mettere in salvo gli inquilini dell’edificio ed evacuare le abitazioni adiacenti. Le vittime sono 6, i feriti 5, almeno 8 i dispersi. I media si affrettano a riportare la notizia dopo pochi minuti di distanza dall’accaduto. Si risale presto al motivo dell’incendio: una fuga di gas dovuto alla cattiva manutenzione dell’impianto. Eppure, lo spettro del terrorismo aleggia sull’esplosione, in maniera più o meno conscia, quasi fosse un’inevitabile reazione impulsiva da contraddire con raziocinio, fatti e prove.
Nello specifico, l’attentato al Bataklan sembra aver lasciato un segno indelebile nel sentimento nazionale. Si tratta di una ferita profonda, sporca, di una cicatrice che fatica, non può o forse non vuole rimarginarsi. Sebbene le cause dell’incendio siano state subito accertate, smentendo in maniera repentina qualsiasi altra ipotesi riguardo all’accaduto, l’istinto dei marsigliesi e di tutta la nazione, anche solo per un attimo, corre al passato, alla remota eppure allarmante possibilità dell’attentato, dell’attacco terroristico.
Il crollo coincide casualmente con l’ultima settimana di apertura della mostra Ghada Amer, Orient – الشرق – الغرب – Occident , ospitata in città dal MUCEM. L’esposizione personale dell’artista egiziana, allestita presso Fort Saint-Jean, si apre con Le Salon Courbé, installazione del 2007. L’opera circoscrive e stravolge l’ingresso del forte secentesco, mettendo in scena un ambiente statico e perturbante nella sua familiarità. Si tratta di un salone scarno, composto solamente da un tappeto e tre poltrone. Nervosi e viscerali filamenti rossi sembrano riaffiorare dalle austere sedute, ricoprendone parzialmente la candida superficie bianca. Se da una parte le accese e rassicuranti policromie delle iscrizioni in arabo ricamate sul tappeto richiamano le opere di Alighiero Boetti, dall’altra le inquiete poltrone al centro della stanza potrebbero ricordare la loggia nera di Twin Peaks o l’Overlook Hotel di Shining.
Allo stesso tempo, però, Le Salon Courbé sembra pronto ad accogliere il dialogo dei visitatori, quasi forzandone l’incontro. L’artista si propone di mettere a confronto la cultura occidentale e mediorientale. Reminiscenze tradizionali confluiscono in elementi di retaggio coloniale. Nello specifico, la carta da parati applicata sull’intero perimetro della stanza riporta numerose definizioni della parola “Terrorismo” in diverse lingue occidentali, mentre il tappeto e le poltrone riportano la traduzione in arabo, evidenziando le sottili ma significative differenze.
Nella cultura araba, il concetto stesso di terrorismo risulta a lungo estraneo e del tutto assente fino agli anni Settanta. “Terrorisme” e “Terroriste”, infatti, sono termini coniati durante la Rivoluzione francese, utilizzati per indicare e condannare la classe dirigente del 1793-94 appartenente al Regime del terrore. Il terroriste per eccellenza è dunque Robespierre, legittimamente considerabile come il primo terrorista della storia. Non a caso, in Inghilterra il governo rivoluzionario francese viene accusato proprio di terrorismo. Dopo la caduta del regime rivoluzionario e l’esecuzione di Robespierre e dei suoi fedelissimi, l’Académie Française annota il neologismo, definendolo come il risultato di un “sistema basato sul terrore”. I nostalgici, come ad esempio Babeuf, avrebbero poi rivalutato quel termine assegnato per condanna, ribaltandone l’accezione originariamente negativa.
Agli inizi dell’Ottocento, la diffusione del concetto di terrorismo sembra arrestarsi. Nei vocabolari europei dell’epoca non sembra lasciare alcuna traccia: l’accademia della crusca, ad esempio, non lo inserisce nel dizionario redatto nel 1830. Nella seconda metà del secolo, questo termine inizia a essere utilizzato più spesso, nello specifico in riferimento ai movimenti europei impegnati nella creazione di stati nazionali indipendenti, mentre negli Stati Uniti viene associato alle proteste sindacali e alle rivendicazioni del movimento operaio. Al contempo, nella Russia Zarista, tra il 1878 e il 1881, il gruppo Narodnaya Volya (Volontà del popolo) contribuisce alla successiva diffusione del neologismo in Oriente, definendosi una formazione terroristica.
La stampa internazionale, a tal proposito, si mostra abbastanza reticente a introdurre questo neologismo, nell’intento di non legittimare politicamente determinate formazioni rivoltose di opposizione. Per questo, importanti forzature come l’uccisione di Umberto I o quella dell’Arciduca d’Austria, rispettivamente per mano di Gaetano Bresci e Gavril Princip, sono spesso derubricate a gesti di follia criminale o a episodi di mero fanatismo anarchico.
Le azioni terroristiche, in quanto forme simboliche di violenza, sono molto più importanti della reale violenza fisica. La principale arma del terrore è proprio lo spettacolo della violenza stessa.
Tuttavia, nel corso del Novecento il termine “terrorismo” cambia drasticamente accezione, venendo utilizzato per delegittimare politicamente l’avversario. Durante la Seconda Guerra Mondiale, ad esempio, gli stati nazionali impegnati nel conflitto si accusano vicendevolmente di adottare strategie terroristiche. Il passaggio dirimente nella percezione di questo fenomeno complesso si verifica nella seconda metà del secolo scorso, durante il lento e incompiuto processo di decolonizzazione iniziato nel Secondo Dopoguerra. Gli attacchi contro le truppe d’occupazione occidentali o contro le altre fazioni in lotta per il controllo del territorio occupato sono infatti definiti nella maggior parte dei casi come atti terroristici.
Alla luce dello scontro montante tra le fazioni in lotta per la riconquista della propria terra e le truppe di occupazione occidentali, il termine terrorismo si diffonde capillarmente, assumendo al contempo un’accezione inedita, prossima a quella attuale. Questa parola, inoltre, viene associata sempre più spesso anche alle formazioni politiche, di entrambe le fazioni, impegnate nel tentativo di sovversione dell’ordine vigente, come ad esempio le Brigate Rosse, i NAR, l’ETA, Avanguardia nazionale o l’IRA.
La definitiva affermazione di questo termine nel vocabolario comune avviene il 5 settembre 1972, in seguito al sequestro, terminato nel sangue, di alcuni atleti israeliani a opera del gruppo palestinese “Settembre Nero”, durante i giochi olimpici di Monaco. Da questo momento, il terrorismo consolida la propria posizione, mai così centrale, nel linguaggio massmediatico, nonostante venga spesso utilizzato a sproposito o in maniera approssimativa e fuorviante. Come scrive Francesco Benigno, la traccia di Conrad nel romanzo L’agente Segreto (1907) indica quanto il fenomeno stesso del terrorismo sia nel mondo contemporaneo qualcosa di più di una semplice disfunzione sociale, costituendo al contrario parte integrante di un codice fondamentale dell’ordine stesso, quello del discorso securitario che presiede alla sicurezza collettiva.

Per questo, oggi questo termine indica l’irruzione improvvisa di un pericolo tangibile per la vita comune. Eppure, il terrorismo appare come un concetto fondamentalmente indeterminato. Si tratta di una delle nozioni più discusse nell’ambito delle scienze sociali. “Terrorismo”, infatti, non è un termine neutro descrittivo, bensì una locuzione valutativa, un’etichetta dispregiativa. Il solo utilizzo del termine implica un giudizio morale negativo. Tutto ciò, dunque, comporta l’inevitabile arbitrarietà della definizione stessa, a seconda delle circostanze politiche e del contesto socioculturale di riferimento. Caso emblematico quello dei mujahidin afghani: inizialmente celebrati da Ronald Reagan in veste di combattenti per la libertà, contro gli occupanti sovietici, sono stati definiti terroristi dalle amministrazioni successive perché contrari alla presenza statunitense nelle proprie terre.
I terroristi, pertanto, non occupano territori. Al contrario, deterritorializzano la violenza, affinché possano colpire ovunque, in qualsiasi momento.
Come spiega William Mitchell nel suo saggio Cloning Terror, il terrore consiste nella combinazione deliberata della semiotica dell’inimmaginabile con quella dell’impronunciabile, affiancando il divino al demoniaco. Il terrorista, allora, potrebbe essere un santo guerriero così come un diavolo. Dipende tutto dal punto di vista o dalla posizione storica. Le azioni terroristiche, in quanto forme simboliche di violenza, sono molto più importanti della reale violenza fisica. La principale arma del terrore è proprio lo spettacolo della violenza stessa, l’immagine della distruzione o la distruzione di un’immagine, spesso universalmente iconica.
Prendendo in esame l’episodio del World Trade Center, Mitchell sottolinea come le numerose vittime dell’attacco terroristico siano in realtà una sorta di danno collaterale rispetto all’abbattimento dell’immagine, del simbolo in oggetto. Non si tratta, quindi, di uccidere il nemico, quanto piuttosto di terrorizzarlo per mezzo di uno spettacolo traumatizzante. I terroristi, pertanto, non occupano territori. Al contrario, deterritorializzano la violenza, affinché possano colpire ovunque, in qualsiasi momento. Casualità e imprevedibilità: il terrorismo parla la lingua dell’impronunciabile e inscena l’inimmaginabile.
Sebbene nell’immaginario collettivo, specie in seguito all’11 settembre, il terrorismo sia spesso associato approssimativamente all’islam, risulta quanto mai significativa la dilazione della lingua araba rispetto alla definizione di questo fenomeno. Allo stesso tempo, questa limitante identificazione comporta il travisamento del concetto stesso di terrorismo. Come afferma – ancora una volta – Benigno, la produzione del terrore non rappresenta affatto la sola e unica dimensione di questo fenomeno. Al contrario, si tratta della necessità di risvegliare le masse dal proprio sonno politico, attuando quella che gli anarchici definivano “propaganda col fatto”.
Il terrore opera sull’immaginazione collettiva per clonare, per riprodurre le immagini del terrore stesso, come fossero la rappresentazione vivente dell’inimmaginabile.
Eppure, il terrorismo consiste anche in una complessa e sfuggente metodologia di conflitto adottata in tempi di pace, rappresentando la deflagrante apertura di uno spazio di possibilità. Secondo Derrida, rappresenta una forma politica e sociale di disordine autoimmune, in cui il corpo sociale viene ingannato e attacca se stesso. Nonostante le apparenze, il terrorismo si rivolge non tanto alla popolazione da colpire ma al proprio popolo, alla comunità di appartenenza. Si tratta di delineare la dualistica polarizzazione del conflitto, riassumibile nello scontro fra noi e loro, tra il bene e il male.
Ogni religione monoteistica, in tal senso, si propone di condizionare l’insieme della vita sociale, adottando una visione esclusiva del mondo. Tuttavia, per quanto riguarda l’universo musulmano, il tema del martirio non si ritrova affatto nell’elaborazione della dottrina sunnita, mentre ha fondamento in quella sciita. Le pratiche terroristiche, presenti in ambo gli universi, mostrano allora la capacità della religione di concretizzare una visione del mondo che ingloba e spiega problemi esistenti.
Se da una parte il comunismo ha saputo esprimere la spinta decolonizzatrice, dall’altra l’islamismo ne ha ereditato la dimensione rigeneratrice e salvifica, proponendosi come interpretazione alternativa della liberazione sociale. Dopo tutto, il primo attentato suicida in Medio Oriente viene compiuto il 30 maggio 1972, presso l’aeroporto di Lod, dai militanti comunisti dall’Armata Rossa Giapponese, in segno di solidarietà con il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina.
Come scrive DeLillo in Mao II, la cultura occidentale ancora non ha trovato un modo di assimilare il terrorismo. Il pazzo per strada, l’artista, tutto il resto viene assorbito, trasformato e incorporato. Tutto tranne il terrorista. Si tratta, in fondo, del linguaggio perfetto per essere notati, controllando il flusso interminabile delle immagini. Forse, secondo l’autore newyorkese, il terrorismo è l’unico linguaggio che l’Occidente comprenda. Gli scrittori stessi sembrano aver perso la propria pericolosità, mentre sono proprio i terroristi, secondo DeLillo, ad avere assunto il ruolo di criticare la cultura occidentale nel più diretto possibile dei modi.
Il terrorismo rivolge contro se stesso la funzione protettiva dell’immaginazione, ossia la propria abilità di prevedere cosa accadrà. In questo modo, il terrore opera sull’immaginazione collettiva per clonare, per riprodurre immagini del terrore stesso, come fossero la rappresentazione vivente dell’inimmaginabile. Il risultato appare come un’immagine distorta di noi stessi allo specchio: rappresenta l’alterità. E proprio in questo senso, l’opera di Ghada Amer si afferma come il necessario tentativo di decolonizzare il terrorismo, affinché sia ancora possibile confermare o stravolgere il modo di pensare noi stessi, opponendosi alla riproduzione figurativa dello straniero, così come alla proiezione delle proprie paure sull’immigrato, sullo straniero, sul diverso.