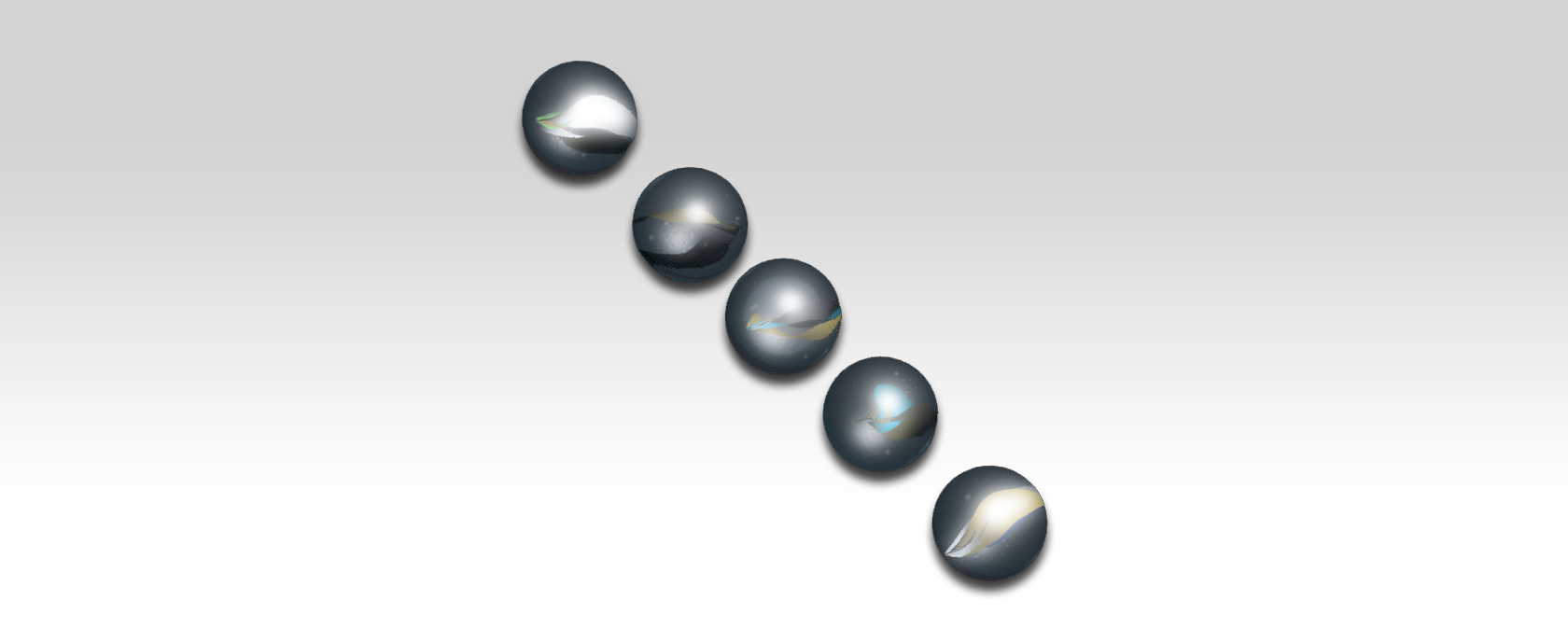e… e… e…
Pubblichiamo un brano tratto da E: la congiunzione, l’ultimo libro di Franco «Bifo» Berardi, disponibile da pochissimi giorni in tutte le librerie e sul nostro sito.
Il 1993 forse resterà nella storia come l’anno in cui, grazie al browser Mosaic, potemmo tutti sbarcare su un nuovo continente che avevamo già cominciato a chiamare Internet.
O forse resterà nella storia perché in quell’anno, per la prima volta dopo il 1945, il nazionalismo tornò a devastare un paese d’Europa, e una città europea che si chiama Sarajevo fu bombardata in nome della purezza etnica.
In quell’anno pubblicai due libri: uno, Mutazione e cyberpunk, uscì con l’editore genovese Costa & Nolan; l’altro, Come si cura il nazi, uscì per la casa editrice romana Castelvecchi.
La mia attenzione era attratta da questi due oggetti: la mutazione culturale che le tecnologie elettroniche di rete stavano scatenando, e il ritorno della bestia nazista che riemergeva con la guerra civile in Jugoslavia.
Erano due oggetti così distanti, così divergenti da sembrare incompatibili sulla scena del mondo. Sembrava impossibile che rappresentassero due tendenze destinate a coesistere, a convergere, a intrecciarsi.
Dalla California, frontiera estrema della modernità, veniva la promessa di un mondo trans-reale. Nel decennio precedente avevo letto i visionari tecnofili, a cominciare da Timothy Leary e Pierre Lévy. Nei loro libri si immaginavano gli scenari sconvolgenti che la rete digitale e i congegni di immersione nella realtà virtuale avrebbero aperto al prossimo futuro del genere umano. A San Francisco avevo incontrato i giovani cyberfanatici che iniziavano a stampare Wired, e pur senza iscrivermi al partito dei cyberutopisti condividevo l’entusiasmo di chi si attendeva una vera rivoluzione dallo sviluppo della rete. Ma soprattutto mi interessavano le implicazioni psichiche e sociali, mi interessava la mutazione antropologica e le patologie che la avrebbero necessariamente accompagnata.
Scrivendo Mutazione e cyberpunk mi proponevo di cartografare il futuro con parole e concetti nuovi. Ma se la grande rivoluzione imminente veniva dalle scintillanti tecnologie digitali, come spiegare l’oscurità che inghiottiva a un tratto le città jugoslave, e costringeva l’Europa a fare i conti di nuovo con il nazionalismo, la guerra civile, la pulizia etnica, i pogrom, le stragi, i campi di internamento, la tortura – in una parola il nazismo?
La bestia – che avevamo lungamente dimenticato, considerandola morta e sepolta – si risvegliava e aggrediva Vukovar, Mostar, Srebrenica, Sarajevo.
La guerra civile jugoslava, un ritorno di follia a cui i governi europei guardarono con un misto di sbigottimento e di anticomunista Schadenfreude, fu rapidamente archiviata dalla coscienza d’Europa non appena, dopo sei anni di violenze e duecentomila morti, la federazione si sbriciolò, e un pulviscolo di staterelli poveri e rancorosi prese il suo posto.
Ma nell’Europa di Maastricht – e soprattutto in Germania, il paese che spinse la Croazia a mettere in moto il processo di sbriciolamento e di guerra – non si poteva allora prevedere che la fine della Jugoslavia sarebbe stata il canovaccio dello sbriciolamento dell’Unione Europea cui assistiamo ora. Il nazismo tornava, con i suoi simboli, con la sua ferocia, con la sua demenza banale.
Dopo la fine del movimento di autonomia, dopo il convegno di settembre 1977 a Bologna, dopo l’impiccagione di Meinhof e Baader nel carcere di Stammheim, in quegli anni pieni di angoscia, di eroina e di terrore, avevamo presentito il ritorno della bestia.
Nel 1977, col film L’uovo del serpente Bergman aveva raccontato l’emergere del nazismo come un effetto di omologazione delle menti umiliate, disperate, terrorizzate. All’inizio degli anni Ottanta, dietro le scintillanti promesse di Reagan e di Thatcher, dietro le paillette delle televisioni di Berlusconi e di Murdoch, mi era sembrato di riconoscere il verso della bestia che si risveglia.
La rete ubiquitaria deterritorializzante e la riterritorializzazione identitaria si presentavano nello stesso momento come due scenari apparentemente incompatibili. Dovevo dunque descriverli come due processi privi di rapporto, nati da radici diverse e destinati a evolvere in due dimensioni separate? Oppure dovevo sforzarmi di elaborare, se così posso esprimermi, una teoria unificata della mutazione in corso, una teoria capace di spiegare al tempo stesso la virtualizzazione digitale dei processi comunicativi e l’irrigidimento identitario che conduce alla violenza, alla guerra, al nazismo?
Quei due libri acerbi che pubblicai nel 1993 contenevano entrambi una domanda: quale rapporto esiste tra la trasformazione tecnica iniziata con la connessione telefonico-informatica resa possibile dalle tecnologie digitali e la psicopatia aggressiva che stava emergendo come tendenza politica globale? Nel 1997, iniziando a scrivere il libro che ho pubblicato vent’anni più tardi col titolo And: Phenomenology of the End, tentavo di rispondere a questa domanda. Quel libro, di cui avete tra le mani la versione italiana (riveduta, ampliata, aggiornata), non finisce mai, perché non finisce il processo di mutazione tecnica cognitiva, psichica e politica cui è dedicato.
UNA DUPLICE CARTOGRAFIA
Alla fine degli anni Novanta, mentre si formava un’area di ricerca teorica e di sperimentazione tecnica e artistica che si definiva net culture, mi proponevo di scrivere un libro sulle modificazioni che la connessione generalizzata stava producendo nella sfera estetica e nella sfera erotica. Poi il ritmo della mutazione accelerò, e mi resi presto conto che non avrei potuto cartografare un territorio così esteso come quello che mi ero proposto all’inizio: dovevo piuttosto analizzare il nucleo essenziale della mutazione in corso, che si trova nel punto di incontro tra sensibilità e ambiente tecnoculturale.
Che ne è della congiunzione nel passaggio tecnolinguistico che si afferma per via di connessione? La competenza congiuntiva viene messa in questione, mentre la connessione si installa saldamente nella competenza cognitiva delle nuove generazioni di umani.
La mutazione antropologica andava interpretata a partire dalla transizione tecnica che porta il linguaggio dal regime della congiunzione al regime della connessione. Questo è il nucleo principale del libro al quale ho lavorato per quasi vent’anni, che sotto la direzione del professor Yuha Varto ho presentato come dissertazione di dottorato alla Aalto University di Helsinki nel 2014, e che è uscito infine nel 2015 per l’editore statunitense Semiotext(e).
Il tema che intendevo affrontare si articola su due piani differenti: lo spazio culturale entro il quale si svolge la transizione tecnica (e la mutazione psichica) non è uno spazio omogeneo. È lo spazio del pianeta modellato dalla storia, dalle differenze culturali, dai conflitti sociali del passato e del presente; soprattutto, è lo spazio di una globalizzazione economica che è anche globalizzazione tecnica e quindi culturale. Si trattava dunque di considerare insieme il passaggio da un regime tecnocomunicativo a un altro, e il territorio difforme e complesso nel quale avveniva la mutazione.
Per cartografare la mutazione occorreva tenere conto di una dimensione temporale, diacronica, entro la quale si realizza il passaggio dalla prevalenza congiuntiva alla prevalenza connettiva; e di una dimensione spaziale, sincronica, che è la dimensione culturale del pianeta Terra alla fine dell’epoca moderna, dopo cinque secoli di colonizzazione, dopo un secolo di lotte di classe, e dopo la sconfitta che gli operai hanno subito per aver creduto nell’inganno della democrazia e dei dirigenti della sinistra.
A livello diacronico si trattava di descrivere, o piuttosto di concettualizzare, la trasformazione che si manifesta nel passaggio da una generazione all’altra e si presenta come tecnomutazione connettiva.
A livello sincronico, però, questa trasformazione intreccia le stratificazioni culturali, estetiche ed erotiche depositate dalla storia moderna, i conflitti culturali ed economici, il divenire politico del mondo. Il trasformatore tecnico (digitale) non si inserisce infatti in uno spazio omogeneo, ma entro contesti culturali diversi. La connessione agisce sulla pellicola della sensibilità, producendo un effetto generalizzato di desensibilizzazione al contatto, che però si manifesta secondo curvature culturalmente diversificate.
Sottoposta a un’omologazione tecnocognitiva, la sfera psichica reagisce in modo patologico e le condizioni stesse dell’agire sociale ne sono travolte.
Nella sfera tecnica della rete, dove enormi masse di dati vengono attraversate da congegni dotati di intelligenza artificiale, si va costruendo l’automa cognitivo globale, e l’automa costituisce l’orizzonte verso il quale è attratto lo sciame dei comportamenti linguistici automatizzati.
Ma questa sussunzione della mente da parte dell’automa non si svolge senza turbamento, perché lo sciame è attraversato dal caos.
Ecco allora prodursi un doppio movimento: la connessione produce una crescente integrazione dell’automa, mentre la sfera sociale, incapace di congiunzione, si disintegra. Disintegrazione psichica, sociale ed emotiva, e integrazione degli automatismi tecnici sono i due processi che si incrociano sulla scena del mondo.
L’automa cognitivo globale si inserisce nella mente vivente collettiva sempre più dominata dalla demenza caotica. È questa doppia prospettiva che mi interessa concettualizzare.
Pubblicai questo libro in inglese nel 2015 – l’anno dell’umiliazione greca, l’anno in cui si accelerò il processo di disintegrazione politica dell’Unione Europea; ma anche l’anno in cui cominciò a stringersi implacabile il processo di integrazione dell’automa tecnofinanziario che strangolò la società greca e spinse la società europea nel cinismo e nella disperazione. Il processo di globalizzazione entrò allora in una fase convulsiva, e un movimento reazionario di massa emerse dall’umiliazione politica e dalla miseria sociale e psichica, mentre il desiderio di vendetta assumeva quasi dovunque un carattere etno-nazionalista. L’astrazione digitale si impadroniva di ogni frammento dell’esistenza. Ma al contempo, l’illusorio calore dell’appartenenza etnica e nazionale alimentava la guerra civile planetaria.
FENOMENOLOGIA DELLA FINE E METAFORA DEL RIZOMA
In un rizoma non c’è inizio e non c’è fine. Deleuze e Guattari propongono di vedere la realtà come un rizoma: una concatenazione aperta di e… e… e…
Per questo ventidue anni fa ho cominciato a scrivere la fenomenologia della fine.
Ma non c’è nessuna fine. Nessuna fine perché la fine non c’è, e non si prenda questa affermazione né come un segno di speranza, né come un segno di disperazione. Sarebbero tutte e due interpretazioni sbagliate.
Non spero e non dispero, né credo che la fine sia peggiore della sopravvivenza.
Non pretendo di sapere cosa è bene e cosa è male: so solo che la fenomenologia è un compito infinito, e quindi la fenomenologia della fine deve essere anch’essa un lavoro senza fine.
A più riprese ho deciso di mettere la provvisoria parola «fine» a questo libro, perché la mia vita non è eterna e in men che non si dica promette di volgere al termine.
And: Phenomenology of the End uscì nel 2015 in inglese, poi in spagnolo con l’editore argentino Caja Negra.
Ma il libro non era finito, e ha continuato a dimenarsi, contorcersi, allargarsi, ridursi, fino a prendere la forma (ancora provvisoria) in cui lo state leggendo, nella quale compaiono i capitoli finali sul caos e l’automa che nelle edizioni precedenti non c’erano.
Il tema della sensibilità, che è quello centrale nel libro, si intreccia con le metafore della fine che affollano l’immaginario contemporaneo, e con la costruzione dell’automa cognitivo globale che è in pieno svolgimento.
Nel 1977, l’anno della premonizione, Deleuze e Guattari scrissero un breve testo intitolato Rizoma, che più tardi pubblicarono come introduzione a Mille piani.
In quell’anno i movimenti sociali, la cultura punk e l’immaginazione distopica dell’arte e della letteratura presentirono in molte maniere una mutazione che oggi stiamo attraversando e che ha infiltrato profondamente l’ambiente tecnico, le relazioni sociali e la cultura. Il rizoma è al tempo stesso l’annuncio di una trasformazione della realtà e la premessa di una nuova metodologia di pensiero. È sia una descrizione della deterritorializzazione caotica che segue alla crisi del razionalismo moderno, sia una metodologia della descrizione critica del capitalismo deterritorializzato.
Quel breve testo di Deleuze e Guattari annunciava con un certo anticipo la dissoluzione dell’ordine politico ereditato dalla modernità e lo svanire dei fondamenti della filosofia razionalista occidentale. Al tempo stesso apriva la via a una nuova metodologia che adotta la concatenazione, piuttosto che l’opposizione dialettica, come modello capace di concettualizzare i processi culturali e le trasformazioni sociali.
Decenni dopo la pubblicazione di quel testo, la metafora rizomatica può essere intesa come un modo per cartografare il processo di globalizzazione neoliberale e la precarizzazione del lavoro che la accompagna. Ma può essere intesa anche come un riferimento all’indeterminabilità del compito del filosofo, ammesso che il filosofo abbia un compito. Il compito interminabile che mi sono assegnato è cartografare il territorio della mutazione e forgiare strumenti concettuali per orientarsi nel territorio in continuo mutamento e in continua deterritorializzazione, fino alla fine imminente ma asintotica.