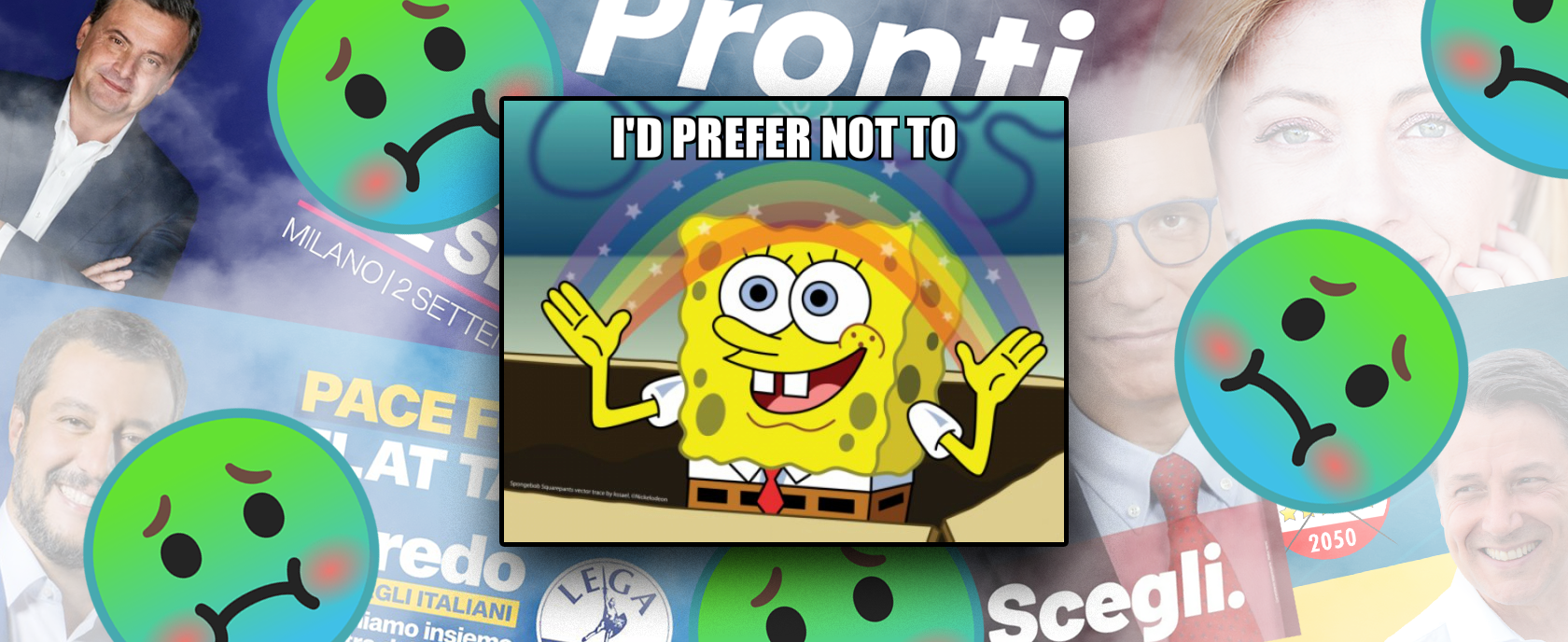Apologia dell’astensione
Il punto di rottura è quel segmento della vita di ogni persona nel quale la distruzione si configura come unica dimensione vitale possibile. Qualsiasi organismo vivente necessita di attraversare quello spazio diverse volte durante la propria esistenza e chi non riesce a farlo, soccombe. Ignorare quel passaggio conduce a un’inversione: la morte prende il posto della vita, configurandosi come morte vivente. Le prossime elezioni in Italia sono la rappresentazione plastica di questo scambio, nel quale viene chiesto agli elettori e alle elettrici di scegliere fra due modalità di morte lenta, una per mano del nemico, l’altra per mano di un amico; a variare è solo la velocità con cui avviene giornalmente quel tipo di scambio mortifero.
I ghiacciai si sciolgono e qualcuno ostenta la propria violenta noncuranza facendoci sopra un aperitivo, mentre agli altri non resta che un vago rancore in sé impotente come tutto ciò che si limita a reagire. Per quaranta anni la politica italiana ha dimostrato di essere null’altro che la manifestazione di una forza reattiva, debole, incapace di alcunché: non servono dati né grafici, la verità autoevidente di questa affermazione è scritta nel cuore di ogni persona sotto i cinquanta anni che ha avuto la sfortuna di vivere in questo paese. La disperazione in questo caso è una tautologia, scritta sui corpi di molte e di molti. Queste parole sono quindi un’apologia dell’astensione, politica in primis, ma soprattutto esistenziale.
La complessità è il nostro labirinto. L’informazione prolifera come un virus, orientarsi è impossibile; l’unica differenza è data dal riuscire ad affermare la parvenza di un senso paranoico o dal lasciarsi andare alla sua assenza più desolante. La crisi costitutiva della contemporaneità porta naturalmente alla richiesta di soluzioni facili: la ricerca di qualcuno che possa salvarci o in alternativa dispensarci dal pensare. Cerchiamo protezione, rassicurazione, allontanando da noi ogni presa sulla realtà che ci circonda. Più si parla di clima, meno si agisce, se non per esigere che chi è nelle posizioni di comando lo faccia al posto nostro.
Farla finita vuol dire ricominciare a credere che la vita di ognuna e di ognuno possa essere altro dal circolo infinito di merce, consumo e sfruttamento.
La vita della maggior parte delle persone è un incubo che si alterna fra lo spettro dell’indigenza e il burnout, mente guerre e pandemie saturano lo spazio del pensabile. È un’eterna ripetizione dell’identico, che a differenza del monito nietzschiano, non è parte di una scelta, di una forza attiva che decide per sé ma rappresenta invece la lenta fine di chi è stanco anche al pensiero di morire. Siamo all’inferno? Continueremo a fare questo fino alla morte? si chiedono i personaggi di Patricia Lockwood nel romanzo Nessuno ne parla, e lo stesso si chiedono le italiane e gli italiani quando si ritrovano chiusi in trappola con Enrico Letta, Giorgia Meloni e le alleanze da 3%.
Ma c’è una terza via: farla finita. Non con la vita tout court, ma con la vita che è non è stata scelta, con le false speranze, con le scelte consolatorie, con la paura di morire e l’ansia di sopravvivere. Una fine che è in realtà un inizio dai molti nomi: diserzione secondo Bifo, destituzione per gli amici del Comitato Invisibile, ma anche undercommons o addirittura venuta del Regno. Alla base c’è un porsi al margine, lavoro nero e dell’ombra, che permetta di ripartire dal desiderio più semplice e immediato: quello di essere felici. Semplicemente, l’urgenza di vivere una vita degna passa in primo piano, riconfigura lo sguardo e le modalità di relazione. La ricerca non passa più dal delegare esternamente, la volontà non muore più di inedia; l’orizzonte prende la forma di una comunità organizzata che condivide i mezzi e le capacità di usarli verso il bene collettivo.
Homo homini lupus è una menzogna, un concetto che ci permette di dare un senso a turni di lavoro massacranti e condizioni di vita umilianti; fuori dalla società neoliberale che il potere occidentale ha costruito esiste un’autonomia possibile. I governi di tutto il mondo si trovano a un bivio: convincere la popolazione del bisogno di restare nei recinti mentre allo stesso tempo operano una selezione volta a decidere chi potrà sopravvivere alla catastrofe ambientale, alle guerre e alle pandemie. Non è una distopia, è la realtà in pieno svolgimento. Ma attenzione, fare secessione, rompere il recinto, destituire non vuol dire isolarsi in qualche comunità montana mangiando semi e radici, rincorrendo così il mito romantico ma poco efficace dell’anarcoprimitivismo, né abbandonare i luoghi e le persone che li vivono.
Al contrario, farla finita vuol dire ricominciare a credere che la vita di ognuna e di ognuno possa essere altro dal circolo infinito di merce, consumo e sfruttamento. La differenza fondamentale è che tale credenza non deriva, a cascata, dalla grande idea, dal grande piano, dalla somma strategia volta a costituirsi come potere alternativo a quello vigente, ma nasce spontanea dalla banale e al contempo abissale consapevolezza che semplicemente, così non si può più andare avanti.
I would prefer not to. Preferirei di no. La formula della creazione, impersonata dal rifiuto di Bartleby, protagonista di uno dei racconti di Herman Melville, illustra perfettamente questo concetto. Bartleby è uno scrivano, un segretario, un sottoposto. Lavora in uno studio di avvocatura, nel quale l’avvocato fa la parte del padrone gentiluomo. All’inizio del racconto, Bartleby lo scrivano si rifiuta di adempiere a una richiesta fattagli dal padrone. “I would prefer not to”, “preferirei di no”, risponde. Non è una sfida né una rivolta, non vi è una domanda, non ci sono richieste: Bartleby, semplicemente, preferisce di no, preferisce non fare ciò che gli è stato chiesto; la sua intera umanità si concentra e si esplicita nell’istante in cui si rifiuta di essere ciò che non è, di fare ciò che non vuole.
Da lì in poi è un attimo: l’avvocato continua a fare richieste sempre più accomodanti, cerca di imbonire Bartleby, di convincerlo, motivarlo e a suo modo anche aiutarlo. Ma Bartleby è un fiume che scorre e afferma la propria volontà: no è la risposta, preferirei di no, e così fino all’assurda conclusione del racconto. L’avvocato perde il proprio principio di realtà, non gli rimane nulla sul quale fare leva, sul quale stabilire un senso logico che è innanzitutto una forma di potere e di dominio. Uno dei concetti chiave alla base di ciò che viene chiamato potere destituente è questo farsi da parte, questo rifiutare lo scontro diretto con il potere costituito: il rifiuto di combattere sul campo scelto dall’avversario.
Destituire, in termini pratici, vuol dire togliersi dall’equazione che ci vede da sempre perdenti, fuggire da questa rappresentazione nefasta che determina a priori la sfera del possibile. Vuol dire decidere finalmente che non serve un’alternativa già pronta all’incubo del capitalismo neoliberale, ma che possiamo trovare la forza di cercarla strada facendo, che possiamo creare spazi di autonomia, libertà e mutuo appoggio che minino gradualmente le fondamenta del sistema di potere vigente, senza esporci direttamente alla sua furia, in due parole: fuggire combattendo. Possiamo togliere le nostre vite dal piatto, riappropriarcene, dando al nostro rifiuto la forma di un’alternativa percorribile.
Scrive Bifo che la diserzione dal territorio simbolico dell’ordine costituito agisce come creazione di una dimensione simbolica autonoma che può darsi regole, può difendersi e può proliferare. Il potere che cerchiamo è il potere di trattenere l’energia, di non dissiparla su ciò che non può essere cambiato.
Le elezioni del prossimo 25 settembre proporranno ancora una volta la stessa scelta illusoria, lo stesso gioco truccato. In Italia l’astensione è ormai il primo partito; eppure, c’è ancora chi si ostina a leggere questo dato con la miope supponenza di sapere meglio degli altri qual è la cosa migliore per tutti. Sarebbe bello sapere da queste persone come giustificano il punto a cui siamo arrivati, come giustificano la svendita del mercato del lavoro, delle persone migranti e delle comunità LGBTQ+, dei diritti civili e sociali in generale. Forse abbiamo vissuto gli ultimi quarant’anni governati dalla destra senza nemmeno accorgercene? Chissà.
Lavorare attivamente non alla campagna elettorale di qualche partito ma alla costruzione di ciò di cui abbiamo bisogno collettivamente per smettere di sopravvivere e cominciare finalmente a vivere.
Sempre Bifo, di recente ha scritto «Disertare è la lotta che ci aspetta. Disertare la guerra, prima di tutto. Disertare la guerra che divampa e divamperà sempre più largamente, perché quando il nazionalismo contagia la mente collettiva la guerra si prepara in ogni nicchia. Disertare il lavoro salariato che tanto non serve più per sopravvivere, ma serve ad alimentare una crescita che devasta il pianeta e arricchisce solo una piccola minoranza. Disertare il consumo di tutte quelle sostanze che, come la plastica, devastano l’ambiente e la mente. Alimentare comunità indipendenti che abbandonano il pianeta in fiamme (per andare dove? a questo ci penseremo). Disertare la politica, arte inutile incapace di comprendere, e di governare.» La domanda sorge spontanea: nella realtà di tutti i giorni, nella pratica della vita quotidiana, che fare?
Come ritrovare un potere capace di sostenere i nostri desideri, libero dalla catena dell’impotente risentimento? Una domanda simile è stata già posta molto tempo fa: nel passo dell’hōs mē (1Cor 7, 29-31) San Paolo risponde a chi gli chiede quando verrà il giorno del Signore: Dio verrà come un ladro nella notte. Kafka, nei quaderni, aggiunge: il Messia verrà soltanto quando non ci sarà più bisogno di lui, arriverà solo un giorno dopo il proprio arrivo, non arriverà all’ultimo giorno, ma dopo l’ultimo. E nel frattempo, che fare?
È sempre San Paolo a rispondere: vivere come se non. Il cristiano delle origini sa che non può aspettare che Dio compia la trasformazione al suo posto e che deve vigilare, essere presente e consapevole, ma allo stesso tempo sa che il potere temporale non è nulla se non un’ombra che non può raggiungerlo. Vive come se non esistesse, in base ad altri principi e altre significazioni; rifiuta il mondo così com’è e orienta ogni giorno la sua vita in altre direzioni. «Se aveste tanta fede quanto un granello di senape, potreste dire a questo monte: passa da qui a là, e passerebbe, e niente vi sarebbe impossibile» (Mt 17,20).
Costruire da subito, qui e ora, altre modalità di relazione fra noi e tutte le persone umane e non umane che ci circondano, usando la potenza riguadagnata per credere che sia possibile farlo fino in fondo. Non c’è niente di più concreto, quotidiano. Non c’è altro da fare. Tutto ciò che è fondato sul perdurare della realtà di cui abbiamo esperienza, con le sue regole e i suoi criteri non può davvero toccarci, se non lo vogliamo, scriveva Sergio Quinzio. Lavorare attivamente non alla campagna elettorale di qualche partito ma alla costruzione di ciò di cui abbiamo bisogno collettivamente per smettere di sopravvivere e cominciare finalmente a vivere. Condividere risorse, saperi, emozioni. Trovarsi, incontrarsi, parlarsi non per fare teorica politica delle bolle intellettuali ma per risolvere, concretamente i problemi che ci affliggono e ci impediscono di vivere come potremmo.
Non è impossibile, in tante parti del mondo sta già accadendo, è già accaduto e accadrà ancora. La scelta è se credere, ancora una volta, alle menzogne della democrazia al soldo del capitalismo neoliberale, espressione di un’oligarchia gerontocratica, reazionaria e vendicativa, o se credere che sia possibile preferire di no.
«Una moltitudine di persone, spazi e infrastrutture preparano il terreno dove territori, forti e autonomi, prendono forma. C’è tutto, per tutti. La terra è spartita per uso comune. La tecnologia non ha più segreti: tutto può essere uno strumento, qualsiasi cosa un’arma. Linee di rifornimento autonome rompono la morsa economica. Reti collaborative si occupano di comunicazione immediata, connettendo coloro che sentono il bisogno di costruire una vita altra. Mentre i governi cadono, i territori autonomi fioriscono col nuovo sentimento che, per essere liberi, dobbiamo legarci a questo pianeta e alla vita che ci circonda. Abbiamo davanti una scelta: l’inferno o l’utopia? Entrambe le risposte ci soddisfano. Infine, raggiungiamo il ciglio – sentiamo il pericolo della libertà, il calore del vivere insieme, il miracoloso e l’ignoto – e sappiamo: questa è vita»