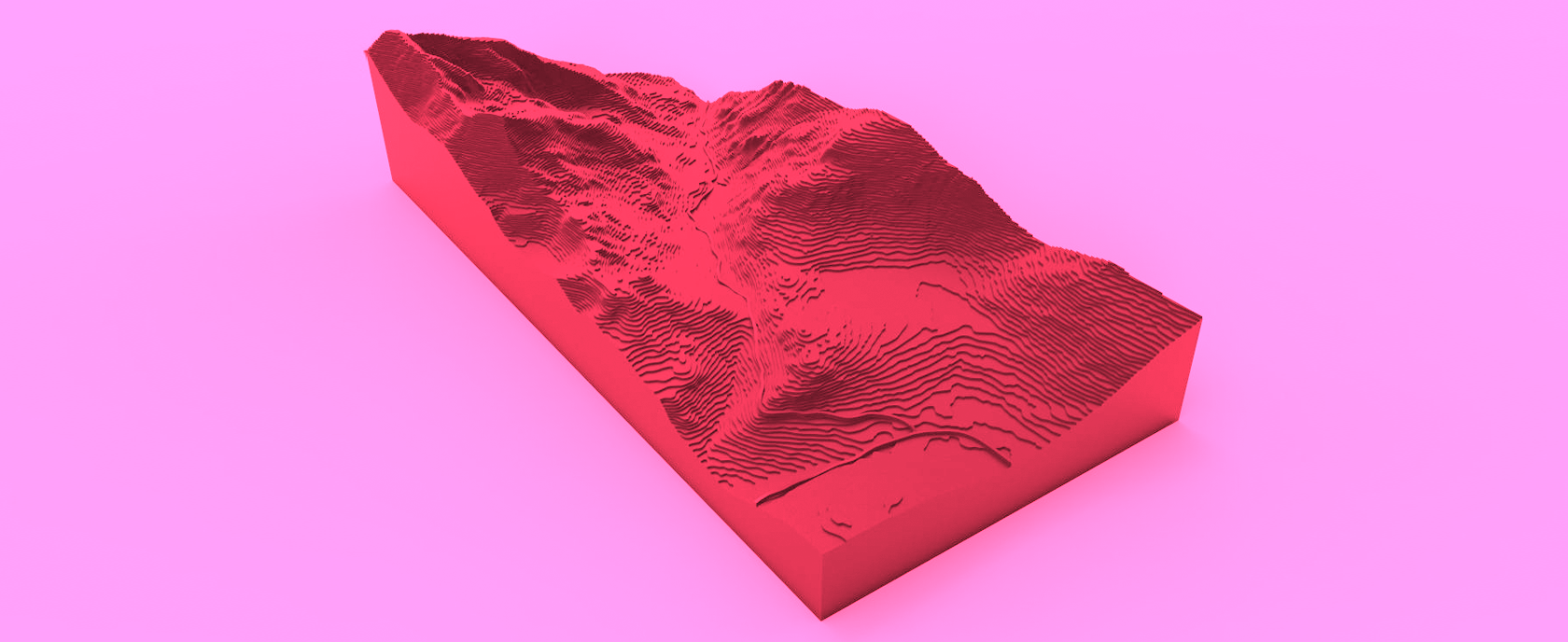3000 anni di eterotopie
Sorprende constatare che ciò che distingue la nostra specie dai mammiferi e dagli ominidi non è semplicemente la capacità di utilizzare un linguaggio, di manipolare segni o, mentendo, di celare le nostre intenzioni. Ciò che è veramente stupefacente è la costante capacità di aggiornare, modificare e migliorare il nostro apparato tecnico. Connessa a questa facoltà di autocorrezione è la specifica tendenza al superamento dei nostri limiti biologici e geografici. Duecentomila anni fa, homo sapiens viveva in una nicchia ecologica limitata all’Africa centrale e meridionale, quarantamila anni fa si era espanso in Europa, a quindicimila, sfruttando lo stretto di Bering, aveva già raggiunto il Canada e l’America. Nel XV secolo si ricongiunge con l’America, dopo millenni di separazione, e alla fine degli anni Sessanta compie l’approdo sulla Luna.
La nicchia ecologica della specie umana è diventata l’intero pianeta, e per questo si utilizza il termine tecnico Antropocene, per identificare tanto un’epoca geologica quanto un fatto geografico e antropologico. Partendo dai termini house e displacement, si potrebbe definire i due rapporti antitetici della nostra specie in relazione all’ambiente: da un alto, una costante espansione e una progressiva alterazione dell’ecosistema, dall’altro la necessità di ricreare una sfera di sopravvivenza, sia questa atmosferica, semiotica o architettonica.
C’è una storiella che si trova spesso nei testi di quella che potremmo definire un’antropologia democratica, cosmopolita, culturalista e moderatamente marxista: la natura dello spazio è cambiata radicalmente nel passaggio fra premoderno e moderno: l’utilizzo della prospettiva in pittura e la conquista dell’America, nel XV secolo, innescano un processo che porterà alla de-sacralizzazione dell’episteme europea, e alla rottura dei vincoli dello spazio simbolico o analogico del medioevo. Questa è la tesi di Marc Augé, ma anche di Franco La Celca, e di Franco Farinelli. Il problema è che questa tesi ha molte ramificazioni, da quella storico-religiosa di Eliade a quella fenomenologica e strutturale di Foucault.
Questo mio intervento sulle rotture epistemiche nella produzione dello spazio intende essere allo stesso tempo un elogio e una critica della conferenza di Foucault sulle eterotopie. Quattro anni fa concludevo il mio dottorato, dedicato proprio alla conferenza di Foucault, anche io pensavo che questa storiella avesse un senso. Certo, il concetto delineato da Foucault era evidentemente troppo generico per poterne trarre una teoria efficace, e lo stesso filosofo l’aveva considerato più come una boutade che come una riflessione proficua. Com’è noto, con eterotopia si intende definire, in modo generico, una certa classe di architetture, la cui funzione differisce dal lavoro o dall’abitazione. Si tratta, in altre parole, di spazi creati per attività ludiche o per conservare archivi, o, ancora per confinare la mobilità di una certa classe di persone (folli, criminali, anziani). L’aspetto centrale delle eterotopie è che queste si sostituiscono a un modello precedente di organizzazione dello spazio, un modello che potremmo definire «simbolico». Il problema di questa definizione, che accomuna strutturalmente la disposizione degli edifici nella cultura Inca con i villaggi del XII secolo, è che è poco precisa e forse non è nemmeno corretta. Lo spazio simbolico è disomogeneo, limitato, gerarchico, pregno di significato e permette un attaccamento al territorio che la metropoli contemporanea non possiede, se non nella forma residuale delle identità dei singoli quartieri nelle megalopoli europee, come negli arrondissements di Parigi o nei rioni di Roma. Lo spazio della prospettiva, per come è descritto da Leon Battista Alberti del De pictura nel 1435, è omogeneo, geometrico, razionale, è un contenitore strutturale di azioni, gesti e figure estratti dalla religione, dalla mitologia e dalla storia. Allo stesso tempo, la planimetria delle riduzioni portoghesi del XVI secolo, è un’utopia funzionalista: disintegra la localizzazione vernacolare delle popolazioni indigene e la sostituisce con una griglia razionale composta da un modulo potenzialmente riproducibile all’infinito: è una serie.
Quando nel 1785 Thomas Jefferson propone il Land Act per l’occupazione dei territori «neutri» del territorio della Virginia, o quando, sempre nel XVII secolo, la famiglia Cassini intraprende il progetto di una cartografia scientifica della Francia, il modello dello spazio prospettico si unisce a quello del governo del territorio, in senso coloniale, razionale e «appartenente» de-simbolizzato. Il problema è che questa forma-griglia non è semplicemente un’invenzione del capitale. Non è, in altri termini, il modello più razionale di organizzazione dello spazio, che proietta un ordine standardizzato su una materia informe e irrazionale. Anche la planimetria degli accampamenti e delle colonie romane seguiva questo schema, seppur conservando una connotazione magico-giuridica. Stabilire i limiti del territorio era quindi considerato più come una sorta di incantesimo che come un’asettica triangolazione militare. Non c’è dubbio che l’organizzazione dello spazio prospettico e quadrettato della pittura e della cartografia moderna siano un prodotto culturale, tuttavia non è così semplice evacuare il problema dell’origine della griglia come forma simbolica.
Quello che recenti studi di neurologia ci dicono sulla forma dell’apprendimento mnemonico e sull’orientamento spaziale nell’uomo e nei mammiferi in generale, è che la memoria di eventi, tecniche, volti, gesti e immagini è codificata in forma spaziale. In altre parole, memorizzare e rammemorare hanno una natura narrativa e architettonica.
Se ritorniamo al periodo del Pleistocene e all’ambiente della savana, ed entriamo dentro la mente dei mammiferi e degli ominidi scopriremo delle strutture neurologiche simili, localizzate nell’area dell’ippocampo e della corteccia entorinale. Si tratta delle place cells e delle grid cells, ovvero due tipi particolari di neuroni che codificano nella memoria a breve termine e a lungo termine una serie di landmarks in una sequenza unica e permettono l’orientamento in uno spazio grazie a una vera e propria griglia mentale, costituita da una struttura esagonale composta da sei cellule. Quello che recenti studi di neurologia ci dicono sulla forma dell’apprendimento mnemonico e sull’orientamento spaziale nell’uomo e nei mammiferi in generale, è che la memoria di eventi, tecniche, volti, gesti e immagini è codificata in forma spaziale. In altre parole, memorizzare e rammemorare hanno una natura narrativa e architettonica. Nella mia mente, così come in quella dei roditori e degli ominidi, la memoria episodica si accumula per mezzo dell’apprendimento di percorsi, composti da punti di arresto salienti, che vengono disposti in sequenza, e possono essere rievocati in ordine casuale. Questo avviene grazie alle place cells. Ciò che fanno le grid cells, invece, è fornire una quadrettatura dello spazio che può essere rievocata anche in assenza di un paesaggio o di un percorso visibile. In altre parole, la scoperta delle grid cells potrebbe comportare un cambiamento radicale nel modo in cui si articolano la geografia culturale e l’antropologia del paesaggio.
In un capitolo delle splendide lezioni sulla pittura rappresentativa europea dello storico dell’arte francese Daniel Arasse, Histoire des peintures, la nascita dello spazio prospettico è contrapposta alla tradizione delle arti della memoria. Come forse qualcuno di voi saprà, le artes memoriarum sono delle tecniche oratorie, descritte dettagliatamente nei manuali di retorica di Cicerone e Quintiliano nel primo secolo dopo Cristo e analizzate nei lavori teorici di Frances Yates, Paolo Rossi, Mary Carruthers e Lina Bolzoni. Le arti della memoria costituivano una sorta di antropotecnica primaria – per usare la definizione di Peter Sloterdijk – ovvero un insieme di regole cognitive utili alla memorizzazione degli argomenti che gli oratori, i filosofi o in generale gli intellettuali utilizzavano in vista di una discussione, o semplicemente per velocizzare il processo di apprendimento. L’aspetto più affascinante delle arti della memoria è la loro configurazione nella forma di un processo mentale di creazione di architetture e scene teatrali, nella quale le parole, i concetti e le storie da ricordare sono trasformate in immagini inconsuete e disposte ordinatamente nelle molteplici stanze dei palazzi immaginari. Le arti della memoria diventano parte integrante della cultura scolastica e sono una tecnica che ritroviamo presso i Domenicani e i Gesuiti. Come ha fatto notare Arasse, la stessa strutturazione della pittura prima dell’introduzione della prospettiva lineare seguirebbe le regole di questa arte, e questo permetterebbe di comprendere l’organizzazione di importanti cicli di affreschi rinascimentali come quelli che si possono ammirare a Palazzo Schifanoia a Ferrara o a Palazzo della Ragione a Padova. Non solo: le arti della memoria coniugano l’organizzazione architettonica dello spazio di memorizzazione con la condensazione simbolica dei contenuti da memorizzare.
A questo punto, ci si potrebbe chiedere: Cos’è un simbolo? E soprattutto, che cos’è uno spazio simbolico? Il concetto di simbolo ha infinite accezioni, dalla filosofia romantica allo strutturalismo in linguistica e in semiotica, sino alla psicanalisi. Quello che ci interessa in questa esposizione è fornire una definizione che permetta di legarlo alla nozione più ristretta di simbolismo architettonico. Definiamo quindi il simbolo come una unità di senso condensata, intendendo quest’aggettivo nell’accezione freudiana. Il simbolo, in altre parole, è una composizione condensata e composita di elementi eterogenei. Per l’iconografia il simbolo rappresenta un oggetto naturale o artificiale che rimanda, metonimicamente, a una rete semantica e referenziale molto vasta. Anche le personificazioni, come quelle descritte da Cesare Ripa nell’Iconologia (1593) sono in qualche modo simboliche. La giustizia, ad esempio, è una donna che regge una bilancia e una spada. Si tratta di una figura composita: un corpo (prevalentemente femminile), una postura, e degli oggetti. Certo, la bilancia stessa è un simbolo, ovvero quello della giustizia, e non è certamente riconducibile alla cultura visiva medievale o greca. Appartiene piuttosto ai Libri delle due vie egizi (ca. 2000 a.C.), dove segnalava l’approdo dell’anima alla fase della pesatura del cuore. La natura stratificata dei simboli, dal punto di vista storico e semantico, rende difficile un’interpretazione semplice, univoca, e nell’iconologia del XV e XVI secolo il modello ermeneutico si affida a quella che Umberto Eco ha chiamato semiosi illimitata, ovvero a un processo di spostamento e rimando del significato da un simbolo all’altro.
Se prendiamo uno dei testi più importanti di mitografia, Le immagini degli dei di Vicenzo Cartari, troviamo un interessante sviluppo della teoria rinascimentale del simbolismo, ovvero la sua applicazione all’antropologia comparata delle religioni. Ci si rende conto che allo stesso concetto simbolico possono essere legate diverse forme rappresentative, a seconda della cultura di riferimento. Inoltre, nella comparazione fra la mitologia greca, romana e le divinità recentemente ritrovate del nuovo mondo, è possibile stabilire delle corrispondenze di funzione fondate sulla somiglianza visiva. Parlare di spazio simbolico significa quindi descrivere una certa modalità di pianificazione spaziale e ornamentazione architettonica satura di elementi che condensano significati complessi. Nelle arti della memoria i simboli sono chiamati imagines agentes e la loro funzione, come abbiamo visto, è quella di sintetizzare un insieme di informazioni complesse. Nonostante le modalità ermeneutiche abbiano subìto una trasformazione dal Medioevo al Rinascimento, l’aspetto centrale dell’interpretazione analogica è l’estrema disinvoltura con la quale si passa da un significante a un significato. Per questo bisogna fare attenzione quando si analizza il simbolismo architettonico: molte volte lo stesso artista ha pensato a una nebulosa di significati vaghi e alle volte contraddittori. Ma è solamente attraverso uno studio comparativo, ovvero attraverso la nascita di una etnologia, che è possibile indagare il funzionamento delle dinamiche di elaborazione e trasformazione dei simboli. La filosofia empirista e la filosofia razionalista del XVII secolo hanno contestato che fra le parole, e in generale i simboli, esistesse un legame «naturale» con il loro significato. Nel Leviatano di Hobbes (1651) l’uso dei simboli e delle allegorie diventa un fatto psicologico da indagare e una strategia militare di propaganda. La manipolazione dei simboli collettivi passa dalla sfera religiosa a quella politica, secondo la famosa affermazione di Carl Schmitt.
Da un punto di vista della psicologia evoluzionistica – quello de L’evoluzione della mente di Merlin Donald – l’oggetto delle prime rappresentazioni visive sono delle forme mimetiche (di gesti, volti, corpi antropomorfi o zoomorfi). Il contenuto visivo delle prime rappresentazioni (17.000 anni) sono tentativi di riproduzione o evocazione degli eventi, delle emozioni, dei gesti e degli animali che avevano colpito maggiormente l’attenzione dei cacciatori/raccoglitori. Sebbene non possiamo ricostruire il significato e la funzione di quel simbolismo, possiamo comunque seguire l’evoluzione storica della mimesi del mondo animale, che nell’astrologia babilonese e poi greca vengono proiettati nella cintura zodiacale. Animali semplici come gli arieti o chimere come il Sagittario, non solo racchiudono i limiti esterni del cosmo, ma sono posti a guardia delle città e dei palazzi, nelle zone di confine. Lo spazio simbolico è esso stesso, come ebbe a dire lo storico dell’arte Aby Warburg, un enorme animale che ci avvolge con le sue membra e di cui noi conosciamo solamente una piccola parte. Questo è il potere dei simboli, di animali, figure geometriche, gesti, colori: ognuno di essi contiene al suo interno, come una monade leibniziana, l’intero sviluppo dell’universo, contratto in pochi elementi. Questo enorme potere attribuito alle forme simboliche è presente nelle culture studiate dagli antropologi, soprattutto nelle modalità di organizzazione ontologica che l’antropologo francese Philippe Descola ha chiamato Analogismo. Gli schemi urbanistici della Cina arcaica, delle città etrusche, di Cuzco in Perù mostrano una struttura duale: essi trasferiscono sulla Terra una stratificazione di significati celesti.
Il movimento moderno, e prima di questo il manifesto dell’architettura futurista di Sant’Elia (1914), avevano preso come modello gli artefatti più avanzati della produzione industriale e come tecnica di costruzione il fordismo. L’apparente eliminazione del simbolismo, inteso come decoro e ornamento, è contestabile, se si pensa che nel Modernismo si passa semplicemente a un altro tipo di simbolismo: quello dei nuovi mezzi di trasporto di lusso.
L’orientamento delle case, il decorum dei templi, la forma delle strade e i confini sono, come dicevamo, pregni di senso. Ora, non è che la prospettiva, la cartografia scientifica e la psicologia razionalista eliminino l’utilizzo del simbolismo, ma sicuramente comportano un cambiamento radicale nel suo uso. Come ricorda Ernst Gombrich nel suo Il senso dell’ordine. Studio sulla psicologia dell’arte decorativa, dal XV al XIX secolo il significato culturale del simbolismo architettonico è profondamente mutato: più che conferire un particolare potere o una particolare aura a un edificio, l’uso di modanature floreali, di Telamoni e Cariatidi, agli inizi del Novecento risulta decisamente ridicolo, e anzi moralmente degenerato come affermano con forza Adolf Loos e Le Corbusier. In Ornamento e delitto, del 1908, in opposizione con lo stile della Secessione Viennese, Loos dichiara senza alcuna esitazione che il decorum negli abiti, nei mobili e negli edifici non è altro la sopravvivenza di un modo di pensare premoderno, inadeguato al progresso tecnologico e allo stile della vita contemporanea. Allo stesso modo, in Vers une architecture Le Corbusier (1923) mette in ridicolo l’opulenza dell’arredamento d’interno delle case dei nuovi industriali e prende come modello per le sue unités d’habitation delle celle monastiche.
Sappiamo che per l’architetto svizzero il modello da seguire, che diventerà poi lo standard del Movimento Moderno e dei suoi congressi, è quello della grande industria (automobili, transatlantici, aerei, silos, fabbriche), che lui interpreta come un perfetto esempio di competenza senza comprensione, ovvero come un processo evoluzionistico di accumulazione inconscia di costanti migliorie da parte di ingeneri poco pretenziosi, occupati principalmente a risolvere problemi tecnici di funzionamento piuttosto che assecondare capricci estetici. Con un’analogia piuttosto sbalorditiva, Le Corbusier assume che il modo di procedere ingegneristico, per trial and error, approdi alla creazione di standard perfetti, funzionali e semplici, e legge in questi termini l’architettura antica, come il Partenone, il Pantheon o Santa Sofia. Il tempio greco sarebbe il prodotto di un sapere proto-industriale, ma comunque basato sulla lenta organizzazione di uno standard.
Leggendo due manifesti altrettanto importanti, ovvero Imparare da Las Vegas (1972) di Robert Venturi, Denise Scott Brown e Steven Izenour e Junkspace (2001) di Rem Koolhaas, si può capire che l’eroica teoria architettonica di Le Corbusier, composta da figure semplici, modelli in serie, solidi platonici e materiali industriali non è un puro funzionalismo privo di simboli. In realtà il simbolismo architettonico non è mai eliminabile, a differenza di quello che pensavano gli architetti moderni. Semplicemente così come a un intellettuale rinascimentale la contorta ornamentazione di una cattedrale gotica era sgradita, allo stesso modo per il modernismo le decorazioni dell’art nouveau o del rococò sono quanto di peggio si possa produrre in architettura. Ma si tratta di un giudizio imparziale: il movimento moderno, e prima di questo il manifesto dell’architettura futurista di Sant’Elia (1914), avevano preso come modello gli artefatti più avanzati della produzione industriale e come tecnica di costruzione il fordismo. L’apparente eliminazione del simbolismo, inteso come decoro e ornamento, è contestabile, se si pensa che nel Modernismo si passa semplicemente a un altro tipo di simbolismo: quello dei nuovi mezzi di trasporto di lusso. Poiché la storia dell’architettura, come in generale la storia degli stili è fatta di azioni e reazioni, verso la metà del 1970 vediamo emergere un nuovo stile, annunciato dal testo di Venturi. Venturi parla chiaramente di necessità di marcare il simbolismo architettonico, basandosi sul suo studio sulle insegne e sull’architettura di Las Vegas. Anche in questo caso si parte da un mezzo di trasporto, e della possibilità di percorrere ampi tratti di strada ad alta velocità. A Las Vegas un edificio moderno, con le sue forme eroiche e tragiche, il cui simbolismo è interno, criptico, risulterebbe totalmente invisibile e indistinguibile da un qualsiasi capannone. Viceversa, la sgargiante insegna al neon, sopraelevata, è altamente visibile, come volesse urlare all’automobilista «guardami, sono qui!». Non è un caso che Venturi parli di architettura della persuasione, dopo circa vent’anni dalla pubblicazione di Public Opinion, il manuale di Walter Lippmann sulla fabbrica del consenso.
L’architettura manierista e post-moderna preannunciata da Venturi appiattisce e ironizza sulla pesantezza storica: è una citazione degli stereotipi e delle forme più banali delle culture di interesse etnografico e della storia. Vi è inoltre un elemento centrale, ma poco considerato nelle storie dell’architettura: ovvero che con il movimento moderno e successivamente con il postmoderno l’operazione architettonica diventa sempre più personale (la nascita delle cosiddette archistar) e tende a confondersi pericolosamente con la scultura e in generale con le arti plastiche. In un certo senso, quando parliamo di «architettura» non intendiamo l’anonima e diffusa espansione del junkspace in tutto il pianeta, ma quelle singolari eccezioni alla regola che sono gli edifici-opera come l’arcinoto Guggenheim di Bilbao.
Dal punto di vista architettonico, la nascita di uno stile «neomedievale», è correlata a una serie di caratteristiche concomitanti. Nel 1960 l’architetto metabolista Fumihiko Maki introduceva il concetto di megastruttura, ovvero una forma architettonica resa possibile dalla climatizzazione e dall’impiego di nuovi materiali che permette di costruire un edificio talmente grande da contenere le funzioni di una città in miniatura. È vero che anche il grattacielo avrebbe questa ambizione, ma la megastruttura non contiene solo unità abitative e ricreative, può permettere anche lo sviluppo di ampie zone di transito comune, come piazze, biblioteche, musei. L’architetto spagnolo Alejandro Zaera-Polo ha parlato di una politica dell’involucro nelle forme costruttive dell’architettura contemporanea. Si tratta di megastrutture capsulari, climatizzate, protette come se si ricoprisse con una cupola una grande città.
Il medioevo digitale rappresenta una riflessione sull’arresto del tempo causato dalla rivoluzione tecnologica. La compresenza di più epoche, più linguaggi o più stili è vissuta in maniera angosciante, come se il blocco del tempo e la sovraccumulazione di informazioni inficiasse la possibilità dell’orientamento nell’oceano della rete.
Parlare di neo-feudalesimo, medioevo digitale o neo-medioevo non è la stessa cosa. Secondo Valerio Mattioli il medioevo digitale è un’estetica legata all’opera di artisti come Daniel Lopatin, Jon Rafman, James Ferraro e David Rudnick, più comunemente nota come post-internet art. Come per il postmoderno, anche il medioevo digitale è basato sul citazionismo, ma ci sono alcune caratteristiche che lo rendono completamente diverso. Il postmoderno è ironico, e le composizioni di elementi disparati servono più che altro a produrre un effetto di stupore e divertimento nello spettatore. Come nella mostra curata da Damien Hirst a Palazzo Grassi nel 2017 (Treasures from the Wreck of the Unbelievable): nel mezzo del finto allestimento di un museo archeologico, sono inserite icone della cultura pop, opportunamente invecchiate e ossidate. Il medioevo digitale invece, rappresenta una riflessione sull’arresto del tempo causato dalla rivoluzione tecnologica. La compresenza di più epoche, più linguaggi o più stili è vissuta in maniera angosciante, come se il blocco del tempo e la sovraccumulazione di informazioni inficiasse la possibilità dell’orientamento nell’oceano della rete. Il medioevo digitale si lega anche alla proliferazione di teorie del complotto sempre più ramificate, molte volte connesse con la creazione di gruppi di estrema destra. C’è chi, come Hito Steyerl, parla di apofenia e paranoia digitale, ovvero della crescente tendenza a interpretare gli eventi politici e sociali in modo allucinato, immaginando burattinai inesistenti e cercando nessi significativi fra immagini, notizie e teorie disparate. Così come l’ermeneutica medievale e rinascimentale non leggeva in un simbolo il suo semplice riferimento referenziale, ma una costellazione infinta di rimandi, allo stesso modo oggi qualsiasi dato, qualsiasi ricerca, qualsiasi informazione mal compresa può essere incasellata in una teoria del complotto priva di fondamento.
Il pensiero neoreazionario di Curtis Yarvin, nel suo blog Unqualified Reservation e il Dark Enlightenment di Nick Land propongono un paradigma politico policentrico, fondato sulla distruzione delle democrazie parlamentari e la loro sostituzione con una rete di piccoli regni o città Stato, caratterizzate da un sistema di governo arbitrario e nelle quali il problema dell’immigrazione è risolto con il bando o il cambiamento di patch. Questo sistema potrebbe in effetti ricordare l’ordinamento politico e giuridico dell’Europa fra VII e XII secolo, se non fosse che il principio di attaccamento al luogo è l’elemento principale della spazialità medievale. Nel sistema a patchwork immaginato dai neoreazionari, invece, ogni piccolo regno diventa una locazione temporanea, che viene abitata finché si vuole o si ha la disponibilità economica per farlo. Non si tratta di un’idea innovativa: nel 2013 Wendy Brown scrive Stati murati, sovranità in declino, dove parla del proliferare delle enclaves e dei muri di divisione fra zone politiche conflittuali. Una delle divisioni più importante è quella che, all’interno delle metropoli, dona una forma materiale alle linee della classe e del colore. Brown parla di funzione performativa di queste nuove divisioni, per sottolineare che spesso queste nuove mura non hanno un’effettiva efficacia geografica: non sono delle barriere architettoniche che impediscono il passaggio, ma sono delle barriere simboliche che comunicano la paura dell’invasione. Per questo il sistema a patchwork è più che altro una distopia ordita dall’immaginario razzista ed elitario dell’ideologia californiana.
A ben vedere, il patchwork e lo spazio simbolico premoderno sono anche il contenuto della maggior parte delle nostre simulazioni videoludiche. Non semplicemente perché esiste un sottogenere di giochi di ruolo ambientati in una ricostruzione kitsch del medioevo britannico, ma perché di fatto lo spazio videoludico rappresenta il riciclaggio mediale di un modello epistemico sorpassato. Così come l’arte della pittura rappresentativa prende degli elementi dalle forme culturali precedenti, ovvero il mito e la mimica corporale, creando un’imitazione iperrealistica, allo stesso tempo l’arte videoludica prende l’interno complesso della cultura premoderna e lo rende spazio di gioco. Più in dettaglio: l’universo videoludico ha sempre dei limiti, è composto da oggetti discreti, ogni evento è significativo: nulla di insensato avviene in uno spazio ludico. Cosa succede quando questo spazio ludico inizia a confondersi con il junkspace reale? Per l’appunto di tratta dell’emergenza di un’estetica neomedievale. Si prenda il caso di Mark Foster Gage, architetto legato all’accelerazionismo e all’object oriented ontology. In un progetto per il Guggenheim di Helsinki immagina un edificio costruito con la tecnica del kitbashing, ovvero attraverso l’assemblamento di parti scomposte di modellini per creare dei nuovi artefatti dal look futuristico. Questi artefatti chimerici, creati da un algoritmo che processa modelli 3D presi da archivi e li mescola, sono depositati sulla superficie di tutto l’edificio, e creano una decorazione ipercomplessa, stratificata. Le opere di Gage assomigliano a cattedrali gotiche, ma in questo caso l’iconografia prende spunto da qualsiasi cosa.
Anche nell’escogitazione delle imagines agentes delle mnemotecniche si usa un procedimento simile, ovvero si mettono assieme parti di animali, oggetti e luoghi disparate in un unico simbolo, per imporgli una salienza visiva. È una sorta di accelerazione e automatizzazione del citazionismo postmoderno, escogitata per eliminare la possibilità che un edificio venga interpretato secondo un’unica isotopia tematica. Questo simbolismo eccessivo e privo di controllo servirebbe, secondo Gage, a provocare un sentimento di orrore e stupore, come dinanzi a una catastrofe naturale.
Questo testo è la trascrizione di un intervento svoltosi nel corso del festival House of Displacement organizzato da CampoBase a Torino dal 3 al 6 ottobre e promosso dalla Fondazione Sandretto Re Rebaudengo con il sostegno della Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea CRT.