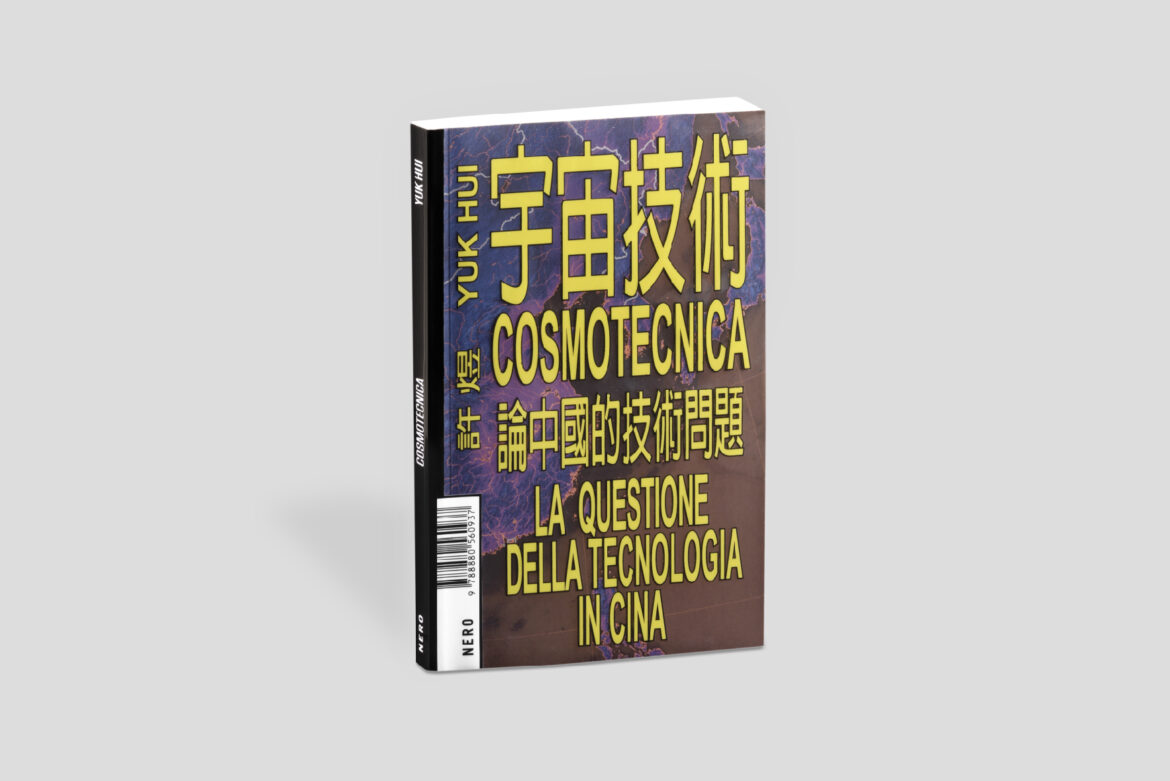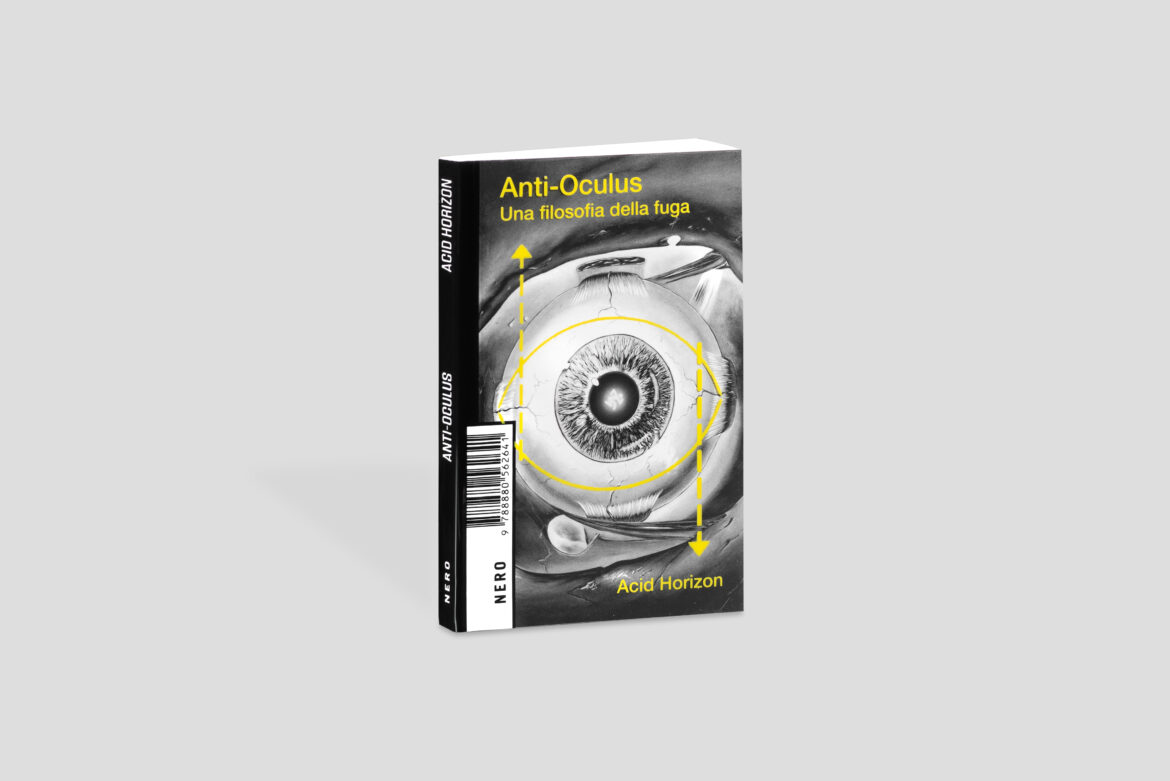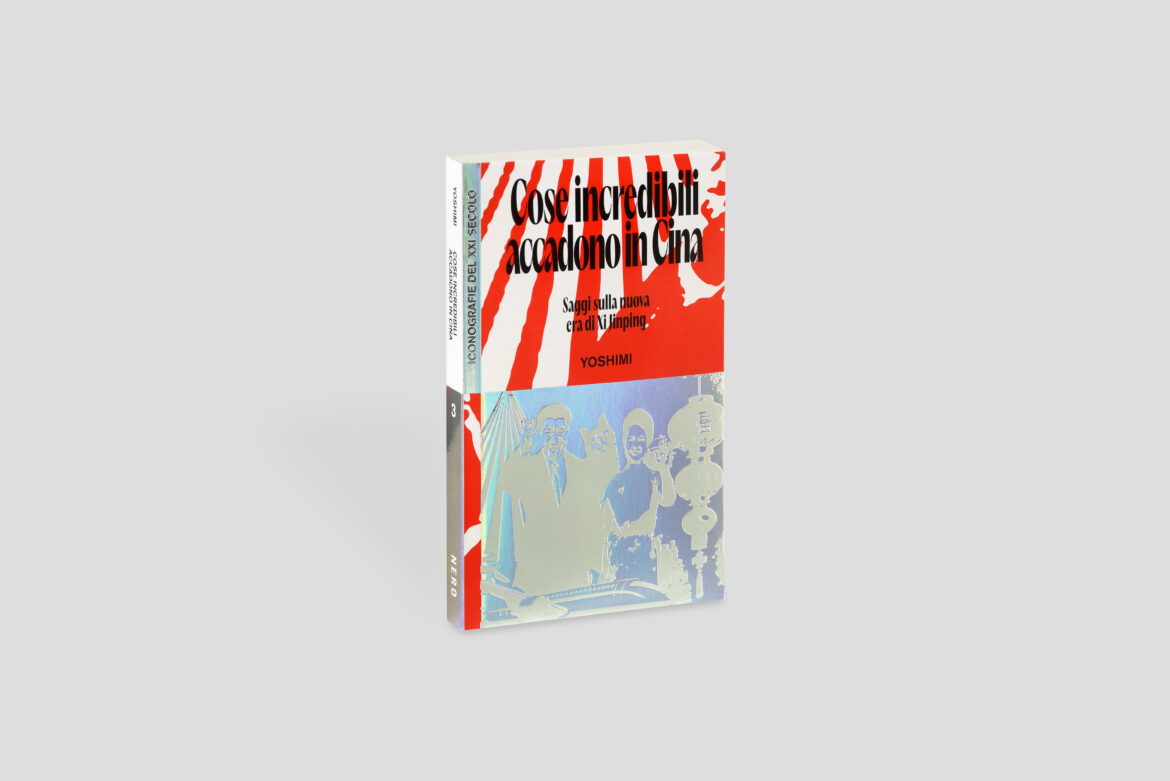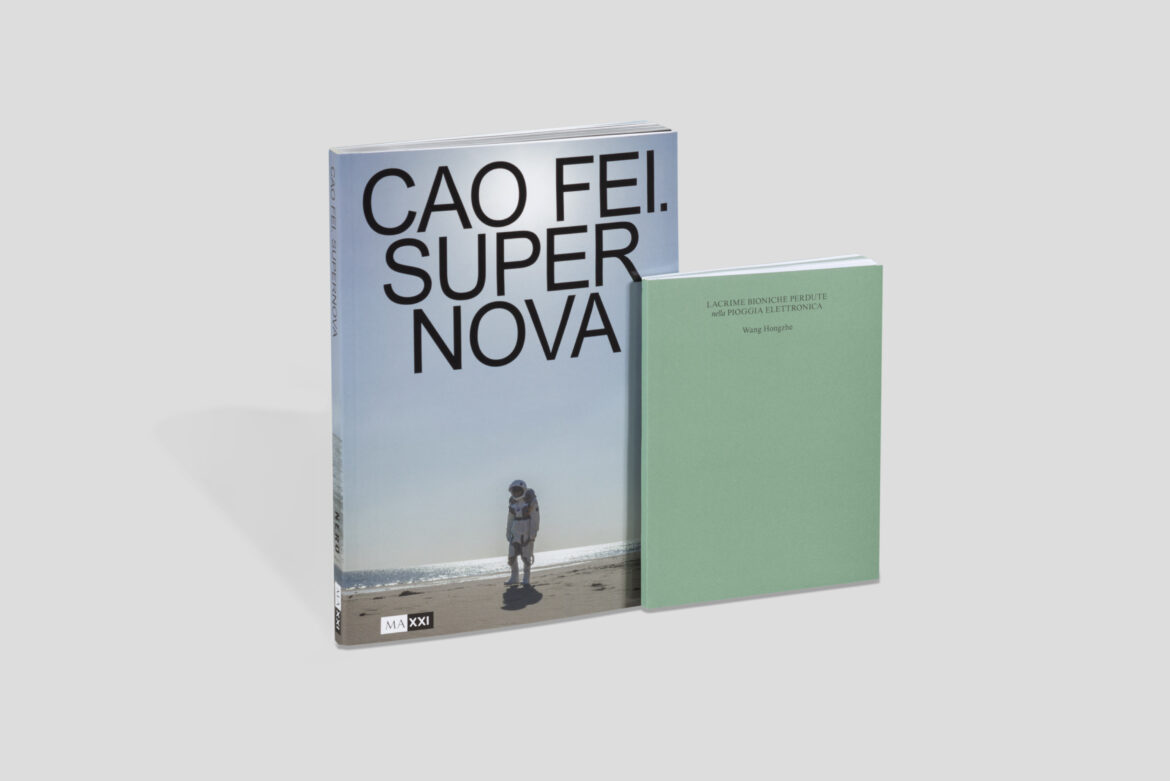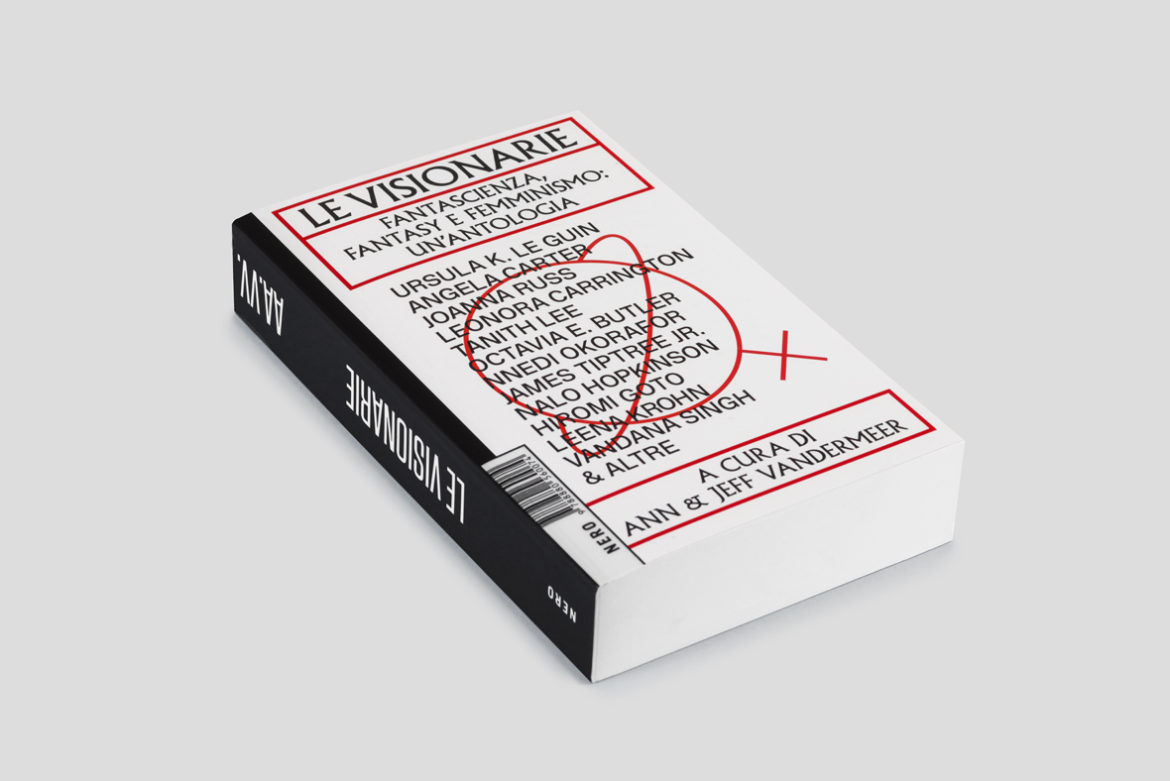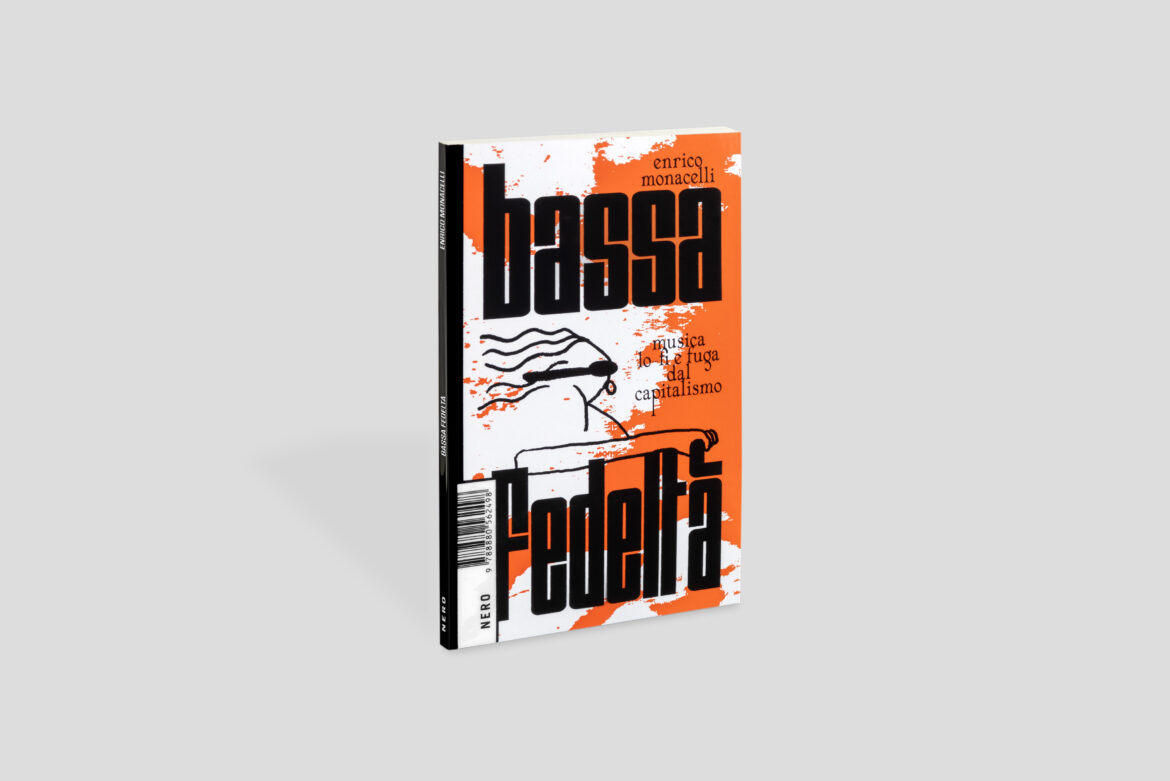La città è indiscutibilmente […] una macchina del tempo
Nick Land, Templexity: Disordered Loops Through Shanghai Time
Vivere tra Roma e Shanghai è come essere viaggiatori nel tempo. Ma la traiettoria di questo viaggio non è quella, prevedibile, che ci eravamo preparati a raccontare, dalle meravigliose rovine di un Occidente in decadenza a un futuro scintillante dove la modernità non è mai tramontata. Camminando per le strade della città, una stratificazione di tempi e spazi si rivela dietro a ogni angolo, dove grovigli di cavi elettrici e spettri di infrastrutture invisibili si inseguono tra i mattoni degli shikumen e la luce fredda dei grattacieli. Se Shanghai ci ha insegnato qualcosa è che il tempo non si muove soltanto in avanti. Si disperde e si contorce in mille rivoli, come il corso di un fiume che si prepara a un’alluvione.

Noi occidentali abbiamo la pretesa di sapere come il mondo andrà a finire: guardiamo oltre i nostri confini come dalla prospettiva paternalistica di chi ha già visto la fine della storia. Ma quello che sconvolge, quando ci si avvicina alla Cina per la prima volta, è un senso di alterità profonda, molto difficile da mediare attraverso le categorie che siamo abituati a utilizzare per capire la realtà. Questa distanza diventa particolarmente evidente davanti alla questione della tecnologia, che è ormai indissolubilmente legata all’affermazione della potenza cinese sul panorama globale. La Cina e la tecnologia sono così profondamente intrecciate che, come osserva la filosofa e co-fondatrice della CCRU Anna Greenspan, il rifiuto della tecnologia e la paura della Cina appaiono talvolta quasi indistinguibili.
Come ha osservato il filosofo Yuk Hui, mentre in Occidente la tecnologia è frequentemente concettualizzata come una rottura razionalista rispetto alla tradizione e al mito, la stessa discontinuità non è percepita in Cina, dove lo spazio mitologico e quello tecnologico non sono mai stati immaginati in conflitto. Questa distanza culturale nel rapporto cinese con la tecnologia non si limita all’antichità, ma emerge anche nelle tecnologie contemporanee più avanzate. Simone Pieranni racconta come lo sviluppo dell’intelligenza artificiale in Cina, dalla nascita del chatbot DeepSeek alla cultura open source, sia pensato non come una rottura con la tradizione, ma in continuità con una genealogia di pensiero filosofico e morale che affonda le sue radici nel Confucianesimo. In modo simile, Anna Greenspan traccia una storia delle tecnologie digitali in Cina in continuità con la tradizione filosofica taoista, dove le onde elettromagnetiche del 5G riecheggiano il ricordo di una cosmologia vibrazionale molto più antica.
Se è vero che il rapporto della Cina con la tecnologia non può essere semplicemente ridotto, come spesso accade, a un autoritarismo tecnocratico, è indubbio che le infrastrutture tecnologiche cinesi siano anche dispositivi di controllo sociale e politico. L’esperienza di chi si muove all’interno del cyberspazio cinese, in particolare, è segnata da una continua negoziazione tra libertà espressiva e sorveglianza, un’ambivalenza difficile da comprendere per chi è nato dall’altra parte del Grande Firewall. JY, esperta di culture digitali e studiosa di nuovi media, racconta la sua esperienza di millennial cresciuta sulle piattaforme social cinesi, come Xiaohongshu, Douyin e Weibo, dove la censura diventa, per una generazione schiacciata tra chiusure autoritarie e capitalismo accelerato, una spinta a inventare sempre nuovi linguaggi in codice e forme indecifrabili di disobbedienza digitale.
Anche nel lavoro di Cao Fei, una delle artiste cinesi contemporanee più influenti nel mondo intervistata per Notzine dal curatore e critico Hou Hanru, emerge una visione ambivalente rispetto alle conseguenze culturali e sociali del progresso tecnologico. Nelle sue opere, Cao Fei ha illuminato la tecnologia come una forza storica e politica profondamente ambigua, allo stesso tempo veicolo di trasformazione e radice di sempre nuove forme di alienazione. “La storia della scienza e della tecnologia non può essere ridotta a una narrazione unica e lineare di ‘progresso’. È invece attraversata da contraddizioni, tensioni, ambivalenze”, scrive l’artista. “La tecnologia può essere tanto un acceleratore della storia quanto uno specchio che la riflette, proprio come la storia, a sua volta, condiziona e orienta l’evoluzione tecnologica”. Ma a intrecciarsi e a plasmarsi reciprocamente con la tecnologia c’è anche la storia dei corpi. Nell’articolo di Ilaria Benini, ad esempio, la fantascienza sinofona diventa uno spazio critico per ripensare la relazione tra genere, intimità e artefatto tecnico. Attraverso le opere di autrici come Regina Kanyu Wang, Tang Fei o Hao Jingfang, la tecnologia non è solo infrastruttura o strumento, ma una forza che attraversa l’identità, la memoria, il desiderio. Come nelle opere di Cao Fei, anche qui il futuro è un terreno ambivalente, dove l’utopia si mescola all’alienazione e la soggettività si rifrange in nuovi ibridi post-umani. La fantascienza, in queste scritture, diventa un modo per immaginare non solo altri mondi, ma altre possibilità di essere al mondo.
Abitare in Cina significa scendere a patti con una simbiosi totale dello spazio fisico con lo spazio digitale, dai pagamenti cashless alle app di traduzione istantanea fino ai codici QR per ordinare nei ristoranti. La disinvoltura con cui persone di generazioni enormemente distanti (non soltanto in termini di età, ma in termini di storia vissuta) si integrano in questo nuovo umwelt tecnologico è una delle cose più sorprendenti di vivere in una città come Shanghai. La nostra prima esperienza appena approdati in Cina è stata quella che Yoshimi, blogger e autore del libro Cose incredibili che accadono in Cina recentemente uscito nella collana Iconografie di NERO, definisce uno “shock da futuro”: uno stupore comprensibile soltanto enfatizzando la differenza irriducibile tra il capitalismo occidentale e il progressismo “con caratteristiche cinesi”. Se si sente spesso ripetere che la Cina è semplicemente capitalista (il più delle volte da persone che non ci hanno mai vissuto), Yoshimi spiega che il rapporto della Repubblica Popolare Cinese con il progresso tecnologico può essere decifrato solo in continuità con l’eredità stratificata del marxismo-leninismo. Al contrario, partendo da una wave memetica recente, Mattia Salvia mette in discussione l’ideologia del “socialismo con caratteristiche cinesi”, rivelandone la natura ambigua nel suo rapporto con il capitalismo.
Dalla prospettiva di un Occidente un tempo egemone ma che sembra aver perso la propria bussola, c’è la tendenza innegabile a trasformare il “modello cinese” in uno specchio delle nostre paure più distopiche o delle nostre più romantiche speranze. Nel curare questo numero, abbiamo invece scelto di dare spazio all’esplorazione della differenza, cercando di capire in che modo la Cina, nella sua enormità culturale, temporale e geografica, eccede e stravolge i nostri modelli, soprattutto rispetto all’idea di “progresso tecnologico”. Dalla prospettiva occidentale, la tecnologia in Cina è allo stesso tempo familiare e distante. A partire da quello che, almeno nel mondo contemporaneo, si è configurato come il fondamento dell’evoluzione tecnologica: il linguaggio scritto. La scrittura cinese si è sviluppata in modo del tutto parallelo e indipendente da quella Occidentale, non soltanto in una forma profondamente differente, ma anche per un uso molto diverso. Mentre in Mesopotamia le prime tavolette d’argilla riportano registri commerciali e inventari di merci, in Cina le prime forme di scrittura documentate sono resti di pratiche di divinazione: oracoli incisi su scapole di bue e carapaci di tartaruga. Questa discrepanza archeologica ha molto da dirci sul rapporto della Cina con il tempo e la storia. I più antichi testi scritti cinesi che conosciamo parlano già del futuro.
Le nostre idee sul futuro sono oggi intimamente legate a un senso di inquietudine nei confronti dell’intreccio profondo tra l’ascesa della Cina e l’onnipresenza dei media wireless. Uso il termine “wireless” come sintesi di un insieme di tecnologie emergenti che definiscono il nostro tempo: computazione planetaria, media digitali, intelligenza artificiale e così via. Per comprendere l’ambiente contemporaneo dei media, specialmente nel suo legame profondo con la Cina, dobbiamo prima imparare a pensare in termini di onde.
È questo il nucleo del mio recente libro, China and the Wireless Undertow: Media as Wave Philosophy. Durante i sei o sette anni necessari per la ricerca e la scrittura di questo testo, il legame tra la Cina e le tecnologie del XXI secolo è diventato sempre più evidente, ma anche più controverso. In questo periodo ho anche lavorato come direttrice del Center for AI and Culture, con colleghi della NYU Shanghai e di altre istituzioni. Il nostro punto di partenza è semplice e chiaro non è possibile cogliere appieno le correnti dell’intelligenza artificiale globale se si resta ancorati a una sola prospettiva geografica. Comprendere l’ecosistema odierno dei media implica un confronto con il pensiero e la cultura cinesi.
Oggi, il rapporto tra la Cina e i media emergenti è spesso definito in termini di “tecnoautoritarismo”: una convergenza tra cultura tecnologica e politica, segnata da un controllo centralizzato portato all’estremo. Questo allineamento, che intreccia il timore per l’ascesa della Cina con la crescente percezione dell’efficacia del potere tecno-autocratico, ha reso i termini sinofobia e tecnofobia quasi indistinguibili. La lunga storia del rapporto della Cina con la modernità tecno-capitalista è complessa e tormentata. La dinamica di questo rapporto sembra seguire un’oscillazione continua, in cui a un tecno-autoritarismo distopico si contrappone una forza opposta, spesso descritta come una spinta verso una liberazione tecnologica dalle tinte utopiche. Forze di chiusura, restrizione e centralizzazione si confrontano continuamente con spinte verso l’apertura, l’espansione e la decentralizzazione.
Un modo per pensare a questa convergenza tra la Cina e l’infrastruttura macchinica che la sostiene è considerare entrambi come eventi all’interno di una struttura temporale più profonda, o di uno schema, che regola i ritmi ondulatori del tempo tecno-capitalista
Lo si può osservare perfino nei momenti di controllo centralizzato più estremo: durante il lockdown per la pandemia, ad esempio, si è acceso un vivace dissenso online, che ha fatto da preludio alle “proteste dei fogli bianchi” contro le misure anti-COVID. Proteste che hanno portato alla fine della politica zero-COVID e al lockdown di Shanghai. Sistemi di tracciamento dati che sembravano destinati a durare sono stati smantellati da un giorno all’altro. Concentrarsi su un solo lato di questa polarità — autoritarismo o utopia — restituisce una visione parziale, e quindi insufficiente. La tesi del mio libro è che il problema sta nel fatto che queste letture non riescono a cogliere l’onda nella sua totalità.
Per ripensare il legame tra Cina e wireless, propongo di adottare la figura dell’onda. Concentrandomi su onde di varie scale – dai lenti ritmi della storia tecno-culturale alle altissime frequenze delle macchine elettromagnetiche – sviluppo questo concetto attingendo al pensiero di importanti filosofi cinesi attivi tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, un periodo intellettualmente ricchissimo in cui si discuteva intensamente il rapporto tra cultura cinese e modernità tecnologica. L’obiettivo è offrire nuove e più complesse chiavi di lettura per comprendere la Cina contemporanea e il suo impatto nella configurazione delle tecnologie del XXI secolo.
Per iniziare ad articolare questa prospettiva, parto da un evento spartiacque avvenuto il 1° dicembre 2018: Meng Wanzhou 孟晚舟, direttrice finanziaria e vicepresidente di Huawei—una delle più grandi e influenti aziende di telecomunicazioni al mondo—viene arrestata all’aeroporto di Vancouver, in Canada, su richiesta degli Stati Uniti, che ne chiedono l’estradizione. Meng, figlia del fondatore di Huawei Ren Zhengfei 任正非 e considerata erede designata di quella che è una delle più potenti imprese informatiche cinesi, viene accusata di frode bancaria per aver utilizzato una shell company (società di comodo) coinvolta nella violazione dell’embargo statunitense contro l’Iran.

Sul fondo di questa vicenda si staglia il ruolo sempre più centrale della Cina nell’infrastruttura globale dei media wireless di quinta generazione. Il tecno-capitalismo si propaga per onde, come lascia intendere lo stesso termine 5G. La prima generazione della telefonia mobile – limitata a chiamate vocali – viene lanciata a Tokyo nel 1979. Da allora, ogni decennio ha visto l’introduzione di una nuova generazione di reti cellulari, ciascuna capace di sfruttare frequenze più alte dello spettro elettromagnetico e di aprire nuovi canali di comunicazione. Il 2G ha reso possibile l’invio di messaggi di testo oltre alle chiamate vocali. Il 3G, introdotto a cavallo del nuovo millennio, ha rappresentato un’innovazione ancora più radicale. Consentendo la trasmissione di dati mobili, le reti 3G hanno alimentato la diffusione globale degli smartphone, trasformando rapidamente anche gli aspetti più intimi della vita quotidiana. Il 4G, in uso per tutto il decennio 2010, ha modificato l’esperienza dell’utente rendendo possibile lo streaming di contenuti. Il dispiegamento del 5G, in corso lungo gli anni 2020, è legato all’Internet delle Cose, alla robotica in rete e all’intelligenza artificiale.
Huawei ha avuto un ruolo enorme nella creazione dell’infrastruttura del 5G: è stata la prima volta che un’azienda non nordamericana né europea ha partecipato a questo livello alla costruzione di infrastrutture per le telecomunicazioni. Al momento dell’arresto di Meng, Huawei era l’unica azienda al mondo in grado di produrre, a costi accessibili, tutti gli elementi di una rete 5G. L’incriminazione di Meng – seguita da boicottaggi contro Huawei – ha rappresentato a livello globale una sorta di punto di svolta: il segno improvviso di una presa di coscienza, ovvero che l’ascesa della Cina e l’avanzamento dei media wireless erano ormai indissolubilmente legati.
Un modo per pensare a questa convergenza tra la Cina e l’infrastruttura macchinica che la sostiene è considerare entrambi come eventi all’interno di una struttura temporale più profonda, o di uno schema, che regola i ritmi ondulatori del tempo tecno-capitalista.
Onde K
Le onde K, o onde di Kondratiev, prendono il nome da un saggio del 1935 intitolato Le lunghe onde nella vita economica dell’economista russo Nikolai Kondratiev (1892–1938), il quale ipotizzava l’esistenza di cicli lunghi di 50 anni che generano una sorta di ritmo ondulatorio nel funzionamento del capitalismo. Questa idea fu ripresa in modo celebre dall’economista Joseph Schumpeter, che sviluppò quella che definiva “economia evolutiva”. Ed è questo il punto essenziale: il capitalismo non viene concepito come una struttura statica, ma come un processo. “I cicli sono come il battito del cuore”, scriveva, “sono l’essenza dell’organismo che li manifesta”.
Come tutti gli organismi, anche l’evoluzione del capitalismo procede attraverso mutazioni che “rompono” regolarmente l’equilibrio del sistema. Sono queste rotture a produrre un andamento ondulatorio. In sostanza, le onde descrivono i cambiamenti nelle innovazioni tecnologiche — le mutazioni — e i modi in cui queste si diffondono e trasformano la società. La teoria delle onde fornisce due osservazioni fondamentali. Primo: le innovazioni tecnologiche non si distribuiscono in modo uniforme, ma tendono a concentrarsi nella parte bassa dell’onda. Secondo: queste onde si propagano sulla Terra in modo tale da avere una componente non solo temporale, ma anche spaziale.

La prima onda di Kondratiev, che ebbe il suo centro in Gran Bretagna, si basava sulle fondamentali tecnologie del carbone, del ferro e del vapore. Durante la sua fase discendente, che durò fino alla metà degli anni 1840, furono poste le basi di una nuova infrastruttura planetaria: ferrovie in acciaio, navi a vapore e il telegrafo. Queste piattaforme alimentarono la seconda onda, generalmente datata dalla fine degli anni 1840 alla fine degli anni 1890. In questo periodo, il cuore dell’innovazione tecnologica cominciò a spostarsi dalla Gran Bretagna alla Germania e agli Stati Uniti. Tecnologie rivoluzionarie emersero negli ultimi decenni del ciclo discendente: nel 1876, Alexander Graham Bell ottenne il brevetto per il telefono; nel 1879, Thomas Edison illuminò il suo laboratorio a Menlo Park con la lampadina a incandescenza; nel 1886, Karl Benz ricevette il brevetto per l’automobile moderna; nel 1896, nel punto più basso dell’onda, Marconi ottenne il brevetto per la radio – il primo mai rilasciato per un’onda hertziana.
La diffusione di queste tecnologie rivoluzionarie (e delle mutazioni socio-economiche e macchiniche che ne seguirono) alimentò la terza onda: l’era dell’elettricità. Quest’onda viene solitamente datata dalla metà degli anni 1890 fino a poco dopo la Seconda guerra mondiale, con un picco appena prima del crollo del 1929. Il declino della terza onda di Kondratiev portò con sé l’industrializzazione di massa dell’elettronica e gli inizi dell’informatica digitale. Il transistor, inventato nei laboratori Bell nel 1947, fu una delle chiavi tecnologiche che aprirono la quarta onda. Le crisi petrolifere e la fine del sistema aureo nei primi anni Settanta innescarono la fase discendente che chiuse il lungo boom della quarta onda di Kondratiev. In questa fase discendente, negli ultimi decenni del XX secolo, telefono e computer iniziarono a convergere. Fu anche il periodo della deindustrializzazione degli Stati Uniti, con il trasferimento della produzione elettronica verso l’Asia.
Sotto gli intrecci di hardware e politica — aste per le frequenze, installazioni di satelliti e antenne, boicottaggi contro Huawei — si cela una forza terrestre e cosmica che è al tempo stesso altamente tecnologica e pienamente naturale
A partire da questo punto, la cronologia dei cicli diventa più speculativa. È plausibile collocare la fine della quarta onda attorno alla fine del millennio, con lo scoppio della bolla dot-com. Secondo questa lettura, siamo ora entrati nella quinta onda di Kondratiev: l’onda wireless, con cui la Cina è profondamente intrecciata. I primi anni 2020 – quando ha avuto inizio il dispiegamento delle infrastrutture 5G – segnano il culmine di quest’onda. Se lo schema regge, la nuova piattaforma tecnologica — basata su un campo di vibrazioni elettromagnetiche ad alta frequenza — darà luogo a mutazioni evolutive che solitamente accompagnano una fase discendente, che si prevede durerà fino alla metà del XXI secolo. La domanda diventa allora: come conciliare questi cicli storici lunghi e lenti con quella che appare come un’intensificazione, o per meglio dire un’accelerazione del cambiamento, soprattutto attorno all’intelligenza artificiale?
Onde elettromagnetiche
Passiamo ora a un altro tipo di onda: l’onda elettromagnetica. C’è una convergenza tra la quinta onda di Kondratiev e il dispiegamento del 5G. Questa concordanza riguarda l’incontro tra due tipi di onde, che si manifestano su scale radicalmente diverse. Le onde K modellano il tempo storico: i loro cicli lenti e lunghi richiedono più di metà di una vita per compiersi. Le vibrazioni elettromagnetiche ad alta frequenza generate dal 5G, invece, costituiscono un campo immersivo di energia vibrante, che opera in frammenti di tempo troppo brevi per essere percepiti. All’interno di questo quinto ciclo lungo del tempo tecno-capitalista, con l’implementazione delle reti cellulari di quinta generazione, questi due tipi di onde — che occupano frequenze radicalmente diverse — convergono. È in questa sovrapposizione della quinta onda che l’ascesa geopolitica della Cina si intreccia sempre più profondamente con l’infrastruttura del nostro mondo wireless.
Nei critical infracture studies, in particolare nella teoria dei media, si è spesso sostenuto la necessità di rendere visibile la “materia” invisibile delle infrastrutture dei media: cavi sottomarini, fili sospesi, antenne camuffate da alberi, data center. Ma le onde elettromagnetiche, in quanto infrastruttura ambientale dei media wireless, rendono questo compito più difficile. Per loro stessa natura, queste frequenze non sono accessibili agli organi sensoriali umani. In risposta, una serie di artisti e di app hanno elaborato strumenti per visualizzare queste onde invisibili. App come The Architecture of Radio permettono di visualizzare e sonorizzare i segnali Wi-Fi captati dal proprio telefono. L’artista Christina Kubisch conduce passeggiate sonore con cuffie appositamente progettate per amplificare la percezione acustica delle onde elettromagnetiche latenti nell’ambiente urbano. Il collettivo Semiconductor ha realizzato video che svolgono un lavoro simile.
Tali progetti non solo rendono visibili le reti di telecomunicazione nascoste della città moderna, ma decifrano – attraverso l’esperienza sensoriale – le forze elementari e cosmiche celate nel quotidiano. L’infrastruttura wireless – il nostro ambiente mediale immersivo – è costituita da onde elettromagnetiche impercettibili. Sotto gli intrecci di hardware e politica — aste per le frequenze, installazioni di satelliti e antenne, boicottaggi contro Huawei — si cela una forza terrestre e cosmica che è al tempo stesso altamente tecnologica e pienamente naturale.
Le vibrazioni elettriche sono increspature generate dal nucleo ferroso della Terra. A circa 3.000 chilometri sotto la superficie si trova un mare metallico semifluido. Il nucleo interno solido del pianeta è avvolto da uno strato di metallo liquido spesso 2.000 chilometri, le cui correnti e vortici immergono la Terra in vasti campi energetici. Per gran parte della storia umana, questo regno vibrante, immersivo e impercettibile è rimasto poco compreso. Il percorso della modernità è stato in larga misura un processo di scoperta e di apprendimento nell’uso di questo campo energetico invisibile.
Alla fine del XIX secolo, quando Heinrich Hertz dimostrò per la prima volta l’esistenza delle frequenze elettromagnetiche, non riusciva a vederne alcuna applicazione pratica. “Non serve assolutamente a nulla”, pare abbia detto. “È solo un esperimento che dimostra che il Maestro Maxwell aveva ragione. Abbiamo semplicemente queste misteriose onde elettromagnetiche che non possiamo vedere a occhio nudo. Ma esistono”. Oggi, quelle stesse vibrazioni invisibili costituiscono il canale di comunicazione occupato da un numero sempre crescente di dispositivi intelligenti, integrati in quasi ogni ambito della vita. Nel corso del XX secolo, la nostra atmosfera elettromagnetica si è intensificata, alimentando un regno macchinico sempre più onnipresente, autonomo e senziente.
Non c’è luogo dove questo sia più evidente che nella Cina urbana, dove una rete iper-densa di dispositivi mobili ha trasformato l’esistenza quotidiana. I telefoni cellulari vengono utilizzati per accedere alle più grandi piattaforme di e-commerce del mondo. I QR code sono onnipresenti: costituiscono la semiotica di un’enorme sharing economy che comprende biciclette, ombrelli e caricatori per telefoni. WeChat, la popolarissima app di messaggistica presente su ogni cellulare, viene usata per comunicare con amici, colleghi e business partners. Le piattaforme di pagamento digitale, sviluppate dai colossi tecnologici Alibaba e Tencent, sono diventate così dominanti che persino i venditori di frutta e i mendicanti per strada non accettano più contanti. Durante la pandemia da coronavirus, le grandi piattaforme digitali hanno collaborato con i servizi governativi per creare un “layer sensoriale” fatto di QR codes e segnali provenienti dai telefoni cellulari, utilizzato come strumento epidemiologico per tracciare e controllare la diffusione del virus.
Filosofia delle onde
Questi due tipi di onde – i pattern ondulatori della storia tecno-capitalista e l’infrastruttura astratta delle vibrazioni elettromagnetiche – sono espressioni materiali di ciò che chiamo una filosofia delle onde. Sviluppo questa idea attingendo ad alcune figure del pensiero cinese moderno. Nel mio libro mi concentro in particolare sul pensiero cinese emerso tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo, tra la caduta dell’impero Qing e l’alba dello stato moderno. Fu un periodo intellettuale straordinariamente fertile, attraversato da una molteplicità di idee ricche e articolate sul paese, sulla sua cultura e sul loro rapporto con la modernità tecnologica. I pensatori di quell’epoca si confrontavano con la sfida di integrare i saperi e le pratiche consolidati nei secoli con un mondo globale emergente, sempre più plasmato dalle macchine elettriche.
Mi interessano le diverse traiettorie convergenti che hanno plasmato questa storia intellettuale, comprese le prime ondate della filosofia neoconfuciana, il revival del buddismo Yogācāra e un confronto serio e duraturo con le idee e le tecnologie della modernità. Il mio intento è sviluppare ciò che definisco una filosofia delle onde, o più precisamente una cosmo-ontologia delle onde.
Per illustrare in modo più approfondito questa idea di filosofia delle onde, mi concentrerò sulla figura di Tan Sitong 譚嗣同 (1865–1898), un rivoluzionario noto soprattutto per il suo ruolo nella Riforma dei Cento Giorni del 1898, che gli costò l’esecuzione. Ma oltre alla sua eredità politica, Tan elaborò un insieme di idee religioso-filosofiche straordinariamente risonanti con un’atmosfera elettromagnetica che all’epoca stava pervadendo ogni cosa. La sua opera principale, Ren Xue (Esposizione della Benevolenza), fu elaborata in forma manoscritta e affidata a Liang Qichao, che la pubblicò postuma. Il libro offre un’affascinante combinazione di neoconfucianesimo intriso di buddismo e intrecciato con concetti tratti dalla scienza nascente della comunicazione elettromagnetica.
Tan era particolarmente affascinato dall’etere (yitai), che all’epoca si riteneva essere il mezzo attraverso cui si propagassero le onde elettromagnetiche, dato che si credeva che tutte le onde dovessero attraversare una sostanza. Sebbene oggi si sappia che la radiazione elettromagnetica non richiede alcun mezzo, nel periodo di Tan l’etere veniva immaginato come un campo vibrazionale sottile e onnipresente. Tan teorizzava l’etere come un substrato immersivo ma invisibile di interconnessione – un piano vibrazionale in cui la filosofia cinese e la scienza moderna potevano incontrarsi. In un passaggio straordinario, scrive:
“Il regno dei fenomeni, il regno del vuoto e il regno degli esseri senzienti sono permeati da una cosa supremamente vasta e supremamente sottile, che aderisce, penetra, connette e riempie ogni cosa. L’occhio non può vederne il colore, l’orecchio non può udirne il suono, la bocca e il naso non ne possono percepire l’odore o il sapore. Non esiste un nome [adeguato] per essa, ma possiamo chiamarla yitai. Le sue manifestazioni funzionali sono onde, energia, elementi [chimici] e nervi. Il regno dei fenomeni proviene da essa, il regno del vuoto si fonda su di essa, e il regno degli esseri senzienti ne deriva. Non ha forma, ma tutte le forme dipendono da essa; non ha mente-cuore, ma è avvertita da tutte le menti-cuori. In verità, possiamo semplicemente chiamarla ren.”
La visione di Tan risuona con ciò che è stato definito vibratory modernism o materialismo occulto: correnti di pensiero che circolavano tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo in Europa e Nord America. Queste formazioni intellettuali scaturirono dalla scoperta del dominio dell’energia elettromagnetica e si diffusero nei circoli artistici e filosofici d’avanguardia. “Al cuore di queste correnti c’era l’intento di coltivare connessioni incarnate con mondi invisibili – desiderio che gli scritti di Tan Sitong esemplificano con sorprendente chiarezza filosofica.
Le idee di Tan prefigurano anche un momento della Cina degli anni Ottanta, in cui il qigong, le pratiche somatiche e le scienze del corpo si fusero con la cibernetica delle origini. Queste forme ibride di pensiero tecnoscientifico furono articolate in modo emblematico dallo scienziato missilistico Qian Xuesen, e vengono analizzate più a fondo in Machine Decision is Not Final, una raccolta di saggi su IA e Cina di prossima pubblicazione che ho curato insieme a Bogna Konior, riunendo storici, teorici dei media, scrittori di fantascienza, filosofi e artisti. L’epoca di Qian immaginava una scienza tecno-somatica fondata non sul razionalismo occidentale, ma su pratiche corporee modellate dalla cosmologia e dalla metafisica cinesi.
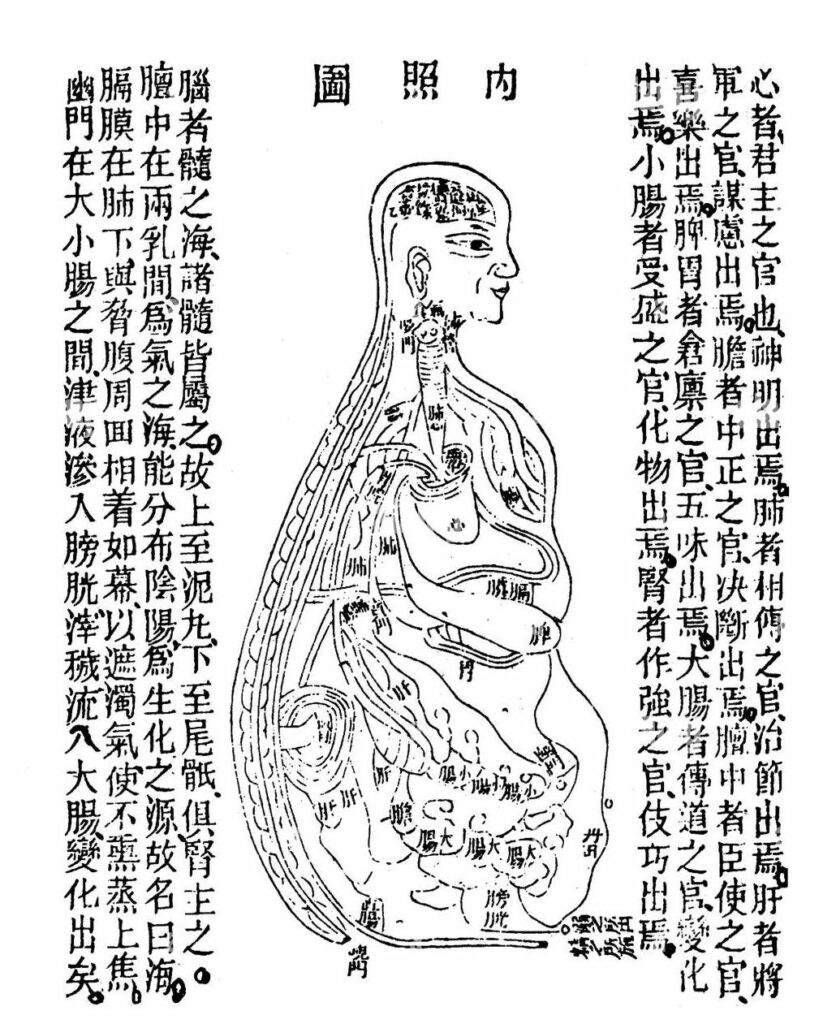
Oggi, l’etere è stato in gran parte sostituito dal concetto di spettro elettromagnetico. Invece di considerare le onde come parte di un mezzo misterioso e invisibile, lo spettro ordina tutte le radiazioni elettromagnetiche in una sequenza misurabile, dalla frequenza più bassa alla più alta, o dalla lunghezza d’onda più lunga alla più corta. Come osserva Zita Joyce, lo spettro “ha imposto un ordine al flusso continuo”. Questo ordinamento, tuttavia, non è soltanto concettuale; è legato anche a istituzioni: agenzie governative, apparati aziendali, trattati e convenzioni internazionali. Tutte istituzioni mobilitate per regolare e suddividere questa risorsa sempre più preziosa. Lo spettro delimita anche i confini percettivi del corpo umano, distinguendo tra ciò che può e ciò che non può essere percepito.
Il pensiero di Tan Sitong indica un’immaginario infrastrutturale alternativo. Invece di insistere su nette separazioni tra frequenze visibili e invisibili, questo immaginario intreccia fonti multiple per concettualizzare il corpo elettrico: gli esercizi rituali degli alchimisti taoisti e dei praticanti di qigong, la filosofia eterica dello stesso Tan, il materialismo occulto ottocentesco, le esplorazioni vibratorie degli artisti d’avanguardia e gli esperimenti tecno-somatici che continuano ancora oggi. Ciò che accomuna queste prospettive è l’enfasi condivisa su pratiche corporee che coltivano un’intimità incarnata tra il corpo umano e il campo elettromagnetico della Terra.
Questo articolo riprende una talk svoltasi al Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea dell’Università Ca’ Foscari di Venezia il 13 Maggio 2025 organizzata nel contesto di uno scambio Erasmus+
Prima è arrivata DeepSeek. Poi, una dopo l’altra, Mianbi AI, Manus e Qwen di Alibaba. Il rilascio di AI a ripetizione, fomentato da una rinnovata attenzione all’open source, ha portato a tutta una serie di analisi e riflessioni dell’ecosistema tech cinese a proposito delle differenze tra Cina e Stati Uniti, delle peculiarità del sistema cinese e delle sfide che attendono Pechino al riguardo. Dato che si tratta di Cina, non è mancato un forte impulso governativo, con il Partito comunista che ha tentato di cavalcare questa ondata, sfruttando lo shock creato da DeepSeek nella comunità americana dell’AI (che non a caso ha parlato di nuovo “Sputnik moment”) e provando a inserire tutto questo all’interno dei propri obiettivi.
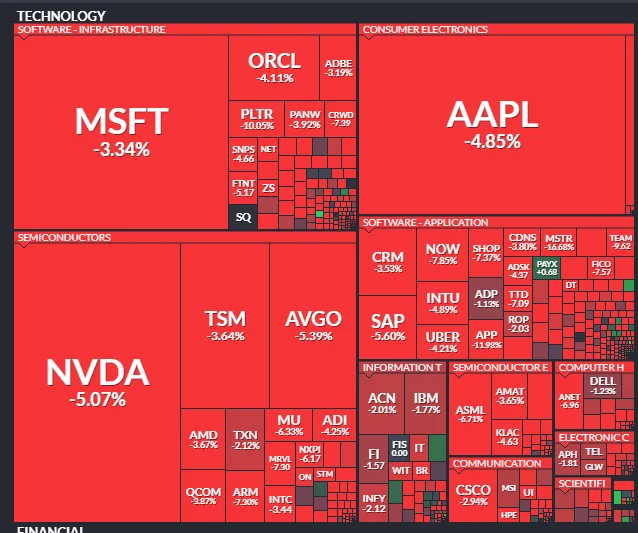
E questo hype si registra anche nella società, nella vita quotidiana: quando mi trovo in metropolitana o in autobus mi capita di dare un’occhiata ai miei vicini, quasi sempre impegnati a scrollare con lo smartphone. E non di rado stanno consultando l’AI (di solito DeepSeek, ma non manca Manus). Ma l’AI in Cina è ormai utilizzata ovunque in qualunque contesto, come dimostrano anche video diventati virali sui social nazionali, dove viene mostrato l’uso di DeepSeek per scegliere il melone migliore dal fruttivendolo. E alla vita reale, in Cina, si cerca sempre di dare una sistemazione, una coerenza, in modo che il flusso tra analisi, quotidianità e politica sia costante e sembri del tutto naturale.
Visti i tempi che corrono (quelli di una leadership che non vuole fare sfuggire niente al proprio controllo) il tema più rilevante da un punto di vista culturale, in materia di AI, è un mix ipnotico di idealismo e sistematizzazione di tutto quanto è nuovo all’interno del contesto culturale cinese. L’esperienza di DeepSeek nel campo dei modelli linguistici di grandi dimensioni, ad esempio, così come l’ha analizzata Yanjun Wu sul “Bulletin of Chinese Academy of Sciences”, non viene presentata solo come un esempio di successo tecnico, ma in quanto fenomeno in grado di esprimere le sfumature di una visione dell’innovazione che affonda le radici nella cultura e nella strategia nazionale cinese. In particolare si dà risalto a un elemento dirompente di DeepSeek, ovvero il rilascio delle sue “creature” attraverso licenze open source o “open weights”, eventualità che è stata considerata una specie di schiaffo ai rivali statunitensi. OpenAi non è “aperta” davvero. DeepSeek, sì.
L’open source, con la sua natura di “bene comune digitale”, troverebbe eco naturale nel principio di “天下为公” (tiānxià wéi gōng), “il mondo appartiene a tutti”
Questa novità è stata esplorata, tra gli altri, nell’articolo “开源的中国机会” (Le opportunità dell’open source in Cina) di Zhu Qigang, Zhang Guofeng, Zhu Caihua e Zhang Yi. Per gli autori il rilascio open source delle AI non va preso in esame solo come strumento tecnologico, ma come leva strategica, culturale e persino geopolitica. A questa prospettiva si aggiungono le voci di imprenditori e leader tecnologici come Liu Zhiyuan, fondatore di Mianbi AI e Liang Wenfeng, fondatore di DeepSeek. Siamo di fronte a prospettive che uniscono idealismo tecnologico, analisi di mercato, metodi di lavoro e rilascio in grado di delineare un percorso che, nel suo complesso, si discosta in modo significativo da quello occidentale. L’integrazione poi di player come Qwen di Alibaba Cloud, una famiglia di modelli potenti con una forte strategia open source, rafforza ulteriormente il quadro di un ecosistema cinese diversificato ma unito da alcuni filoni strategici distintivi.
Cina: chmod 777
L’articolo dal titolo Le opportunità dell’open source in Cina offre una bussola importante per allacciare tutti rivoli che si stanno sviluppando in Cina, perché fornisce una cornice teorica all’approccio cinese all’innovazione digitale e all’open source.
Gli autori argomentano che la Cina, avendo rapidamente attraversato le fasi di industrializzazione e informatizzazione, oggi si trova nell’era dell’economia digitale con “l’opportunità storica di sfruttare l’open source per formare un nuovo modello basato sulla combinazione di nuove forze produttive (AI), fattori di produzione non esclusivi (conoscenza) e relazioni collaborative (open source)”. In pratica, l’open source è visto come un pilastro per un nuovo paradigma economico digitale, non come un semplice dettaglio tecnico.
Le “nuove forze produttive di qualità” (新质生产力, xīnzhì shēngchǎnlì) – il nuovo mantra della leadership cinese – rappresentate dall’AI si fondono con la conoscenza, considerata un “fattore di produzione non esclusivo” che, a differenza della terra o del capitale, non si esaurisce con l’uso ma si accresce con la condivisione, e con le “relazioni collaborative” insite nell’open source.
Ciò che rende l’approccio cinese particolarmente distintivo, secondo gli autori, è la sua profonda “risonanza” con concetti chiave della cultura tradizionale cinese. L’open source, con la sua natura di “bene comune digitale”, troverebbe eco naturale nel principio di “天下为公” (tiānxià wéi gōng), “il mondo appartiene a tutti”, un ideale di società in cui il bene collettivo prevale sugli interessi individuali.
La condivisione della conoscenza e del codice, pilastro dell’open source, riflette questo spirito di mettere le risorse a disposizione di tutti per il beneficio comune. Analogamente, la natura collaborativa delle comunità open source si allinea con il principio di “和合共生” (héhé gòngshēng), “armonia e coesistenza” o “unità nella diversità”. Le comunità open source, composte da individui con background diversi che collaborano per un obiettivo condiviso, incarnano questa capacità di integrare prospettive differenti in un ecosistema armonioso. L’ideale confuciano del “大同” (dàtóng), “la grande armonia” che promuove equità e condivisione delle risorse, è citato proprio in relazione ai meccanismi di condivisione delle comunità open source, viste come espressioni moderne di questo ideale di beneficio collettivo.
Infine, il sistema di governance meritocratica che caratterizza le comunità open source, dove “la qualità del codice e il contributo determinano il diritto di parola”, viene collegato alla tradizione confuciana del governo basato sul merito, “选贤与能” (xuǎn xián yǔ néng), “eleggere i virtuosi e capaci” (un altro grande classico della vulgata cinese).
Questo sistema, che premia il contributo attivo e la competenza tecnica, pur essendo infuso di un nucleo moderno di “uguaglianza di fronte alla comunità” che garantisce a tutti la possibilità di contribuire, trova paralleli nella selezione basata sul merito auspicata dal Confucianesimo.
Questo quadro culturale, proseguono gli autori dell’articolo, si riflette nell’evoluzione del sistema di valori nell’economia digitale, con il passaggio da fattori di produzione tradizionali a dati e algoritmi che porta all’ “etica del contributo”, dove il valore di un individuo è sempre più legato al suo apporto alla creazione e condivisione della conoscenza. La reputazione digitale costruita attraverso i contributi all’open source diventa una forma di realizzazione del valore individuale, in cui “il contributo è esistenza”. Questa “etica del contributo” è vista come un’evoluzione moderna dei principi confuciani che valorizzano l’impegno e il contributo sociale.
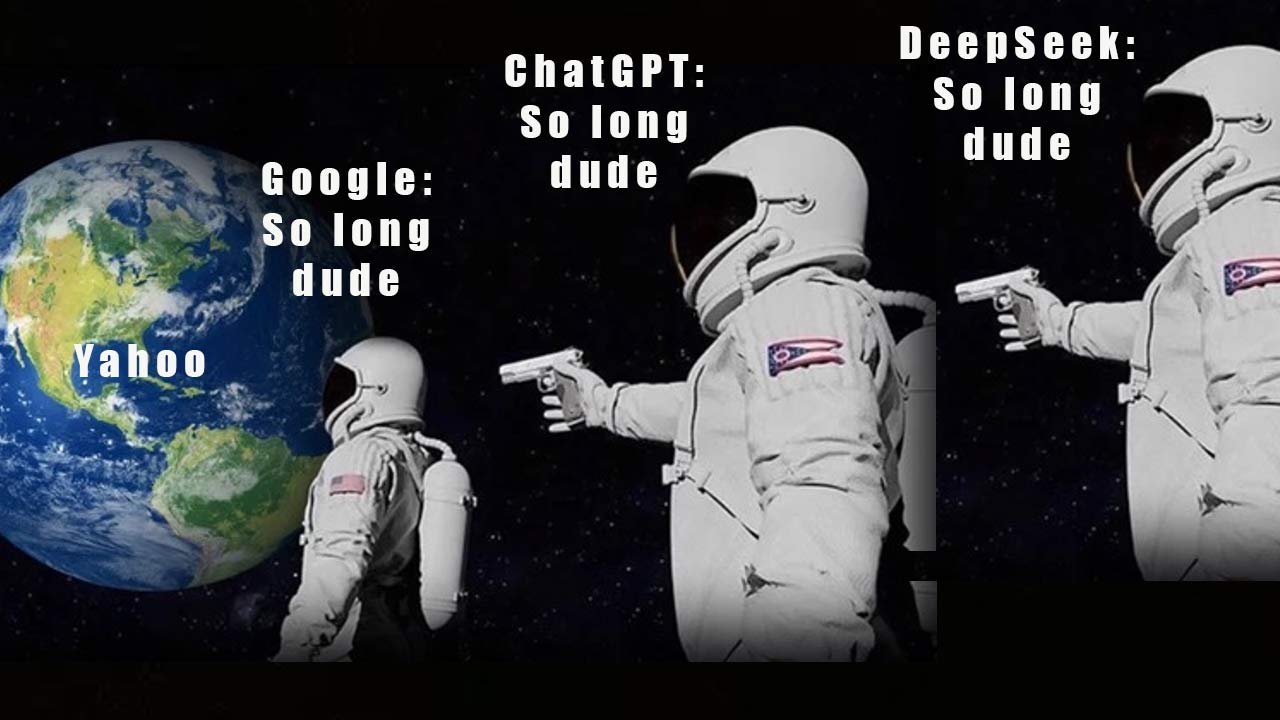
L’Agent Xi Jinping
Dal punto di vista politico e geopolitico, l’adozione dell’open source è inserita in una strategia più ampia, quella della “Via della Seta Digitale”. In sostanza secondo molti osservatori cinesi, Pechino può trasformare questo suo momento storico in beni pubblici infrastrutturali digitali, aiutando i paesi in via di sviluppo a superare il “divario digitale” e rimodellando le regole della governance digitale globale attraverso principi di condivisione. Questo posiziona l’open source come uno strumento di politica estera e di costruzione di un ordine digitale globale più equo e collaborativo, dal punto di vista cinese, offrendo nuove opzioni per la “ri-globalizzazione” economica e sfruttando la “saggezza unica nella governance culturale” cinese.
In tutta questa new wave di AI cinese, infatti, non manca il tentativo dello Stato di provare a guidare questo processo. E questa presenza dello Stato (cioè del Partito) è un’altra grande differenza rispetto alla Silicon Valley americana, ad esempio. E qui serve, per forza, un contesto.
In Cina, l’AI è considerata una tecnologia strategica fondamentale per la trasformazione economica, la modernizzazione militare, la sicurezza nazionale e la competizione globale. Questa visione è sancita ai massimi livelli di governo ed è integrata in piani nazionali di vasta portata. Già nel 2017, il governo cinese ha pubblicato il “Piano di sviluppo di una nuova generazione di intelligenza artificiale” (新一代人工智能发展规划 – Xīnyīdài Rēngōng Zhìnéng Fāzhǎn Guīhuà), che ha fissato obiettivi ambiziosi per posizionare il Paese come leader mondiale nell’AI entro il 2030.
Questo piano ha rappresentato una specie di tabella di marcia per decidere dove piazzare investimenti, ricerca e sviluppo. L’ultima iniziativa si chiama “AI Plus” (人工智能+ – Rēngōng Zhìnéng Jiā) e prova a mettere in pratica il piano del 2017 promuovendo l’integrazione dell’AI in tutti i settori dell’economia reale per stimolare la crescita e l’innovazione industriale.
La Cina ha una struttura statale, per quanto meno rilevante di quella del Partito. Dobbiamo immaginarci due livelli: il Partito che decide, lo Stato che mette in atto le decisioni. In tema di AI quindi lo Stato, via Partito, definisce la strategia e gli obiettivi nazionali e sceglie le aree prioritarie per la ricerca e lo sviluppo dell’AI. Ovviamente non c’è solo l’aspetto decisore, c’è anche quello economico. Lo Stato si fa carico di finanziamenti pubblici diretti, sia a livello centrale che locale, per supportare progetti di ricerca all’avanguardia, costruire infrastrutture computazionali su larga scala e investire in aziende considerate strategicamente importanti per il raggiungimento degli obiettivi fissati.
Un’altra componente cruciale del ruolo statale è la spinta verso l’autosufficienza tecnologica, nota anche come “innovazione indigena” (自主创新 – zìzhǔ chuàngxīn): siamo di fronte a un tema che è stato sempre presente nelle politiche economiche e industriali del Partito e che nel contesto della guerra commerciali con gli Stati Uniti diventa determinante. Basta guardare dentro la propria casa, se si vive in Cina: quanti prodotti non cinesi ci sono in una casa a Pechino? Probabilmente zero. Siamo di fronte a una politica “autarchica” in preparazione di tempi burrascosi, come questi che viviamo, e che ha trovato nella tecnologia uno dei suoi campi di applicazione più rilevanti.
Su questo aspetto di recente ha scritto Peng Yijie, professore della Peking University. L’articolo si intitola “从DeepSeek看人工智能自主创新的战略价值” (Il valore strategico dell’innovazione indigena nell’intelligenza artificiale di DeepSeek) ed è stato pubblicato sul 学习时报 (Xuexi Shibao) il 26 marzo 2025. Peng Yijie inquadra l’intelligenza artificiale non solo come un campo tecnologico in rapida evoluzione, ma come un indicatore cruciale della competitività nazionale in un contesto globale sempre più teso. L’AI diventa così uno strumento indispensabile per potenziare lo sviluppo, promuovere l’aggiornamento industriale e guidare l’innovazione a tutti i livelli.
Secondo il professor Peng, il modello linguistico di grandi dimensioni DeepSeek-R1, lanciato all’inizio del 2025, rappresenta un esempio emblematico del valore strategico dell’innovazione indigena nell’AI cinese. E ne dà una spiegazione quasi sociologica, perché definisce la strategia di DeepSeek una “vittoria ottenuta con l’ingegno” (以巧取胜 – yǐ qiǎo qǔ shèng), un approccio che dimostra come sia possibile ottenere successi anche senza un vantaggio assoluto di risorse, semplicemente attraverso l’innovazione nelle tecnologie sottostanti e nelle metodologie di ricerca e sviluppo. Peng Yijie nota inoltre come la scelta di DeepSeek di aprire e condividere parte dei suoi risultati di ricerca rifletta una crescente importanza attribuita alla collaborazione open source nell’industria cinese dell’AI.
Peng la mette giù così: se le imprese riescono a combinare il possesso di un maggiore controllo autonomo sulle tecnologie chiave con una partecipazione attiva nelle comunità open source e una collaborazione con i partner della catena industriale per costruire ecosistemi applicativi, “si possono creare meccanismi di iterazione robusti e solidi per l’evoluzione dei modelli e le loro applicazioni”. Peng è in ogni caso un realista e nonostante i progressi e i vantaggi unici della Cina (dovuti alla dimensione del mercato, ai dati e agli scenari applicativi) riconosce onestamente che “permangono lacune in alcuni campi tecnologici chiave e fondamentali”, specificamente i chip di fascia alta, il grande tallone d’Achille della Cina.
Ma per accelerare l’innovazione indigena in questo campo Peng Yijie propone alcuni percorsi strategici, tra i quali la necessità di “incoraggiare ulteriormente la ricerca congiunta focalizzata sulle tecnologie core, come i grandi modelli, i chip intelligenti e i sistemi operativi, attraverso meccanismi di integrazione tra industria, università e ricerca, supportati da progetti statali e finanziamenti” e l’integrazione dell’AI con l’economia reale. Siamo di fronte a un punto fondamentale: l’AI deve essere, e questa è un’altra grande differenza con gli Usa, al servizio delle necessità nazionali. Dunque deve essere inserita nei processi di governance e in settori come la manifattura, la logistica, la medicina e l’istruzione. Peng definisce questo approccio come “promozione della ricerca attraverso l’applicazione” (以用促研 – yǐ yòng cù yán), dove l’applicazione su larga scala in scenari tipici valida le tecnologie e ne accelera la maturazione.
We are the champions
Ora veniamo ai protagonisti. Dobbiamo per forza dedicare un paragrafo al fondatore di DeepSeek, Liang Wenfeng, utilizzando una sua (rara) intervista del 2023 (il titolo è 疯狂的幻方:一家隐形AI巨头的大模型之路 e la potete trovare cercando sul sito 36kr). In quella circostanza Liang aveva chiarito che l’obiettivo primario di DeepSeek non è l’acquisizione di utenti o il profitto rapido, ma il perseguimento dell’AGI (Intelligenza artificiale generale). Questo obiettivo ambizioso richiede di “esplorare nuove strutture di modello per ottenere capacità superiori con risorse limitate” un approccio che considera una ricerca fondamentale per lo scaling (il processo attraverso cui i modelli di intelligenza artificiale migliorano le loro prestazioni in base alle risorse a loro disposizione). Liang aveva criticato la pratica diffusa di copiare semplicemente la struttura di modelli esistenti, definendola ragionevole per lo sviluppo di applicazioni rapide ma insufficiente per la ricerca di frontiera sull’AGI.
Insomma Liang è un idealista e ha rivoluzionato anche i metodi di lavoro delle imprese tech cinesi. Liang Wenfeng è nato in una città del Guangdong negli anni ’80. Ha raccontato che a casa sua girava un sacco di gente, di genitori amici dei suoi, che nel tempo ha fatto i soldi. Gli anni ’80 e ’90 sono stati gli anni ruggenti in Cina, quelli durante i quali in tanti hanno svoltato. L’economia che si apriva al mondo, nuove opportunità, un mercato interno tutto da creare e l’aumento della ricchezza: era la Cina che via via si apprestava a diventare potenza economica mondiale. Liang ha raccontato che quelle persone che raccontavano le proprie gesta, avevano una certezza: che studiare non servisse a niente.
Anni dopo però, ha raccontato Liang, hanno tutti cambiato idea. Perché fare soldi non è più facile come un tempo. Liang dice che ha studiato con un obiettivo molto chiaro: cambiare radicalmente il modo di fare dei cinesi. Perché si era reso conto di una cosa: che la Cina rincorreva modelli di intelligenza artificiale statunitensi, specializzandosi poi in applicazioni. Secondo lui questa strategia nazionale non è corretta, non ha funzionato: da un lato è pigra, perché si attende l’innovazione e poi si procede a sfruttarla, dall’altro è una strategia che mira a fare soldi subito. E non innova. Per lui, ha detto, questo meccanismo non solo non funziona, ma finisce anche per deprimere i più giovani. Secondo lui infatti i giovani ricercatori cinesi vogliono l’impossibile, sono attratti da progetti di ricerca ambiziosi: se sono messi a rincorrere, ha detto, non esprimono tutto il loro talento.
Insomma, secondo Liang, bisogna puntare sull’innovazione, quella grossa. E così, grazie a un fondo di investimento con cui ha iniziato a collaborare, ha via via messo insieme una squadra di giovanissimi, neo laureati e dottorandi e gli ha detto: noi dobbiamo cambiare tutto, dobbiamo pensare alla cosa più importante: alla General Artificial Intelligence, quella forma di intelligenza artificiale che può eguagliare o addirittura battere gli umani in una serie di compiti. Quella che noi conosciamo con l’acronimo di AGI.
Il team di Liang, ad esempio, è orizzontale, non è gerarchico: procediamo dal basso verso l’alto ha spiegato. E ha scommesso su alcuni fattori: matematica, codice e linguaggio. E così per avvicinarsi al grande obiettivo è partito dal modello linguistico, puntando molto in alto: rivoluzionare l’architettura, entrare in concorrenza con gli Stati Uniti sul campo più delicato, quello dell’innovazione, quello del “modello” vero e proprio, non dei suoi corollari.
“Negli ultimi 30 anni, ha detto Liang, abbiamo enfatizzato solo il fare soldi, trascurando l’innovazione. L’innovazione non è interamente guidata dal business; richiede anche curiosità e desiderio di creare. Siamo solo vincolati da vecchie abitudini, ma questo è legato a una particolare fase economica”. Non è facile trovare un ragazzo cinese parlare così. Eppure negli ultimi mesi la sua creazione è diventata un elemento disruptive, come si dice in questo caso, cioè capace di modificare per sempre l’esistente, creare un prima e un dopo.
la Cina sembra puntare su un modello più apertamente strategico, che lega l’innovazione tecnologica a obiettivi sociali, culturali e geopolitici
Anche sull’open source ha la sua idea: ha detto di non credere nei “fossati” basati sul codice chiuso in un settore come l’AI, poiché anche i modelli proprietari finiscono per essere raggiunti dai concorrenti. Il vero “fossato” per DeepSeek risiede nella “crescita del team, nell’accumulazione di know-how e nel promuovere una cultura innovativa”; l’open source è un fattore “culturale, non solo commerciale”, e “dare indietro è un onore”.
A questa prospettiva si affianca quella di Liu Zhiyuan, fondatore di Mianbi (startup cinese che si occupa di modelli linguistici di grandi dimensioni). In una intervista ha raccontato la storia del suo modello. Riassumiamo: Liu Zhiyuan ha spiegato la decisione di commercializzare il suo modello di AI già nel 2021, perché era convinto che i modelli linguistici di grandi dimensioni avessero raggiunto la maturità tecnica per l’applicazione pratica e stessero avanzando verso l’intelligenza generale (AGI).
Questa scelta si basava su due giudizi: primo, che l’IA fosse pronta per il mercato, paragonando la situazione attuale alla transizione dei motori di ricerca dall’accademia all’industria; secondo, che i LLM fossero un’ingegneria di sistema complessa che superava le capacità tipiche dei laboratori universitari. Questi giudizi portarono alla fondazione di Mianbi AI nel 2022. Riguardo al vantaggio competitivo di Mianbi, Liu ha sottolineato l’importanza dell’innovazione continua e la capacità di integrare rapidamente le tecnologie all’avanguardia, distinguendosi da chi crede bastino solo denaro e potenza di calcolo.
Ha inoltre motivato la decisione, presa nella seconda metà del 2023, di spostare il focus dallo sviluppo di modelli molto grandi (centinaia di miliardi di parametri) ai modelli per l’edge computing. Questa strategia è stata adottata prevedendo che altri team cinesi avrebbero rapidamente raggiunto livelli simili a GPT-4, innescando una guerra dei prezzi. Ha criticato la strategia di semplice replicazione dei modelli occidentali in Cina data l’alta concorrenza interna e ha ribadito che l’innovazione originale è cruciale per guidare lo sviluppo dell’AGI. L’azienda si concentra quindi sull’essere un passo avanti rispetto agli altri e sull’essere efficiente con meno risorse.
Insomma a chi ritiene che ora nel mondo, anche grazie a DeepSeek, si scatenerà una “guerra dei prezzi”, è bene far presente una cosa: in Cina siamo già all’era “post” guerra dei prezzi, a sottolineare un mercato interno sottovalutato in Occidente e in grado di stritolare aziende e portare anche i big (vedi Alibaba) ad alzare in continuazione l’asticella.
未来 (wèi lái) – Futuro
Nonostante l’impeto e la diversità dell’innovazione cinese descritta, le sfide permangono. Ad esempio, i rischi legati alla dipendenza da componenti e infrastrutture straniere sono reali e strategici, come sottolinea Yanjun Wu, aggiungendo la necessità di sviluppare alternative autonome. Per mitigare questi rischi e rafforzare l’autonomia, le raccomandazioni di Wu includono lo sviluppo di un “sistema operativo per grandi modelli”, il rafforzamento della “governance della supply chain del software open source”, la costruzione di “infrastrutture open source paragonabili a GitHub” e l’intensificazione della “collaborazione software-hardware open source”.
Le due strade però appaiono ormai tracciate: se la Silicon Valley continuerà a spingere i confini con modelli proprietari e servizi a valore aggiunto, spesso partendo da una posizione di forza nelle risorse, la Cina sembra puntare su un modello più apertamente strategico, che lega l’innovazione tecnologica a obiettivi sociali, culturali e geopolitici, sfruttando l’open source come strumento per costruire alternative, ridurre le dipendenze e promuovere un diverso tipo di ordine digitale globale basato sulla condivisione. La presenza di attori come DeepSeek, focalizzato sulla ricerca AGI e sull’innovazione strutturale, Mianbi AI, che cerca percorsi differenziati nell’edge computing con un tocco di idealismo, e colossi come Alibaba (con Qwen) che abbracciano l’open source su larga scala ha in ogni caso un grande pregio: offre visioni alternative per il futuro dell’innovazione e apre nuovi punti di osservazione sulla Cina, il suo futuro e quindi anche il nostro.
All’inizio degli anni ’90, mentre la Cina apriva con cautela le finestre al mondo globalizzato, si affermava una visione paradossale: accogliere l’aria fresca del progresso tecnologico, ma tenere lontane le “mosche” del dissenso ideologico. Questa doppiezza, riassunta in un celebre aforisma di Deng Xiaoping, è diventata la base di un ecosistema digitale che oggi funziona allo stesso tempo come ponte e come barriera.
“Se apri la finestra per far entrare aria fresca, devi aspettarti che entrino anche delle mosche.”
— Deng Xiaoping
Introdotto ufficialmente nel 1994, l’internet cinese non è mai stato soltanto uno strumento di modernizzazione economica: è sempre stato una realtà che segue un copione scritto, un’apertura controllata attraverso cui lo Stato poteva filtrare il rapporto dei cittadini con il mondo esterno. Come ha osservato Graham Webster, questa apertura calcolata comportava un compromesso: accedere ai mercati globali a costo di sacrificare una parte dell’autonomia interna. Da questo patto è nato il Great Firewall, una creatura quasi mitologica che si aggira ai confini del cyberspazio cinese.
“Hanno visto il valore di un maggiore accesso ai mercati e alle tecnologie globali, anche a costo di rinunciare a parte dell’autorità.”
— Graham Webster
Il Firewall, proprio come certi spazi di confine esplorati dalle sottoculture online, esiste in una zona liminale tra libertà di accesso e controllo autoritario. Wu Jichuan, uno degli architetti principali del sistema e ministro delle telecomunicazioni tra il 1993 e il 1998, lo descrisse come una sorta di dogana digitale: un posto di controllo dove le informazioni, come i viaggiatori, devono essere ispezionate. Ma questa metafora nasconde il vero lato surreale del progetto. Il Firewall non è solo una barriera, è una macchina che altera la realtà: crea un internet parallelo in cui il consenso è costruito e il dissenso viene reso spettrale.

Questo è l’ingresso di un internet café cinese (wangba 网吧) in una foto apparsa su Xiaohongshu [è il nome cinese di REDnote, una piattaforma social e di e-commerce, NdT]. Questi vivaci hub digitali occupano un posto speciale nella memoria di molti millennials cinesi nati negli anni ’80 e ’90, come Tao, che hanno trascorso qui una parte formativa della loro adolescenza. L’atmosfera multisensoriale e la socialità unica di questi luoghi li rendono veri e propri landmark generazionali.
Per i netizen cinesi, muoversi in questo spazio è diventato una danza rituale, una miscela di creatività e prudenza che richiama le forme di sotterfugio memetico comuni a molte community online globali.
“Quando parliamo di internet, non intendiamo una libertà assoluta d’informazione. Penso sia un concetto chiaro a tutti. Se attraversi la dogana, devi mostrare il passaporto. Lo stesso vale per la gestione dell’informazione. Non c’è alcuna contraddizione tra lo sviluppo delle infrastrutture digitali e l’esercizio della sovranità statale.”
— Wu Jichuan, ex Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni della Repubblica Popolare Cinese, 1995
In quest’arena attentamente sorvegliata, anche la lingua muta. Gli utenti hanno sviluppato un vero lessico dell’elusione. Espressioni come 996 (la massacrante settimana lavorativa 9–21, sei giorni su sette) o “sdraiarsi” (una forma di resistenza passiva all’iperproduttività) prosperano nei piccoli interstizi lasciati dalla censura, sbocciando brevemente prima di essere abbattute dal sistema algoritmico di controllo che opera come una mazza schiaccia-talpa. Il risultato è una performance continua, ironica e disperata allo stesso tempo – un gioco in cui ogni protesta virale rischia di diventare un fantasma digitale.
Il vero genio della cultura digitale cinese sta proprio in questa creatività perpetua – una forma di resilienza che riflette una più profonda adattabilità culturale. Nel conflitto tra espressione e controllo, nasce forse la cultura digitale più dinamica del pianeta.
Noi ragazzini cinesi non stavamo semplicemente usando internet: stavamo inventando un nuovo sistema linguistico, progettato per essere indecifrabile a chiunque avesse più di venticinque anni
La lingua marziana
Nel 2008, mentre gli adolescenti americani personalizzavano i loro profili MySpace con musica in autoplay e grafiche glitterate, in Cina stava prendendo forma qualcosa di molto più sofisticato. Lo so bene: ci ero dentro fino al collo.
Sono cresciuta a Shanghai, ho ricevuto il mio primo computer a dodici anni e, a sedici, vivevo praticamente online. Le mie giornate erano accompagnate da quel suono iconico, simile a colpi alla porta, dei messaggi di QQ, e la mia vita sociale si misurava in contatti salvati. Le notti infinite passate nei Wangba (gli internet café), mentre i miei genitori pensavano che fossi a studiare da un’amica, hanno forgiato un’intera generazione di nativi digitali con un rapporto unico con il linguaggio.

La lingua marziana è sbocciata insieme al fenomeno 非主流 (“non-mainstream”), una specifica sottocultura giovanile cinese dei primi anni Duemila. Questo movimento si esprimeva attraverso selfie modificati in modo pesante: pelle tremendamente sbiancata, occhi ingranditi, guance finte e pose intenzionalmente innaturali. Le foto venivano scattate dall’alto, con espressioni esagerate o sguardi volutamente vuoti, poi editate con filtri LOMO, negativizzazioni, pixel sfocati ed effetto flou.
L’estetica era completata da elementi visivi ricorrenti – ruote panoramiche, fili dell’elettricità, palloncini, foglie cadute, cieli pieni di nuvole – e da testi scritti in lingua marziana, usando font contrastanti. L’insieme creava un vero sistema identitario sottoculturale che permetteva alla gioventù cinese di usare una comunicazione codificata e, al tempo stesso, di sviluppare una specifica estetica digitale che rifiutava il mainstream.
Noi ragazzini cinesi non stavamo semplicemente usando internet: stavamo inventando un nuovo sistema linguistico, progettato per essere indecifrabile a chiunque avesse più di venticinque anni. Ricordo ancora le piccole scariche di dopamina che avevo quando personalizzavo il mio avatar, e l’euforia nel trovare modi sempre più complessi per scrivere frasi semplici che mia madre, nonostante gli sforzi, non sarebbe mai riuscita a decifrare. Era il nostro superpotere generazionale: comunicare alla luce del sole, restando invisibili agli occhi delle figure che rappresentavano l’autorità.
Poi è arrivata la lingua marziana (火星文), e di colpo ho avuto il mezzo perfetto per dare voce a tutti i miei melodrammi adolescenziali. La usavo per raccontare le mie crush non ricambiate, per confessare sentimenti a persone che a malapena sapevano della esistenza, per elaborare quel delicato dolore che accompagna l’avere sedici anni ed essere costantemente fraintesi. Questo sistema linguistico – un caos affascinante fatto di frammenti di alcuni caratteri, simboli, kaomoji ed elementi del cinese tradizionale – era diventato la nostra password generazionale.
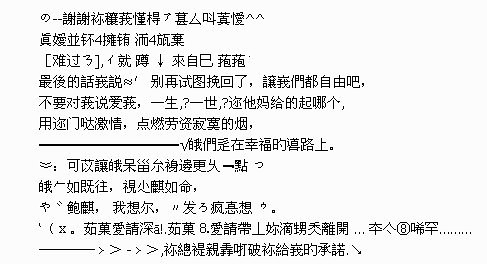
Questi sono esempi di “火星文” (lingua marziana) dall’internet cinese dei primi anni 2000. Queste frasi fortemente emotive includevano espressioni come: «Grazie per avermi insegnato cos’è il vero amore», «Se ti senti triste, accovacciati e abbracciati», oppure «Non dirmi che mi ami».
Non si trattava solo di nascondere messaggi ai genitori: stavamo costruendo comunità attraverso la complessità. Ogni messaggio decifrato con successo era una prova d’appartenenza alla nostra tribù digitale. Era la firma culturale della generazione post-anni ’90, la nostra impronta linguistica in un internet che si stava espandendo a vista d’occhio. La usavamo per tutto: dalle confessioni struggenti alle prese in giro feroci, dagli inside jokes ai racconti più articolati. Poi, come succede con molte cose da adolescenti, la lingua marziana si è gradualmente dissolta: siamo cresciuti, abbiamo iniziato a lavorare, a formare famiglie, ad allontanarci dal mondo di QQ. La ribellione in codice dei nostri anni più turbolenti sembrava morta insieme alle pettinature elaborate e agli aggiornamenti di stato strappalacrime.
O almeno, così pensavamo.
Con un colpo di scena inaspettato, quelle abilità linguistiche nate per nascondere ai genitori le nostre crush hanno assunto un significato del tutto nuovo in un ambiente digitale cinese sempre più controllato. Ciò che era iniziato come tattica per proteggere la privacy adolescenziale si era evoluto in una sofisticata strategia di elusione della censura. La lingua marziana, che una volta serviva a nascondere un “ti amo” dagli adulti ficcanaso, ora permetteva di parlare di temi sensibili senza farsi individuare dai filtri automatici keyword-based.
Il 10 marzo 2020, mentre il COVID-19 travolgeva Wuhan, la rivista People pubblicò “The Whistle-Blower”, un’intervista ad Ai Fen, direttrice del pronto soccorso dell’ospedale centrale di Wuhan, in cui raccontava i primi due mesi della pandemia. L’articolo fu subito cancellato, ma ciò che seguì fu pura poesia della resistenza digitale.
Gli utenti iniziarono a ricostruire l’intervista in decine di formati creativi per aggirare la censura: la scrittura oracolare cinese delle osse, il codice Morse, il braille e, naturalmente, la nostra amata lingua marziana. Ogni articolo trasformato sopravviveva solo per pochi minuti, a volte ore, prima di sparire, e ogni versione successiva era più indecifrabile della precedente. Ma continuavano a circolare, in una sorta di epica staffetta cibernetica, in cui ogni trasformazione era un piccolo atto di sfida al controllo dell’informazione.
La lingua che un tempo proteggeva i nostri segreti adolescenziali ora preservava le storie che rischiavano di scomparire. Dalla ribellione adolescenziale alla resistenza digitale: la distanza tra le due era più breve di quanto avessimo mai immaginato.
躺平的韭菜不好割 (L’erba cipollina quando è distesa è difficile da tagliare)
L’ascesa vertiginosa di piattaforme come Weibo (l’equivalente cinese dell’energia caotica di Twitter) e Xiaohongshu (pensate a una sorta di Instagram, ma con un livello di esibizione del proprio lifestyle ancora più curato) è diventata il battito cardiaco digitale della generazione nata negli anni ’80 e ’90. In questi spazi prende forma la coscienza collettiva di un’intera fascia demografica.
Ciò che rende questa generazione particolarmente interessante è la sua posizione paradossale: è allo stesso tempo la colonna portante economica delle famiglie e la principale vittima delle crisi — dalla pandemia alla stagnazione economica fino all’instabilità del mondo aziendale. Ma la loro risposta non è propriamente la protesta diretta. O almeno, non in modo esplicito. È qualcosa di silenzioso, di più sovversivo: una grammatica della diserzione.
Se in Occidente la “burnout culture” ha prodotto espressioni come goblin mode o rotting – vale a dire un’accettazione gioiosa del disordine, dei capelli sfatti e dei contenitori del cibo da asporto come dito medio contro la produttività performativa – in Cina i nativi digitali hanno creato un vero e proprio vocabolario del distacco professionale.
“躺平” (tang ping, “lying flat”, sdraiarsi) non è solo un’espressione: è una presa di posizione filosofico-esistenziale contro l’iperproduttività. La sua versione più moderata – la “vita a 45 gradi” (45度人生) – racchiude perfettamente quello stato d’animo sfumato tra la rassegnazione totale e il partecipare con riluttanza: l’arte di esserci senza davvero esserci. E poi c’è 摆烂 (bai lan, lasciar marcire), un’espressione che significa accettare il declino invece di sprecare energie per combattere qualcosa di inevitabile. È il gesto consapevole di chi sceglie di non combattere più, perché ogni sforzo è già scritto nel fallimento.

Un meme cinese molto diffuso raffigura la “vita a 45 gradi” (45度人生) – questo stato liminale vissuto dai giovani professionisti intrappolati tra impulsi opposti. La didascalia recita: “Voglio partecipare alla hustle culture, ma non ho le energie; ma nemmeno riesco davvero ad accettare il dolce far niente” (想卷卷不动,躺又躺不平). Questa metafora visiva cattura alla perfezione la realtà psicologica di una generazione che non riesce né ad abbracciare pienamente l’estenuante “involuzione” (内卷) dell’ipercompetitività né ad adottare del tutto la filosofia ribelle del “tang ping” (躺平), cioè il rifiuto consapevole del sistema. Vive invece in un perpetuo angolo di 45 gradi: una partecipazione riluttante a meccanismi che non può né accettare fino in fondo né abbandonare del tutto.
Ma il disimpegno non nasce nel vuoto. È una reazione a ciò che è venuto prima. Il mito del Da Chang – le “grandi fabbriche” come Alibaba e Tencent – si è deteriorato. Un tempo simboli scintillanti di mobilità sociale, oggi sono diventati abbreviazioni per indicare la fatica del 996. Anche il linguaggio si adatta per affrontarlo: Niu Ma (mucca-cavallo), un termine che una volta descriveva il bestiame, ora descrive te, che affronti un’altra giornata di lavoro logorante.

“996” indica l’estenuante orario lavorativo cinese: dalle 9 del mattino alle 9 di sera, sei giorni a settimana — una pratica ormai normalizzata nel settore tech cinese. Il fondatore di Alibaba, Jack Ma, l’ha persino difesa, dichiarando: «Lavorare 996 è una benedizione che molti desiderano ma non hanno l’opportunità di ricevere».
E così il ciclo si restringe. Non si tratta solo di stanchezza. Parliamo di nei juan: l’involuzione, la ruota del criceto che gira sempre più veloce senza andare da nessuna parte. Le vie di fuga non sono fisiche, ma linguistiche, psicologiche: un modo per restare nel sistema senza aderirvi veramente. Perché quando non puoi andartene, sovverti. E sotto tutto questo, c’è anche qualcosa di più oscuro, di ancora più insubordinato: l’anonimato come armatura, una generazione che impara il potere di scomparire sotto gli occhi di tutti.

Ad esempio, questa è un’immagine generata con intelligenza artificiale tramite Recraft, raffigurante impiegati antropomorfi con sembianze di mucca e cavallo – una rappresentazione visiva del termine “牛马” (Niú Mǎ). Questo slang molto diffuso su internet in Cina, nato come espressione dispregiativa, è stato oggetto di riappropriazione dai giovani professionisti come abbreviazione autoironica per descrivere i lavoratori moderni che faticano come bestie da soma. La metafora visiva cattura perfettamente il modo in cui i netizen cinesi usano linguaggio e immagini in codice per commentare lo sfruttamento sul lavoro, evitando allo stesso tempo critiche alle dinamiche sistemiche.
In questa equazione culturale, abbracciare il tang ping significa evitare il nei juan, sfuggire al tapis roulant del 996 e superare lo status di Niu Ma. Ma c’è un altro livello in questa forma di resistenza digitale: un’identità collettiva avvolta nell’anonimato.

Questi, ad esempio, sono screenshot di immagini generate con intelligenza artificiale tramite Recraft, in cui Hello Kitty appare in scenari d’ufficio assurdi e apocalittici — un fenomeno visivo che sta travolgendo i social media cinesi. I giovani professionisti cinesi hanno abbracciato queste creazioni surreali in quanto perfetta rappresentazione del burnout lavorativo legato alla famigerata cultura del “996”. Il trend incarna quello che i netizen definiscono “微疯” (“leggera follia”): l’uso di personaggi dell’infanzia in contesti disturbanti per commentare in modo criptato l’esaurimento professionale. Queste immagini funzionano come manifesti digitali, che permettono ai lavoratori di esprimere emozioni legate allo stress aziendale che sarebbe rischioso dichiarare apertamente, trasformando Hello Kitty in un’insolita icona di ribellione silenziosa sul posto di lavoro.
L’Armata Momo
Se la rivoluzione linguistica cinese offre un commento implicito alle pressioni sociali attraverso un linguaggio codificato, l’Armata Momo rappresenta qualcosa di molto più diretto: un movimento di resistenza digitale collettiva che si nasconde in piena vista dietro l’avatar disarmante di un simpatico dinosauro rosa.
A gennaio 2025 si è verificata un’imprevista migrazione tra piattaforme, quando alcuni utenti americani di TikTok, preoccupati dallo spettro di una totale messa al bando, hanno cominciato a colonizzare Xiaohongshu, la piattaforma cinese ossessionata dall’estetica. Questa diaspora digitale ha generato un raro momento di scambio culturale non filtrato tra due universi online solitamente separati da firewall governativi e bolle algoritmiche.
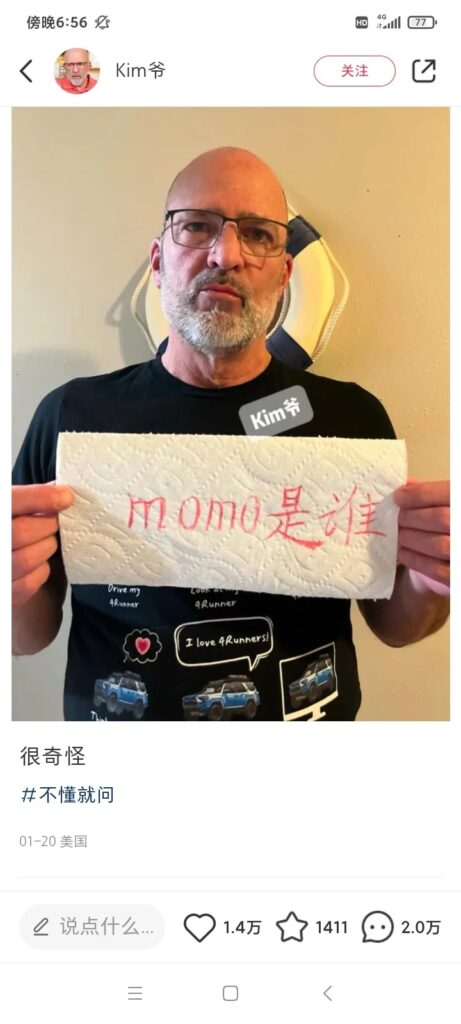
Navigando con una certa goffaggine in questo nuovo ambiente, questi immigrati digitali si sono trovati di fronte a un fenomeno curioso: migliaia di utenti apparentemente scollegati tra loro che usavano lo stesso avatar con un dinosauro rosa chiamato “Momo”.

In origine, il dinosauro rosa era semplicemente l’avatar predefinito assegnato ai nuovi account di Douban e Xiaohongshu. Ma questa figura apparentemente innocua si è evoluta in qualcosa di ben più significativo: un’identità condivisa che consente agli utenti di esprimersi con maggiore libertà in uno spazio digitale sempre più sorvegliato. Non è stato scritto nessun manifesto, non è emerso nessun leader, non è stata lanciata nessuna campagna con hashtag. Eppure, migliaia di utenti hanno scelto indipendentemente lo stesso travestimento digitale, dando vita a una forma di mimetismo sociale non pianificato, ma sorprendentemente efficace.
Il percorso di Momo — da avatar anonimo a mascotte della resistenza — è cominciato sui campi di battaglia dei fandom delle celebrità. I membri del “Goose Group” su Douban hanno adottato per primi questa identità per chiacchierare in sicurezza sulle star, evitando così l’ira di altri gruppi di fan rivali. Una soluzione pratica a un problema ben noto della cultura pop cinese, dove esprimere l’opinione sbagliata sull’idolo sbagliato può scatenare una guerra digitale.
Per molti, Momo è al tempo stesso un costume e una stretta di mano segreta: permette agli utenti affini di riconoscersi, pur rimanendo anonimi agli occhi esterni.
È una resistenza digitale che può sempre essere negata – una testimonianza del potere dell’anonimato collettivo, capace di generare un nuovo tipo di coraggio digitale.
Come ha osservato un netizen: «Da quando mi sono unito all’Armata Momo, sono diventato più schietto. Se qualcuno si offende, ci sono migliaia di altri Momo su cui far ricadere la colpa!».
Per gli utenti cinesi tutto questo genera un’esperienza digitale schizofrenica. Accedere a internet significa entrare in un tunnel della realtà
Ciò che rende davvero straordinari questi movimenti paralleli non è solo il loro ingegno individuale, ma anche il modo in cui si coordinano collettivamente all’interno del controllatissimo ecosistema digitale cinese. Dai rivoluzionari del linguaggio con la loro filosofia tang ping alle armate di dinosauri rosa con il loro travestimento collettivo, fino alla resurrezione della lingua marziana nei momenti di crisi: non stiamo assistendo a tattiche isolate, ma a un intero ecosistema di resistenza creativa, che opera in un’ingegnosa zona grigia, dove il significato si annida tra le righe.
Questi approcci riflettono una comprensione sofisticata dei meccanismi del controllo. Trasformando in strumenti di espressione autentica ciò che è nato come codici tra adolescenti per proteggere la privacy, umorismo nichilista da ufficio e avatar predefiniti, gli internauti cinesi hanno scoperto che la resistenza efficace non richiede lo scontro diretto. Al contrario, essa prospera nell’ambiguità, creando espressioni che possono esistere allo stesso tempo come fenomeni apparentemente innocui della rete e come commenti sociali profondi.
Per gli utenti cinesi, tutto questo genera un’esperienza digitale schizofrenica. Accedere a internet significa entrare in un tunnel della realtà, dove la visibilità è condizionata e l’espressione è una prova d’equilibrismo. Bisogna mantenere più stati mentali attivi allo stesso tempo: sapere cosa si può dire apertamente, cosa va codificato in metafora, cosa richiede un camuffamento completo e cosa non si può proprio dire. Questa compartimentazione mentale genera una forma di doppia coscienza digitale.
Ogni tasto premuto implica un calcolo complesso: Questo post sopravviverà? Sarà visibile agli altri? Per quanto tempo? Questa formulazione è sicura o richiama un termine recentemente bandito? Il peso psicologico di questa auto-moderazione costante è profondo, e crea un’esperienza frammentata in cui comunicare diventa una forma di arte performativa.
Eppure, all’interno di questo paesaggio digitale frammentato, è emerso qualcosa di straordinario. Nello spazio tra l’“aria fresca” e le “mosche” evocato da Deng Xiaoping, gli utenti cinesi hanno costruito qualcosa di unico: una cultura digitale che dimostra che, a volte, la forma più potente di espressione non è urlare, ma sussurrare in una lingua meravigliosamente complessa che solo i tuoi compagni di viaggio possono comprendere.
Una delle prime cose che bisognerebbe raccontare alla gente sulla Cina è WeChat Pay. In molte parti del mondo ormai è normale pagare con il telefono. In Cina continentale, però, non è solo comune: è praticamente obbligatorio. Il contante, che ovunque si fa sempre più raro, è qualcosa che puoi passare anni senza nemmeno vedere. I negozianti non vogliono usarlo, nemmeno nei posti più piccoli e remoti. I ragazzi che fanno lavoretti senza prospettive, come quelli nei Seven Eleven, non hanno voglia di perdere tempo ad aprire la cassa per te. Sempre più spesso, i mendicanti per strada non ti agitano davanti agli occhi una tazza di metallo, ma ti mostrano un foglio plastificato con il QR code di WeChat Pay.
La prima volta che ho assistito a questa scena ho provato quello che si potrebbe chiamare uno shock da futuro. È una sensazione comune tra chi arriva per la prima volta in Cina: può essere davanti ai treni ad alta velocità, ai grattacieli, ai robot che servono ai tavoli nei ristoranti, alla comodità delle app per ordinare cibo o prenotare un taxi. Per me è stato proprio WeChat Pay a suscitare quella sensazione di essere catapultato nel futuro.

Una parte di questa reazione è sicuramente legata a un certo orientalismo, lo stesso che portò Napoleone, osservando la Cina da lontano, a definirla un “gigante addormentato” destinato a “scuotere il mondo”. C’è sempre una certa fascinazione per l’altro, soprattutto se distante. Ma c’è anche qualcosa, in quella percezione del futuro che si respira in Cina, che continua a colpirmi. È in questo senso che si può cogliere ancora oggi un tratto fondamentale del marxismo nella Repubblica Popolare: una visione del mondo intrisa di tecno-ottimismo radicato nella convinzione che la storia abbia un andamento progressivo.
Questa idea di “tecno-ottimismo”, naturalmente, non è esclusiva della Cina: è un fenomeno globale. In Occidente affonda le radici in una visione progressiva della storia che ha trovato il suo compimento simbolico nel 1991: con il raggiungimento della “fine della storia” teorizzata da Francis Fukuyama, cioè l’affermazione egemonica di un sistema liberale imperfetto ma sostanzialmente solido, il rovesciamento delle dittature marxiste da parte degli stati socialisti, e le classi medie dei paesi in via di sviluppo che diventano abbastanza mature da scrollarsi di dosso i tiranni anticomunisti del periodo della Guerra Fredda. La questione politica era dunque archivia, e – almeno nelle versioni più utopiche di questa narrazione – si immaginava che l’umanità sarebbe andata avanti, più o meno in armonia, verso livelli sempre più alti di prosperità. Una prosperità che si pensava strettamente legata al progresso tecnologico, come quello legato a internet.
Oggi, questo ottimismo sopravvive quasi solo nella Silicon Valley. Come per molti altri tipi di ottimismo occidentale, la crisi del 2008 ha lasciato il posto a una disillusione diffusa: i social media sembrano minacciare la democrazia, mentre le nuove tecnologie – come l’intelligenza artificiale, il fracking o le criptovalute – vengono associate sempre più a profitti, truffe, inganni, o comunque a nulla che abbia un reale beneficio per la collettività. Elon Musk sogna un’umanità che abbandona la Terra in rovina per trasferirsi su Marte – forse l’unico sogno “ottimista” rimasto.
La Cina è diversa. Non sempre in senso positivo. Nel 2019, lo scienziato He Jiankui è stato condannato a tre anni di carcere per esperimenti genetici su esseri umani, dopo aver modificato due embrioni per renderli immuni all’HIV. L’episodio ha suscitato un’ondata di polemiche in tutto il mondo – e sì, He è stato processato e condannato da un tribunale cinese. Ma solo a tre anni. Ora è libero, come hanno fatto notare con sarcasmo in molti su Twitter, e pubblica regolarmente contenuti in cui afferma che la cosiddetta etica non fa altro che frenare il progresso scientifico.
Fukuyama, in un’intervista del 2023, ha commentato così la vicenda:
“Una cosa che ho notato e percepito è che questo tipo di sviluppi [biotecnologici] accadranno in Asia molto prima che in Europa o negli Stati Uniti. Fondamentalmente è una questione culturale. Nei paesi con una tradizione cristiana c’è una dicotomia netta tra la natura umana e quella non umana. Si crede che Dio abbia conferito all’essere umano una dignità che la natura non umana non possiede… Nelle tradizioni culturali asiatiche, invece, questa dicotomia non esiste davvero. C’è una continuità tra natura e umanità, e la possibilità di intervenire sull’una si estende anche all’altra. In effetti, la Cina è stato il primo paese in cui è stato condotto un esperimento genetico su embrioni umani. Anche se poi è stato bloccato e il ricercatore punito, credo che in Europa e in Nord America ci saranno resistenze culturali molto più forti che in altre parti dell’Asia”
Anche qui, si può cogliere una certa dose di orientalismo nella sua visione delle “tradizioni culturali asiatiche”. Eppure non ha torto nel notare una differenza tra la Cina e l’Occidente. Solo che questa differenza non risiede tanto nella cultura, quanto nella percezione della storia.
Il liberalismo occidentale, che qui rappresenta per Fukuyama la base teorica, è un’ideologia che si definisce progressista – ma immagina il progresso solo come attuazione dei suoi principi cardine: libero mercato, diritti umani, democrazia rappresentativa. Una volta spuntati questi requisiti, non resta altro da fare. La tecnologia, in questo scenario, non ha più una direzione da seguire: viene introdotta, certo, ma senza più quel movimento totalizzante che la portava a insinuarsi ovunque, a sconsacrare “tutto ciò che è sacro”, come diceva Marx.
C’è chi spiega tutto questo con un problema di regolamentazione, ma è evidente – basta guardare Twitter, Facebook, le criptovalute – che non è tanto il fatto che regoliamo male la tecnologia: è che non crediamo più che possa portare da qualche parte. E per questo finisce col rafforzare lo status quo capitalistico.
In Cina, invece, persiste un’eredità intellettuale che affonda le radici in Mao, Stalin, Lenin e Marx. Mao fu il leader che, con il Grande Balzo in avanti e la Rivoluzione culturale, ipotizzò una sorta di “rincorsa” accelerazionista all’Occidente e postulò quella “grande confusione sotto il cielo” che avrebbe portato a un progresso rivoluzionario continuo. Ma in questo, non fece che elaborare quanto già aveva teorizzato Stalin, con i suoi piani quinquennali di sviluppo industriale su larga scala – a loro volta estensioni del pensiero di Lenin. Lenin, costretto dalle circostanze storiche ma anche guidato dalla propria visione, concepiva il socialismo come indissolubilmente legato al progresso tecnologico, anche se ottenuto a caro prezzo. Celebre la sua frase: «Il comunismo è il potere dei Soviet più l’elettrificazione di tutto il paese».
in Cina la tecnologia non serve a rattoppare le falle di uno status quo liberale imperfetto e immutabile. Serve invece come strumento per costruire una futura fase della storia
Anche questo affonda le sue radici in Marx, il cui disgusto morale per le devastazioni del capitalismo, espresso sia nel Capitale sia nel Manifesto, si accompagna a una certa inclinazione poetica da intellettuale e scrittore – un’ammirazione che, in qualche misura, resta indispensabile per comprendere davvero il processo storico: Marx, nel Capitale, paragona la trasformazione del lavoro in capitale a «un mostro vivente che si mette in moto, come se il suo corpo fosse animato dall’amore». In altre parole, fin dall’inizio il marxismo ha abbinato l’idea di uno stadio futuro di sviluppo democratico oltre il liberalismo a una miscela di repulsione e ammirazione nei confronti della tecnologia. È questo il “mostro animato” che costringe l’umanità ad attraversare le fasi della storia, fino all’emergere del proletariato e all’avvento del comunismo. Lenin, e poi Stalin, in condizioni di brutale guerra civile, hanno accentuato l’aspetto tecnologico rispetto a quello democratico, convinti che lo sviluppo tecnico sotto la guida del partito proletario – il Soviet – potesse offrire una versione più razionale dell’incubo gotico dello sviluppo capitalistico, spingendo così verso l’orizzonte comunista.
Il comunismo cinese – o socialismo con caratteristiche cinesi – porta avanti proprio questa eredità. Anche qui si parte dal presupposto che potere dei Soviet più tecnologia possano dar vita a un modello di sviluppo superiore in grado di accelerare la storia. «Introdurremo tecnologie avanzate per espandere le nostre forze produttive», diceva Deng Xiaoping nel 1978. «È ancora più conforme al nostro sistema socialista trovare il modo di ottenere risultati nello sviluppo che siano maggiori, migliori, più rapidi ed economici piuttosto che il contrario».
Questo richiamo al “maggiori, migliori, più rapidi” era un’eredità diretta di Mao, Stalin e Lenin. Ma l’innovazione di Deng fu quella di spingersi ancora oltre rispetto a quella logica da “basta che funzioni” adottato dai teorici comunisti precedenti, autorizzando di fatto qualunque misura: borse valori, investimenti esteri, relazioni di mercato e persino violazioni delle norme del partito, della legge cinese e della costituzione, purché tutto ciò servisse al raggiungimento di quel “maggiori, migliori, più rapidi”. In termini ufficiali, si parla delle Quattro Modernizzazioni, tappe che dovrebbero condurre alla Grande Rinascita della Nazione Cinese e, un giorno, anche se non lo si dice apertamente, verso il luminoso futuro del comunismo.
Cosa c’entrano dunque He Jiankui e WeChat Pay? Potrebbe sembrare una distinzione arbitraria, ma in Cina la tecnologia non serve a rattoppare le falle di uno status quo liberale imperfetto e immutabile. Serve invece come strumento per costruire una futura fase della storia – una fase che, per ragioni politiche, non può essere discussa apertamente. Di conseguenza, si finisce per considerare la tecnologia come un fine nobile in sé, da abbracciare con la stessa urgenza con cui Stalin abbracciò la pianificazione centrale negli anni Trenta: «Siamo indietro di cinquanta o cento anni rispetto ai paesi avanzati. Dobbiamo colmare questo divario in dieci anni. O ce la facciamo, o ci schiacceranno». Il timore di essere schiacciati, e insieme la tensione verso lo sviluppo: è questo impulso che ha guidato la Cina attraverso l’anarchia delle fasi maoiste e riformiste, e che resta vivo anche nella sua fase più stabile. Ed è un fatto significativo. Non sono WeChat Pay, i treni ad alta velocità o gli scintillanti skyline delle città cinesi a stupire in sé: è l’ambizione, l’urgenza, la dichiarazione d’intenti che li accompagna a colpire l’immaginario occidentale, a farci credere che il secolo cinese sia già cominciato. Ma secondo i principi teorici del Partito, non è così – e non lo sarà finché le “forze produttive” non saranno davvero mature.
È il sogno marxista-leninista del Novecento, ma senza le zavorre del modello centenario di pianificazione sovietica. E guardarlo mentre viene messo in pratica, tentare di comprenderne la scala, è davvero impressionante. Molti dei nostri esperti non riescono a cogliere la natura di questa scala – come sia nata e perché persista. Nella stessa intervista già citata, Fukuyama torna sulle classiche paure occidentali legate alla tecnologia – l’IA, la disinformazione online – per poi rivolgersi di nuovo alla Cina: «Sul tema del controllo totalitario» dice, «il sistema di credito sociale cinese rappresenta un nuovo livello di sorveglianza individuale reso possibile dal machine learning e dall’analisi su vasta scala dei dati. Con l’integrazione del monitoraggio COVID e del sistema generale di controllo sociale, la Cina oggi ha una conoscenza dettagliata degli spostamenti, delle interazioni sociali e persino delle conversazioni dei singoli individui».

Qui si insiste ancora su una visione astorica delle cose: il totalitarismo come esito negativo contrapposto all’esito positivo del liberalismo. È una visione che non coglie come la Cina concepisca questi sistemi di controllo sociale, spesso fraintesi come strumenti rigidi per imporre una sorta di “armonia” neoconfuciana. In realtà, essi – così come le “stretta autoritarie” dell’era Xi, ad esempio nei settori immobiliare e tecnologico – non sono altro che contrappesi alla corsa sfrenata allo sviluppo, che minaccia costantemente di oltrepassare i confini morali e politici. He Jiankui è stato arrestato; il vasto e turbolento settore tecnologico è stato regolamentato – certo, per il bene della nazione, ma anche in funzione di quella visione più grande a cui tutto è subordinato.
È proprio quella visione – il comunismo, in forma astratta, ma più in generale il progresso storico – a fornire la base tanto per lo sviluppo tecnologico più o meno accelerazionista quanto per la consueta tendenza alla regolamentazione, talvolta eccessiva, non solo della tecnologia ma delle vite e delle attività umane. Alcuni, in Occidente, provando lo stesso stupore che provai io la prima volta davanti a WeChat Pay, hanno iniziato a desiderare un tecnocratismo autoritario, l’emulazione delle grandi campagne di sviluppo condotte dalla Cina sotto il potere statale assoluto, “per il bene dell’Occidente”. Ma manca loro la chiave essenziale: senza una visione sottostante di progresso storico, senza la consapevolezza che il presente non è un punto d’arrivo, nulla di ciò che la Cina ha fatto dal 1949 in poi sarebbe stato possibile. Inclusi, curiosamente, anche i mendicanti con il QR code di WeChat Pay.
L’interesse per gli eventi che animano il presente in un mondo in rapida evoluzione è una costante nel lavoro di Cao Fei, che nel corso degli anni ha affrontato le questioni più pressanti della società dalla sua peculiare prospettiva e con il suo linguaggio. Un linguaggio in continua evoluzione, che si confronta e adotta le potenzialità più avanzate offerte dalle nuove tecnologie per creare e comunicare immagini.

63min 21sec. Commissioned by the Solomon R. Guggenheim Museum, New York, for The Robert H. N. Ho Family Foundation Chinese Art Initiative
Cao Fei cresce a cavallo tra gli anni Ottanta e gli anni Novanta – un’epoca di drastici cambiamenti per una Cina che inizia ad aprirsi al resto del mondo – a Guangzhou, il laboratorio della modernizzazione cinese nel cuore del Delta del Fiume delle Perle. Si muove in un contesto urbano caratterizzato da una cultura liberale e alternativa, utilizza tutti gli strumenti che ha a disposizione per esplorare il mondo esterno appena scoperto, abbracciando un sistema di valori che supporta la libertà e l’apertura e sviluppando, nel tempo, un approccio personale per esprimere il desiderio e la fantasia.
La cultura pop emergente, fortemente influenzata dall’industria dell’entertainment di Hong Kong (soprattutto dalle canzoni Cantopop) ha un forte impatto sul modo in cui Cao Fei dà voce e forma alla sua immaginazione, insieme alla fascinazione per il linguaggio trendy imposto dalla nuova economia di mercato: le pubblicità con immagini e suoni elettronici (e poi digitali), l’intrattenimento audiovisivo e i videogiochi. Ma è anche profondamente attratta dalla fotografia, dal teatro e dal cinema d’avanguardia e riesce a trasformare tutte queste fonti di ispirazione in un sistema espressivo personale e straordinariamente eclettico che restituisce i sogni, i piaceri, le paure e i bisogni della sua generazione. Le opere che produce sono spesso oltraggiose e stravaganti, ma allo stesso tempo romantiche e poetiche, con una forte componente di serietà e di critica, sempre accompagnate dall’ironia, dalla satira e, soprattutto, dall’umorismo.
La tecnologia può essere tanto un acceleratore della storia quanto uno specchio che la riflette, proprio come la storia, a sua volta, condiziona e orienta l’evoluzione tecnologica
È un’attitudine che esprime un senso del realismo profondamente cantonese. Come recita il titolo di una delle canzoni più famose del maestro del Cantopop di Hong Kong Sam Hui, «La cosa più importante è il divertimento». Gli abitanti della regione del Delta del Fiume delle Perle sono bon vivants. Da sempre si godono la vita a modo loro, mantenendo le distanze dall’influenza dei poteri centrali. Sono aperti a tutto l’immaginabile, e sono riusciti a fare della propria regione una porta d’accesso del paese al mondo esterno e un laboratorio per le rivoluzioni moderne. Il vivace processo storico di negoziazione delle tensioni tra la Cina e il resto del pianeta ha reso gli abitanti di questa regione i difensori naturali di una cultura che celebra e sostiene la diversità e l’ibridazione. Sono al tempo stesso risoluti cosmopoliti e tenaci conservatori: proteggono le tradizioni locali (tra cui lingue, religioni e stili di vita) dalle pretese di omologazione ideologica, culturale e politica.
Divertirsi è il modo più pragmatico ed efficiente per resistere e distaccarsi dalla strumentalizzazione messa in atto dalle autorità che impongono il progresso e l’ascetismo politico come obiettivi ufficiali; cercare il divertimento nella vita di tutti i giorni significa avere la libertà di essere indifferenti ai giudizi politici e morali.
[…]
La gioia e la risata hanno il potere di far esplodere la brama di emancipazione e di scuotere le fondamenta di una sovrastruttura basata sull’oppressione e sulla violenza. Questa attitudine ha portato alla formazione di una cultura indipendente e ottimista del quotidiano che spazia dal cibo alla musica, dai film alle serie televisive, fino alle opere audiovisive alternative. E ha generato l’esplosione di un mercato delle copie pirata – di audiocassette, videocassette, CD, VCD e DVD – che tra gli anni Novanta e gli anni Duemila ha dato impulso alla diffusione di modi di vivere e pensare indipendenti in tutta la regione del Delta del Fiume delle Perle.
È da questo humus che ha preso vita una scena dinamica e indipendente di arte sperimentale. Dagli anni Ottanta fino agli anni Duemila, collettivi come i Southern Art Salon, i Big Tail Elephant Working Group (Chen Shaoxiong, Liang Juhui, Lin Yilin e Xu Tan), il Borger Liberia/Institute (fondato da Chen Tong), lo Yangjiang Group (Zheng Guogu, Chen Zaiyan e Sun Qinglin) e altri artisti sono state le figure di riferimento della comunità. Realizzavano alcuni dei loro progetti in strada con improvvisazioni, installazioni e mostre che sfidavano il modello ufficiale di urbanizzazione, commercializzazione e ordine prestabilito. Le loro opere erano spesso effimere e in continuo cambiamento, evocavano umorismo e inquietudine, condividendo con il pubblico o con i passanti momenti di ilarità. Questi artisti riuscivano a sfuggire ai sistemi di sorveglianza e di controllo, creando di fatto una sorta di zona autonoma temporanea, una modalità alternativa di esistenza ed espressione in un momento critico di transizione storica. Uno stato di «straniamento», che continua a diffondersi nella regione come una possibilità di fuga, di emancipazione e liberazione ogniqualvolta la libertà individuale, sociale, culturale, economica e politica è a rischio.
Cao Fei, coinvolta nella formazione di questa cultura come una sorta di «sorella minore», non solo segue le orme dei fratelli maggiori nella ricerca di questo «straniamento» ma stabilisce anche una sua personale prospettiva, un suo modus operandi e un suo linguaggio narrativo. Mostra subito una profonda sensibilità nei confronti di tutto ciò che vincola la libertà, personale o collettiva, sessuale o sociale, culturale o politica, e tenta di smascherare e deridere ogni forma di alienazione umana. Ispirandosi sia alla cultura popolare «locale» che alla produzione artistica «globale», si immerge nelle immagini, nei suoni e nelle modalità performative dei video musicali, delle serie tv, dell’opera e, soprattutto, dei lavori di Cindy Sherman, Terayama Shuji e Wong Kar-Wai, inventando un linguaggio espressivo personale, fresco, energico ed «eccentrico».
Nelle sue prime produzioni, come Imbalance 257, Chain Reaction (2000), Rabid Dogs (2002), e la serie «Cosplayers», è già evidente il suo gusto per il bizzarro e il fantastico. Un aspetto che matura, fino a trasformarsi in uno strumento di narrazione cinematografica più complesso, intenso e profondo, come mostrano i suoi ultimi lavori, tra cui Haze and Fog (2013), La Town (2014), Asia One (2018) e Nova (2019). Questi lungometraggi, però, restano fermamente ancorati al reale. Con una parvenza surreale e sardonica, rivelano l’assurdità della vita e il suo impatto sull’interiorità degli esseri umani e sottolineano come ognuno possa sviluppare un’immaginazione propria per trovare modi di sopravvivere in una nuova era mostruosa, che unisce tutti i «vantaggi» dell’economia di mercato al totalitarismo.
La vita è intensa, ma anche paradossale. Questa intensità ha nutrito una nuova generazione, che si fa chiamare New Type, o New Human (新人類). Completamente diversi dai loro padri e fratelli maggiori, questi giovani affrontano una realtà in rapida evoluzione a modo proprio. Utilizzando i nuovi gadget elettronici, dai videogiochi agli smartphone, da internet a modalità innovative di immaginare il mondo, come l’animazione in 3D, realtà aumentata e realtà virtuale, inventano delle identità fittizie per sfuggire al controllo e alle imposizioni del potere. Si travestono da «cosplayers» e si chiudono in casa (come nel caso degli otakus) o trasgrediscono virtualmente le norme del politicamente corretto (come i «cyber warriors»). Eppure, una volta tornati alla vita reale, devono necessariamente confrontarsi con lo sfruttamento e l’alienazione. Il surreale è, per loro, una porta sul retro che dà accesso alla società e al mondo che li circonda. Il sogno a occhi aperti, perfino la trance, sono forme normali della loro esistenza, poiché la libertà assoluta che sognano non esiste e prima o poi dovranno inevitabilmente fare i conti con il peso di vivere in «tempi interessanti».
[Questo testo introduttivo è un estratto dal saggio di Hou Hanru “Quanto ancora possiamo divertirci? Sull’opera di Cao Fei” contenuto in Cao Fei. Supernova pubblicato da Nero Editions]

Hou Hanru: Hai iniziato a sperimentare con nuovi media come la fotografia e il video per fare arte già prima del 2000, entrando così a far parte della seconda generazione di artisti multimediali in Cina. Più tardi sei stata tra i primi a esplorare Internet non solo come strumento creativo, ma anche come spazio espositivo per il tuo lavoro. Hai utilizzato immagini in realtà virtuale, collaborato direttamente con amici e persone in tutto il mondo, trasformando la rete in un modo autentico di vivere e fare arte. Guardando a tutto questo dalla prospettiva della Cina, qual è la consapevolezza più significativa che hai maturato negli ultimi venti o trent’anni?
Cao Fei: La Cina è un Paese che non ha paura di sperimentare. Dalla famosa frase di Deng Xiaoping “Non importa che il gatto sia bianco o nero, finché cattura i topi” fino all’invito di Xi Jinping a “rimboccarsi le maniche e lavorare sodo”, si è sempre promosso uno spirito di sperimentazione e di pragmatismo concreto. Questo approccio, anche se a tratti rozzo, ha dato grande slancio a tanti settori, ma ha anche generato inevitabili tensioni sociali lungo il percorso.
Sia nelle fasi iniziali della diffusione di Internet in Cina sia oggi, nel discorso sull’intelligenza artificiale, emerge un senso di urgenza, una convinzione profondamente radicata, che risuona nelle parole di Mao Zedong secondo cui “restare indietro è un invito all’aggressione”. Questo senso di crisi pervade non solo il racconto nazionale, ma anche l’immaginario collettivo e individuale.
il progresso tecnologico non è lineare. È plasmato da una miriade di variabili che si incrociano, che generano percorsi di sviluppo divergenti. L’IA ci sta già trasformando — non solo come artisti, ma anche come persone comuni
Credo sia difficile, per chi fa arte, parlare di qualcosa senza condividerne il contesto. Se consideriamo la Cina come sfondo costante del mio lavoro, allora penso che alcune delle esperienze che viviamo qui possano raccontare anche qualcosa al resto del mondo. Non sono esperienze universali, ma rappresentano frammenti di una condizione globale. Penso, ad esempio, al passaggio dalla globalizzazione all’espansione del mercato interno, dal lavoro intensivo alla nuova alienazione prodotta dall’intelligenza artificiale, o ancora dalla visione utopica della tecnologia alle piattaforme digitali dominate dalle corporate, con tutte le questioni etiche che ne derivano.
In questo senso, ciò che accade in Cina non riguarda solo la Cina: fa parte di un mosaico globale frammentato ma connesso. E credo che gli artisti abbiano un ruolo importante nel provare a ricomporlo.

2007. Machinima, Single channel video, 4:3, colour with sound 5min 57sec. Per gentile concessione dell’artista, Vitamin Creative Space and Sprüth Magers
Hou Hanru: In questi anni, il tuo lavoro si è incentrato sull’impatto che hanno internet e l’intelligenza artificiale sulla vita quotidiana. Hai creato opere che mescolano realismo e fantascienza, riflettendo sul ruolo centrale che la nuova tecnologia ha avuto nella storia della modernizzazione socialista. Come vedi il rapporto tra tecnologia e storia? E quale pensi sia il ruolo specifico dell’arte in questo contesto?
Cao Fei: Nel corso della mia pratica artistica, ho attraversato diversi momenti storici del rapporto tra la Cina e la tecnologia: dal tecnocomunismo dei primi anni della Repubblica Popolare, nato dalla cooperazione sino-sovietica, al tecno-socialismo durante la Rivoluzione Culturale, fino all’ottimismo tecnologico e alle visioni utopiche attorno al 2000, e infine all’ascesa attuale del tecno-capitalismo — se non addirittura di un tecno-feudalesimo.
Credo che la relazione tra storia e tecnologia sia tutt’altro che lineare. La storia della scienza e della tecnologia non può essere ridotta a una narrazione unica e lineare di “progresso”. È invece attraversata da contraddizioni, tensioni, ambivalenze. La tecnologia può essere tanto un acceleratore della storia quanto uno specchio che la riflette, proprio come la storia, a sua volta, condiziona e orienta l’evoluzione tecnologica.
Nel film Asia One (2018), ho cercato di raccontare la crisi della soggettività umana e l’alienazione del lavoro all’interno dei sistemi automatizzati. La piovra gigantesca e spettrale che appare nel film diventa un simbolo anti-algoritmico, una creatura mostruosa che resiste alla meccanizzazione. In Nova (2019), invece, ho adottato un’estetica fantascientifica socialista per immaginare un passato fittizio visto dal futuro: un modo per riflettere su come, in passato, la corsa al progresso tecnologico sia spesso avvenuta a discapito del futuro stesso.

Hou Hanru: Oggi sempre più artisti usano l’intelligenza artificiale nei propri processi creativi. Secondo te, in che modo l’IA potrebbe cambiare la nostra idea di arte?
Cao Fei: Porsi questa domanda mi ricorda altri momenti in cui nuovi media hanno fatto il loro ingresso nella pratica artistica: la fotografia, il video, internet, gli NFT. Nella breve storia dell’evoluzione dei media, ci troviamo continuamente a dover rivedere, correggere e riattivare le nostre pratiche, inseguiti da un senso costante di urgenza.
Ma il progresso tecnologico non è lineare. È plasmato da una miriade di variabili che si incrociano, che generano percorsi di sviluppo divergenti. L’IA ci sta già trasformando — non solo come artisti, ma anche come persone comuni — ma non siamo ancora arrivati a un punto di svolta chiaro. Quel che ci attende è ancora incerto.
Quello che possiamo osservare, però, è la risposta emotiva intensa e polarizzata che l’IA suscita negli esseri umani: da un lato entusiasmo sfrenato, dall’altro un senso di disperazione. Questa corsa a definirla, a darle un senso, somiglia più a un tentativo di autoconforto temporaneo che a una riflessione reale e approfondita.
Forse un approccio più aperto e realistico consiste nel restare in contatto con la tecnologia, usarla, esplorarla man mano che si sviluppa, per togliere il velo di mistero che la avvolge. Se non si è mai usata l’IA in prima persona, forse è troppo presto per darle una definizione netta. A volte è meglio camminare al fianco dell’ignoto, invece di cercare di dominarlo frettolosamente.

Hou Hanru: Molti artisti attorno a te — soprattutto tra le nuove generazioni — ti considerano un modello da seguire, oppure un punto di riferimento da mettere in discussione. Come guardi al loro lavoro? Puoi citare qualche esempio che segui con particolare attenzione?
Cao Fei: Quando ero giovane anch’io avevo figure che ammiravo e altre che criticavo. Con il passare del tempo, le generazioni nel mondo dell’arte si alternano: cambiano le estetiche, cambiano i curatori, mutano le condizioni geopolitiche e il panorama internazionale dell’arte. Ora che sono entrata, per così dire, nella “generazione di mezzo” (tra i 40 e i 60 anni), mi chiedo: diventare oggetto di ammirazione o di critica è forse un passaggio inevitabile? O si può anche sfuggire a questo schema?
Negli ultimi tempi ho osservato il lavoro di alcuni giovani artisti che mi circondano (naturalmente non posso darne un quadro esaustivo). Alcuni seguono i linguaggi dell’arte più alla moda, in stretta sintonia con il mercato, il capitale e il consumo di massa. Altri, che un tempo lavoravano con la fotografia o il video, si sono spostati sulla pittura — spesso più per necessità che per scelta, spinti da pressioni economiche o dalle richieste del mercato dell’arte. Ci sono poi artisti che riescono a portare avanti la propria pratica grazie a programmi di residenza che offrono fondi e spazi, ma che devono comunque trovare altri modi per sostenersi nella vita quotidiana.
Il rallentamento economico globale ha avuto un impatto profondo anche sul sistema dell’arte, in Cina come altrove. Dai musei privati alle gallerie, dalle fiere agli artisti indipendenti, tutti ne hanno risentito. I giovani artisti, in particolare, devono fare i conti con la mancanza di fondi e di spazi espositivi. Senza un ecosistema sano e di supporto, la loro produzione riceve poco riscontro, e manca un vero sostegno dopo il momento della creazione. Col tempo, questo genera stanchezza, persino un senso di impotenza. Rispetto al periodo prima del 2020, il mondo dell’arte oggi appare decisamente meno vitale e dinamico.
A tutto questo si aggiunge il fatto che smartphone e tablet occupano ormai gran parte del tempo libero delle persone. L’ondata dell’intelligenza artificiale ha ulteriormente diluito l’attenzione nei confronti dell’arte contemporanea. In questo contesto, forse è il momento per gli artisti e per il sistema dell’arte di chiedersi seriamente: come possiamo aprire una nuova strada?
Tutte le persone che incontrava parlavano in modo sconclusionato, come se fossero impazzite. Pian piano, capì di trovarsi in un mondo dove tutti vivevano doppie vite, portando il peso di due identità e due memorie. Solo un individuo fuori posto, cioè quello che aveva causato la fusione dei due mondi, era in grado di distinguere tra l’universo originale e quello alternativo.
Regina Kanyu Wang, Il giardino d’inverno
Il primo romanzo di fantascienza cinese a immaginare una società utopica femminile fu scritto molto probabilmente da un uomo. Come racconta Regina Kanyu Wang (王侃瑜) in un articolo uscito su Vector, The Evolution of Nüwa: A Brief “Herstory” of Chinese SF, si tratta di 女娲石 (La pietra di Nüwa), dove Nüwa è la dea mitologica cinese che riparò il cielo spezzato e modellò gli esseri umani dall’argilla. Scritto nel 1904 sotto lo pseudonimo 海天独啸子 (Hǎitiān dúxiào zǐ), il romanzo immagina donne competenti in arti marziali, scienza e medicina, impegnate nella salvezza della patria. Tuttavia, i loro strumenti d’azione restano intrappolati in stereotipi di genere «feudali»: ragazze carine vengono addestrate per sposare e assassinare funzionari governativi, frequentano bordelli per acquisire armi di seduzione. Tutte strategie che trasformano il corpo femminile in arma di stato. È difficile definire quest’opera come il primo esempio di fantascienza femminista in Cina, ma ci offre un punto di partenza storico.

Spostandoci sul presente, sono ormai passati dieci anni da quando Il problema dei tre corpi di Liu Cixin (刘慈欣) ha vinto il celebre premio Hugo, portando per la prima volta la fantascienza cinese sotto i riflettori globali. Da allora, il genere ha guadagnato spazio, ma le voci più celebrate – Liu Cixin, Wang Jinkang (王晋康), Han Song (韩松), Chen Qiufan (陈楸帆) – restano quasi esclusivamente maschili. Anche Ken Liu (刘宇昆), cruciale come traduttore, appare spesso accanto a questi nomi. Festival, premi e traduzioni hanno consolidato l’attenzione internazionale, ma anche reso evidente la parzialità dello sguardo. Ancora una volta, la fantascienza è stata raccontata come un territorio maschile.
Scrivere questo testo è stato un viaggio in territori poco esplorati, in cerca di piccole oasi, come il catalogo di Future Fiction, che negli anni ha pubblicato diverse autrici di fantascienza cinesi. Le omissioni sono inevitabili, ma spero perdonabili. Può sembrare paradossale che, in un’epoca di traduzioni automatiche e intelligenze artificiali, esplorare queste letterature continui ad avere il sapore di un’impresa temeraria.
Come sottolinea Tang Fei (糖匪) in un’intervista su Words Without Borders dal titolo Sexism and Science Fiction, l’invisibilità delle autrici non è solo questione numerica: riguarda lo sguardo con cui si leggono le loro opere, spesso ridotte a “tema”, a “curiosità di genere” o a parentesi estetiche. Non si tratta di aggiungere autrici a una lista per riequilibrare il conteggio, ma di ascoltare come la loro voce riscrive le coordinate stesse del genere: come destabilizza potere, desiderio, tecnologia. Tang Fei ci invita a rovesciare la domanda: non perché una donna scriva fantascienza, ma cosa diventa la fantascienza quando attraversa l’esperienza di chi ha imparato a sopravvivere ai margini.
La sua narrativa, ad esempio, lo dimostra con forza. In Call Girl, pubblicato da Apex Magazine, Tang Fei affronta con sottigliezza temi come la mercificazione del corpo femminile e l’autodeterminazione della protagonista, ribaltando le aspettative del lettore. Xiaoyi, liceale apparentemente coinvolta in un giro di prostituzione, si rivela invece una venditrice di esperienze: non offre sesso, ma storie che trasformano, in un’epoca in cui il desiderio autentico è merce rara. Tang Fei ci consegna così una riflessione inquieta e poetica sul bisogno umano di connessione e sul prezzo, non sempre monetario, delle emozioni vere.
Una storia di corpi e potere: dal maoismo al femminismo
Le scrittrici che ho incontrato in questo percorso guardano alla tecnologia non come strumento di dominio, ma come lente per ripensare intimità, relazioni, corpi, possibilità. La strada è stata lunga dal 1904 a oggi, e vale la pena segnalare tre tappe storiche per collocare questa produzione letteraria nel contesto cinese.
Con la fondazione della Repubblica Popolare di Cina nel 1949, alle donne cinesi venne detto che “Uomini e donne sono uguali” (男女都一样) e che “Le donne sorreggono metà del cielo” (妇女顶起半边天). Tuttavia, mentre le lavoratrici venivano celebrate come forza lavoro fondamentale per costruire la giovane nazione, al pari degli uomini, oltre a occuparsi della patria dovevano anche essere responsabili del lavoro domestico, della cura e del lavoro di servizio.
Dopo il periodo di “Riforma e Apertura”, a parte dalla fine degli anni ’70, gli intellettuali cinesi iniziarono a divorare il pensiero occidentale, mettendo in discussione alcuni pilastri del pensiero maoista. Anche su questa spinta, intorno alla metà degli anni ’80, in Cina emerse il concetto di “letteratura femminile”, introdotto per distinguere la scrittura delle autrici. Se da un lato questa può essere considerata la prima ondata di discussioni di genere nella Cina contemporanea, come in effetti ben illustra un recentissimo studio che ricostruisce la genealogia degli Studi di genere in Cina negli ultimi quarant’anni, bisogna aspettare gli anni ’90 perché avvenga il passaggio da una visione delle donne come meri oggetti di ricerca a un riconoscimento della loro agentività.
In preparazione alla Quarta Conferenza Mondiale sulle Donne, tenutasi a Pechino nel 1995, il governo cinese promosse attivamente la ricerca sulle donne e la diffusione delle conoscenze correlate. Di conseguenza, gli studi di genere diventarono un campo accademico molto visibile e le prospettive di genere iniziarono a prendere forma nel discorso scientifico. È proprio intorno alla Conferenza di Pechino che sorsero le categorie di “letteratura femminista” (女性主义文学) e “scrittura femminile” (女性写作), ma il mercato spinse molte autrici verso filoni come la “scrittura del corpo” o della “bellezza”, neutralizzandone il potenziale critico.
È difficile dire quanto tutto ciò abbia influenzato la scrittura fantascientifica femminile in Cina in quel periodo, poiché, a partire da una campagna del 1983, la fantascienza in generale era sottoposta a critiche per “inquinamento spirituale”, a causa dei suoi “elementi capitalistici”, considerati dannosi dal punto di vista politico.
Ma come ben evidenziato da Simone Pieranni nel suo libro Tecnocina, le scienziate, ricercatrici e imprenditrici hanno giocato un ruolo cruciale nello sviluppo tecnologico cinese, e proprio in quegli anni due donne hanno hanno contribuito in modo decisivo.. Sarà infatti Zhang Shuxin (张淑欣) a fondare il primo provider cinese di Internet della storia, Yinghaiwei, nel 1995. E nel 1998, a capo del neo-ministero della Scienza e della Tecnologia ci sarà Zhu Lilan (朱立兰), nata a Shanghai e laureata in chimica in Unione Sovietica.
Le comunità online, sin dalla fine degli anni ’90, avranno un ruolo centrale nel far crescere il numero di lettrici donne, a partire dalla prima piattaforma online di letteratura femminile, hongxiu.com (Fragrant Red Sleeves), fondata già nel 1999. Successivamente, dagli anni 2010, anche grazie al #MeToo, le scrittrici di fantascienza hanno iniziato a integrare nelle loro opere questioni di genere, identità, sessualità, disuguaglianza, in maniera più sistematica e sofisticata. La stessa Regina Kanyu Wang parla di un percorso personale di consapevolezza femminista, nato nel tempo, anche perché costretta a confrontarsi con l’idea di una fantascienza percepita come dominio occidentale e maschile.
Intimità, tecnologia e identità in trasformazione
Wang è una delle poche autrici tradotte in italiano. Nuvole e nebbia, pubblicato in Italia da Future Fiction in edizione bilingue, è una novella che si muove tra cyberpunk intimista e distopia psicologica. Ambientato in una Cina del futuro dove la condivisione dei pensieri e dei ricordi attraverso un cloud mentale ha trasformato radicalmente l’identità individuale, Wang sfrutta l’impianto speculativo del libro come uno strumento per indagare la coscienza, il senso del sé e la natura dell’autonomia. In questa città avvolta da nebbie simboliche e reali, dove i confini tra sé e altri si sfaldano, la sua scrittura si fa densa, sensoriale, attraversata da tensioni etiche profonde: fino a che punto possiamo essere connessi senza smarrire la nostra singolarità? Quale memoria è veramente nostra? E cosa significa amare, o scegliere, quando i pensieri non ci appartengono più del tutto? Nuvole e nebbia interroga la promessa di trasparenza totale delle tecnologie affettive, restituendoci un futuro inquieto, stratificato, a tratti lirico, dove ogni relazione è anche un rischio di dissoluzione.
Un altro esempio chiave della sua poetica è The Winter Garden, racconto disponibile su Clarkesworld in inglese. Anche qui Wang si confronta con il tema della scelta. Esplora l’identità come campo mobile, stratificato, poroso: la protagonista si confronta con una versione alternativa di sé proveniente da un universo parallelo, e tra le due si innesca un cortocircuito di desiderio che sfiora l’eros, ma che è soprattutto un’esplorazione di possibilità e riconoscimento. L’incontro non è solo un gioco speculare, ma un’esperienza liminale: toccare l’altra sé significa esplorare il limite tra io e non-io, tra intimità e alienità. La narrazione mette in crisi le categorie binarie di soggetto e oggetto, mostrando come l’identità non sia mai fissata, ma sempre in divenire, moltiplicata, rifratta.
Wang lavora sulla messa in discussione delle strutture: non tanto “più voci”, ma altre griglie, altre mappe, altre logiche. Nei suoi racconti, la tecnologia non è semplicemente un ambiente o un dispositivo esterno, ma un’estensione della psiche e della relazione, un elemento capace di far esplodere i confini del sé.
In quasi tutti i racconti, la tecnologia non è spettacolare o centrale nel senso tradizionale della sci-fi più “dura”, ma agisce come interfaccia sottile.
Tanto nella scrittura narrativa quanto nella sua ricerca accademica, Wang sfrutta l’immaginabile offerto dalla tecnologia per minare il pensiero binario, ricorrendo allo stesso pensiero tradizionale. In una tavola rotonda dal titolo, Can Chinese Science Fiction Transcend Binary Thinking?, si è soffermata sulla coppia concettuale della cosmologia cinese antica: yin (阴) e yang (阳), che hanno ancora oggi un’enorme influenza nella Cina contemporanea. Yin e yang possono rappresentare femminile e maschile, ma anche oscurità e luce, inanimato e animato, fiume e montagna. Yin e yang sono intrecciati l’uno nell’altro, costituendo una vitalità fluida (qi 气). Questo concetto pone l’accento sulla distribuzione del potere d’azione tra diverse soggettività, piuttosto che sulla loro separazione. In questo contesto, la circolazione della vitalità fluida tra entità e soggettività diverse costituisce l’elemento centrale dell’individualità, più che le differenze di genere. In alcuni racconti di fantascienza cinese c’è la tendenza a mostrare questo equilibrio, nell’interazione e nell’interdipendenza di yin e yang: sono racconti che non si concentrano necessariamente sul genere, ma mettono in scena forze interdipendenti che cercano un bilanciamento.
Frutto di questo campo di interesse è l’antologia curata dalla stessa Wang insieme a Yu Chen (于晨), The Way Spring Arrives and Other Stories: A Collection of Chinese Science Fiction and Fantasy in Translation from a Visionary Team of Female and Nonbinary Creators (Tor Books, 2022). Qui la sfida è duplice: da un lato dare visibilità a una scena narrativa che in Cina è stata a lungo marginalizzata, dall’altro ridefinire le coordinate stesse della speculative fiction, intrecciando genere, identità, ecologia, linguaggio e appartenenza. La raccolta non solo dà voce ad autrici e persone non binarie, ma intreccia storie con saggi critici e riflessioni teoriche, creando un dialogo continuo tra narrazione e interpretazione. È un progetto che si presenta come opera letteraria, ma funziona anche come dispositivo metanarrativo: un laboratorio in cui si ragiona apertamente su cosa significhi scrivere, tradurre, leggere in un’epoca di trasformazioni radicali.
Che si tratti di riflettere sulla memoria, sul corpo, sul linguaggio, le autrici e le persone non binarie raccolte in The Way Spring Arrives mettono al centro l’instabilità, la trasformazione, la possibilità. In quasi tutti i racconti, la tecnologia non è spettacolare o centrale nel senso tradizionale della sci-fi più “dura”, ma agisce come interfaccia sottile. È spesso la tecnologia della connessione, della trasformazione, e della rottura delle gerarchie (umano/non umano, centro/periferia, maschile/femminile, umano/postumano).
La fantascienza, nelle loro mani, diventa uno strumento per immaginare non solo altri mondi, ma altri modi di essere al mondo. L’antologia è chiaramente un gesto politico, ma anche una dichiarazione poetica. È una raccolta che non cerca di normalizzare o includere, ma di disturbare e ridisegnare.
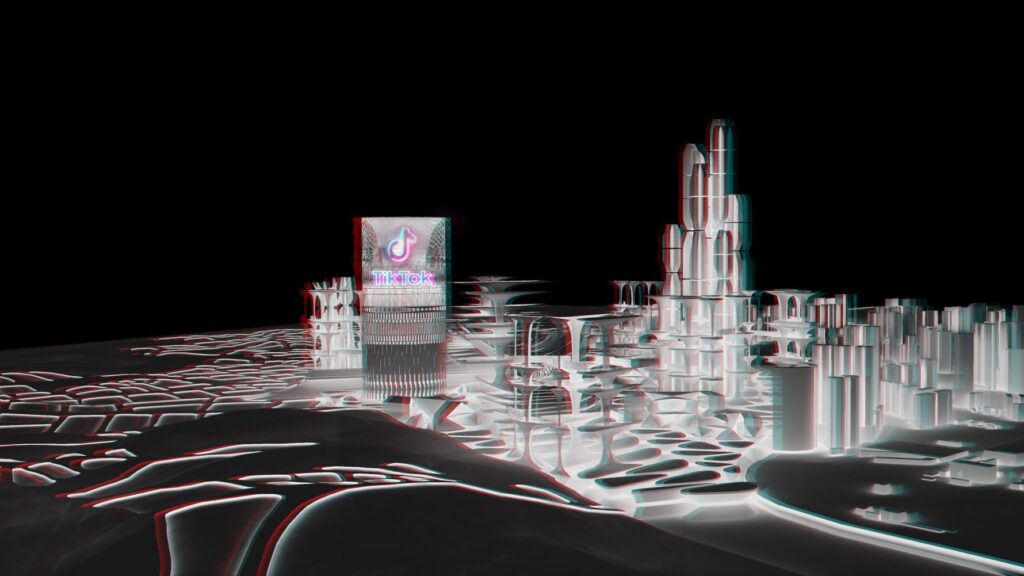
Algoritmi sociali e segregazione
Si posiziona su un piano ugualmente politico Pechino pieghevole di Hao Jingfang (郝景芳), pubblicato in italiano nella collana Asia, che curo per add editore insieme a Ilaria Peretti. Qui, l’autrice immagina la capitale cinese divisa in tre livelli temporali che si alternano come pieghe di carta, una Pechino che si piega letteralmente su sé stessa per assegnare spazi, ore, risorse e possibilità a tre diverse classi sociali: i ricchi vivono sei giorni alla settimana, la classe media due giorni, e gli ultimi della scala sociale appena 24 ore, durante le quali devono lavorare. Quando una città intera si piega e si dispiega per dare spazio, letteralmente, a vite che non devono incontrarsi, Hao Jingfang ci parla della segregazione sociale, ma anche delle promesse mancate del progresso: un futuro tecnologico che non porta giustizia, ma riproduce – e spesso amplifica – le disuguaglianze che già conosciamo. L’architettura urbana in questa novella, premiata anch’essa con l’Hugo (prima e unica autrice donna cinese a ottenerlo), diventa algoritmo sociale, segregazione codificata.
Ciò che rende il racconto memorabile non è solo la precisione della costruzione distopica, ma la capacità di restituire l’esperienza quotidiana di chi abita queste fratture. I personaggi si muovono all’interno di un paesaggio regolato tecnologicamente, ma portano dentro sogni, desideri, malinconie. Il futuro, in questo immaginario, non è solo uno spazio di oppressione, ma anche un terreno fragile di contatto e possibilità. Le crepe nel sistema non vengono idealizzate, ma diventano i luoghi in cui la politica si fa esperienza vissuta.
La scrittura di Xia Jia (夏笳) si muove sul crinale sottile tra fantascienza e filosofia, tra sperimentazione narrativa e riflessione sul linguaggio. Nei suoi racconti, popolati da fantasmi e robot (si veda ad esempio uno dei più celebrati, L’estate di Tongtong, disponibile in italiano), sperimenta loop, alternanze di registro, per costruire un ambiente affettivo in cui tecnologia e umanità non sono mai opposti, ma intrecciati in un unico respiro. Non sorprende che, anche quando sceglie di scrivere direttamente in inglese, Xia Jia lo faccia come se stesse giocando a un gioco speculativo: nel racconto What Does the Fox Say, descrive il suo processo creativo come una sorta di “algoritmo” costruito in collaborazione con motori di ricerca e software di traduzione, spingendo la scrittura oltre la soglia dell’umano. Per Xia Jia, la letteratura diventa un laboratorio in cui esplorare l’intertestualità che plasma il nostro tempo – collage, citazione, parodia – ma sempre con la consapevolezza che un algoritmo, per quanto perfetto, non potrà mai cogliere il piacere sottile del riconoscimento, il momento in cui un lettore umano sussurra “so da dove viene questa frase”. È in questa tensione tra macchina e umanità, tra codice e intimità, che la sua scrittura rivela la sua natura più filosofica: una continua interrogazione su cosa significhi essere vivi, connessi, consapevoli.
Se Xia Jia lavora sulla soglia tra umano e postumano esplorando il linguaggio come spazio d’ibridazione, Lin Hsin-Hui (林新惠) radicalizza lo sguardo sul corpo. Qui mi sono concessa un passo fuori dalla Cina continentale, pur restando nell’ambito sinofono: Lin Hsin-Hui è infatti un’autrice taiwanese, erede di un’incomparabile tradizione queer radicata sull’isola. Ho voluto deliberatamente oltrepassare i confini statali, proprio per tracciare un gesto che fosse, paradossalmente, l’opposto dell’imperialismo cinese che rivendica Taiwan come propria provincia. Intravedo in questa scelta un potenziale di solidarietà transnazionale, offerto da una letteratura di genere radicale che non conosce frontiere. Sarebbe stato un errore, credo, tralasciare un testo così attuale e inquietantemente plausibile nel raccontare un possibile sguardo sulla tecnologia. Il suo romanzo Intimità senza contatto (ed. originale del 2023, ed. italiana uscita del 2025), racconta un mondo governato da un’intelligenza artificiale che, sulla base dei dati raccolti sull’intera popolazione terrestre, ha decretato che la radice dell’infelicità umana è il contatto fisico. Qui la sperimentazione non è solo narrativa, ma profondamente politica: un programma di accoppiamento tra umani e androidi in cui i corpi sono stati “neutralizzati” – senza sesso, razza, età, genitali – promette un’uguaglianza radicale, ma l’identità incarnata resiste. La protagonista percepisce la mancanza del proprio corpo originario, cerca tra le gambe una fenditura che non c’è più, ricorda ciò che la tecnologia pretendeva di cancellare. In questa società, l’intimità non è più un’esperienza, ma una performance normata, misurabile, sorvegliata. L’amore diventa asset, capitale relazionale, indice di valore sociale. La dissidenza si insinua in gesti minimi: un abbraccio, un contatto, un ricordo. Anche la madre della protagonista, segnata dalla perdita del marito per “contaminazione emotiva”, insegna alla figlia a evitare il tocco, confondendo protezione e isolamento. Ma la distanza non salva: il dolore si sposta, si trasforma, si accumula.
Metamorfosi riproduttive, dissidenza e futuri ibridi
Ci vorrebbe un focus esclusivo sul tema del ruolo riproduttivo della donna nella società cinese e la sua rappresentazione e interpretazione nella fantascienza. Ma per ragioni di spazio mi soffermerò su un lavoro pionieristico di Zhang Jing (张静), nata nel 1938 e attiva nella fantascienza dal 1985. In L’amore di Nüwa (女娲恋, 1991), con cui ha vinto il suo terzo Galaxy Award quell’anno, racconta la storia di una ragazza aliena che si assume la responsabilità di garantire la riproduzione della specie umana. La protagonista ha il nome della dea che, nella mitologia cinese, “ripara il cielo spezzato e crea gli esseri umani”. È un testo che non a caso esce in quel periodo storico in cui, in alcuni circoli intellettuali in dialogo con idee provenienti anche dall’estero, il ruolo della donna nella società iniziava a essere messo in discussione. Prosegue su questa scia Chi Hui (迟卉), nata nel 1984, e autrice di Nido di insetti (虫巢, 2008), racconto in cui interroga la violenza epistemica e di genere radicata nelle strutture di potere umane. Il racconto immagina un pianeta pacifico e matriarcale in cui le specie convivono in simbiosi e hanno un sistema riproduttivo collettivo, distribuito. Questo mondo è incomprensibile per i colonizzatori terrestri, ostili a un modello di potere femminile. Il racconto riflette sulla violenza coloniale, maschilista e antropocentrica, e sulla difficoltà degli umani a comprendere forme di vita e organizzazione sociale radicalmente diverse, in cui le tecniche riproduttive hanno frantumato le categorie binarie e spalancato mondi ibridi, dove la metamorfosi è la norma e l’identità è costantemente negoziata.
Ciò che accomuna queste scrittrici è un rifiuto delle semplificazioni. Non offrono né incubi tecnologici né utopie salvifiche: costruiscono scenari aperti, esperienze di vita, possibilità. Il critico Mingwei Song (宋明炜) ha definito questa corrente “neo-barocco”, un paradigma estetico e conoscitivo che la interpreta come una risposta ai cambiamenti radicali nella cultura e nella scienza contemporanea in analogia con la crisi epistemologica del Barocco storico. Il termine, come l’autore spiega in Fear of Seeing. A poetics of Chinese Science Fiction,è debitore ai testi La piega: Leibniz e il Barocco di Gilles Deleuze, che descrive il barocco come una funzione operativa che genera pieghe infinite, e a Neo-Baroque: A Sign of the Times di Omar Calabrese, che lo legge come lo “spirito del tempo” nella cultura contemporanea. Come nel Barocco, il neo-barocco rifiuta una visione lineare del tempo e dello spazio, proponendo invece immagini che riflettono la complessità del presente e una conoscenza in continua trasformazione. In questo contesto, la fantascienza neo-barocca “genera nuove modalità di discorso letterario che alienano ciò che diamo per scontato, aprono gli occhi a conoscenze insorgenti e immagini sovversive, ed evocano una gamma di sensazioni (ir)reali o virtuali che vanno dall’infernale al sublime, dallo spettrale allo spettacolare, dall’inebriante all’esuberante, dal trascendentale all’apocalittico, dall’umano al postumano, e così via. La tesi di Mingwei Song è che la produzione contemporanea che rientra in questo universo letterario mostri la futilità del pensiero binario.
Attraversando queste storie, capiamo che non parlano solo di futuri remoti; ci riportano al presente, ci costringono a rivedere i nostri spazi, le nostre relazioni, le nostre infrastrutture emotive. Ci domandano: Chi ha diritto al futuro? Di chi è il tempo? Quali corpi possono sopravvivere all’impatto della tecnologia? E, soprattutto, come possiamo imparare a convivere senza annientarci?
Traduzioni disponibili in italiano
Questo articolo rappresenta un tentativo parziale di tracciare una panoramica delle autrici cinesi di fantascienza contemporanea, con un’attenzione particolare al loro sguardo sulla tecnologia. La riflessione si basa sulle poche opere disponibili in traduzione italiana e inglese, e si avvale anche di fonti secondarie e del lavoro di divulgazione di studiose come Regina Kanyu Wang. Per completare il quadro, segnalo di seguito le traduzioni disponibili in italiano, dove compaiono altre autrici che non ho potuto approfondire nel corpo del testo.
Duan Ziqi e Francesco Verso, Zendroide, Future Fiction, 2022
Gu Shi, Il continuo di Möbius, Future Fiction, 2024
Hao Jingfang, Pechino pieghevole, add editore, 2020
Lin Hsin-Hui, Intimità senza contatto, add editore, 2025
Mu Ming, Colora il mondo, Future Fiction, 2021
Regina Kanyu Wang, Nuvole e nebbia, Future Fiction, 2019
Tang Fei, Spore, Future Fiction, 2022
Xia Jia, Festa di primavera, Future Fiction, 2022
Antologie (tra parentesi i nomi delle autrici tradotte)
AA.VV., Nebula. Fantascienza contemporanea cinese, Future Fiction (Xia Jia), 2018
AA.VV., Sinosfera. Fantascienza contemporanea cinese, Future Fiction (Fan Yilun, Tang Fei), 2018
Caratteri n.9, Mondi futuri, Foreign Languages Press (Xia Jia, Mu Ming, Tang Fei), 2019
AA.VV., ArtifiCina. Fantascienza contemporanea cinese, Future Fiction (Fan Yilun, Tang Fei, Peng Simeng), 2019
AA.VV., Il sole cinese, Future Fiction (Xia Jia, Mu Ming, Tang Fei, Chi Hui, Su Min), 2021
AA.VV., Futugrammi. Fantascienza contemporanea cinese, Future Fiction, 2020 (Bella Han, Su Min), 2021
AA.VV., Il colibrì e la pagoda, Future Fiction, 2023 (Wang Kanyu), 2023
Chen Qiufan (a cura di), Il Tao delle macchine, LUISS (Gu Shi e Mu Ming), 2025
Negli ultimi mesi ho notato un fenomeno interessante tra le pagine di meme politici che seguo: l’emergere di una wave sul socialista ottocentesco Ferdinand Lassalle (1825-1864). Primo agitatore politico socialista della storia tedesca, Lassalle fu il fondatore dell’Associazione generale dei lavoratori tedeschi (da cui dopo la sua morte sarebbe nato il Partito socialdemocratico di Germania, l’odierno SPD) e il promotore di una visione del socialismo contrapposta a quella marxista, basata non sulla costruzione di organizzazioni autonome dei lavoratori con scopi rivoluzionari ma sulla competizione elettorale e la collaborazione con lo stato – figlia di una visione hegeliana dello stato in cui questo non era uno strumento di dominio delle classi dominanti ma un universale in grado di arbitrare tra i particolarismi della società.
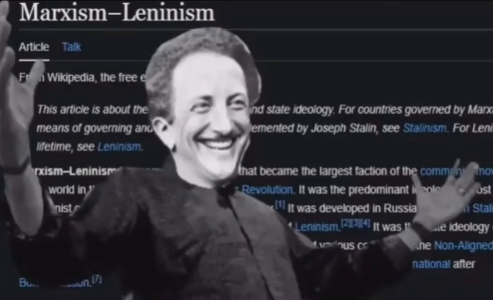
Nella quasi totalità dei meme Lassalle è considerato una figura negativa. Marx lo considerava un opportunista disposto a moderare le rivendicazioni delle masse lavoratrici in cambio di concezioni da parte delle classi dominanti: un’accusa che i comunisti avrebbero seguitato a rivolgere alla socialdemocrazia, e che le pagine che fanno questi meme – come @rosemediayt – radicalizzano muovendola contro tutta la storia del socialismo. Il loro punto è il modo di dire “non era vero socialismo” preso alla lettera, approfondito e rivendicato: ogni socialismo realmente esistito, non importa di che periodo storico o di che ispirazione, è stato sempre e solo una versione autoritaria della socialdemocrazia. Il socialismo non è mai esistito, sono esistite solo corruzioni dell’idea: un punto di vista a metà tra la Redpill e una versione laicizzata dello gnosticismo. Che arriva alla condivisione di posizioni anticomuniste, come la teoria del totalitarismo e l’idea che comunismo e nazifascismo siano sostanzialmente dei mostri gemelli accomunati dalla statolatria e diversi solo nei dettagli.
Alcuni esempi di meme di questo tipo: un video in cui una frase presa dal pezzo rap “Like that” di Future e Kendrick Lamar (“Motherfuck the big three, nigga, it’s just big me”) viene illustrata con le tre teste del socialismo (Marx, Engels, Lenin) sostituite su “big me” dalla faccia di Lassalle per dire che tutto il marxismo-leninismo è in realtà lassalleismo (un ulteriore layer è dato dalla presenza del verso della N-word e dal fatto che Marx ha famosamente usato la N-word per riferirsi a Lassalle in una lettera a Engels). Un meme nel formato “every squad got the” dove i vari leader socialisti del Novecento vengono etichettati in vari modi, nessuno dei quali ha niente a che vedere col socialismo: Stalin è il “burocrate termidoriano”, Mao è il “nazionalista agrario” e via dicendo. Un poster in stile maoista in cui Lassalle occupa la posizione che di solito è di Mao, quella del sole, e sotto i suoi raggi avanzano tutte le figure del socialismo e del fascismo storici: Hitler e Stalin, Chruscev e Deng Xiaoping, Mussolini e Xi Jinping.
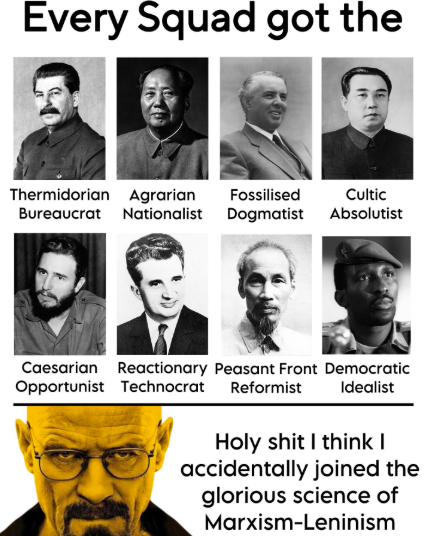
Non si tratta di un dibattito nuovo, ma del riemergere in forma di meme di discorsi che si facevano già negli anni Settanta quando il movimento studentesco e i gruppi extraparlamentari si contrapponevano ai Partiti comunisti e l’idea di autonomia dei lavoratori al socialismo sovietico burocratizzato. La cosa interessante è che stavolta accanto al sottotesto implicito in questa visione (“il vero socialismo è il nostro, che non si è mai realizzato”) ne esiste un altro, opposto, che ricalca il famoso meme dell’astronauta con la pistola: il socialismo è sempre stato solo una versione autoritaria della socialdemocrazia? Always has been. Non c’è mai stato – né potrà mai esserci – nulla di più, e comunque questo socialismo non che proprio ha fatto male alla causa dell’avanzamento dell’umanità – per cui fatevelo andar bene.
È un messaggio che non emerge solo dai pochi meme apertamente lassalleani del Politigram, ma soprattutto dal mondo reale: è ciò che sostiene, in modo inconsapevole, tutta quella sezione di sinistra occidentale che oggi è affascinata dalla Cina, dai campisti che parlano di multipolarismo come OttolinaTv e Marx21 ai liberali progressisti orfani del liberalismo progressista come Adam Tooze. È il messaggio dei caroselli Instagram compagni che ti consigliano libri per approfondire il socialismo con caratteristiche cinesi o ti spiegano che la Cina ha tirato fuori dalla povertà 800 milioni di persone.

Incredible things are happening nella sfera dell’ideologia
Il socialismo con caratteristiche cinesi è socialismo, non un qualche altro “ismo
(Xi Jinping)
Uno dei fenomeni politici più rilevanti dell’ultimo decennio è stata l’ascesa di Xi Jinping e il ritorno della politica in Cina dopo gli oltre trent’anni di de-politicizzazione dell’era della riforma e apertura 改革开放, la traduzione cinese della fine della storia fukuyamiana. Questo ritorno è stato in primis materiale: la campagna anti-corruzione diventata un metodo di governance per ri-radicare il Partito comunista a ogni livello della società, l’intervento statale in diversi settori dell’economia per riequilibrare gli squilibri creati dai decenni di laissez-faire post-dengista. Ma è stato anche ideologico: una nuova enfasi sul socialismo dopo decenni di enfasi sulle sue caratteristiche cinesi. Nel 2018, Xi ha presidiato a una sontuosa cerimonia nella Grande sala del popolo di Pechino per il 200esimo anniversario della nascita di Marx, grazie alla quale abbiamo un video in cui canta “L’internazionale” davanti a un enorme ritratto del filosofo tedesco.
Accanto a questo Marx, però, nella Cina di Xi ce ne sono anche altri. C’è la sua versione anime uscita a puntate su Bilibili che ne faceva un eroe da cartone animato scollegato dalla realtà, e la sua versione sinizzata apparsa in una serie tv prodotta dal governo provinciale dell’Hunan in cui dialogava con Confucio riconoscendo le somiglianze tra le loro visioni del mondo. Sembrano personaggi di Italian brainrot e in effetti l’agglomerato teorico del socialismo cinese è un AI slop ideologico, il prodotto delle allucinazioni di un LLM (Large Language Model): marxismo-leninismo, pensiero di Mao Zedong, teoria di Deng Xiaoping, Teoria delle tre rappresentanze, Prospettiva scientifica sullo sviluppo e Pensiero di Xi Jinping sul socialismo con caratteristiche cinesi per una nuova era. Già il solo nome ufficiale dell’ideologia di stato, con la sua litania di formule ufficiali, sembra un testo prodotto da Chat GPT in cui ogni parola occupa uno spazio non in virtù di una relazione di senso con ciò che la precedente ma in virtù di un calcolo probabilistico. E se leggi un qualsiasi testo scritto nel gergo di partito, ad esempio un discorso di Xi Jinping, l’impressione è ulteriormente confermata: ti sembra di leggere un testo generato da Chat GPT, in cui una serie di formule standard come “comprehensively deepening reform” o “whole-process people’s democracy” sono ripetute ad nauseam e fatte interagire tra loro con minime variazioni. Come nei testi generati da ChatGPT, è chiaro che non c’è vita sotto la superficie.
Nonostante o forse proprio per questa scarsa chiarezza, il ritorno della politica in Cina ha dato nuova linfa al dibattito perennemente in corso in Occidente sulla natura del suo sistema economico-politico. Chi guarda alle questioni materiali fa notare come il modo di produzione dominante nell’economia politica cinese sia senza ombra di dubbio quello capitalistico, chi guarda alle questioni ideologiche accetta questo punto ma lo considera secondario notando come il potere politico sia nelle mani di un partito d’avanguardia che si considera legato all’eredità del socialismo novecentesco. Branko Milanovic (e altri) ha paragonato il sistema cinese all’URSS della NEP, quel periodo di ritirata strategica voluto da Lenin dopo i traumi della guerra civile, in cui il partito-stato sovietico apriva spazi controllati al mercato e al commercio privato. Ho-fung Hung l’ha paragonato al corporativismo fascista, in cui il partito-stato cinese disciplina in modo paternalistico il capitale privato per un interesse superiore.
Tutte queste opinioni riguardo alla natura del socialismo cinese, prese singolarmente, risultano convincenti. È innegabile che lo stato cinese si comporti in modo paternalista e corporativo rispetto al capitale privato, disciplinandolo ma scegliendo sempre in ultima analisi di tutelarne gli interessi generali. E però anche le similitudini con l’esperienza storica della NEP sovietica, in cui un partito-stato lasciava spazio al mercato mantenendo uno stretto controllo, sono innegabili. Xi Jinping sarà anche un burocrate legato a doppio filo all’era delle riforme, ma c’è un fondo di verità nelle copertine dell’Economist sul “nuovo Mao” e lo vediamo quando Xi appare dai rostri di piazza Tiananmen con la zhongshan zhuang grigia come il suo predecessore. Quale di questi paragoni è quello giusto? Quale di queste immagini della Cina contemporanea rispecchia la realtà?
Proprio perché sono tutte convincenti, nessuna è vera; proprio perché sono tutte razionali, nessuna è reale. La Cina contemporanea non è il fascismo italiano né l’URSS della NEP né il maoismo né il socialismo come lo intendono i comunisti occidentali. Come ha detto Xi Jinping, il socialismo con caratteristiche cinesi è socialismo, non qualche altro “ismo”. Se mai il socialismo con caratteristiche cinesi è una nuova variante di una cosa di cui in passato sono state varianti il maoismo, l’URSS della NEP e il fascismo storico. E qui torniamo ai meme su Lassalle.
L’intenzione originaria
L’arrivo dell’era di Xi Jinping è stato accompagnato dalla comparsa di un nuovo slogan politico nel noiosissimo politichese del Partito comunista cinese: 不忘初心, “non dimenticare l’intenzione originaria”. Come avviene spesso per le parole d’ordine nel contesto politico cinese è stata elaborata da un accademico, Huang Huilin, in un articolo sul Quotidiano del popolo nel 2013 dedicato al 120esimo anniversario della nascita di Mao, poi diventare parte del vocabolario politico ufficiale tra il 2016, quando Xi Jinping l’ha utilizzata come tesi centrale di un discorso che ha tenuto in occasione del 95esimo anniversario del Partito, e il 2017, quando l’ha citata nel suo rapporto politico al XIX congresso del PCC.
L’origine della frase è un’interpretazione di una sutra buddista (del resto Carl Schmitt, che piace tanto ai funzionari del PCC, ha scritto che tutti i concetti politici sono concetti religiosi secolarizzati) che si riferisce all’aderire alle intenzioni originarie di Buddha; nell’uso del PCC, si riferisce al fatto che la missione e la fonte di legittimità del Partito comunista è il suo lavoro per il benessere e la felicità del popolo cinese. Non un obiettivo ma un compito, non un risultato da raggiungere ma qualcosa da portare continuamente avanti: il movimento è tutto, il fine è nulla. Siamo arrivati così a Eduard Bernstein, dirigente dell’SPD, stretto collaboratore di Marx e Engels, e teorico del marxismo revisionista.
lo scopo di un sistema è ciò che quel sistema fa, e ciò che fa l’ideologia del socialismo con caratteristiche cinesi è permettere a ciascuno di vederci dentro quello che più gli aggrada
Il revisionismo bernsteiniano, con la sua negazione della necessità di una rottura rivoluzionaria e la predilezione per un percorso di riforme graduali attraverso cui arrivare al socialismo, è stato il punto di rottura che ha portato alla nascita del movimento comunista come lo intendiamo comunemente – ai partiti comunisti, al leninismo, all’esperienza storica dell’Unione Sovietica. Tutta quella storia può essere vista come la storia di una scissione purista, di sinistra, del movimento socialdemocratico che, nato dal conflitto tra Marx e Lassalle, aveva finito poi con Bernstein per ricadere verso il secondo di quei due poli. Quando fanno i meme su Lassalle, i teenager del Politigram stanno dando voce anche loro agli stessi sentimenti che hanno portato a quella scissione, solo rivolgendoli contro la scissione stessa. Il revisionismo come un cancro che estirpi e che ritorna. L’influenza di Lassalle come un’impurità di cui per quanto si provi non ci si riesce mai a liberare.
La prospettiva della sinistra occidentale oggi affascinata dalla Cina è, inconsapevolmente, questa ma ribaltata: il cancro che non si riesce a estirpare, la macchia che non si riesce a lavare via… forse non si riesce perché non sono impurità ma elementi costitutivi, risultati necessari del processo. Forse se tutta l’esperienza storica del comunismo può essere condannata come una versione distorta della socialdemocrazia è perché la socialdemocrazia è l’intenzione originaria del comunismo. Ironicamente proprio chi vede il socialismo cinese come una forma di socialismo sta dando ragione ai meme su Lassalle: always has been, non può esserci niente più di questo usare lo stato per disciplinare il capitale, per fare quel tanto di ridistribuzione delle risorse che basta a potersene vantare presentandola come una diversità ontologica rispetto al capitalismo, e mantenere inalterati i rapporti di produzione vigenti.
“Il Partito comunista cinese”, ha scritto giustamente Yoshimi, “è il partito socialdemocratico più di successo della storia”. Il suo successo non sta tanto nel fatto di essere riuscito a mantenere il potere così a lungo o nei milioni di cinesi che ne hanno la tessera, quanto nell’aver risolto questa tensione tra socialdemocrazia e comunismo, che altrove ha portato alla separazione delle due parti, in un compromesso secondo cui un partito organizzato secondo i dettami leninisti agisce come partito socialdemocratico di massa, in cui i simboli rivoluzionari adornano la negazione della necessità di una rivoluzione, in cui Marx parla e Lassalle agisce, e con i risultati delle azioni di Lassalle si conferma la giustezza delle teorie di Marx. È un risultato ancor più notevole se pensiamo a che fine hanno fatto gli altri partiti comunisti prima e gli altri partiti socialdemocratici poi – compresa la stessa SPD di Marx e Lassalle, oggi attestata su percentuali di voto che non vedeva dai tempi delle leggi antisocialiste di Bismarck.
È un risultato possibile proprio grazie alla scarsa chiarezza di quell’impasto chatgptiano che è l’ideologia ufficiale – lo scopo di un sistema è ciò che quel sistema fa, e ciò che fa l’ideologia del socialismo con caratteristiche cinesi è permettere a ciascuno di vederci dentro quello che più gli aggrada: i comunisti ci vedono un partito leninista che prende seriamente la propria discendenza da una rivoluzione, i liberali progressisti un capitalismo dal volto umano grazie al forte impegno statale, gli anticomunisti un corporativismo fascista. Tutto vero, tutto falso. Del resto anche il Partito bolscevico si chiamava “partito socialdemocratico” e il suo leader avrebbe definito la socialdemocrazia “oggettivamente l’ala moderata del fascismo”.
[…] perché Brian Wilson? Cosa c’è di così speciale nei Beach Boys? In poche parole, Brian Wilson, e la band che per lungo tempo è stata una specie di estensione diretta del suo particolare genio – i Beach Boys –, è stato il musicista che più di ogni altro ha incarnato l’idea del lo-fi come evasione. Una pratica estetica dalle profonde conseguenze esistenziali e politiche – ambigua, gloriosa, contraddittoria, inquietante, a volte disastrosa, a volte sorprendentemente bizzarra – intesa come evasione dalle costrizioni e dalle fatiche del capitalismo contemporaneo. Un modo di creare melodie meravigliose in fuga dalla morsa di questo mondo, forgiate nella tragedia e nella bellezza, nel destino e negli incidenti. Un lo-fi acido (lo-fidelia?) da accendere, sintonizzarcisi e a cui abbandonarsi, con tutte le contraddizioni che questo comporta.
Nemmeno Paul McCartney – che Wilson stesso considerava il suo unico spirito affine – poteva avvicinarsi alla stranezza in cui Wilson si imbatteva con le sue esplorazioni nei territori del lo-fi. Infatti, se McCartney era, come Wilson e contrariamente a quanto si crede, uno sperimentatore nell’animo, innamorato di Stockhausen e delle stranezze da studio, che fuggiva letteralmente dalla società per comporre i suoi rivoluzionari dischi lo-fi – McCartney nel 1970, Ram nel 1971 e McCartney II nel 1980 – era allo stesso tempo e, stavolta al contrario di Wilson, impantanato in una certa domesticità di fondo. I suoi esperimenti lo-fi sembravano piccoli embrioni che galleggiavano placidamente nel loro sacco amniotico, sorvegliati dalla grazia amorevole di Paul e Linda McCartney, nel loro abbraccio idilliaco.
Una tale quiete mitologica potrebbe essere commovente, ma non potrebbe reggere il confronto con i viaggi psichedelici di Brian Wilson ai limiti dell’estasi e dell’esaurimento, che, proprio per la loro stranezza, mi appaiono come l’unico punto di partenza naturale per una lettura radicale del fenomeno lo-fi. Ma troppo, e troppo presto! Riavvolgiamo il nastro e ripartiamo dall’inizio. Un inizio piuttosto paradossale, visto che questa storia deve muovere i primi passi da uno dei dischi più straordinariamente hi-fi mai realizzati: Pet Sounds. L’agiografia di questo album è diventata giustamente parte integrante della storia del rock’n’roll. Pochi album sono stati lodati e commentati quanto l’undicesimo dei Beach Boys. Dopo tutto, ha portato i Beach Boys fuori dal loro guscio di infantile solarità, tutto surf e divertimento sulla sabbia, direttamente nel regno etereo di una forma quasi inedita di musica pop barocca e straziante. Un momento di svolta nella storia della musica e nella nostra coscienza collettiva. Pet Sounds nasce da uno strano esperimento esistenziale: nel 1964 Brian Wilson decide di lasciare le luci del palcoscenico al resto della band, composta per lo più dai suoi fratelli, per concentrarsi esclusivamente sulla produzione musicale. Era profondamente affascinato dall’approccio radicale di Phil Spector alla registrazione dei suoni: stravolgere la funzione dello studio trasformandolo in uno strumento a sé stante. Decise che, da quel momento in poi, si sarebbe sposato con la macchina proprio come Spector. «Non sono stato in grado«, ha detto Wilson «di pensare veramente come un produttore fino al momento in cui ho conosciuto il lavoro di Phil Spector. Allora ho cominciato a capire il senso di fare dischi. Sei nel settore per creare un disco, quindi progetti l’esperienza perché sia un disco piuttosto che una semplice canzone». Un altro fattore che contribuì al suo isolamento in studio fu sicuramente la competizione dilagante che sentiva montare con i Beatles, una band che secondo Wilson stava alzando la posta della produzione musicale a livelli impensabili:
[…]
La fuga di Wilson dal palcoscenico non fu però una scelta puramente artistica e disincarnata. Nell’aprile del 1965 ebbe la sua prima esperienza con gli acidi, una sostanza che per lui si sarebbe rivelata al tempo stesso una svolta e una frattura. Parlando dei suoi primi trip, confesser. felicemente: «Ho preso l’LSD – una dose intera di LSD – e più tardi, un’altra volta, una dose più piccola. Ho imparato molte cose, come la pazienza e la comprensione. Non posso insegnarvi o dirvi cosa ho imparato prendendolo, ma la considero un’esperienza molto religiosa». Quello che è certo è che gli acidi lo hanno messo in contatto con qualcosa che sta al di là del quotidiano. Con una forma di piacere non limitata dagli stretti confini della normalità. Ma i suoi viaggi mettevano alla prova anche la sua salute mentale. Gli acidi da soli non potevano abolire o alleviare la pressione di un’industria culturale che lo costringeva a sfornare successi a ritmi sempre più veloci, e in queste circostanze divennero un veleno per la mente di Wilson.
Si rivelò essere l’inizio del momento più sbalorditivo della sua carriera e al contempo di una tragica spirale discendente. I sintomi schizoaffettivi iniziarono a manifestarsi, insinuandosi come crepe uditive nella sua coscienza, e fu costretto a convivere con voci che lo rimproveravano continuamente. Come avrebbe ricordato in seguito:
Negli ultimi quarant’anni ho avuto allucinazioni uditive, tutto il giorno, tutti i giorni, e non sono riuscito a farle sparire. Ogni pochi minuti le voci mi dicono qualcosa di offensivo, il che mi scoraggia un po’, ma devo essere abbastanza forte da dire loro: «Ehi, volete smetterla di parlarmi? Vaff******! Non mi parlate, lasciatemi in pace!». Devo dire questo genere di cose tutto il giorno. È come se dovessi mettermi a litigare.
Si può solo immaginare quanto possa essere infernale l’esperienza del palcoscenico, con la sua buia fossa di fan, e la vita da celebrità in uno stato simile. «Quando ero sul palco sentivo delle voci che dicevano cose negative sul mio conto. Ancora oggi, quando sono in scena, devo costringermi a non ascoltarle. Ma quando il concerto finisce, le voci tornano». Anche la sua depressione peggiorava: «La mia depressione va molto a fondo, molto in profondità. Mi deprimo al punto di non riuscire a fare nulla, nemmeno a scrivere canzoni, che è la mia passione». La psichedelia è stata per Brian Wilson l’esperienza di una profonda rottura dell’io, rivoluzionaria e infernale, che ha messo a nudo sia la miseria della sua condizione materiale e di quella del mondo, sia l’inaspettata possibilità di qualcosa di diverso da ciò che abbiamo e che giace latente – da qualche parte nello spazio e nel tempo. O, come disse una volta Deleuze in maniera più elegante: «Un mitragliamento della superficie per trasmutare il pugnalamento dei corpi, oh psichedelia».

Un’esperienza evidentemente gravida di terribili verità sul mondo e su Wilson stesso, in termini molto più semplici. «Ha mandato in frantumi la mia mente e sono tornato, grazie a Dio, in non so quanti pezzi». Pet Sounds era un modo per esplorare questa frantumazione con altri mezzi e al di fuori delle costrizioni velenose che rendevano la psichedelia così nefasta per Brian Wilson. O, come dice Deleuze,
un modo per non rinunciare alla speranza che gli effetti delle droghe e dell’alcol (le loro «rivelazioni») possano essere rivissuti e recuperati per sé stessi sulla superficie del mondo, indipendentemente dall’uso di queste sostanze, a condizione che le tecniche di alienazione sociale che ne determinano l’uso siano rovesciate in mezzi rivoluzionari di esplorazione.
Date tutte queste premesse, è diventato un luogo comune considerare Pet Sounds il prodotto della «fragilità emotiva di Brian». Il suono incantevole di qualcuno che sta per esplodere in mille pezzi, chiuso in studio tra macchine e nastri che si aggrovigliano tutt’intorno. Sebbene questa sia una verità inconfutabile, in un certo senso ho sempre pensato che fosse un’idea scandalosamente semplicistica; un’idea che sminuisce la portata del malcontento di Pet Sounds, un sentimento che innerva l’intero disco, riducendolo alle difficoltà individuali di Wilson.
Naturalmente, il dolore di una persona è sempre, in un certo senso, un’isola a sé stante, e non vorrei mai dover spiegare il dolore espresso in modo così chiaro da Wilson con una narrazione più ampia o con un concetto generale. C’è sempre un vuoto nella sofferenza: non posso mai raggiungere e toccare direttamente il tuo mal di denti, o il tuo cuore spezzato, o qualsiasi altra cosa. Quando si parla di qualsiasi tipo di dolore non bisogna mai dare spiegazioni, ma cercare di dare spazio a chi soffre di esprimere liberamente la propria condizione e ciò che ritiene stia accadendo intorno a sé. Ma, allo stesso modo, non si dovrebbe mai trattare il dolore come qualcosa che esiste nel vuoto, che si presenta da solo, senza contesto. Ogni sofferenza è una sofferenza all’interno di determinate condizioni: esistenziali, sociali, persino cosmiche, se ci sentiamo avventurosi.
l’espressione della sofferenza (e della gioia, ovviamente) di Brian Wilson in Pet Sounds aveva certamente un messaggio per l’umanità intera: la volontà di evadere e di realizzare qualcosa che uscisse dalla noia, dalla miseria e dall’accanimento della vita capitalistica, con l’aiuto dei macchinari dello studio di registrazione al massimo delle loro potenzialità
L’angoscia umana è sempre qualcosa che ha a che fare con l’umanità nel suo complesso, in un determinato momento, e l’angoscia di Brian Wilson non è certo diversa. Analizzare un album così profondamente legato alla malattia mentale e al dolore, un disco che Wilson considerava un vero e proprio «album di schizzi della sua vita», come espressione di una fragilità emotiva privata, è mutilante: lo priva di gran parte del suo significato, escludendo il mondo più ampio in cui è stato realizzato. Ne addomestica le parole e il suono. Il dolore, come le origini, è sempre un evento di cui si deve parlare al plurale, essendo legato alla nostra fugace esistenza, e che parla dell’esistenza umana nella sua interezza. E l’espressione della sofferenza (e della gioia, ovviamente) di Brian Wilson in Pet Sounds aveva certamente un messaggio per l’umanità intera: la volontà di evadere e di realizzare qualcosa che uscisse dalla noia, dalla miseria e dall’accanimento della vita capitalistica, con l’aiuto dei macchinari dello studio di registrazione al massimo delle loro potenzialità. Realizzare un disco che ponesse fine a questo mondo noioso e costruisse una via d’uscita attraverso la più alta forma di produzione hi-fi disponibile all’epoca: la missione era questa. Quasi un’apocalisse del pop.
A mio parere ciò risulta evidente, più che in ogni altro luogo, nella traccia d’apertura del disco, «Wouldn’t It Be Nice». Una grande canzone d’amore, elegante e immensa, colma di desiderio adolescenziale. Due giovani amanti si fondono in una sola persona, desiderando che ogni bacio sia infinito. L’espressione di chi spera in qualcosa di meglio, in una passione più pura e in un futuro felice. Queste interpretazioni, che sono la lettura più superficiale e naturale, non esauriscono la profondità del brano, relegandolo in qualche modo agli strati più privati del desiderio e allo status di semplice canzonetta d’amore. Al di sotto di questo banale desiderio adolescenziale traspare qualcos’altro: una profonda frustrazione nei confronti di un mondo costituito da barriere, confini e scarsità di beni su ogni fronte – e l’urgenza di trasgredire tutto ciò. «Esprime la frustrazione della giovinezza, di ciò che non si può avere, di ciò che si desidera veramente e che si deve aspettare» ha ammesso Brian Wilson molto candidamente.
È sicuramente un sentimento inerente alla lussuria adolescenziale, ma trova in questa canzone un significato più ampio, slegato dalle necessità fisiologiche di un’età specifica, suscitato dalle costrizioni materiali di questo nostro mondo. In altre parole, è perseguitato dalla paura che, anche se la giovinezza potrebbe finire, queste costrizioni non saranno eliminate:
Maybe if we think and wish and hope and pray It might come true.
Brian Wilson, dopo tutto, aveva poco più di vent’anni ed era già sposato: non dovrebbe cominciare a diventare piacevole a quel punto? Il brano esprime la stessa frustrazione repressa che Herbert Marcuse aveva espresso appena dieci anni prima, quando aveva scritto: «La gente abita in concentrazioni di appartamenti – e possiede automobili private con le quali non può più fuggire in un mondo diverso. Ha enormi frigoriferi pieni di cibi surgelati. Ha decine di giornali e riviste che sposano gli stessi ideali. Ha innumerevoli scelte, innumerevoli gadget che sono tutti dello stesso tipo e che li tengono occupati distogliendo la loro attenzione dal vero problema, che è la consapevolezza che potrebbe lavorare di meno e determinare i propri bisogni e le proprie soddisfazioni».
You know it seems the more we talk about it It only makes it worse to live without it.
Sotto la patina di una dolce canzone d’amore pulsa il desiderio adolescenziale di «ciò che il capitale deve sempre ostacolare: la capacità collettiva di produrre, curare e godere», come disse Mark Fisher. Il bisogno di fuggire e di trovare un posto migliore in cui vivere sembra essere, fin dall’inizio, l’idea che corona le dolci melodie di Wilson. C’è il sospetto persistente che questo mondo, così com’è oggi, sia abbastanza osceno e certamente non un bel posto in cui stare. Bloccato nei gorghi dell’industria culturale e del mondo capitalista, Wilson sembrava desiderare di tirar fuori da tutto questo un numero alla Houdini. Il suo dolore e i suoi desideri non provenivano esclusivamente dalla sua psiche, ma anche dalle condizioni materiali del suo tempo, che erano davvero troppo ingombranti, esigenti, insoddisfacenti e strazianti per l’anima. «L’oscenità non si limita alla sessualità, perché oggi esiste una pornografia dell’informazione e della comunicazione, una pornografia dei circuiti e delle reti, delle funzioni e degli oggetti nella loro leggibilità, disponibilità, regolamentazione, significazione forzata, capacità di esecuzione, connessione, polivalenza, libera espressione…» scriveva Baudrillard, ed è difficile non pensare che Brian Wilson sarebbe stato in qualche modo d’accordo.
Poi arriva «Sloop John B» e qualcosa si rompe. Alla fine della prima metà dell’album, la maschera cade e il disagio nei confronti del mondo capitalista e dell’emaciato mondo libidico che lo accompagna si dissolve. «Sloop John B», fin dall’inizio, rende palpabile il disgusto per il presente. Lascia trasparire il desiderio di qualcos’altro. Nato come brano folk marittimo delle Bahamas, Brian Wilson lo scopre grazie al Kingston Trio, che lo registrà con l’inquietante titolo di «The Wreck of the John B». Questa volta, chiaramente, non si tratta di una canzone d’amore: racconta la storia di un marinaio arenato da qualche parte nell’Atlantico. L’uomo solitario si aggira per Nassau strafatto, ubriaco e malridotto, con un equipaggio di incompetenti e lupi di mare. Singhiozza per tutta la canzone:
I feel so broke up
I wanna go home.
La metafora è evidente. Brian Wilson è bloccato in studio, claustrofobico e circondato da nastri e strani strumenti che producono un milione di suoni, costretto a far girare la macchina dei Beach Boys per sfornare sempre più soldi per la sua casa discografica e per l’industria culturale in generale. Si sente esausto e finito, vorrebbe solo andarsene ed essere felice; trovare una casa e potersi godere la propria vita come si deve. Non c’è da stupirsi che si sentisse come su una nave che affonda! Voleva sciogliere i legami che lo vincolavano a un’etichetta discografica, allo showbiz e all’economia mondiale. C’è quasi un elemento folk-horror, alla Wicker Man, nella canzone: questa natura selvaggia (il mare aperto, la nave che affonda, l’equipaggio infuriato) che riflette la nevrosi dei moderni, quelli che vivono sotto il capitalismo – in altre parole, noi. L’oscenità che Wilson sente intorno a sé è soffocante e la dolce melodia serve solo a trasmettere tutto il digrignare i denti e lo stringere i pugni di Wilson.
È ovviamente un brano cantato da qualcuno che pensa che la sua situazione sia offensiva e deprimente – che vorrebbe far toccare con mano all’ascoltatore il proprio desiderio di un nuovo mondo e il suo disgusto per quello che abbiamo. La canzone è avvolta da un’oscura psichedelia:
Why don’t they let me go home?
This is the worst trip I’ve ever been on.
Il suono di un mondo così piccolo e angusto da essere diventato invivibile. Del desiderio di viaggi migliori e di una bella vita. Da questo momento in poi inizia una lunga dissolvenza a nero, una delle più commoventi nella storia della musica pop. Il tema centrale, il voler fuggire da questo mondo pur essendovi bloccati, diventa quasi insostenibilmente pressante: cosa significa desiderare un mondo o una vita postcapitalista per noi? Questo dolore scomparirebbe? Possiamo anche solo iniziare a immaginare un mondo nuovo? Queste domande sono così insistenti che, lungo il percorso, troviamo persino una canzone che parla apertamente e in maniera inequivocabile del non adattarsi all’infernale e tortuosa America capitalista.
Ci avviciniamo pericolosamente al nome di ciò da cui vorremmo fuggire: il nostro attuale sistema economico. Una canzone quasi apertamente anticapitalista, in altre parole. È cantata dal punto di vista di chi continua a cercare un posto dove stare. Lui è un buono a nulla, anche se gli viene detto che è intelligente. Non ha nulla di sbagliato, in realtà, ma il mondo in cui vive non gli permette di trovare le cose di cui ha bisogno. La sua vita emotiva è prosciugata dalle vicissitudini di una quotidianità vuota. Le rivoluzioni, o perlomeno un qualche spirito di gruppo o qualcosa che lo aiuti a sentirsi meno solo in questa situazione di stallo, non si trovano da nessuna parte:
Every time I get the inspiration
To go change things around
No one wants to help me look for places
Where new things might be found.
Non esiste alcuna solidarietà che gli permetta di tenere la testa fuori dall’acqua, nessun movimento o comunità o organizzazione che gli garantisca la speranza di una via d’uscita realistica, o anche solo l’ombra fugace di un miglioramento o di una consolazione. È forse possibile sognare qualcos’altro?
Wilson soffre palesemente di quel malessere che Mark Fisher ha diagnosticato nel suo libro più celebre, Realismo capitalista – l’incapacità di immaginare qualcosa di differente dal deserto emotivo e fisico del capitalismo che abbiamo ereditato, e che ha precluso qualsiasi azione comune contro lo stato attuale delle cose. «L’impotenza riflessiva equivale a una visione del mondo non dichiarata […] e ha il suo correlato in alcune patologie molto diffuse», ed è abbastanza evidente che sia stato il capitale a fare ammalare Wilson. Il ritornello recita: Sometimes I feel very sad. La canzone si chiama «I Just Wasn’t Made for These Times»: anche il titolo è un pugno allo stomaco. Pet Sounds si avvia quindi alla sua naturale conclusione. Dopo questo dolce tour de force, la traccia conclusiva, «Caroline No», sembra un momento apicale – il picco febbrile in cui tutta la tensione viene finalmente scaricata. Tragicamente, devo aggiungere, visto che si rivela essere un’azzeccata ripresa del brano che apre l’album, «Wouldn’t It Be Nice»; una triste riproposizione del suo nucleo nevrotico.
La canzone è, ancora una volta, un esercizio di massima ambiguità, che esaurisce ciò che l’album è stato finora: una dolce ballata su un amore amaro, lentamente rosicchiato dal tempo e dalla banalità, consumato dalla pura inerzia. Due figure contrastanti si intrecciano contraddittoriamente: Caroline, la ragazza che Wilson amava al liceo, l’epitome di un piacere così pieno da infrangere i limiti della realtà, e l’attuale moglie di Wilson, con tutti gli inevitabili dettagli insignificanti che costellano ogni relazione, presentata qui come l’archetipo di come le cose sono realmente nella loro pallida e quotidiana tristezza. Anche il titolo stesso è un po’ come Giano: bifronte. Questa scissione inconciliabile è presente anche nelle parole che la battezzano. Lette entrambe ad alta voce, suonano come «Caroline No», un lamento di profondo malcontento e rifiuto per come stanno le cose, e «Carol, I know», in cui si respira tutta la rassegnazione di chi deve vivere in un mondo che non sente come casa propria. Niente viene risolto e siamo lasciati in mezzo all’impossibilità di vivere davvero secondo i nostri bisogni e desideri, lontano da qui.
Quando la canzone si spegne, non posso fare a meno di pensare che Pet Sounds suona come il miglior preludio mai registrato. Una lunga e maestosa ouverture verso qualcos’altro, qualcosa che possa effettivamente realizzare la fuga che la ossessiona. L’inizio di un atto di sparizione che poteva cominciare a compiersi solo attraverso una delle tante nascite della musica lo-fi. E visto come si svolsero le cose dopo l’uscita di Pet Sounds, direi che la mia, più che una sensazione, è la resa fedele di come Wilson stesso si sentiva riguardo al disco e agli eventi che seguirono di lì a poco.
Una volta terminato, iniziò subito a lavorare a un disco che sarebbe stato molto più grande, un progetto che avrebbe superato l’enormità del precedente. Nonostante le vendite relativamente mediocri, la casa discografica voleva di più, presentando Brian Wilson come un nuovo genio della forma più assoluta di musica pop hi-fi. Inoltre, una nuova schiera di artisti stava irrompendo sulla scena – Jimi Hendrix, i Doors, i Jefferson Airplane – minacciando di far sembrare addomesticate e superate anche le fughe psichedeliche dei Beach Boys più avventurosi. Pet Sounds doveva essere una transizione o un primo atto, anziché un punto fermo che sarebbe stato presto soppiantato dalla cultura capitalista in continua accelerazione e dalle sue controculture avversarie. Il progetto successivo, una collaborazione con il cantautore Van Dyke Parks, si sarebbe chiamato SMiLE e sarebbe stato finalmente quella fantasticheria fuori dal mondo che Pet Sounds aveva semplicemente introdotto.
Niente più ambiguità e desideri frustrati. Nessuna noia o infelicità sarebbe sopravvissuta a questa nuova pubblicazione: se la fuga era stata il grande miraggio di Pet Sounds, la sua frontiera sbiadita e il suo inconscio dolente, in SMiLE era destinata a diventare una realtà tangibile. La vera realtà. Vita e musica unite in qualcosa di più grande di tutto ciò che abbiamo mai avuto. «In una scala da 1 a 10, darei a Pet Sounds un 4 e a SMiLE un 10», così la vedeva Wilson. «Più esplorazione, più avventura». Una sinfonia adolescenziale rivolta a Dio: ecco cosa voleva che fosse. Il processo di registrazione fu straziante. Wilson si era sottoposto a una sconsiderata dieta tossicologica a base di acidi e cocaina, rendendo assolutamente atroce il già complicato compito di registrare una cosa così complessa. «Noi [Brian Wilson e Van Dyke Parks] eravamo così rallentati dalle droghe che riuscivamo a scrivere solo 20 secondi alla volta» affermerà in seguito.

Oltre alle sperimentazioni chimiche, Wilson era del tutto e, probabilmente, ancor più radicalmente assorbito da un’incrollabile mania creativa, interamente posseduto da qualcosa che sfuggiva sempre più al suo controllo. Il suo studio dell’inconscio sonoro del pop, da Pet Sounds in poi, aveva prodotto risultati inaspettati, portandolo in luoghi che probabilmente non aveva mai immaginato prima. Proprio come aveva previsto Guattari nella sua analisi delle radio libere, il fatto di giocare direttamente con la macchina stessa, con l’aspetto tecnico della registrazione e della produzione di suoni, ha messo Wilson di fronte a cose piuttosto strane: una valanga di domande politiche, esistenziali ed estetiche che probabilmente aveva ignorato prima di ritirarsi in studio. Domande che sicuramente lo hanno sconvolto, scuotendolo nel profondo della sua identità di musicista all’interno dell’industria musicale. Il suo isolamento discografico lo aveva portato a contatto con suoni non ortodossi e metodi sperimentali radicali, spingendolo a voler scrivere un’opera rock simile a una sala degli specchi in cui tutte le convenzioni e le norme, sia sociali che artistiche, dovevano essere sospese e stravolte. Un giorno di dicembre, nell’edificio di fronte scoppiò un minaccioso incendio. Wilson lo prese come un cattivo presagio. Sorprendentemente, lo fu davvero. Il disco non fu mai terminato.
Dopo un po’ di tempo, a causa di molte ragioni e vicissitudini, tutte piuttosto controverse e poco chiare – dai disaccordi interni a Carl Wilson che diserta la leva militare e viene incarcerato, oltre all’uscita di Sgt. Pepper’s Lonely Heart Club Band, un disco impossibile da superare per le orecchie di Wilson –, il progetto viene dichiarato fallito. Nel 2004, Brian Wilson pubblicò una versione rivisitata dell’album, Brian Wilson Presents SMiLE; nel 2010 la band pubblicò le sessioni rimanenti, ricreando un’idea di ciò che SMiLE avrebbe potuto essere. Ma nessuna di queste era il vero prodotto finito, perduto per sempre. Nel corso degli anni sono state pubblicate alcune canzoni complete di quel periodo, in particolare la perfetta e famosissima «Good Vibrations» e la gotica e inquietante «Surf’s Up». La seconda, una descrizione di ispirazione poesca delle rovine di un mondo da lasciarsi alle spalle con la sua nauseante e cieca aristocrazia, dà un assaggio di come sarebbe potuta suonare l’impresa impossibile, prima che la fuga promessa affondasse nel regno dell’avrebbe-potuto-essere, trasformandosi eternamente in un futuro incompiuto e perduto.
Ma l’industria culturale capitalista voleva ancora la sua offerta. Da vampiro qual è, non poteva accettare un «non posso» come risposta: doveva ancora risucchiare la forza vitale e l’energia pulsante di qualcosa per produrre una qualche forma di valore e di guadagno per sé, dopo tutto. I Beach Boys cercarono di rescindere anticipatamente il contratto, ma avevano l’obbligo di pubblicare un altro album che pendeva sulle loro teste. Dovevano inventarsi qualcosa. Brian Wilson decise di optare per un inaspettato piano B: creò il suo studio casalingo nell’ormai mitologica Bellagio Road di Los Angeles, richiamò il resto dei Beach Boys, lasciando andare i turnisti che aveva impiegato in precedenza per registrare i suoi portenti hi-fi, e registrò un album frastagliato e bizzarro su un registratore a otto tracce. Il tutto fu realizzato in una manciata di settimane.
L’album era crudo e spigoloso, anche nei suoi momenti più bucolici. Abbandonava completamente e bruscamente la produzione immacolata di Pet Sounds. Si chiamava Smiley Smile, un titolo allo stesso tempo euforico e minaccioso, come labbra aperte che mostrano denti lucenti. Un vero e proprio disco lo-fi. Senza dire altro su Smiley Smile, è necessario risolvere un’enorme questione preliminare: di che tipo di lo-fi si tratta? Perché Brian Wilson ha scelto di abbandonare l’hi-fi? A ben vedere, sembrerebbe soprattutto che non sia stato realizzato con l’intento consapevole di suonare nel modo in cui suona. La registrazione scadente fu un danno collaterale causato dalle circostanze, l’assedio contrattuale di un’etichetta discografica affamata. In poche parole, era lo-fi per errore. Il vero SMiLE, quello che non è mai stato e che si aggira per i corridoi di Smiley Smile, doveva essere un altro album elevato e hi-fi come Pet Sounds, giusto? In molte interviste e dichiarazioni, sia Brian Wilson che il resto dei Beach Boys hanno ribadito questa idea: se fossero stati lasciati a loro stessi, il disco avrebbe avuto un suono molto diverso.
Sono stati costretti a farlo in quel modo perché avevano poco tempo per consegnarlo. La nostra storia lo-fi inizia davvero con un errore? Mettendo da parte il potenziale rivoluzionario del fallimento, che Jack Halberstam ha ampiamente esplorato e che potrebbe essere una grande linea di argomentazione per difendere l’importanza di qualcosa come Smiley Smile – una vera e propria falla nella matrice del mainstream che inciampa nella sua strada verso il pubblico globale e non riesce a essere all’altezza delle norme estetiche del mondo capitalista – credo che ci sia un’argomentazione ancora più forte. Un’argomentazione che, banalmente, recita più o meno così: sì, Smiley Smile è stato un pretesto e le circostanze hanno costretto Brian Wilson a ricorrere al lo-fi, ma in realtà il risultato non è poi così lontano da ciò che SMiLE avrebbe dovuto essere. Non è stato affatto un fallimento o un errore!
Il sound dell’album è in qualche modo legato alla sperimentazione che Wilson portava avanti nel suo studio di registrazione, ed è stato possibile solo perché Brian era già profondamente affascinato dalle potenzialità dei suoni poveri. Le prove a sostegno di questa idea sono davvero numerose. Innanzitutto, Smiley Smile non è il primo disco dei Beach Boys che si possa definire lo-fi, o forse più precisamente proto-lo-fi.
Nel 1965, poco prima che Wilson iniziasse il suo inquietante esicasmo in studio, prendendo confidenza con paesaggi sonori radicali e con il pieno potenziale dei mezzi di produzione musicale, i Beach Boys avevano registrato un album intitolato Party!. Si trattava di un divertente piccolo album di cover, facile da ascoltare ma anche da dimenticare – a parte, ovviamente, i numerosi tormentoni che si sarebbero immediatamente incollati all’ascoltatore. L’unica caratteristica degna di nota è che fu registrato come se si trattasse di una vera e propria festa in spiaggia, con tanto di rumore di fondo, chitarre acustiche strimpellate e occasionali difetti. Prendiamo, per esempio, «Barbara Ann», il singolo più famoso del disco. Inizia con la band che strimpella senza scopo per qualche secondo e poi procede come se fosse una qualcosa di improvvisato. In sottofondo c’è gente che ride e che batte svogliatamente le mani durante il ritornello.
La canzone termina con alcune ripetizioni casuali del ritornello, condite da gente che parla e si diverte. Nei momenti pi. sorprendenti, come in «The Times Are A-Changing» o «I Should Have Known Better», Party! si potrebbe facilmente inserire nel catalogo di etichette lo-fi come la Woodsist. Naturalmente, era tutto «finto»; non c’era nessuna festa, o perlomeno nessuno ti aveva davvero invitato. Ma è chiaro che i Beach Boys erano già affascinati da ciò che i suoni poveri erano in grado di fare: potevano, per esempio, creare un senso di intimità inedito, catturare una dimensione che i dischi hi-fi non potevano nemmeno lontanamente immaginare. I suoni cheap non erano di meno in confronto alla normalità dettata dell’alta fedeltà, ma potevano facilmente essere di più. Più profondi, più meravigliosi.
Se William Burroughs una volta sosteneva che i suoni violenti e crudi di un’insurrezione suonata in mezzo alla folla potevano effettivamente crearne una, i Beach Boys capirono che ricreare i suoni grezzi di una festa in spiaggia poteva portarne una nell’intimità delle camere da letto del mondo e nelle orecchie degli ascoltatori. «Non c’è nulla di mistico in questa operazione. Gli effetti sonori di una sommossa possono produrre una vera sommossa in una situazione di sommossa. I FISCHI DELLA POLIZIA REGISTRATI ATTIRANO I POLIZIOTTI. COLPI DI PISTOLA REGISTRATI, ED ECCO CHE TIRANO FUORI LE PISTOLE» – chiacchiere di una festa registrate, ed ecco che tutti tirano fuori sandali e tavole da surf. Sotto il parquet, la spiaggia! Ci volevano solo i suoni giusti.
Non possiamo considerare questo album come il primo disco lo-fi, soprattutto per il modo in cui i suoni lo-fi vengono utilizzati – come un espediente cartoonesco –, ma la fascinazione per i suoni poveri era comunque già presente. In secondo luogo, cosa più interessante, SMiLE è sempre stato destinato a essere un disco costellato di suoni dozzinali e grezzi fin dall’inizio, anche prima che il tremendo breakdown costringesse Wilson ad abbracciare completamente il lo-fi. Sappiamo, dopo tutto, che Brian Wilson si era imbattuto in qualcosa di piuttosto radicale nei suoi esperimenti in studio, qualcosa che in SMiLE avrebbe dovuto assumere la sua forma più compiuta e completa. Ma, fino a questo momento, non abbiamo ancora specificato che cosa sia esattamente questa tecnica sperimentale, o questo insieme di suoni eterodossi destinati a sconvolgere il pop per sempre.
Semplicemente, quando Wilson ha iniziato a immaginare come avrebbe dovuto suonare il suo prossimo progetto, ha avuto una chiara intuizione su come voleva che fosse: un disco «modulare». In parole povere, per registrazione modulare intendeva indicare che l’album sarebbe stato registrato utilizzando moduli distinti, frammenti di melodie sciolte, sequenze di rumori e di altri suoni riassemblate in studio. Piuttosto che scrivere una canzone come un’unica entità coerente, voleva registrare pezzi e frammenti che si armonizzassero e contrastassero in base al tipo di atmosfera o di flusso che potevano creare insieme, avventurandosi al di fuori dei confini della classica canzone pop e imitando gli schemi che si susseguono durante un viaggio – fisico o meno.
Una sorta di album «sampladelico», un precursore degli ipnotici cut-up di gruppi folk come i Books e, pi. in generale, della musica ricca di campioni, dalla musica elettronica alla trap, che avrebbe dominato i decenni successivi. Wilson aveva già sperimentato questo stile di lavorazione del suono, ma ora voleva che prendesse il sopravvento e diventasse la sua firma sonora. Questa tecnica lo emancipava dai vincoli della struttura-canzone: poteva fare canzoni più o meno lunghe, sinfonie o frammenti, a seconda della loro natura, e poteva usare rumori non ortodossi, purché si adattassero in qualche modo.
Poteva anche registrarle in modi disparati e altrettanto eterodossi. La composizione delle sue canzoni era, in altre parole, un modo per mettere insieme suoni di qualità e suoni poveri, sperimentando vari gradi di asprezza e di lucidità, che si scontravano artificialmente l’uno con l’altro – insieme all’ukulele strimpellato a tentoni, agli strumenti più soavi e alle atmosfere più strane che era in grado di registrare. L’esempio più eclatante è quello che avrebbe dovuto essere il brano più lungo di SMiLE, «Elements», una canzone estremamente sperimentale sui quattro elementi.
La struttura di base voleva essere piuttosto bizzarra: groove contrastanti che si incastrano l’uno nell’altro e, per dare all’ascoltatore un assaggio degli elementi, una raffica di rumori, dall’ululato del vento agli schizzi d’acqua e molto altro. Per registrare la parte sul fuoco, costrinse i musicisti di sessione a presentarsi con dei caschi da pompiere in testa, in una sorta di gioco sciamanico per evocare gli spiriti del fuoco. Registrò un falò scoppiettante, riempiendo lo studio di fumo e portando il processo di registrazione ai suoi limiti. Naturalmente, l’incendio nell’edificio di fronte scoppiò proprio mentre stava registrando questo preciso pezzo. Per i superstiziosi: traete le vostre conclusioni.
Chiaramente, una registrazione modulare non equivale a un disco lo-fi, ma dimostra qualcosa di molto più interessante: ciò che ha reso grandioso e sconcertante il processo di registrazione di SMiLE è stato il tentativo di Wilson di catturare la totalità dello spettro sonoro, utilizzando suoni che la norma musicale avrebbe spesso rigettato come rifiuti. Armeggiare direttamente con la macchina ha fatto sì che Wilson sovvertisse le proprie idee su come la musica potesse suonare. Lavorare esclusivamente in studio, ossessionandosi con i tecnicismi della registrazione musicale, gli ha fatto mettere in discussione il modo in cui le cose vengono normalmente eseguite. Gli ha dato la possibilità di vedere i recinti che l’hi-fi aveva imposto alla produzione e al consumo di musica e dunque di oltrepassarli – un atto di fuga diretta attraverso una sorta di hacking sonoro. Voleva abbracciare tutto ciò che la macchina del pop poteva effettivamente produrre, profanando ciò che era ritenuto accettabile e infestando le sue canzoni con materiali vietati.
La sua analisi sonora del rovescio nascosto della musica pop lo ha condotto dritto nel regno dei suoni poveri e lo ha portato a considerarli di per sé un elemento radicale da usare ed esplorare, nonché un modo per incendiare le canzoni e liberarle dalle loro catene. Questo, naturalmente, ha aperto alla possibilità di realizzare, se necessario, un intero disco composto unicamente da suoni poveri: la possibilità di concepire un album completamente lo-fi. Queste considerazioni hanno alcune conseguenze interessanti, credo, per chiunque cerchi di cogliere il potenziale rivoluzionario della musica lo-fi: sfatano fin dall’inizio una certa immagine che ha accompagnato il lo-fi per tutta la sua esistenza e che ha in qualche modo limitato e nascosto le implicazioni radicali di questo «genere» musicale. Spesso, quando si parla di lo-fi, si può facilmente cadere nello stereotipo che lo descrive come una musica più «naturale», organica e priva di artifici. Poiché è più spoglia, si pensa, deve essere anche più immediata e ingenua.
Uno stereotipo che potrebbe calzare a pennello a Smiley Smile: un album affascinante per la sua immediatezza perché privo di quei pomposi artifici da studio. Una band che suona sul momento, senza grossi studi di registrazione in vista. Sebbene, come la maggior parte degli stereotipi, possa essere a volte vero, questo non riesce comunque a cogliere il quadro generale e la cosa veramente degna di nota da segnalare in questa sede: Smiley Smile e il lo-fi che ha seguito la sua scia è interessante perché punta esattamente nella direzione opposta. Infatti, la scoperta dei suoni lo-fi da parte di Wilson attraverso la sua ossessione per lo studio di registrazione, con la sua ricerca maniacale delle minuzie tecniche legate alla musica registrata, non è stata una coincidenza né una contraddizione: dimostra, al contrario, che la musica lo-fi non è più «naturale» di qualsiasi altro suono registrato. In realtà, è molto più artificiale, nel senso che implica un’analisi pratica dell’atto stesso della registrazione e del modo in cui questa avviene, oggi, sotto il capitalismo.
C’è una grande liberazione in una cosa registrata di merda. E chi altro avrebbe potuto scoprirlo se non qualcuno che, più di chiunque altro all’epoca, si era immerso nel vivo del processo di registrazione, trafficando con microfoni, corde e cavi?
La radicalità della musica lo-fi deriva dal fatto che, paradossalmente, essa blocca il flusso naturale della registrazione, decostruendone le pratiche e le convenzioni, e utilizzando tutti quegli elementi prima esclusi per creare qualcosa di nuovo e stranamente bello. L’unica cosa che il lo-fi sembra essere «naturalmente» è uno strumento di critica, nel senso meno pedante del termine, ma non c’è nulla di naturale nella critica. Le pratiche critiche mettono in crisi i nostri usi, costumi e abitudini più comuni facendo emergere come tutto, dal modo in cui registriamo le nostre canzoni fino all’enormità del sistema mondiale capitalista, sia temporaneo e riposi su condizioni materiali e storiche contingenti.
La critica estrania il suo oggetto per rivelare come è nato, per intensificare i punti di rottura e le vie di fuga. Quando Karl Marx, nel Capitale, si preoccupava di come un cappotto diventasse una merce di valore, non era per un feticismo masochista, ma per dimostrare come anche la più banale delle merci poggi su un substrato di processi che la rende ciò che è. O, in termini più complessi e marxiani, per dimostrare che «la forma definitiva dei rapporti economici, quale si manifesta alla superficie, nella sua esistenza reale […] differisce considerevolmente dalla intima, essenziale, ma nascosta struttura fondamentale di questi rapporti e dal concetto che ad essi corrisponde, anzi ne rappresenta addirittura il rovesciamento, l’antitesi».
La critica mostra, in altri termini, gli schemi non detti e nascosti che guidano la produzione capitalistica. Una canzone lo-fi, sovvertendo il modo in cui un suono viene normalmente prodotto nell’industria culturale capitalista, mette in discussione le condizioni e le strutture di potere che la modellano, così come le strutture intime ed essenziali. Non c’è bisogno di ulteriori messaggi o elaborazioni oltre ai suoni stessi. Il gesto di registrare qualcosa in questo modo è già un affronto estetico e un’azione politica in un senso davvero fondamentale: agisce, quasi come un parassita, sulle condizioni materiali della produzione musicale e le apre a nuove possibilità.
Il lo-fi è una forma d’arte critica non perché aderisce necessariamente a questo o a quello, ma perché mette palesemente e direttamente in discussione, deviando dall’interno i motivi e i metodi che stanno alla base del più quotidiano degli oggetti sonori: la canzone pop. C’è una grande liberazione in una cosa registrata di merda. E chi altro avrebbe potuto scoprirlo se non qualcuno che, più di chiunque altro all’epoca, si era immerso nel vivo del processo di registrazione, trafficando con microfoni, corde e cavi?
Smiley Smile non è stato un errore, ma una conseguenza più o meno imprevista dell’avere ripreso il controllo della propria musica, di aver scoperto come e in quali condizioni è stata realizzata e di aver esplorato la quantità di suoni che possono comporre una canzone pop. Il semplice fatto di registrare male qualcosa, questa peculiare forma di critica, porta immediatamente i suoi frutti sui temi concettuali e sul registro complessivo della registrazione stessa. In effetti, in Smiley Smile il tono cambia radicalmente. Non c’è più la duplicità, né la fuga da questo mondo che affliggeva Pet Sounds. Le canzoni, pur essendo chiaramente plasmate nella visione di Wilson, sono molto più bizzarre e artisticamente deformate di quelle che avevamo sentito in qualsiasi altro disco dei Beach Boys.
Le imponenti canzoni d’amore hi-fi e le frustrazioni solari che avevano riempito i lavori più riusciti di Wilson fino a quel momento non ci sono più; ora c’è solo la pura beatitudine dell’equivalente sonoro di un racconto di Lewis Carroll o Russell Hoban: sognante, fiabesco, pieno di delizie psichedeliche. è un disco utopico, nel senso che Herbert Marcuse ha dato alla parola: non come «ciò che non ha posto e non può avere posto nell’universo storico», ma come la liberazione in forma sonora di «ciò che è bloccato dal potere delle società costituite». Ci sono momenti di puro terrore e claustrofobia, assolutamente, ma fanno parte di un viaggio meraviglioso.
C’èanche un aspetto sperimentale nella struttura delle canzoni: il modo in cui incedono, inciampano o sbandano in avanti; una caratteristica che la registrazione spoglia a otto tracce porta a un livello massimo. La maggior parte dei brani suona come una canzone pop esplosa nel salotto di qualcuno. La fuga è, ancora una volta, uno dei temi principali del disco, ma gli sberleffi e i doppi sensi forzati appartengono al passato.
Il più delle volte, la fuga si presenta come compiuta, come qualcosa che è accaduto, con successo, in un certo momento – come se l’atto di registrare un album lo-fi avesse di per sé infuso un ritrovato senso di libertà e speranza nella poetica di Wilson. L’incipit della prima canzone, «Heroes and Villains», un residuo delle sessioni di SMiLE che è stato completamente rivisitato e lo-fizzato nel processo di registrazione di Smiley Smile, la dice lunga in questo senso: I’ve been in this town so long that back in the city I’ve been taken for lost and gone And unknown for a long, long time.
Siamo fuori dai confini, ora. Gli oggetti nello specchietto retrovisore possono essere più vicini di quanto sembrino, ma l’universo delle cose normali è svanito nella polvere rossa di un deserto inesplorato.
[…]
Dopo Smiley Smile, i Beach Boys pubblicarono a sorpresa un paio di altri dischi lo-fi: Wild Honey e 20/20. Purtroppo, sono entrambi poco interessanti. Canzoni pop spogliate e nulla più. Divertenti finché ci sono. A volte sono piacevoli, ma le stranezze selvagge e le grandi melodie sono completamente scomparse. Brian Wilson aveva perso il controllo sulla band e la sua vena creativa sembrava prosciugata: l’unica cosa degna di nota è il senso di stanchezza che trasuda dal gruppo. L’inquietante e straordinario escapismo rimane, ma appare come un fantasma, spettrale e distorto da altre presenze fantasmatiche molto più oscure.
Ma Brian Wilson era riuscito a fuggire, almeno una volta. Di fronte agli orrori e agli orizzonti che si chiudevano, un disco può sembrare poco, ma anche se la rivoluzione diventava sempre più difficile da concepire e la psichedelia si imbrattava di terrori orribili, il lo-fi era ancora là per restare e fare scalpore
In un giorno di primavera del 1968, Dennis Wilson fa salire a bordo due autostoppiste, Ella Jo Bailey e Patricia Krenwinkel. Diventano amici e, per un po’ di tempo, si trasferiscono nella casa di Dennis sul Sunset Boulevard con un gruppo di persone chiassose – una vera e propria setta, che ruota intorno a un carismatico trentaquattrenne di nome Charles Manson. Manson voleva diventare una star del rock’n’roll e convinse Dennis a fargli registrare alcuni demo nello studio di Brian. Il rapporto tra Dennis e Charles si deteriorò velocemente. Nessuno voleva quei demo. Manson puntò un coltello contro Wilson e Wilson, in cambio, gli rubò una canzone. Si chiamava «Cease to Exist», ma Wilson la ribattezzò «Never Learn to Love You». È apparsa su 20/20. Inizia con un drone minaccioso per poi scivolare in un’inquietante canzone d’amore che parla di come attirare qualcuno ad abbandonare le proprie resistenze e a innamorarsi.
Per qualche motivo, il netto contrasto tra il drone e la minacciosa canzone pop mi ricorda una delle più straordinarie esploratrici dell’oscurità lo-fi, Liz Harris e il suo progetto Grouper. Una sorta di oscuro precursore delle forme più cupe che il lo-fi avrebbe assunto in seguito. Nell’agosto del 1969, Charles Manson inviò Tex Watson, Susan Atkins, Linda Kasabian e Patricia Krenwinkel in quella che era la villa di Terry Melcher a Cielo Drive, un produttore noto ai Beach Boys che aveva rifiutato i demo di Manson. Non trovarono Melcher, ma uccisero comunque altre cinque persone: Sharon Tate, Jay Sebring, Abigail Folger, Wojciech Frykowski e Steven Parent. Il sogno di una rivoluzione acida morì quella notte nella coscienza collettiva dell’Occidente, con «PIG» scritto con sangue secco sulle pareti della villa. O perlomeno iniziò a tramontare in modo irreversibile. È difficile non pensare che i Beach Boys abbiano ereditato quella morte, che abbiano portato sulle loro spalle il lutto di un tempo in cui la felicità era reale, la fuga possibile e la rivoluzione imminente. L’unico momento che avrebbe potuto portare al mondo qualcosa come Smiley Smile.
Ma Brian Wilson era riuscito a fuggire, almeno una volta. Di fronte agli orrori e agli orizzonti che si chiudevano, un disco può sembrare poco, ma anche se la rivoluzione diventava sempre più difficile da concepire e la psichedelia si imbrattava di terrori orribili, il lo-fi era ancora là per restare e fare scalpore. Era la testimonianza sonora che le cose avrebbero potuto essere diverse, e che possono ancora esserlo. I fan di Brian Wilson assemblano ancora oggi album ucronici realizzati con i suoi demo grezzi e i suoi outtake in studio, come l’ossessionante Trinidad Cassette. Sono fantasmi di una fuga che, per una frazione di secondo, è stata davvero tale; schegge di un universo in cui è durata per sempre. Il suo lo-fi scuote ancora le persone fuori dai confini della normalità. Li riporta al sogno di un mondo che poteva essere libero.