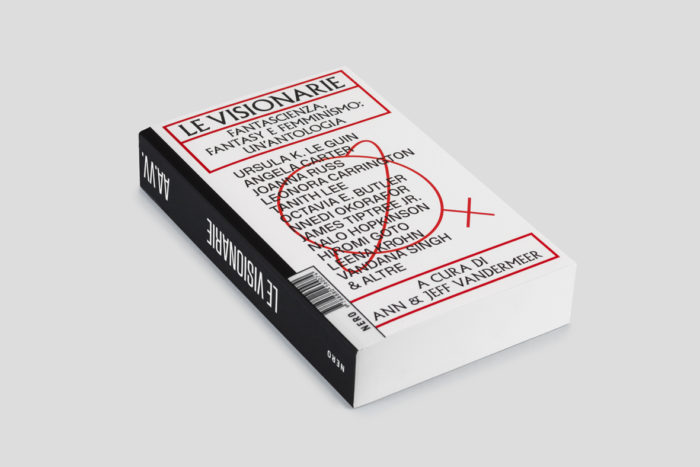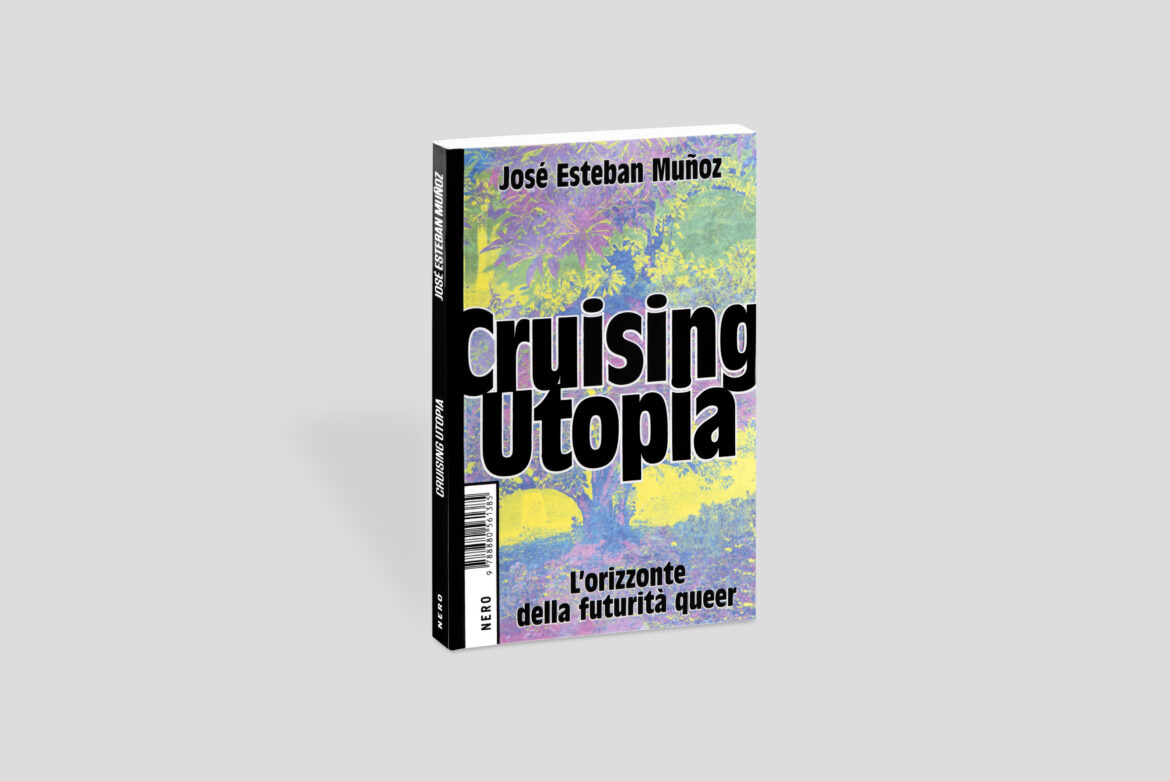Nella torma di intransigenze che hanno puntellato la sua vita di letterato, Nabokov era solito dire che “uno scrittore deve avere la precisione di un poeta e l’immaginazione di un scienziato”. È una suggestione arguta che ha da sempre esercitato un certo fascino sul dibattito letterario, ma anche volendo scomodare i più disparati generi, stili e approcci alla letteratura, è difficile immaginare qualcuno che più di Stanisław Lem riesca a eccellere in questa duplice ordalia. Nato nel 1921 a Leopoli, nell’odierna Ucraina, e noto ai più come autore di Solaris (alla cui trasposizione di Tarkovskij non risparmiò tuttavia delle rimostranze). Lem fu un autore straordinariamente prolifico, con un corpus in grado di sintetizzare rigore scientifico, spirito ludico e speculazione filosofica in un eclettismo e una fantasia non dissimili da quelli dei geni rinascimentali.
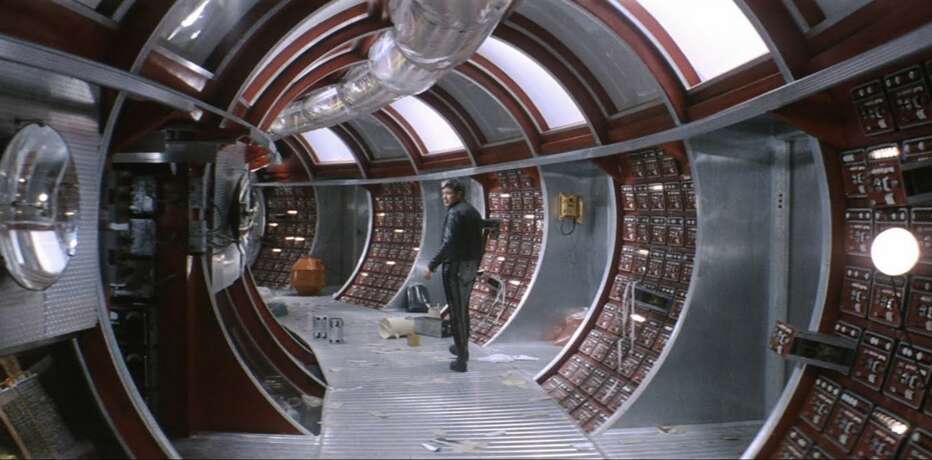
Conosciuto e ricordato principalmente per la narrativa fantascientifica, il suo rapporto col genere fu complesso nel migliore dei casi e sfortunato nel peggiore. Gli attriti più celebri, infiltratisi persino nella cultura popolare, furono quello con la Science Fiction and Fantasy Writers of America e quello con Philip K. Dick, culminato in una denuncia venata di teorie complottiste che vedevano Lem ai vertici di un comitato comunista, ma la critica all’appiattimento della narrativa speculativa e alla fantascienza come genere di consumo hanno accompagnato tutto il suo percorso di autore, come si può riscontrare nella raccolta Micromondi. Se infatti la logica del mercato ha uniformato la qualità dei testi subordinando filosofia e scienza a una formularità dal gusto spiccatamente kitsch che ha reso la fantascienza, per Lem, “un caso disperato con qualche eccezione”, i suoi scritti si muovono in direzione opposta, nel tentativo di strappare cultura e letteratura “al diluvio dell’informazione”. Memore di autori come Verne, Wells e Stapledon, che per primi si avventurarono nelle svariate possibilità della terra incognita della speculative fiction, l’autore di Solaris osserva scorato le potenzialità inesauste di un genere la cui evoluzione è rimasta soltanto in embrione, appiattita dall’applicazione sempre più meccanica di schemi e modelli prefissati.
La fantascienza, infatti, è sempre stata letta, venduta e analizzata come un fenomeno a sé. Il critico Darko Suvin, tra i pionieri dell’analisi letteraria della fantascienza, vede come condizione necessaria del genere un rapporto di tensione tra cognizione ed estraniamento, che spazia dai roman scientifiques ai toni sociali di utopie e distopie. Nell’esaminare l’opera di autori come Asimov, Efremov e Lem, tuttavia, Suvin ravvisa tre visioni del mondo che si distaccano non soltanto da questo luogo comune, ma anche e soprattutto dalla fiducia nell’apertura delle scienze umane tipica della fantascienza commerciale. Se tuttavia per Asimov la limitatezza degli umani costringeva il lettore a mutuare lo scoramento dell’autore, o se di converso l’ottimismo di Efremov, noto per La nebulosa di Andromeda, polemizzava apertamente con il fatalismo distopico del’epoca, l’atteggiamento di Lem trascendeva entrambe le posizioni: secondo Lem, infatti, pur nelle capacità e nelle cognizioni limitate di cui l’essere umano è provvisto, è nondimeno necessario sospendere qualsiasi criterio interpretativo, dall’antropocentrico all’escatologico, e abbracciare la fiducia nel genere umano, perché è l’unico “in grado di comprendere i propri limiti e di evolversi lentamente e dolorosamente verso un livello superiore”.
La Summa è innanzitutto un trattato storico-scientifico di futurologia, concepito e redatto per la formulazione di problemi teorici e pratici legati allo sviluppo tecnologico
Oltre che come la naturale prosecuzione dei suoi studi scientifici, la scelta della fantascienza appariva a Lem come l’opzione più praticabile nell’epoca postbellica, segnata irreparabilmente da pessimismo, rottura delle convenzioni narrative e compromissione della fiducia nel progresso e nelle istituzioni. “Per creare qualcosa di totalmente nuovo”, afferma nella retrospettiva Sulla mia vita, “c’era bisogno di una spinta verso un’altra sfera di possibilità. Per quel che mi riguarda credo di aver scritto, nella prima fase della mia carriera di scrittore, solo cose secondarie. Nella seconda (Solaris, L’invincibile), sono approdato ai confini di un ambito che era già quasi esaurito. Nella terza fase […] ho abbandonato invece quel campo già battuto”. È in orrore a qualsiasi interpretazione esaustiva o finalistica del mondo che Lem sviluppa la sua filosofia: se le correnti politiche del Novecento aspiravano a una lettura dei fenomeni sociali che fosse univoca, statica e autosufficiente (“una pretesa di perfezione statica finale”, per dirla con Suvin), l’autore polacco si riaggancia alla tradizione dei romanzi educativi del razionalismo ottocentesco cambiandone completamente le coordinate. In aperta opposizione alla fantascienza che si serviva di un solido impianto metodologico per garantire un’interpretazione definitiva del mondo, Lem rigetta ogni soluzione in nome di uno scetticismo sì doloroso e consapevole del proprio fallimento, ma che proprio in virtù della disillusione può fornire un’alternativa autenticamente rivoluzionaria al riduzionismo scientifico e moralismo spicciolo a cui la fantascienza commerciale del tempo aveva abituato il lettore.
Per Lem, infatti, evoluzione umana e tecnologica procedono fianco a fianco, secondo un disegno che ricorda i concetti di tecnicità originaria e tendenza tecnica postulati da Stiegler
Se tuttavia può risultare difficile tracciare una parabola delle sorti del genere sci-fi nella sua interezza, almeno alla luce delle teorie sull’evoluzione che Lem rimemora in saggi e interviste, il percorso dell’autore sembra orientarsi secondo un vettore ben preciso: col passare del tempo emerge con sempre maggiore intensità la delusione nei confronti della narrativa (che si tratti di quella “fine a se stessa” o di “quella subordinata a una scienza” poco importa), rea di aver distolto lo sguardo dei lettori dalla direzione del mondo, ormai incompatibile con le utopie ingenue e irrealizzate che Lem pronosticava nella prima fase della sua carriera di scrittore. Questo sconforto annichilente sarà ciò che muoverà la produzione saggistica di Lem degli anni Sessanta e Settanta, cui fanno capo il saggio La filosofia del caso (1968), che si pone l’obiettivo di formulare, anticipando il campo delle digital humanities, una teoria empirica della letteratura; o Fantascienza e futurologia, monografia datata 1971 che contempla la possibilità di avvalersi della narrativa di fantascienza per elaborare teorie futurologiche. Entrambi i testi non sarebbero però stati possibili senza un fortunatissimo precursore, la raccolta del 1964 Summa Technologiae, che ricalca, per ambizione e portata argomentativa, opere come il De rerum natura di Lucrezio e la Summa di Tommaso d’Aquino, a cui si rifà esplicitamente nel titolo offrendosi come sua controparte laica e tecnoscientifica.
Pubblicato per la prima volta in Polonia nel 1964, il testo ha subito numerose riedizioni ampliate o corrette in seguito a pareri e consulti di scienziati e lettori esperti e orientato i due saggi retrospettivi Vent’anni dopo e Trent’anni dopo, configurandosi, quando non come un’“impresa dissennata” (parole dello stesso Lem che Luigi Marinelli, curatore dell’edizione italiana, riporta nella prefazione), come un vero e proprio joyciano work in progress, secondo la definizione avanzata da Peter Butko. Un paragone importante, ma al tempo stesso l’unico in grado di testimoniarne la potenzialità inesausta e carica di suggestioni analitiche e interpretative. La Summa è innanzitutto un trattato storico-scientifico di futurologia, concepito e redatto per la formulazione di problemi teorici e pratici legati allo sviluppo tecnologico. Tra i temi trattati figurano la collocazione della civiltà umana nell’universo, l’etica dell’evoluzione scientifica, le peculiarità dell’evoluzione umana sullo sfondo di quella naturale, la teoria dell’informazione oggi in uso nei motori di ricerca e nella bioinformatica, e infine quella che Lem chiama fantomologia, precorritrice degli attuali studi sulla realtà virtuale.
Pur nell’apparente caos dell’eterogeneità tematica, il filo conduttore dei saggi è l’annosa questione evoluzionistica, da sempre al centro delle riflessioni di Lem, affrontata con l’ambizione filosofica e la profondità che hanno da sempre contraddistinto la produzione dell’autore. Che si tratti di un testo profetico o meno poco importa, benché lo stesso Lem abbia sollevato la questione nella postilla Trent’anni dopo: lungi dall’essere un almanacco prescrittivo, l’intento della Summa è, secondo Butko, ascrivibile più all’esplorazione concettuale delle due evoluzioni e delle loro relazioni con la società e la civiltà, la ricerca di un ritmo o di un pattern nella loro progressione non sempre lineare. Non bisogna però lasciarsi trarre in inganno dall’apparente semplicità del termine evoluzione e dalle sue accezioni consuete, soprattutto di fronte a un’opera che si prefigge già nel titolo di muoversi nella sfera della tecnologia: ad animare i saggi è la volontà di esplorare l’interpolazione tra progresso biologico, tecnologico e culturale, rileggendo i concetti di entanglement e relazionalità alla luce dell’impianto teorico del suo autore. Per Lem, infatti, evoluzione umana e tecnologica procedono fianco a fianco, secondo un disegno che, come rilevato da Joanna Zylinska, curatrice dell’edizione anglofona, ricorda i concetti di tecnicità originaria e tendenza tecnica postulati da Stiegler:
Ogni tecnologia è sostanzialmente la prosecuzione artificiale della naturale tendenza, innata in tutti gli esseri viventi, a dominare l’ambiente circostante, o quantomeno a non soccombergli nella lotta per l’esistenza. […] L’attività omeostatica dell’essere umano, che utilizza le tecnologie come propri organi, lo ha reso signore della Terra, essendo riconosciuta la sua potenza soltanto da quell’apologeta che è lui stesso. […] Ma per l’omeostasi su scala planetaria la strada è ancora lunga, figuriamoci per l’omeostasi a misura stellare. (Summa, p. 41)
Lem è, dopotutto, un pensatore pragmatico, che anche nel fermo e scettico rigetto dell’antropocentrismo non tralascia di considerare l’umanità nel quadro evolutivo. È anzi proprio questo rigetto, presente nella sua produzione narrativa in opere come Golem XIV o L’invincibile, a facilitare una riflessione sulle implicazioni omeostatiche dell’evoluzione umana, da sempre inserita in un contesto più ampio, sia esso legato alla sfera della natura, della tecnologia o della civiltà. Già dal primissimo capitolo, ironicamente intitolato Dilemmi,Lem espone la sua visione con lucidità, postulando un futuro in cui tecnoevoluzione e autoevoluzione possono condurre agli esiti più disparati – un’accelerazione improvvisa della velocità evolutiva, fino ad allora fluita in periodi di stasi interrotti da brevi fermenti, o persino uno stadio di autoconsapevolezza di cui la natura si può servire nella propria evoluzione futura. Tutto porta alla cognizione del ruolo del genere umano in un determinato contesto, da cui è necessario muovere per porsi le giuste domande.
Il capitolo finale, Un pamphlet contro l’evoluzione, parte infatti da un assunto che diparte dal darwinismo classico: se s’intende l’evoluzione come processo di trasmissione e modifica di informazioni, è la longevità, e non la capacità riproduttiva, a garantire la sopravvivenza culturale e tecnologica delle civiltà. La tecnoevoluzione, la trasmissione del patrimonio tecnico di generazione in generazione, di società in società, è parte del processo di evoluzione della specie quanto la sua controparte biologica, e il progresso scientifico non fa che dimostrarne la sempre più crescente commistione. Con l’invenzione e l’innesto di tecnologie artificiali nel corpo, e l’utilizzo (parzialmente pronosticato da Lem) di smartphone e altri dispositivi che fungono da memoria portatile o estensione di alcune funzioni biologiche o cerebrali, la differenza tra naturale e artificiale va via via assottigliandosi; eppure, contrariamente al cliché letterario che vede l’umanità sotto la costante minaccia della meccanizzazione, la Summa riconosce in questo sviluppo una possibilità di ottimizzazione del genere umano analoga alla postura eretta, ottenuta attraverso un lungo processo di autoregolazione. Come rilevato dal filosofo Felice Cimatti, “sono solo le ‘sfumature indesiderate’ a qualificare l’effettiva portata di una tecnologia, non il suo obiettivo dichiarato, bensì gli effetti imprevisti”. E a differenza della tecnoevoluzione, innescata da un agente attivo (l’uomo) e connessa a questioni di carattere pratico, etico o legale, la bioevoluzione non ha un obiettivo né uno scopo, si limita solamente a reagire alle variazioni ambientali nel tentativo di regolare la sopravvivenza o la competizione di ogni specie. E anche senza scomodare temi come i fenomeni extrasensoriali, a cui dedica una sezione ingente del capitolo, le speculazioni bioevoluzionistiche di Lem su autorganizzazione e referenzialità precedono di oltre un decennio quelle di Dawkins e Hofstadter.
Oltre alla disamina dei due tipi di evoluzione, ad animare le meditazioni di Lem nel corso della Summa è la questione dell’intelligenza artificiale. L’eterogeneità delle due macrotematiche è solo apparente, dal momento che, in entrambi i casi, a essere in gioco è il processo di conservazione, creazione e trasmissione di informazioni. Se le iniziali riflessioni sulla civiltà terrestre nel contesto più ampio dell’universo e sulla questione dell’onniscienza, presenti anche in testi narrativi come L’invincibile o La voce del padrone, gettano le basi per i Prolegomeni all’onnipotenza che occupano il quinto capitolo della Summa, la faccenda si fa ben più interessante quando entra in gioco quella che Lem chiama la pantocreazionistica, “la capacità di raggiungere qualsiasi obiettivo, anche fra quelli non realizzati dalla natura”. L’inganno dell’onniscienza, che Lem equipara all’onnipotenza, sta nell’impossibilità quasi asintotica di conoscere una teoria definitiva del tutto. Se anche come esseri umani raggiungessimo la comprensione di un dato sistema o processo, sarebbe oltremodo difficile ottenerla in tutti i campi. Al concetto di onniscienza subentra quindi quello di conoscenza di un sistema o processo individuale, che in campo informatico può essere impiegato nella ricostruzione virtuale di suddetto sistema – ed è qui che per la prima volta si menziona la pantocreazionistica, suddivisa in imitologia, che si applica ai fenomeni naturali, e in fantomologia, che di converso crea oggetti, processi o sistemi inesistenti in natura.
Le digressioni su fantomologia e fantomatica sono a oggi tra i frammenti più discussi della Summa. Ormai considerati tra i precursori della speculazione su realtà virtuale e intelligenza artificiale, non colpiscono più soltanto per le suggestioni teoriche che interessano gli appassionati di fantascienza, ma anche e soprattutto per le questioni collaterali divenute via via più impellenti: se infatti una macchina fantomatica, così la battezza Lem, è in grado di sollecitare i neuroni per creare ex novo un’esperienza, una sensazione o una modalità d’intrattenimento, quali sono i limiti etici, giuridici e psicologici di una simile tecnologia? E se le informazioni false fornite al cervello, che le elabora comunque autonomamente, distinguendone il grado di verità in base alle proprie facoltà interpretative, potessero addirittura modificare il modo in cui il cervello processa questi stimoli? L’esistenza della fantomatica, trascende il semplice contesto tecnico e sconfina in dilemmi epistemologici ben più pressanti. Con l’avanzamento della tecnica, infatti, la frontiera tra naturale e artificiale, tra concreto e virtuale, va assottigliandosi al punto da rendere la distinzione quasi impossibile, proprio come per il caso dell’evoluzione. Le considerazioni di Lem in materia sono varie e ramificate, ma convergono verso un’unica soluzione, in grado di arginare il pericolo del regressum ad infinitum: la relatività esistenziale, che postula la stretta interdipendenza dell’identità dall’ambiente e dai quadri concettuali impiegati per interpretarlo.

A dispetto dell’eclettismo dei saggi, però, la scrittura di Lem sembra fare costantemente ritorno a due nodi essenziali della sua produzione, il caos e il caso. Del resto, è con una meditazione su queste spinte contrarieche si apre Sulla mia vita, sguardo retrospettivo sulla propria formazione di scrittore che inaugura la raccolta Micromondi: “Sono consapevole che due opposte polarità guidano la mia mano. Da un lato è il caso, dall’altro il principio ordinatore che dà forma alla nostra vita. È possibile che tutto ciò per cui sono venuto al mondo, sfuggendo indenne ad innumerevoli e mortali minacce per diventare infine uno scrittore, e per di più uno scrittore che cerca instancabilmente di conciliare principi così antitetici come realismo e fantasia, – è possibile che tutto ciò sia solo il risultato di eventi casuali?”. Si può leggere il ritorno ossessivo a questi due principi alla luce dell’esperienza della guerra, di quella che lo stesso Lem definisce, sempre in Micromondi, “l’inesplicabile nullità della vita umana nel grembo dell’eccidio di massa”, ma anche a volerne dare una spiegazione behavioristica, nelle scelte letterarie permane sempre un residuo aleatorio – o, per citare direttamente l’autore, “non credo sia un fatto fortuito che nelle mie opere io abbia attribuito al caso il ruolo di artefice del destino”. Tutte tematiche che affronterà con maggiori rigore precisione nel già menzionato La filosofia del caso, tentativo di Lem di polemizzare con la teoria letteraria di Ingarden, imperniata sul radicamento ontologico, fornendone una controparte che rendesse invece conto dei fattori sociali, temporali e culturali della ricezione dell’opera. Specie se paragonata alla ricezione e alla fortuna della Summa, La filosofia del caso si rivela un esperimento parzialmente fallito, ma ha in sé il pregio di fornire ai lettori un inquadramento più ampio sulla produzione teorica di Lem.
In una conversazione del 1992 con il critico Peter Swirski, Lem affermerà di essere “un convinto sostenitore della massima che la letteratura, così come la filosofia, non dovrebbe mai annoiare a morte i suoi lettori”, e che “la lettura non dovrebbe mai essere una lotta in una giungla di parole e concetti, condotta con disagio e difficoltà, per afferrare ciò che dovrebbe venire naturale”, nell’auspicio che la letteratura del futuro poggi sull’umiltà e sull’onestà intellettuale. L’inquadramento della Summa in questo proposito, caratterizzato dalla possibilità per il romanziere di sperimentare creativamente con la speculazione letteraria, è allora essenziale, giacché è proprio per tale motivo che tra il 1961 e il 1963, anni della stesura di Summa, Lem si sforzò, a cavallo tra il saggistico e il bellettristico, di “rinunciare a questa comoda protezione dal confronto con la realtà”. La componente futurologica era forse troppo all’avanguardia per quei tempi, ma la prognosi della Summa, anche al di là della resa dei conti sopraggiunta in Trent’anni dopo, è più che positiva. Nel ripercorrere a ritroso la propria opera di scrittore, Lem dirà infatti che “Summa Technologiae testimonia […] che sono sì un utopista deluso, ma non ancora disperato. Non credo infatti che l’umanità sia ‘un caso per sempre incurabile e senza speranza’”. Si tratti allora di narrativa, saggistica, o di una terza cosa segreta di cui Summa è tra i titoli più esemplari, Lem continua a portare avanti l’assunto, doloroso quanto consolante, che il tempo dei miracoli crudeli non è ancora finito.
Come da appuntamento aspetto Maria Galindo all’uscita della proiezione di Diva Futura. Mentre saliamo al bar del piano di sopra le chiedo come fosse il film. “Ho delle critiche”, taglia corto visibilmente assorta dalla vista su piazza Barberini, ma poi sente addosso il mio sguardo sospeso e mi dice: “È dalla prospettiva di lui”. “Te pareva”, commento io, ma non so se mi sente; ho tutte le parole in bocca, sono un po’ intimidita. Poi penso che potrei evitare di dire cose tipo “te pareva” ed essere un po’ più formale. Anche se non è Galindo a richiedermelo, ma una certa postura che mi impongo di avere nel ruolo di intervistatore sulla base di chissà quale riferimento culturale passivo e sbiadito. Lei aggiunge: “Sai, abbiamo passato del tempo insieme, con Cicciolina, quindi mi interessava vederlo. Poi sono a Roma! Cerco di fare tutto, tutto quello che vent’anni fa non ho potuto fare”. Mentre lo dice siamo già sedute a bere del vino che sicuramente non posso permettermi. Incastra lo sguardo oltre la sua spalla destra, dietro di lei Santa Maria della Concezione se ne sta tutta piena di teschi dei monaci cappuccini. I platani intorno alla chiesa le fanno quasi da corona. Sarà sicuramente anti-monarchica, ma la corona le sta bene. “Quando vivevo qui non sono mai entrata in un posto simile, capiscimi: stasera questa è la mia piccola venganza”.

L’avevo ascoltata al CSOA Forte Prenestino due giorni prima, insieme a centinaia e centinaia di persone, e a Lucha y Siesta il giorno dopo, in un’assemblea con le altre realtà transfemministe e queer romane. Registro la nostra chiacchierata anche se so che non sentirò praticamente niente: Maria ha perso la voce, urlando addosso a una persona lì a Lucha. “Non dobbiamo perderci nella politica identitaria, per esempio”, aveva detto la compagna, “nell’identità sessuale. Quando invece la lotta di classe ci unisce subito”. Traduzione degna dei primi tempi di Google translate. Galindo allora si raddrizza, tira fuori il petto come un avvoltoio dalle piume rosse scintillanti. E grida con tutta la voce che ha: “Noi in Bolivia siamo il proletariato del proletariato. Siamo stati schiacciati, esauriti, dal colonialismo”. Galindo giustamente odia che le sue parole siano tradotte e manipolate. Non è in effetti quello che ha scritto o detto. Però è esattamente il discorso con cui le istanze queer vengono de-legittimate dai vetero-compagni o quelle compagne che Galindo chiamerebbe macho-materne, macho-accondiscendenti o quant’altro (la lista è lunga). Seppur con responsabilità diverse, siamo tuttɜ parte di questo processo di delegittimazione, tocca scarnificarci. La critica all’identitarismo è una delle perle che Galindo ci porta in dono e che va custodita senza snaturarla. È stato uno dei piccoli regali (li ha chiamati così) che ci ha fatto alla serata al Forte: “Io ho tre piccole proposte per voi, ma sono proposte dolci che ho già testato”. Io arrivo al Forte con un leggero ritardo, cioè un’ora dopo, e Galindo aveva appena iniziato a parlare. Come sempre negli spazi sociali e nei cortei, si arriva e si diluisce lo sguardo in una serie di convenevoli e saluti che percorrono l’imbarazzo di non saper interagire e l’emozione di sentire di far forse parte di un branco.
Primo regalo
“Dobbiamo prima di tutto uscire dalla politica identitaria, cioè capire che nessunǝ è solo questo o quell’altro: l’identità è sempre un pezzo di altro. Allo stesso tempo, simultaneamente. Organizzarci solo in base alle identità è omogeneizzante: è una logica in cui tremila diventa una persona sola. Diventiamo la fotografia di Benetton”. La platea ride di gusto. “Significa interrogarci di nuovo sul soggetto della politica contemporanea con lo scopo di creare un soggetto multiplo eterogeneo e sempre incompleto. Affinché la porta rimanga aperta”. Non vedo il suo volto, ma sento la sua voce e la stanza del Forte si riempie di punti esclamativi sospesi e immaginati. La folla arriva fino a oltre il cinema nei corridoi della fortezza occupata più grande d’Europa. Almeno un centinaio di noi si ritrova circondato di teste, e con la voce, alta e limpida, di Galindo che riecheggia profetica mentre noi compagnɜ siamo costrettɜ a guardarci in faccia con una luce artificiale da interrogatorio. Neanche fosse fatto apposta. Galindo parla per circa un’ora, mi dice poi che “è come fare teatro”. Nel senso che parlare a tanta gente richiede un certo tono di voce, un linguaggio, delle climax. Ascoltarla in effetti è fenomenale: riesce ad entrare nelle cose in profondità senza perdersi, senza smettere di essere accessibile. Gliel’ho detto: “Sei universale e specifica”. Ad ogni climax e applausi e ululati ne approfitto per studiare le reazioni di chi mi circonda, analizzo i consensi, i sorrisi e gli accigliamenti. “Un soggetto complesso non può essere cooptato”, lo ripete lei o tuttɜ noi nelle nostra testa: non siamo solo lesbiche, autistiche, proletarie o quant’altro, siamo tanto altro, possiamo diventarlo. La porta deve rimanere aperta, non possiamo essere co-optate. Dobbiamo essere indigeste! “Dobbiamo creare alleanze insolite, vietate dal sistema e io ho una metafora per questo valida per la mia società: voi dovete trovare la vostra metafora. È la metafora di uno spazio che ci unisce, dove entrano tuttɜ, siamo state invece addomesticate ad avere delle alleanze utili al sistema. Dobbiamo domandarci: qual è la politica che vogliamo fare? Se non vogliamo fare quella dei diritti e identitaria?”
Secondo regalo.
“Se non vogliamo fare la politica dei partiti e anche quella dell’assemblea io propongo la politica concreta cioè massiva: è una politica chiara e tangibile e popolare. Per costruire cosa? Qualcosa che il patriarcato e il colonialismo non possono assorbire. Per costruire l’empatia sociale che è la nostra forza: che non può essere cooptata o sostituita da nessun potere”. Si prende spazio, respiro, e lo ripete un’altra volta: “È urgente creare un’empatia sociale massiva”. Ha urlato anche: “Le assemblee sono noiose”. L’applauso, quasi automatico ormai a ogni climax dialogica, ha scrosciato un po’ meno forte mentre in alcuni punti della sala si è acceso un ronzio colpevole. Della noia delle assemblee siamo tuttɜ co-responsabili, ne è forse però colpevole chi militarizza gli spazi socio-politici applicando sanzioni sociali (commenti, sguardi) a ciò che non riesce a decifrare o inglobare; applicando spesso anche un dress code o un gergo militante (dire cose tipo “agire il conflitto” o altre mille parole incomprensibili che nonostante l’editing ritrovate anche qui: sono anche io una sopravvissuta). Contro l’accademismo (di cui anche negli spazi ci siamo contaminate) Galindo propone un femminismo intuitivo pieno delle voci silenziate che non hanno mai avuto luogo d’espressione o microfono. E forse anche noi dovremmo tornare lì. Le sue domande ci rimangono addosso più del previsto: “Siamo capaci di fuggire dalla logica del leader? Del martire? Possiamo fuggire dal conflitto sociale come luogo di sacrificio e di sofferenza?”
Terzo regalo
Galindo parla di utopia, ma prima afferma: “Di fronte al potere non cerchi l’empowerment, ti ribelli”; in sala ci si chiede a vicenda: “Ha detto: ribelli o riveli?”. In tantɜ prendiamo appunti. “Riveli, riveli”, mi conferma la sconosciuta con cui stavo dividendo la birra. “Ribelli, ma anche riveli, vogliono dire la stessa cosa alla fine”, mi aveva detto poi Maria. “Abbiamo bisogno di utopia, cos’è? Un orizzonte de sentido”. Galindo tiene la pause sul filo delle gambe pelose di tante di noi, che, assorte, ce li arricciamo. “Cosa vi propongo io? Come utopia e orizzonte de sentido: un orizzonte che può essere dentro le nostre profonde discrepanze ed eterogeneità e pluralità femministe. Quello che vi propongo è la de-patriarcalizzazione”. Depatriarcare, scrive Galindo, è quello che facciamo noi femministe “con la famiglia, con la terra, con il cibo, con il lavoro, con l’arte, con la vita quotidiana, con lo spazio, con la salute, con il sesso”. La de-patriarcalizzazione è un orizzonte, “è una grande porta dove possono stare caoticamente tutte le nostre lotte”, è un movimento “assetato e insaziabile che non può venir divorato né negoziato da interessi o gruppi o governi”.
Per Galindo i diritti sono uno strumento secondario di controllo che divide la società in segmenti: “Sono un copione da ripetere anche se non ci appartiene. E stiamo a ripetere. Sono uno chantaje : oggi te li do domani te li tolgo. Parlando solo di diritti non parliamo di strutture di potere”.
Fiocchi e nastri bonus
Eccoci di nuovo sulla terrazza a Barberini divise da un tavolino caotico tra bicchieri sparsi, tapas mezze mangiate e fogli scritti e già stinti dalla bottiglia di vino gocciolante. Non era tra le domande che mi ero preparata, ma le chiedo come fosse andata male alla Biennale di Venezia. Dico “male” per sbaglio e lei sorride. “È stato come stare dentro ad un bicchiere”, prima di fare il primo sorso ci infila le dita dentro e sparge delle gocce di vino bianco in aria e verso terra, per gli antenati. “Tornare così, negli spazi politici, tra la gente, è realizzare un sogno. La Biennale questo non lo sa fare”. C’è una rete militante che ha portato, in dieci tappe, Galindo in giro per l’Italia. Lei la descrive con “una capacità organizzativa meglio della Biennale stessa”. Quando ci parliamo siamo solo all’inizio del tour che si concluderà dallɜ compagnɜ di Squeert al CSO Pedro a Padova. Incontro due di loro a Vienna, qualche giorno dopo, parliamo di Galindo e concordiamo su quanto abbiamo bisogno della sua voce, del suo grido. “Femminismo Bastardo”, edito da Mimesis edizioni, è un testo ibrido e compatto. Non è insensato pensarlo come un manuale di non-assimilabilità: dopo la devastazione del colonialismo, contro il risucchio del capitale. Speriamo che mentre provano a digerirci si strozzino con le paillettes e i moschettoni. L’abbiamo ribadito quando con la cucciolata queer di Priot abbiamo presentato il suo libro con Hanay del Gruppo Ippolita: “Non vogliamo essere frociɜ ad alta digeribilità”, e testi come quelli di Galindo non vogliono spianarci la strada, ma insegnarci a stare nel rigoglio e costruirci tane e fortini. Infatti, “Galindo pensa al corpo delle donne come una potenza sessuale espropriata, come piacere distrutto, come soggettività devastata”, scrive Paul B. Preciado nella prefazione al testo. E aggiunge che i transfemminismi possono essere solo bastardi perché sorgono da “un luogo socialmente conflittuale, dolorosamente irrisolto, ardentemente illegittimo e mille volte proibito”.
Le chiedo se avesse delle aspettative o un intuito su come avrebbe risuonato il suo pensiero in Italia. Femminismo Bastardo non è solo una guida, un dizionario specifico e potenzialmente universale, ma è uno spazio arioso dove tanti collettivi e individui possono andare a prendere una boccata d’aria; e vedere se qualcosa germoglia o brucia fino alla radice. “Sono convinta che con la scrittura e la radio stiamo inventando nuovi femminismi. Ma non voglio cadere nell’arroganza europea, non voglio essere, per farti capire, Bifo Berardi (in effetti io non ho mica capito come dobbiamo disertare e forse alcuni di noi per posizionamento, anche volendo, non potrebbero mai?). Quello che dico è interessante se poi nasce un dialogo e una pratica politica. In America Latina, in quella che io chiamo ‘il continente senza nome’, abbiamo crisi in comune e abbiamo anche delle crisi in comune con voi, anche se le vediamo da punti diversi”. Rifletto insieme a lei che sicuramente ciò che nei nostri spazi politici risuona di più è la critica alla politica identitaria. È vero: “La lotta per i diritti è satura, esausta”. Per Galindo i diritti sono uno strumento secondario di controllo che divide la società in segmenti: “Sono un copione da ripetere anche se non ci appartiene. E stiamo a ripetere. Sono uno chantaje: oggi te li do domani te li tolgo. Parlando solo di diritti non parliamo di strutture di potere”.
Le chiedo di tornare su alcuni punti che aveva detto la sera prima: cosa voleva dire con “la mia nazione è l’immaginazione”? Intanto, sorridendo mi dice che suona bene, annuisco pensando a quanto sia musicale la sua scrittura; merito anche della traduttrice Roberta Granelli. Galindo continua: “Quando non hai neanche le scarpe ti offrono la Nazione. Guarda Meloni, Meloni questo lo sa benissimo”. Annuisco. Aggiunge: “Lo spazio simbolico è lo spazio emozionale”. Le chiedo come stimola la sua immaginazione, se ha uno spazio ancora vuoto o se la sua immaginazione è satura. Mi risponde: “Io ho la capacità immaginativa di una bambina, lo dico in senso positivo, ma non fraintendermi: lo sforzo d’immaginazione che dobbiamo fare è collettivo”. Le chiedo come sia stato sentire una rete così, che dalla Bolivia l’ha portata in Italia in giro per gli spazi politici. Mi dice: “C’è un deseo profondo di ascoltarsi, di rispetto, di organizzarsi”. Concludiamo proprio su questo: su quanta potenza ci sia nell’autogestione, sulla passione, sulla cura che mettiamo. Ce lo scordiamo spesso, non abbiamo certo l’arroganza di tenere in piedi il mondo (spesso neanche noi stessɜ), ma riusciamo ancora a creare spazi di respiro e germinazione. Invidio Maria che domani sarà dallɜ compagnɜ della Vampa e poi sarà accolta da tutto ciò che in giro, senza chiedere il permesso, brulica di bastardismo e femminismo intuitivo. Tengo stretto in mano un diavoletto fatto dal collettivo che ha co-fondato: Mujeres Creando. I diavoletti, ci ha spiegato alla libreria Antigone, sono una traduzione anarchista-blasfema degli altari. Li teniamo stretti mentre cospiriamo sempre più all’unisono. Galindo è un gigantesco ombrello sotto il quale ci troviamo tuttɜ d’accordo e soprattutto faccia a faccia: in questo spazio ristretto possiamo iniziare a intessere trame, amache e ghirlande.
“La lotta sociale è un paradiso in cui restare, grazie mille!”