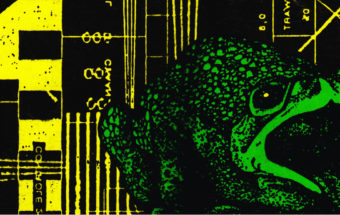Ricordi dal Loft
Esattamente un anno fa – e per la precisione il 14 novembre 2016 – moriva David Mancuso, uno dei grandi nomi della cultura dance, padrino di buona parte del cosiddetto clubbing «underground», nonché «padre dei dj e della disco», per usare una formula del nostro Rolling Stone. Nel 1970 organizzò, nel suo appartamento di New York, il primo appuntamento di quello che sarebbe diventato noto come The Loft: una festa a suon di musica soul e funk che avrebbe fatto da modello per tutti i successivi club del periodo, dal Paradise Garage allo stesso Studio 54. L’esempio di Mancuso fu tale che, ancora in pieni anni 2000, party sulla falsariga del Loft continuavano a essere organizzati ovunque, dagli Stati Uniti al Giappone, dal Regno Unito all’Italia.
Tra questi c’era senz’altro il Lucky Cloud Sound System fondato a Londra da Tim Lawrence, a sua volta autore di saggi classici come Love Saves the Day: A History of American Dance Music Culture e il recente Life and Death on the New York Dancefloor. Per ricordare David, riproponiamo qui un’intervista che proprio Tim Lawrence gli fece nel 2007, originariamente apparsa sul numero 15 di NERO Magazine.

David Mancuso, 1974
Come una zuppa o una bicicletta o Wikipedia, il Loft è un composto di parti che prese singolarmente possono apparire deboli, ma che diventano divertenti, rivelatrici e potenti una volta messe insieme. Primo ingrediente è il desiderio di un gruppo di persone di stare insieme e divertirsi. Il secondo è trovare una stanza abbastanza confortevole per il ballo e con una buona acustica: in altre parole una sala rettangolare con un soffitto ragionevolmente alto, un bel pavimento di legno e la possibilità di una privacy. Mattone successivo è il sound system, meglio quando è semplice, pulito, caldo, e quando è spinto poco più di una frazione sopra i 100 decibel (in modo che le orecchie delle persone non si stanchino o si danneggino). La stanza poi dovrebbe essere decorata, con palloncini e una palla specchiata quale soluzione più economica e veloce, e – visto che il party può tirare per le lunghe, con conseguente appetito per alcuni dei partecipanti – anche una sana dose di cibo e bibite dovrebbe essere pronta all’uso. Per chiudere – e questa è una cosa che viene dopo tutte le altre – gli amici necessitano di qualcuno che porti un po’ di dischi da ballare. Fatto ciò, è tempo di festa.
Tutte queste parti vennero assemblate al numero civico 647 di Broadway, nel distretto abbandonato di NoHo a New York, quando David Mancuso tenne nel suo loft un party di San Valentino. Era il febbraio del 1970. Quella festa, che presto divenne nota come «il Loft», non fu tanto un punto di partenza, quanto il momento di rinascita di un certo numero di pratiche ed esperienze, alcune delle quali possono essere ricondotte ai decenni precedenti, che si riunirono per prendere una nuova forma.
Ciao David, da dove vogliamo cominciare?
Ommmmmm…
Perché vuoi partire da lì?
È la parola spirituale per l’essenza del suono. È un canto. «Om» dice tutto.
Al momento come sei messo con il tuo Om?
«O» e «m» sono le due lettere centrali di home, «casa». Om è veramente potente. Jeremy [uno dei fondatori del Lucky Cloud Sound System di Londra, NdR] mi ha mandato un link con il suono del big-bang e sembrava un Om. I buddisti intonano Om da moltissimo tempo e, quando sono in gruppo e in armonia, la vibrazione crea il suono di una campana. È l’illuminazione.
Speri di creare una specie di Om ai tuoi party?
Deve essere qualcosa di più di un semplice tocco umano-acustico. Non puoi farlo elettronicamente. Ma la vibrazione è lì. Le feste possono diventare molto mentali. La campana però non suona, se anche solo una persona del gruppo diventa dominante sulle altre.
Quanto è importante per te il legame tra suono, spiritualità e feste?
Con l’Om i buddisti aspirano a un livello spirituale, e la via è appunto il canto. Noi ai party non ci incontriamo per cantare, e l’illuminazione non è quel genere di cosa che puoi raggiungere durante una festa di otto ore. Ma Om non è una o due persone, un uomo o una donna, un adulto o un bambino. Om è la parola spirituale per l’essenza del suono. La vita intera è una vibrazione, il battito cardiaco, il tuo ventre [womb in inglese, w-OM-b, NdT], sono vibrazioni. Il suono ha qualcosa a che fare con i party? Certo. La musica è una cosa fortemente spirituale.
Hai mai cantato in passato?
Ho preso parte ad alcuni gruppi, certo, negli anni Sessanta e Settanta. Ne è passato di tempo da quando mi sono seduto la prima volta con un gruppo di persone con questo obiettivo in testa. L’importante è farlo in gruppo. Serve una vibrazione collettiva. Una volta che la provi, questa esperienza ti condizionerà per il resto della vita.
Mi puoi dire qualcosa di più sulla tua idea di «casa»?
Probabilmente risale a Suor Alicia e alla sua stanza delle feste. Suor Alicia è la mia levatrice. Si è presa cura di me fino ai sei anni. Sono andato a trovarla di recente e durante la visita ho usato la parola «orfanotrofio». Disse che non era un orfanotrofio: era la Casa di Saint Joseph. Mi corresse dicendo che era una casa per bambini. Io ci ero entrato che avevo due giorni, direttamente dall’ospedale.
Ti ricordi qualcosa di questa casa?
Ho ricordi molto vaghi. Le uniche immagini sono dei giochi all’aperto, dello scivolo, e degli altri bambini che giocano fra loro. I ricordi sono riemersi quando Eddy, uno dei miei amici nella casa, mi ha fatto vedere delle foto.
Quando hai visto per la prima volta queste foto?
Avevo quarantacinque anni. Nessuno aveva detto a Eddy che da piccolo era stato in quella casa. A un certo punto la casa fu demolita e ci costruirono sopra un complesso di appartamenti. Eddy si sposò e andò a vivere lì, senza saperne nulla. A un certo punto lo scoprì. Ne rimase così sconvolto che se ne andò, ma voleva sapere di più sui suoi primi anni di vita, così si mise a cercare nei registri e risalì a Suor Alicia. Quando la trovò le chiese: «Eri tu che mi cambiavi i pannolini?» E lei: «Sì».
Donald Byrd – ho avuto un’illuminazione in questo istante! – I’ve Longed and Searched for My Mother. È un bellissimo disco, uscito per la Blue Note. Risale ai tardi anni Cinquanta, primi Sessanta. Quando lo sentii, mi rapì. È veramente angelico. Ho sempre sentito uno strano legame con questo disco: ora so perché.
Perché?
È una canzone bellissima, e Suor Alicia è stata veramente una madre per me, anche se non ricordo nessuna suora prendersi cura di me. Ci sono tante cose che non ricordo. Ma sotto ipnosi, o con una pillola della memoria, magari i ricordi riaffiorano, sono tutti nel mio cervello. Quando vedo una sua foto, comincio a unire i puntini. Mi sento molto vicino a questa donna.

Il piccolo David Mancuso in orfanotrofio (Suor Alicia è sullo sfondo). Dal sito timlawrence.info
Come sei tornato in contatto con Eddy?
Eddy chiese a Suor Alicia: «Come si chiamava l’amico con cui giocavo di solito?» Lei gli mostrò delle foto e, quando lui indicò un bambino, disse: «Questo è David». Così si mise a cercarmi, ci mise cinque o sei anni prima di trovarmi. Eddy lavorava a Utica, la città dell’orfanotrofio, in un negozio di alimentari di famiglia. Un giorno un commesso disse: «Signor Mancuso, il suo ordine è pronto!» Eddy andò dalla persona che stava ritirando l’ordine e disse: «Lei ha un nipote o un figlio?» Al che gli fu risposto: «Sì, ho un nipote». E così mio zio mi disse che Eddy mi stava cercando, che voleva incontrarmi. Io ero sbalordito, totalmente scioccato. Era qualcosa che apparteneva ai miei primi anni di vita – roba pesante – ci ho messo sei mesi a prendere il telefono in mano. È come aprire delle porte, trovare un fratello che non sapevi di avere. Comunque, visto che Eddy veniva a New York un paio di volte l’anno, mi venne a trovare. Era il 1984, proprio quando mi stavo spostando sulla Terza Strada. Gli spiegai che avevo creato il Loft, che facevo delle feste, e lui guardando la stanza disse: «Devi vedere queste foto!» Aveva con sé le foto che di Suor Alicia, e ne trovammo una in cui c’era la famosa stanza delle feste con giradischi, dischi e palloncini. Era l’immagine riflessa allo specchio della mia stanza al Loft. Rimanemmo entrambi piacevolmente sconvolti.
Quando sei rientrato in contatto con Suor Alicia?
La chiamai fra Natale e Capodanno. La riconobbi subito. Ha una voce molto bella. È fluente e profonda, come un canto. Dissi: «Ciao Suor Alicia» – me la stavo facendo sotto! – «sono David Mancuso». E lei: «Ciao David». Allora dissi: «Ti ricordi di me?» E lei: «Come fosse ieri». Le dissi che ero molto felice di averla raggiunta telefonicamente – in altre parole che era ancora viva – e che vivendo vicino a lei avrei avuto piacere ad incontrarla. La vidi qualche mese dopo. Non so come spiegartelo, fu assolutamente da brivido.
E siete rimasti in contatto?
L’ho continuata a chiamare almeno una volta ogni due mesi. Poi qualche anno fa sono andato con Eddy a trovarla e alla fine della visita lei ci ha chiesto di andare nella cappella. Ma non per pregare (era un’organizzazione interreligiosa). Una volta lì ci disse: «Lasciate che vi mostri qualcosa». C’era una grande ampolla di vetro e se strofinavi un bastoncino sul bordo, sentivi le vibrazioni attraverso il corpo. Dissi a me stesso: questo deve essere quello che facevamo da bambini. Ci mostrò questo strumento musicale, e come creare questa vibrazione. Questo mi sbalordì.
Sono tornato a trovarla qualche settimana fa con un giornalista di nome Matt e le abbiamo chiesto dei dischi che erano nella foto della stanza delle feste: «Ricordi i nomi dei dischi? C’era qualche James Brown?» Lei ci ha risposto che erano dischi da bambini, cose che i bambini ballano. Matt allora le ha chiesto: «Dove hai preso quei dischi?» E lei: «Uscii e li comprai». Non è da poco. Non erano stati donati da nessuno. Era stata lei a creare quell’atmosfera, quella stanza. Anche l’idea di metterci i palloncini. Ci trattava come se fossimo nella sua casa durante una festa di compleanno.
Più sto seduto con lei, più riaffiorano i ricordi. La sua voce è molto familiare e spirituale [h-OM-ish, NdT]. Quella stanza era il modello-base in termini di vibrazioni. La stanza ovviamente era pensata per le feste dei bambini. Era un posto felice. Suor Alicia avrebbe trovato qualsiasi scusa pur di fare un party. Anche se i bambini compivano gli anni lo stesso giorno, lei trovava il modo di festeggiarli individualmente. Quando vidi per la prima volta le immagini della stanza realizzai che anche se non lo ricordavo direttamente, il sentimento che mi accompagna da sempre veniva proprio da questo posto.

Ballerini al Loft nel 1980 (foto di Waring Abbott)
Il Loft è come una casa?
È una casa lontana da casa. Per alcune persone, in verità, lo è stata per davvero. Qualcuno lo facevo stare lì. Li accoglievo per sei mesi o un anno. A un certo punto avevo undici persone che vivevano nel Loft. Ho sempre detto a chi stava con me: se vi azzardate a pronunciare la parola affitto, vi caccio fuori. In altre parole, non mi potevi pagare nessun affitto.
Vuoi dire che i party sono una cosa un po’ da bambini?
Certamente. Ritrovi qualcosa che hai perso durante l’infanzia, o che non hai mai avuto. Il party è un’esperienza infantile. Puoi avere la tua torta, e mangiarla. Il Loft non è mai stato un business. Negli ultimi anni la cosa si è allargata e ora vengo spesso a Londra e in Giappone, ma sono sempre tra amici. Londra e il Giappone non sono molto distanti, in quanto sono entrambi luoghi dove le comunità nascono, crescono, si sviluppano e si espandono. È come un canto, come l’Om. La vibrazione che ne esce può essere davvero curativa. Quando stanno con i propri figli, le persone reagiscono come normalmente non farebbero. Possono fare gli scemi, fare di tutto, giocare. E questo ci tiene giovani nell’amore e nello spirito.
Come sei arrivato dall’orfanotrofio al Loft? Cosa hai fatto una volta lasciata la casa?
Vivevo ad Utica e all’età di 15 anni mi spostai dalla parte opposta della strada, dove stavano le minoranze e i poveri. Utica è una città molto isolata, piena di pregiudizi, ma l’ospitalità che c’è per strada è incredibile. Riuscivo già a mantenermi da solo, la maggior parte dei miei amici viveva nelle case popolari. Dopo la scuola ci vedevamo a casa di qualcuno e ascoltavamo musica. Eravamo molto giovani all’epoca, erano una specie di feste doposcuola. Oppure passavamo i pomeriggi in un posto all’angolo chiamato Birdland dove suonava un trio di musicisti, un ragazzone biondo all’organo e due musicisti neri. L’entrata era libera e noi ci andavamo spesso per ballare. Ci sapevano fare! Noi comunque eravamo un gruppo molto eterogeneo – gay, etero, bianchi, ispanici – ascoltavamo musica e ballavamo nei salotti. Consumavamo i tappeti. Tutto ciò ha avuto un’enorme influenza su di me. È stato qui che mi sono avvicinato a James Brown, alle Shirelles e a molti altri artisti. Ho imparato a ballare, a conoscere altre culture e a fare amicizia. Ci trattavamo con rispetto. A 18 anni compiuti lasciai Utica.
Dove vivevi?
A 15 anni e mezzo rimasi da mio zio per sei mesi. Appena compiuti i 16 me ne andai. Il mio tutore mi diede una stanza tutta per me, così mi decisi ad andare in una rooming-house, una camera ammobiliata. Lasciai la scuola e cominciai a lustrare scarpe e a lavare piatti.
Da lì partisti per New York?
Un caro amico mi disse: andiamo a New York! Partimmo il weekend del Labour Day e per tre giorni ci sistemammo al YMCA sulla 34a strada. Era il 1962. In seguito incontrammo due tipi che ci invitarono a stare a casa loro nel Bronx. Avevo già 18 anni, e trentatré giorni dopo tornai. Il weekend che feci ritorno a New York i russi erano sulla via di Cuba e calcolai che se tutto fosse scoppiato, sarebbe successo il martedì seguente. Arrivai che era giovedì, e mi feci il weekend. Se tutto quel casino era destinato a succedere, almeno sarei stato dove volevo stare. Rimasi poi con i miei amici per circa sei settimane, durante le quali mi insegnarono a rastrellare, a prendere il cibo da un alimentari senza avere un soldo. Trovai velocemente un lavoro e cominciai a frequentare un po’ di feste private. Mi sentivo sempre a mio agio in quelle situazioni. C’era la musica, la gente e lo schema era sempre lo stesso. Fu il momento più felice e spensierato della mia vita e divenne il mio punto di riferimento per il futuro. Era tutto quello che avevo, ed era qualcosa di cui essere davvero felici e grati. La mia vita in quel momento era come questi scenari: la mia casa, le case degli altri, le feste private. E poi cominciai a frequentare i club, in particolare il Territorial, sulla 125a Strada.
Dimmi qualcosa di più sul Territorial.
Era gestito da due lesbiche e noi ci sentivamo un po’ esclusi. Dovevi arrivare con una tessera o con un accompagnatore e in questo caso dovevi pagare 2 dollari per avere la tessera temporanea. In questo modo non erano costrette ad aprire al pubblico. Andai come ospite di qualcuno e, la prima volta che entrai, incontrai Larry Patterson (con il quale diventai grande amico e che molti anni dopo fu uno dei principali dj allo Zanzibar nel New Jersey). Vidi anche qualcuno che avevo incontrato il giorno prima a Prospect Park. Pensai: «Wow!» Larry era con degli amici e mi disse: «Vieni al mio tavolo!» C’era un jukebox e ballavamo tutti. Mettevamo le canzoni che ci piacevano, poi arrivava qualcuno a cambiare e così continuavamo a ballare le canzoni che piacevano agli altri. Suonavamo l’uno per l’altro, socializzando in maniera molto intima, privata, e questo era ciò che ci rendeva più felici. Così torniamo di nuovo al sentimento di familiarità, che è il motivo per cui faccio quello che faccio. È stato il trampolino di lancio. Era praticamente destino. Insomma, la ragione per cui faccio quello che faccio è recuperare i sentimenti della mia infanzia. Mi tengo lontano dall’aspetto economico delle cose perché è il momento in cui comincio a perdere interesse. Il Loft non ha mai riguardato me: riguarda noi. Una situazione imbarazzante per me è quando vai in qualche posto e le persone cercano il dj. Non sono lì per quello. Altra gente può interpretare quel ruolo, e alla fine è meglio così perché posso lasciare più spazio a loro. Non significa che sono anti-dj; è solo che non sono qui per la fama e il successo. E quando qualcosa si muove in quella direzione comincio a perdere interesse, perché preferisco rimanere in un contesto più intimo e privato.
Qual è la differenza concettuale tra il Loft e un club?
I club sono creati con l’obbiettivo di fare soldi. Questo non c’entra con il Loft. Il Loft nasce per fare feste e fare amicizia. Questo non significa che non puoi festeggiare e fare amicizia in un club, ma sono posti strutturati per produrre profitto; è tutt’altra cosa. Senza dubbio è questo aspetto che determina il modo in cui le cose accadono e quanto riescono ad andare avanti. Il Loft per me riguarda il progresso sociale. Ai miei party potevi portarti da casa da bere e i tuoi bambini potevano venire con te. Se non avessi trovato un posto dove queste cose potevano accadere, sarei giunto alla fine della mia strada.
Nello Stato di New York, qualsiasi persona che entra in un negozio di alcolici o in un bar con la licenza per la somministrazione di alcool deve, per legge, essere servito. Le leggi variano da situazione a situazione, ma in generale se sei in regola devi rimanere aperto al pubblico. Tutto ciò richiede una certa mentalità, e io non ho la testa per questo genere di cose. Preferisco coltivare l’uva in una fattoria e fare il vino. Non sto cercando di creare distinzioni di merito: è solo il modo in cui sono cresciuto. Forse alcuni di noi non si sentivano sicuri, ma avevamo trovato il modo di sostenerci l’un l’altro. Quello che faccio ha a che fare con qualcosa di molto personale e non deve essere paragonato a un club. Il che non significa che una cosa sia meglio dell’altra. Sono solo diverse e, a mio parere, il Loft era sicuramente più intimo.
Nei club non c’è molta intimità. Perché l’intimità è così importante per te?
Per me il nocciolo della questione riguarda il progresso sociale. Quanto progresso sociale può esserci in una situazione repressiva? In un nightclub non ce ne può essere. A New York hanno modificato la legge dai diciotto ai ventun anni. Dove possono ballare i ragazzi di questa età? Da me puoi avere qualsiasi età, bere o non bere, fumare o non fumare. È in un posto così che a me piace stare. Negli ultimi tremila anni abbiamo fatto pochi progressi come razza umana, quindi è molto importante se succede qualcosa. Secondo me i party rappresentano una via per il progresso sociale, perché non sono limitati dalle numerosi leggi esistenti. Ho sempre applicato le leggi di sicurezza, ma non ho mai voluto la licenza per gli alcolici, perché sarei entrato in un’altra categoria. Più leggi entrano in gioco e più alti sono gli interessi.
Quanto sono violenti da un punto di vista economico i bar e i club?
Dovendo pagare 5 dollari per l’acqua, per non parlare dei 10 per un drink, può essere davvero poco accessibile. Se pensi al contributo che dai per venire al Loft, è un buon investimento. C’è da mangiare, puoi portare il tuo alcol e non devi pagare il guardaroba. È tutto incluso. Se vai da qualche altra parte puoi facilmente spendere 150 dollari. È una specie di comunità che si autosostiene. Ma una volta che acquisti la licenza per gli alcolici ci sono tante norme e i tuoi costi di gestione salgono così tanto che di conseguenza salgono tutti i prezzi. Il non avere la licenza mi permette di tenere i costi al minimo e rendere i party accessibili a chiunque: e questo per me è molto importante.
In quale altro modo il progresso sociale si esprimeva al Loft?
Finché ti comporti come un essere umano puoi fare quello che vuoi. Questo è l’accordo. Non ci sono risse. Non abbiamo i problemi di tanti altri posti. Questo ti dovrebbe dire qualcosa. Ci si può fidare delle persone. Al Loft ci si porta l’alcol da casa, e questo rende più facile bere e rilassarsi. Vedere la gente consumare alcol e non litigare è progresso sociale.
Come capisci chi può e chi non può venire ai tuoi party?
Sta tutto nel riuscire a entrare nella lista degli sponsorizzati. Non comando io, ma la maggioranza. Due terzi del pubblico sono ospiti delle persone che sono nella mailing list, e se qualcuno nella mailing list ti sponsorizza, puoi entrarci anche tu a meno che non andiamo oltre la nostra capienza, in quel caso entri in lista d’attesa. Qualcuno torna dopo vent’anni e riappare: per questo abbiamo la «clausola nonno». Le persone che tornano dopo vent’anni hanno la precedenza su chi è nuovo. Hanno l’anzianità e quindi devi dare loro il giusto rispetto, dal momento che hanno contribuito a costruire questo castello e che sono amici da lungo tempo. Chiunque viene sponsorizzato può essere nella mailing list a patto che non sia piena. Penso sia meraviglioso non avere il controllo nelle mie sole mani.
Ci sono tre tipi di segnali che indicano se i party stanno andando bene. Primo, se le persone vogliono che i party continuino, le supporteranno con un contributo. Noi non facciamo pubblicità o promozione. L’incasso arriva solo se le persone vogliono contribuire e stare lì con i loro amici. Questa è una prima indicazione. Secondo, se cominciano a scoppiare le risse bisogna chiedersi se si è fatto qualcosa per contribuire a questa violenza. E ultimo, se la porta diventa il luogo in cui le persone devono essere controllate, con i metal detector come succedeva al Paradise Garage, io non voglio far parte di tutto questo. Se dovessi fare una di queste cose, non sarebbe più come andare a casa di un amico dopo la scuola. Sì, c’è un aspetto economico del Loft, ma è ordinato e semplice. Se per qualche ragione il Loft dovesse finire, gli sarei comunque riconoscente. Faccio questo da trentasette anni. E qualsiasi cosa accada, ci sarà sempre almeno un altro party. Ho un posto di riserva dove posso mettere su un party molto velocemente e un giorno dargli un nome, se necessario.

David Mancuso davanti al Loft nella sua sede di Prince Street (foto di Pat Bates)
Per tanto tempo hai organizzato feste nel posto dove vivevi, ma ora non sei più in grado di farlo perché il tuo appartamento è troppo piccolo. Questo per te ha cambiato le cose?
Il posto dove organizzo i party a New York è grande quanto gli altri miei spazi. L’unica differenza è il posto per dormire. A parte il fatto che non vedi il letto, non noteresti la differenza. Ogni volta che vedo uno spazio – e non sto parlando solo dei miei party qui a New York – la prima cosa che mi viene in mente è: «Dove posso mettere le casse?» Poi penso: «Mi andrebbe di dormire qui stasera?» Se le risposte sono positive, so che è il posto giusto. Ha a che fare con il suono e con l’essere abbastanza comodo da dormirci la prima notte.
Per te è un problema focalizzare l’attenzione sul dj invece che sul dancefloor…
Certo. Interpretare il ruolo del dj limita il mio intero orizzonte. Non so come fare a spiegarlo a parole. Presentare dei dischi preregistrati è davvero solo l’ultima cosa che faccio e, in fondo, anche l’ultima che preferisco. Quello che mi porta ad essere qui è la passione per le persone e per la musica. Quando l’attenzione si sposta sul tuo ruolo da dj vieni isolato, o al limite è quello che succede a me. Mi piace pensare che succeda a chiunque abbia voglia di liberare il proprio ego, per mischiarlo a quello delle altre persone e fluttuare in questo viaggio chiamato vita.
Può l’attenzione sulla figura del dj portare via energia ai party?
Se le persone mi trattano con questa idea di dj in testa vorrei dirgli: «Anche io voglio mettermi di fronte alle casse, amico! Lasciami un po’ di spazio!» Non ho paura di stare di fronte alla musica. E se poi qualcuno mi dice «Suoni davvero bene!» io gli dico: «Ma se non so suonare neanche il piano! Ringraziamo il musicista per questi regali». Questa è la mia idea. Essere un dj significa fare molto più di quello che io faccio mentre i giradischi suonano. Mettila così.
Puoi spiegarti meglio?
Io non faccio nulla al di fuori di pulire i dischi, metterli sul giradischi e stare in connessione con il pubblico. Cerco di mettere il lato tecnico a margine e di rimanere in quello stato che io chiamo di grazia: che significa essere degno di fare quello che faccio e condividere con altre persone il piacere della musica. Se volessi essere un dj allora mixerei, avrei il pitch-control, ma è tutto un altro gioco. Non mi riguarda. Un giorno, dopo undici anni, decisi che non avrei mai più mixato, e la decisione aveva anche a che fare con la qualità del suono. Io posso mixare, ma per mixare ho bisogno di un mixer e se ho un mixer interferisco di fatto con la qualità del suono; così decisi che il suono doveva avere meno dispositivi elettronici possibili a interferire. Mi sono dovuto sbarazzare del mixer, e lo feci per rispetto agli artisti, ai musicisti e agli ingegneri del suono.
La qualità del suono è un elemento importante nell’esperienza di un party.
Preferiresti andare in un ristorante dove il cibo è al top o dove è così-così? Visto che non abbiamo il vantaggio di avere una band dal vivo, cerchiamo di avvicinarci a quella sensazione il più possibile. Non si può cambiare il pitch-control. Prendi Lo Schiaccianoci: gli cambieresti il pitch? Ma se invece parti da un approccio totalmente diverso, ti aspetti anche questo, fa parte di quel genere di circo. È una storia differente. Se lo fai, si spera almeno che tu lo faccia bene. Ma per me non è qualcosa di musicalmente puro.
Il suono quando è buono produce un party di diverso tipo?
Il cibo non troppo buono fa bene al tuo corpo? Certamente un buon sound aiuta a fare una buona festa, anche se la musica in sé deve avere vita propria e donare energia. Molti dischi non hanno questo potere. Perché Dark Side of the Moon è un lavoro così bello? Perché parte con un battito cardiaco. Le persone si fermano e ascoltano. Parla da solo. Il battito del cuore ci riporta al ventre [womb in inglese, NdT]. The w-OM-b is mother of all ro-OM acoustics.
Una versione completa di questa intervista si può trovare sul sito timlawrence.info