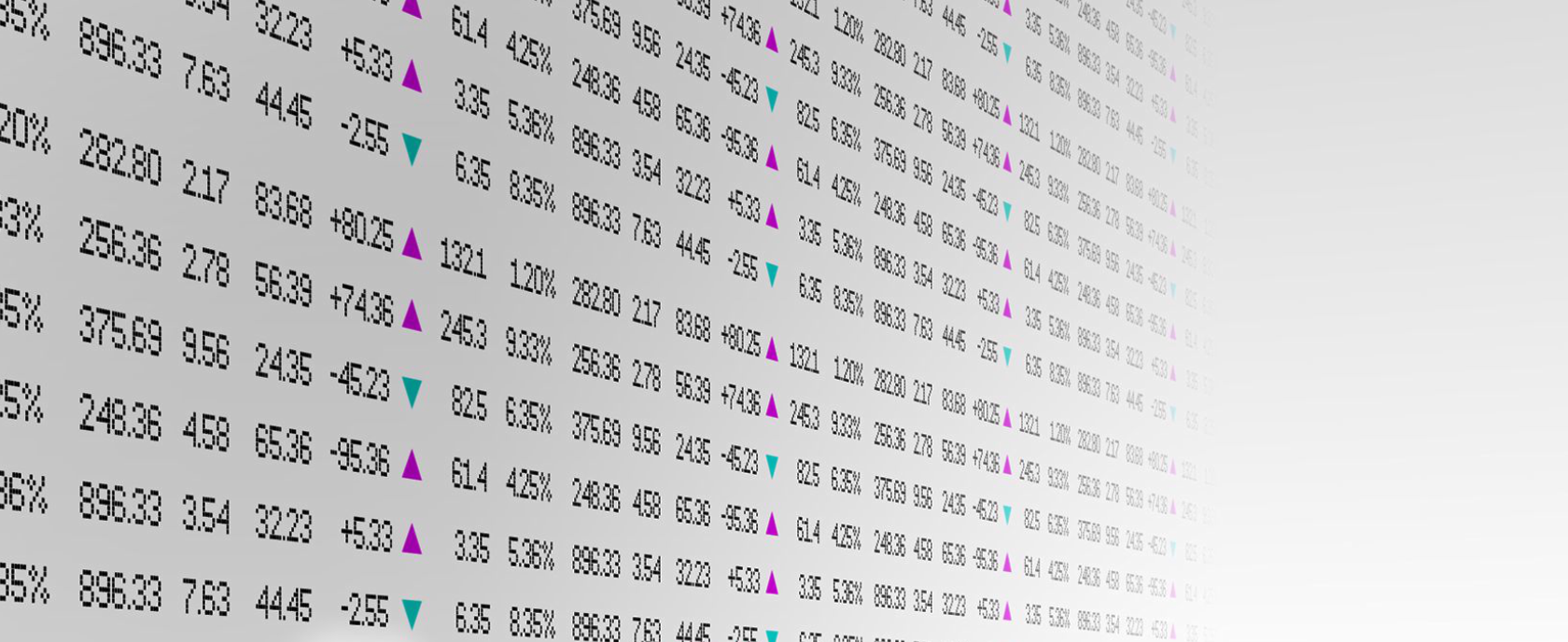Che scienza è l’economia?
Nessuna massima condensa l’orizzonte politico del mondo occidentale degli ultimi trent’anni come il «non c’è alternativa» formulato da Margareth Thatcher. È un motto che riesce ad esprimere un paradosso: non cancella la possibilità di scelta, ma la canalizza dentro una rigida struttura logica fino al punto in cui non sono più possibili altre opzioni. Attraverso il discorso economico introduce nella gestione della società un’istanza scientifica, un calcolo ottimale che tratteggia lo spazio d’azione e i limiti dell’attività umana, e che di fatto rende progressivamente normato ogni aspetto della vita. L’economia, secondo Éloi Laurent, diventa «la grammatica della politica. Col suo uso e le sue regole condiziona il linguaggio, la parola pubblica, il cui libero arbitrio si limita ormai alla scelta del vocabolario, della retorica e dell’intonazione».
Più che una scienza, dunque, è una mitologia, ma una mitologia che si impone tramite l’autorevolezza scientifica. La vecchia divisione del mondo in due blocchi mostrava su larga scala l’esistenza di almeno due modelli contrapposti, ma con il collasso dell’Unione Sovietica il modello capitalista ha preso a raccontarsi come il portatore dell’unica scienza economica possibile, fissando l’egemonia del libero mercato come cornice irrinunciabile del discorso politico.
Il System Dynamics Groups del MIT presentò nel 1972 al Club di Roma un rapporto intitolato The Limits to Growth («I Limiti della Crescita», anche se in italiano venne tradotto come I Limiti dello Sviluppo). Si tratta di 205 pagine di precise analisi sulla tendenza di crescita del sistema economico mondiale, sul rapporto tra questa e la tecnologia, sul rischio di esaurimento delle risorse, e vi appaiono anche delle proiezioni sugli scenari futuri. Fu la prima vera sintesi dell’impatto che un secolo e mezzo di rivoluzione industriale ha avuto sul pianeta Terra. Quella precoce analisi non riuscì però a cambiare il modo di intendere il rapporto tra l’uomo e il suo ecosistema. Nei decenni successivi, abbiamo ad esempio assistito al tentativo di costruire un «capitalismo verde», contrapposto ad un troppo antiquato capitalismo fossile, ma in nessun momento la categoria di «crescita» è stata messa in dubbio dai grandi policy maker globali. La crescita è un dogma, un concetto economico assunto come dato di realtà inconfutabile: una buona politica deve essere di crescita, a cui magari aggiungere la parola «sostenibile», se siete sensibili al tema ambientale.
I mezzi di comunicazione di massa portano questi aspetti dogmatici a livelli quasi grotteschi. È il caso di un indicatore come il Prodotto Interno Lordo, numero magico la cui crescita arriva a sintetizzare l’andamento economico generale. Poco importa che, per esempio, il PIL aumenti anche nel periodo immediatamente successivo ad una catastrofe naturale, in conseguenza degli investimenti per la ricostruzione. Poco importa che il PIL valorizzi il moltiplicarsi degli scambi, anche inutili: se compro frutta e verdura a chilometri zero il PIL cresce meno che se mi rifornisco alla grande distribuzione acquistando gli stessi alimenti, ma dopo tutta la serie di intermediazioni necessarie a quel canale di vendita.

L’esempio del PIL mostra anche tutto il contenuto ideologico che è nascosto da questo atteggiamento: per non fare che un esempio, quando l’andamento borsistico è seguito con apprensione da giornali e tv, raramente si sottolinea che il FTSE MIB (l’indice di Piazza Affari, il principale indice italiano) è ottenuto mediando gli andamenti delle 40 società a maggior capitalizzazione; semplicemente, l’interesse di questi 40 soggetti è identificato nel linguaggio all’interesse generale.
Per capire questa «fede» in certe impostazioni del dibattito economico dobbiamo analizzare l’interfaccia tra la ricerca accademica e il piano della comunicazione del marketing politico. Il dogma agisce sui linguaggi e non elimina il contraddittorio, ma lo costringe all’interno di categorie rigide, spesso dicotomiche. Nel caso della crescita, due fattori rendono difficile l’elaborazione di alternative epistemologiche: da una parte l’onnipresenza ossessiva di retoriche espansive, dall’altra il fatto che ogni critica viene intrappolata nella dialettica troppo stretta tra crescita e decrescita, riducendo di fatto la complessità dell’analisi. Portare una critica alla crescita non significa semplicemente evidenziare in quali casi la crescita può essere dannosa, ma elaborare altre categorie valoriali, nuovi paradigmi.
Il potenziarsi degli strumenti di calcolo ha accentuato queste tendenze, banalizzando ancora di più il dibattito pubblico. Tanto più la capacità di fare un’analisi «scientifica» del mondo economico aumenta, tanto più l’aritmetica economica diventa stringente e impone paletti. Ogni processo economico è descritto come una sorta di algoritmo in cui la libertà degli operatori è ridotta a quale input inserire tra quelli concessi, lasciando sempre meno capacità di mettere mano ai processi.
L’economia quindi assume uno statuto contraddittorio: è una disciplina sempre più matematizzata in cui si sviluppa un’analisi scientifica, ma molti elementi del modello non vengono mai discussi (il ruolo dell’ecosistema, una certa nozione di libertà individuale, la nozione di povertà, la correlazione tra ricchezza e benessere, ecc.). Allora in che maniera questa «analisi scientifica» viene intesa? In che modo costruisce delle verità e quindi produce delle realtà?
La ricerca scientifica viene pensata come un tentativo di unificazione sistemica; si ricercano cioè leggi universali per il comportamento di alcuni oggetti dentro uno spazio di possibilità predefinito
Qui conviene soffermarsi su una tendenza che ha accompagnato la scienza durante tutta la modernità ed è diventata particolarmente marcata a partire dalla seconda guerra mondiale: la ricerca scientifica viene pensata come un tentativo di unificazione sistemica; si ricercano cioè leggi universali per il comportamento di alcuni oggetti dentro uno spazio di possibilità predefinito. È un approccio tipico della scienza fisica, che viene però adattato a sempre più campi: dal moto dei corpi celesti o degli atomi, ha iniziato a essere usato nell’analisi di sistemi chimico-biologici, di questioni mediche, fino ad arrivare a essere applicato anche alle scienze sociali.
Ogni sistema fisico è descritto da una serie di «grandezze osservabili» come, ad esempio, le masse di alcune particelle, le loro posizioni e velocità, ecc. Il sistema evolve nello spazio di queste variabili secondo le leggi fisiche date dalla teoria. Detto altrimenti, il sistema analitico percorre una traiettoria in quello che viene chiamato «spazio delle fasi». Questa evoluzione non è necessariamente deterministica, può avere elementi casuali ma sempre all’interno di alcune possibilità già note: le teorie quantistiche prevedono che lo spin di un elettrone sia uno stato aleatorio, ma lo spazio delle fasi è comunque fissato a priori; l’elettrone può assumere stato up oppure down con probabilità ½. Non ci sono terze vie.
Questo paradigma pone un problema quando applicato all’economia, perché in una scienza sociale non è possibile definire uno spazio delle fasi che sia indipendente dal tempo storico. Le evoluzioni politiche, le grandi scoperte, i cambiamenti nei comportamenti di massa o semplicemente il caso, sono tutti elementi che aprono delle possibilità sconosciute. Applicare teorie rigide ad un ambiente evolutivo di questo tipo significa di fatto espellere dall’analisi la possibilità del cambiamento.
Pubblicità del Moplen
Nel 1954 Giuliano Natta sintetizzò il polipropilene isotattico, materia plastica che fu onnipresente nelle case italiane durante il boom economico sotto il nome di Moplen. Alla vigilia della scoperta sarebbe stato impossibile prevedere l’andamento successivo del mercato delle suppellettili casalinghe, perché l’attore principale degli anni Cinquanta-Sessanta non era ancora stato concepito: l’invenzione di Natta ha cambiato lo spazio delle fasi in maniera totalmente imprevedibile. Se riproduciamo questo ragionamento su più mercati, su linee temporali più lunghe, introducendo elementi sociali e politici, un approccio «fisicista» all’economia non permetterà di cogliere evoluzioni storiche fondamentali.
Il tormentone mediatico-politico dello spread fornisce un altro caso molto significativo. Con la parola «spread» si intende il divario tra i valori di due titoli. In Italia il termine indica il differenziale che esiste tra i titoli di stato tedeschi (Bund) a 10 anni e gli equivalenti italiani (i cosiddetti BOT, Buoni Ordinari del Tesoro). Per accedere a denaro liquido, ogni Stato emette dei titoli di debito con un certo tasso di interesse; nel momento in cui scrivo, l’interesse dei BOT a 10 anni è del 2,62%:acquistando oggi 100 euro di titoli si ha diritto a riscuotere 2,62 euro di interessi annuali. Nello stesso momento i Bund sono allo 0,41%, quindi con una differenza del 2,21% (221 punti di spread) che dimostra la maggior sicurezza ed appetibilità sul mercato dei titoli tedeschi, perché per stimolare la domanda, lo Stato italiano deve promettere tassi d’interesse più alti.
BOT e Bund sono però allo stesso tempo dei titoli scambiabili in borsa. Chi li possiede può venderli (vendendo anche il diritto alla riscossione degli interessi), e il valore di questi buoni varia nel tempo in base all’andamento di domanda ed offerta. Se per qualche motivo molti investitori vendono i loro BOT, il loro prezzo scende: nell’ipotesi precedente, i titoli acquistati per 100 euro potrebbero trovarsi ad avere un valore di 98 euro, sempre però concedendo il diritto a ricevere 2,62 di interessi all’anno. Il prezzo diventa quindi misura di quanto gli investitori sono disposti a scommetteresulla capacità del tesoro italiano di saldare alla scadenza il valore del titolo più gli interessi maturati (piuttosto che comprare altri titoli, come quelli tedeschi, storicamente più stabili).
Dunque se il valore nominale scende, l’interesse effettivo associato al titolo aumenta, e alla prossima asta di BOT (se vi interessano, ecco il calendario) lo Stato italiano rilascerà nuovi titoli con questo tasso aggiornato. Qui l’intreccio di aspettative e realtà è abbastanza evidente: la percezione di rischio si tramuta in tassi d’interesse più alti, quindi in maggiori difficoltà per il tesoro italiano a pagare gli interessi stessi. L’andamento dello spread risulta, insomma, dall’incontro di diversi valori e rapporti fiduciari e non può esistere un modo storicamente stabile per descrivere l’andamento di domanda e offerta. Al contrario il contesto borsistico è continuamente modificato dalle informazioni che arrivano dall’esterno, e la maniera in cui si dibatte dello spread diventa essa stessa un fattore nell’andamento dei prezzi.
Non si esce dallo schema descrittivo lineare realtà → politiche economiche → spread, e gli schieramenti differiscono solo nelle interpretazioni.
Quando però la narrazione dell’economia è riportata sul piano politico, i termini del discorso sono quelli classici. «Lo spread? Colpa di Salvini e Di Maio», diceva Renzi poco prima della formazione del nuovo governo. «Il problema non eravamo noi […] ma l’incertezza che regna sovrana», gli rispondeva pochi giorni dopo lo stesso Salvini. Entrambi i fronti cercavano e cercano le condizioni oggettive all’origine delle oscillazioni, senza alcuna capacità o volontà di mostrare il piano complesso all’interno del quale lo spread può essere letto solo come termine di paragone con altri fattori. Dall’attuale coalizione di governo è arrivata nelle fasi più tese anche l’accusa che alcuni attori (la Merkel, Draghi, …?) potessero controllare direttamente lo spread, corrompendolo in un certo senso come se si trattasse di un comando eseguibile su un computer. Insomma non si esce dallo schema descrittivo lineare realtà → politiche economiche → spread, e gli schieramenti differiscono solo nelle interpretazioni. Ed è abbastanza chiaro perché lo spread sia da tutti raccontato come un meccanismo oggettivo (anche se eventualmente corrotto): l’area all’opposizione ha per anni praticato politiche di taglio alla spesa seguendo i «dettami dei mercati», mentre l’alleanza Lega-M5S ha tutto l’interesse a nascondere sotto il neutrale velo dei numeri la difficile posizione italiana nei rapporti di forza internazionali.
C’è però una parte di realtà che scompare dalla discussione. Nel 2016, meno del 30% dei titoli italiani a medio/lungo termine era in mano a famiglie o amministrazioni pubbliche, mentre quasi il 60% apparteneva a società finanziarie. Se ne deduce facilmente quali attori e quali retoriche siano più determinanti sull’andamento dei prezzi, e che se facciamo scegliere allo spread la bontà della politica nazionale (flat tax, chiusura delle frontiere, tagli alla spesa pubblica…) alcuni soggetti hanno più peso di altri sulle decisioni.
Prendiamo ora un caso totalmente diverso, che mostra una possibile angolazione nel rapporto tra retoriche scientifiche e dibattito economico-politico. Il coanoitto è una specie di pesce apparsa nel Devoniano e antenato degli anfibi. Con un corpo cilindrico marroncino e quattro piccole pinne, si tratta di un animale esteticamente poco affascinante, ma la sua peculiarità sta in un polmone primitivo che convive con le branchie. A un certo punto degli ultimi 400 milioni di anni, alcuni esemplari di coanoitto impararono a regolare la profondità in acqua sfruttando la capacità di gonfiare e svuotare il loro proto-polmone, finché una successione di variazioni evolutive casuali eliminò definitivamente la funzione respiratoria. Il polmone dei coanoitti è probabilmente uno degli antenati della vescica natatoria di cui sono provvisti moltissimi pesci; nel corso della storia l’organo ha completamente cambiato di funzione diventando un supporto nel movimento acquatico.
Con questo esempio (per niente isolato nella storia dell’evoluzione) nell’articolo «Economics for a Creative World» pubblicato nel 2015 sul Journal of Institutional Economics, Koppl, Kauffman, Felin e Longo mostrano in cosa l’aleatorietà biologica differisce da quella fisica, e propongono la biologia come modello per la scienza economica. Se invece di uno spazio delle variabili fisso concepiamo uno spazio variabile, evolutivo, l’elemento del tempo storico torna ad essere pensabile all’interno di un’analisi scientifica del mondo economico. I vincoli ambientali smettono di essere elementi assoluti, e tornano ad essere elementi che si possono rifunzionalizzare ed oltrepassare.

Nel libro 6|5 di Alexandre Laumonier il protagonista, Sniper, è un algoritmo finanziario che vive una storia, un’evoluzione, proprio perché calato all’interno di un ecosistema adattativo fatto di altri algoritmi come lui. Creato per un concorso tra software di trading, Sniper elabora una strategia ottimale per vincere la competizione (una banale strategia di attesa) ma in breve gli altri algoritmi imitano il suo comportamento e questo modifica completamente le dinamiche di mercato, fino a creare, di fatto, una paralisi.
Con questo sguardo che ammette la nascita di nuove possibilità, uno sguardo più «biologico», si riapre lo spazio per l’azione soggettiva che è totalmente chiuso quando prevalgono narrazioni oggettiviste-fisiciste. Nel dibattito moderno il ruolo dello scienziato e dell’analista è sempre quello di rispondere in maniera binaria a domande di sistema: «Con queste politiche lo spread salirà o scenderà?», «questi componenti chimici sono dannosi per la salute?», «di quanto devo ridurre il salario medio per rientrare nei limiti europei?». Ma con una concezione evolutiva si può invece pensare di cambiare le domande poste all’analisi scientifica, di superare le dicotomie, trasportando all’interno del dibattito tecnico i diversi (e spesso contrapposti) interessi che popolano ogni società.
Se il futuro non è già scritto nei numeri, se gli strumenti scientifici agiscono dentro un’evoluzione imprevedibile di contesti, allora chiaramente ricompare la possibilità di alternativa: le modellizzazioni numeriche non sono più «leggi», ma vincoli, che possono essere deformati o aggirati.