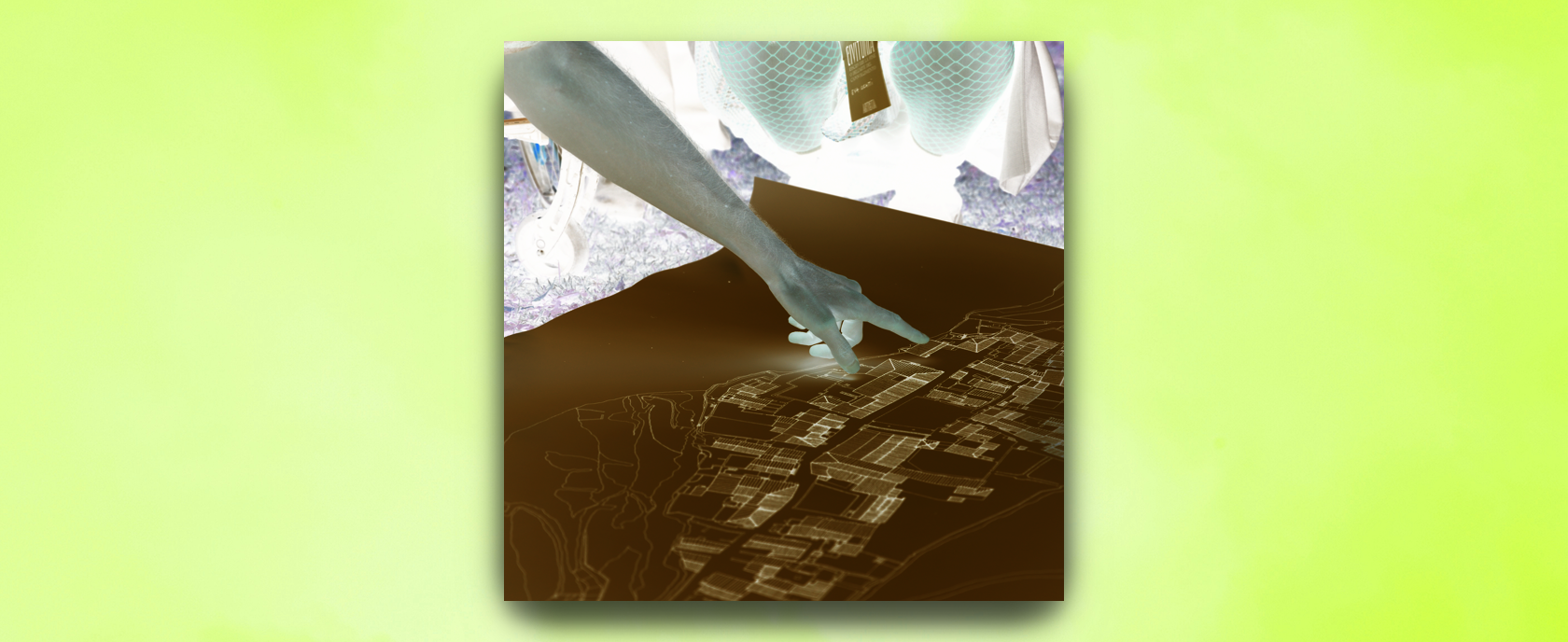Civitonia: moti del tempo in un festival dalla fine
di Viola Lo Moro
Sapevo che tornare a Civita di Bagnoregio avrebbe avuto un costo. Questi sono appunti di quei giorni immersi nel festival, e sono appunti ripescati nel fondo della mia memoria di altri giorni, quando l’estate era sempre sul punto di finire, e non finiva mai; di quando vivevo l’orlo dell’adolescenza senza avere idea di cosa sarebbe stata la vita adulta. Civitonia è riuscita a compiere il miracolo intimissimo (e quindi universale) di farmi stare nel passato e nel presente così vivamente, così vividamente. Un festival pieno di sensi e di fantasmi. Un cluster temporale.
Ho passato alcune delle estati più estati che ci possono essere a Civita: tra i quattordici e i diciott’anni, per alcune sere, le appartenevo. Uso non casualmente la parola appartenere, perché la sensazione, anche nel ricordo, è questa: ero sua. Civita mi possedeva, e possedeva tutte e tutti noi, giovinastre scapestrate, più di quanto noi pensassimo di gestire lei. Mi sono rannicchiata sul bordo dello strapiombo per nascondermi in una nottata di giochi di streghe di mezzanotte, pressata a un giovane uomo più grande di me, che mi appariva, al tatto delle ginocchia, un saggio.
Quando mi sono fatta bendare per l’esperienza organizzata nel lavoro di Francesca Pennini e Vasco Brondi, Panorami per palpebre chiuse, e sono arrivata con gli altri, temporaneamente cieca, a vedere un nuovo panorama, ho intuito l’intento di Brondi e Pennini, mi sono fidata, e ho sentito di nuovo il rumore del vento di Civita, ho toccato con le dita la consistenza delle rocce. Come allora: vedere non implicava la vista. La veduta si spalanca attraverso la privazione e il respiro.
Civita, da ragazza, sembrava volermi dire qualcosa con il vento. Ma ero parzialmente stolta allora, e pensavo raccontasse qualcosa di romantico. Non era così, il rumore era ed è tuttora un segno di come sta il paese: in alto, solitario, adagiato in modo tale che i giochi del suono sembrano sussurri. E di sussurri ne ho sentiti molti anche in questo festival. Giorni di cose dette all’orecchio. Siamo state spettatrici e spettatori delle maldicenze nei cortili delle case, delle piccole minuscole e maiuscole cattiverie che riempiono il suono nei paesi, quando non sono superate dallo strepitio dei turisti e delle campane. Quando abbiamo il coraggio di ascoltare prima, e non di immaginare romanticizzare l’ignoto, come fanno le esotizzazioni turistiche nelle cittadine. Con la verità, l’abisso delle mediocrità si spalanca. Attraverso l’istallazione di Daria Deflorian, Pane per i loro denti, siamo state trascinate in un vortice di parole sbocconcellate dai cortili, così magistralmente montate insieme da sembrare sempre reali: litigi, incomprensioni, pianti, grida, malinconie. C’era la possibilità finale per noi spettatori di “vuotare il sacco”; ho provato a gridare qualcosa, ma sono rimasta afona, e chissà se quell’afonia non era esattamente lo scopo del lavoro. In quel momento di impossibile suono, come una reale magia, come in un’occasione montaliana, ho iniziato a sentire un nuovo brusio.
Dentro Civita, in compagnia delle api, mi perdo, ci perdiamo tutti e tutte, perché, forse, non è più giusto ritrovarsi. È loro il regno, è loro la potenza. È un rito di occupazione.
Cammino per questi vicoli, cerco di far coincidere la mappa della mia memoria con la mappa fornita al centro accoglienza del festival; ovviamente mi perdo. Mi perdo in quattro strade, incredibile! Cresce di un po’ l’angoscia, eppure c’erano tante e tanti vicini e a me. Si allaga l’orecchio di un nuovo suono. Un ronzare perpetuo, sempre più forte, come se stesse arrivando da molto lontano uno sciame di calabroni. Ripercorro a mente il programma, deve essere qualcosa di architettato, qualcosa che conosco perché l’ho letto già. Ma la mente si confonde quando il brusio esterno è più forte di quello interno. La Bugonia. Beehumming, eccolo il nome dell’istallazione di Anagoor.
Capisco che tutto il festival si muove su degli assi cardinali legati alla percezione di ciò che ci circonda (reale o sognato che sia) e alla spercezione di sé. I sensi sono occasione di verità e di inganno. Dentro Civita, in compagnia delle api, mi perdo, ci perdiamo tutti e tutte, perché, forse, non è più giusto ritrovarsi. È loro il regno, è loro la potenza. È un rito di occupazione.
Non possiamo ritrovarci, ma, sembra volerci dire Linea Fissa di Chiara Bersani e Marta Montanini, esiste la possibilità di stare per un po’ e comunicare qualcosa di piccolo, di sottile. Attivo, come da istruzioni, la mia cabina telefonica e scelgo di farmi ripetitrice di un messaggio che ancora non conosco, accetto la sfida di quello che mi pare essere, fino ad ora, il lavoro più criptico di questo festival. Ripeto “sono custode di una cabina”. E accetto il mistero.
Il paese, come nei miei ricordi, dopo una certa ora, prova a soffiarci via, a espirarci. Tornare ha un prezzo: mi si para davanti un grande poster nero attaccato sul muro, con una scritta tanto esplicita quanto volutamente friabile. Fermati, per favore è l’istallazione di CHEAP. I muri e le scritte mi costringono a una resa temporanea: contemplare che anche la scritta CIVITA è sgretolata, anche la denuncia della sua usura si è usurata. Dei muri nei quali mi sono imbattuta durante il festival, quello che ancora oggi mi perseguita è VIENI ANCHE TU A MORIRE A CIVITA. È da quando sono tornata che mi chiedo quanto di me sia morto già durante quelle estati.
Decido di andare via, il tramonto non è passato da molto, ma prima passo alla mostra fotografica Andare Fuori. Mostra timida di Simona Pampallona, in uno dei ventri umidi e tufici di Civita. Queste foto hanno una qualità rara ai miei occhi non esperti ma sensibili a quest’arte: registrano ma non catturano. Lo sguardo mi restituisce un grande rispetto per quello che è intorno a Civita, come se finalmente potessero esistere delle foto libere dalle foto viste da sempre da quell’unica prospettiva di un paese isolato, tra le nuvole.
Non bisogna puntellare tutto, evitare il franare, bisogna forse solo averne cura.
E mentre vado via da Civita e mi avvicino alla terrazza di Lubriano – era lì che c’era sempre radio Subasio che suonava dal bar? Era lì che bevevamo delle Ceres? – scivolo. Mi pare veramente un fatto tautologico: frano pure io. Dalla terrazza di Lubriano guardo i calanchi che sostengono il paese e inizia la performance pensata e architettata da Eva Geatti, Ascesa di un futuro. Posso dire che inizia la performance scrivendone oggi, ma in quel momento non avevo capito subito cosa stesse accadendo. Un po’ come le frane molto lente, un po’ come le formazioni delle montagne e dei continenti, un po’ come le faglie: ci si accorge dopo dell’enorme sforzo che è esistere, anche per le rocce. Si accendono ai lati dei calanchi in tufo che sostengono Civita moltissime luci – non esattamente luci, fluorescenze. Attaccate alle fluorescenze ci sono delle persone, scalatori e scalatrici di umana sembianza. Leggo la brochure, leggo che raccolgono ciò che frana, frammenti. Gli scarti di Civita. Ho l’impressione che finalmente qualcuna ha potuto capovolgere il punto di vista: non bisogna puntellare tutto, evitare il franare, bisogna forse solo averne cura. Mi godo lo spettacolo dell’ascesa in silenzio. Poi giunge come un buio assoluto.
La notte, insieme ad altri visitatori e visitatrici, risaliamo il ponte, mi torna in mente quel pellegrinaggio cieco della mattina. Alla fine di questi giorni realizzerò quanto sono stata immersa dentro dei riti collettivi – diversissimi tra loro – , siamo state e stati, grazie a Michele Di Stefano, Adiòs, e Alessandro Sciarroni, Civita, rapiti in una antispettacolarizzazione della fine. Siamo state compartecipi di uno spettacolo cupo, esagerato, volutamente capovolto. Qualcosa che anche qui rimane irraccontabile.
La notte, dicevo, risaliamo, per vedere la proiezione di un film. Francesca Marciano e Valia Santella con il loro mediometraggio, Il Sonno e la Cura, inseriscono Civita in un tempo altro, in un altro ritmo. La trama è semplice: una ricercatrice va in paese a studiare il fenomeno probabilmente virale che ha infettato tutti gli abitanti del paese: tutti insieme, senza apparenti segni di discontinuità e di fine, dormono. Il sonno ha invaso tutto. Il sonno e, chissà, i sogni. Noi che guardiamo rimaniamo in silenzio, i personaggi sono tutti in silenzio, di nuovo Civita respira. Delle tante sceneggiature possibili per un paese il cui claim turistico è “il paese che muore” ho trovato questa scelta geniale. Il paese che dorme, perché, sembra volermi dire, e sembra volermi ricordare la visione, esiste la possibilità di resistere quietamente al progresso, al tempo furioso e cannibale del tempo stesso: il sonno e i sogni.
Tornare a Civita aveva un prezzo, e lo capisco ancora una volta il giorno seguente, perché d’improvviso realizzo che non voglio mai più andare via. Crollasse tutto ora! Crollasse tutto durante questi giorni di Civitonia! Nella drammaturgia di Sciarroni, tutte e tutti siamo compartecipi del grande interrogativo iniziatico sul perché stazioniamo, abitiamo in un determinato posto. E Civita, col suo perpetuo crollare, non può che essere figura, per qualche istante, del pianeta stesso. Vivo e destinato, vivo e denaturato.
Oggi mi sono messa un abito più comodo, delle scarpe da trekking, e non mi tiro indietro anche quando capisco che, similmente agli scalatori* di Geatti, se faccio lo Scivolovalle, un dispositivo incredibile inventato da Alice Rohrwacher, dovrò risalire a piedi dal fondo valle fino al paese senza l’ausilio dal ponte, l’unica strada ormai dettata come percorribile per arrivare in paese. Chiudo gli occhi nello scivolo, faccio memoria delle palpebre, come ho imparato da Brondi-Pennini, scorrono velocemente gli anni, le immagini di questi giorni e del passato, il vociare nei cortili dei paesi, le mie grida soffocate per le piccole paure. La risalita è stata faticosa, per tappe, ma ho accettato il gioco. E il gioco era il più amorevole atto per questa terra. Mi sembra di intuire che l’artista abbia per queste rocce, per il verde sbiadito, il rumore dei ruscelli, le bestie dei dintorni, un amore che sfugge dalle regole della celebrazione e dell’appropriazione. Ridiventiamo piccole, ridiventiamo bambine quando amiamo. Gioco a nascondino oggi, posso permettermelo dopo vent’anni di abbandono. Solo la terra può perdonare.
Un festival questo che ha capovolto, per qualche istante, il tempo. E quindi i sensi.
Civitonia. Riscrivere la fine o dell’arte del capovolgimento è il primo festival di arti performative immaginato per Civita di Bagnoregio.